INDICE
Introduzione
Capitolo primo: A PROPOSITO DELLE LINGUE SACRE
Capitolo secondo: CRISTIANESIMO ED INIZIAZIONE
Capitolo terzo: I GUARDIANI DELLA TERRA SANTA
Capitolo quarto: IL LINGUAGGIO SEGRETO DI DANTE E DEI “FEDELI D’AMORE” – I
Capitolo quinto: IL LINGUAGGIO SEGRETO DI DANTE E DEI “FEDELI D’AMORE” – II
Capitolo sesto: NUOVE CONSIDERAZIONI SUL LINGUAGGIO SEGRETO DI DANTE
Capitolo Settimo: “FEDELI D’AMORE” E “CORTI D’AMORE”
Capitolo ottavo: IL SANTO GRAAL
Capitolo nono: IL SACRO CUORE E LA LEGGENDA DEL SANTO GRAAL
Capitolo decimo: CRISTO SACERDOTE E RE SAN BERNARDO
Alla presente edizione italiana è stato aggiunto un articolo, Cristo Sacerdote e Re, scritto da René Guénon per la rivista cattolica Le Christ-Roi (Paray-le-Monial), e pubblicato per la prima volta in italiano nel n° 25 della Rivista di Studi Tradizionali (Torino), dell’ottobre-dicembre 1967. In appendice alla presente edizione è stato posto il breve studio su San Bernardo, che in Francia viene pubblicato in un opuscolo a parte (Editions Traditionnelles, 1984). Perla traduzione sono state utilizzatele pubblicazioni sopra indicate. 1954 – Editions Traditionnelles – Parigi 1997 – Arktos – Giovanni OGGERO EDITORE – via Valobra 128 – Carmagnola NOTIZIA (Le informazioni di carattere biografico sono quanto di più distante dalla mentalità di René Guénon che, molto giustamente, ricordava sempre come fossero importanti solo le idee ed i comportamenti manifestati piuttosto che le speculazioni voyeuriste sulla vita privata di una persona. Ci limitiamo pertanto a fornire le date essenziali legate alla sua opera). René Guénon nacque a Blois, Loir et Cher, il 15 novembre 1886; nel 1903 completò i suoi studi e nel 1904 si stabilì a Parigi, ove, oltre ad interessi accademici poco sentiti, ebbe modo di curare composite relazioni con gli ambienti che definirà «neo-spiritualisti». Dal 1906 al 1912 ha modo di intrattenere rapporti, più o meno impegnativi, con personaggi ed organismi che saranno altrettanti punti di riferimento per la sua formazione, in senso costruttivo o critico: da Papus (1906) alla «Chiesa Gnostica» (1908), da L. Champrenaud (Abdul-Haqq) al conte di Pouvourville (Matgioi) (1909) dalla Massoneria (Loggia Thébah, della G.L.N.di Francia) (1907) al pittore J.G. Angelii (Abdul-Hadi) (1910). Fonda la rivista La Gnose (1909-1912) ed intrattiene i primi rapporti con ambienti cattolici, indù ed islamici. Dal 1913 al 1921 approfondisce i suoi rapporti con elementi indù e col Tasawwuf e nel 1921 inizia in maniera consistente la sua opera di informazione tradizionale, di messa a punto e di rettificazione, che si esprimerà tramite i suoi scritti (libri, articoli e lettere). Dal 1921 al 1930 pubblica i suoi primi otto libri, ove si delineano gli insegnamenti tradizionali e l’evidente deviazione del mondo moderno. Dal 1925 al 1927 collabora anche alla rivista cattolica Regnabit, mentre nel 1928 ha inizio la sua collaborazione con la rivista Le Voile d’Isis, che nel 1937 diventa Etudes Traditionnelles, collaborazione, parecchio marcata d’altronde, che durerà fino alla sua morte. Contemporaneamente scrive degli articoli per riviste di diverse nazioni, come l’Inghilterra e l’Italia. Nel 1930 si stabilisce definitivamente al Cairo, ove realizza, anche dal punto di vista dell’esistenza quotidiana, quel suo ricollegamento all’ambito esoterico della tradizione islamica che comporta inevitabilmente e logicamente un pari collegamento exoterico all’Islam e che certamente è qualcosa di molto diverso dalla fin troppo banale pretesa di «conversione» che si tenta di attribuirgli. Dal Cairo mantiene un costante collegamento con la pubblicazione dei suoi restanti scritti, costituiti prevalentemente da articoli e recensioni. Muore il 7 gennaio 1951)
INTRODUZIONE
Dopo la morte di René Guénon è stata curata la raccolta in volumi dei suoi articoli, raggruppati, per quanto possibile, in base all’argomento trattato. Sotto il titolo di Considerazioni sull’Esoterismo Cristiano sono stati raccolti alcuni articoli relativi alla tradizione cristiana ed alla sua componente esoterica, articoli che non hanno trovato posto in altre raccolte ma che, comunque, non sono gli unici in cui René Guénon si occupa dell’esoterismo cristiano. La questione dell’esoterismo cristiano è una di quelle che, ai nostri giorni, sembra presentare delle enormi difficoltà, sia in ordine alla sua importanza in seno al Cristianesimo, sia in relazione alla sua stessa esistenza, soprattutto ove si pensi che negli ultimi secoli si è andata sempre più affermando la strana idea che esso non sarebbe mai potuto esistere. Il termine «esoterico» sta ad indicare, soprattutto, quella parte di uno stesso insegnamento che, a causa della differenziata comprensione degli uomini a cui questo si rivolge, è riservata a quei pochi fra loro che sono in grado di comprenderlo ed hanno quindi le qualità a ciò atte. e questo per distinguerlo del restante insegnamento che, essendo più comprensibile alla maggioranza degli uomini, perciò stesso si presenta privo della riservatezza che caratterizza il primo; da qui la sua denominazione di «exoterico». Ora, che gli uomini abbiano una capacità di comprensione differenziata è un dato di fatto che solo un partito preso di poco conto potrebbe contestare, ma le cose si complicano ove si pensi che negli ultimi secoli è andata in voga la strana e contraddittoria idea che tutti gli uomini sono uguali, anche a dispetto di qualsivoglia evidenza. Che si tratti di un mero sofisma verbale è chiaro a tutti, basta pensare che i «colti» fautori dell’uguaglianza continuano a sostenere che loro hanno capito tutto a differenza degli altri che «non capiscono», e questo alla faccia dell’uguaglianza; ma, ciò nonostante, di fatto si è venuta a determinare la formazione di una sorta di strumento di prevaricazione poggiante su una specie di «tabù»: tutto ciò che c’è da capire è quello che è accessibile alla maggioranza, in base alla sua capacità «media» (o mediocre) di comprensione e, quindi, chiunque pretende di capire di più e meglio è in errore, o è un impostore o un nemico: e a nulla valgono le credenziali di «acculturamento» vantati da codesti «studiosi», perché basta pensare all’insegnamento «mediocre» che, ormai da tempo, si impartisce nelle scuole di ogni ordine e grado. La cosa più stupefacente è la pretesa di voler applicare tale puerile concezione ad ogni genere di sapere: non solo al sapere meramente umano ma anche a quello relativo ad ambiti che stanno al di là dell’umano, e questo è veramente uno di quei sintomi eclatanti che denunciano lo stato di totale oscurità e il reale stato di «salute» in cui si trova l’uomo moderno; e ci troviamo anche al cospetto del principale aspetto dell’inversione moderna portata avanti dallo spirito di negazione che va sempre più affermandosi in questa nostra Età Oscura. Tale «diabolica» inversione di ogni normalità, che si ritrova in ogni campo, si applica con protervia nei confronti di quanto rimane degli insegnamenti tradizionali, nel mondo intero; e in Occidente, un tale spirito di negazione si accanisce nei confronti della forma assunta dalla tradizione, or sono duemila anni, e cioè nei confronti del Cristianesimo. A prescindere, in questa sede, dalle prime manifestazioni di ripudio di ogni autorità di ispirazione non-umana, che si espressero con le stupide affermazioni del «libero esame» e che si concretizzarono nei vari «protestantesimi», ci interessa far notare come si fosse già giunti da tempo alla «catalogazione» ed alla «suddivisione» dell’intero corpo tradizionale, tanto da arrivare a separare l’aspetto più elevato della dottrina dal suo aspetto più semplice, determinando così uno stato di fatto nel quale l’aspetto più elevato viene prima accantonato, poi negato ed infine anche condannato. Indubbiamente, all’inizio, quando la forma tradizionale del Cristianesimo andava stabilizzandosi, per assumere le connotazioni «religiose» che le sono proprie, non esisteva alcun motivo perché non si riconoscesse naturalmente la complessità della dottrina e quindi non si desse per scontata una certa gradualità di comprensione, tale che i più potessero assimilarne solo gli aspetti più semplici, mentre solo pochi fossero in grado di approfondire i suoi significati più elevati (San Paolo allora scriveva: «A tale riguardo noi avremmo da dire molte cose, ma son difficili a spiegarsi, perché voi siete diventati lenti a comprendere…. tanto che siete ridotti ad aver bisogno di latte e non di solido cibo» Ebrei, V, 11-12). Ma, data la condizione di incomprensione in cui si trovava l’Occidente, tale naturale situazione finì col trasformarsi e col complicarsi, a causa di alcuni che, pur non appartenendo ai più in quanto a comprensione, non appartenevano neanche ai pochi in quanto a capacità di penetrazione «intellettuale». Fu così che nacquero e si espressero come meteore, più o meno durature, le prime eresie, e fu un tale stato di cose che rese necessario l’accantonamento della parte più elevata della dottrina, tanto da determinare l’etichettatura dei due ambiti dottrinali: l’esoterico e l’exoterico (Sembra che il termine esoterico sia stato usato per la prima volta dagli «alessandrini»). Ogni etichettatura implica necessariamente una separazione, almeno apparente, che finisce poi col tramutarsi in divisione effettiva, in forza della comprensione parziale e «specialistica» dell’uomo «decaduto». Una tale separazione, beninteso, corrisponde effettivamente alla condizione attuale dell’umanità, che da diversi millenni vive nella fase ciclica dell’Età Oscura, ma ciò, mentre spiega le ragioni profonde che sono alla base di tale separazione, non ne sancisce certo la rigorosa regolarità. Nondimeno, se questa è la condizione dell’attuale umanità e se tale separazione, fra esoterismo ed exoterismo, è un dato di fatto dal quale non si può prescindere, tenuto conto del naturale adattamento della tradizione, ciò non ha mai significato, nelle diverse civiltà tradizionali, compresa la Cristianità fino al Medioevo, che i due domini fossero assolutamente distinti e non comunicanti, se non addirittura opposti. In definitiva, si può solo trattare di riconoscere la collocazione più idonea ai diversi gradi di comprensione della dottrina tradizionale: l’ambito esoterico, allora, molto semplicemente, si delinea sulla base della comprensione superiore e metafisica della tradizione ed assicura, per ciò stesso, il necessario raccordo con tutti gli altri ambiti più immediati e gradualmente inferiori; questi ultimi, raccolti entro il termine di «exoterismo», si definiscono per una comprensione meno profonda della tradizione, ma non per questo meno importante o meno «necessaria», anzi, data la gradualità di comprensione a sua volta esistente in seno ad ognuno di questi ambiti, e limitandoci a quello exoterico, è indubbio che si avrà anche una maggiore ed una minore comprensione exoterica della tradizione, tanto che inevitabilmente si verrà a costituire una sorta di dipendenza fra i diversi corpi dell’organismo sociale, cosa questa che fa comprendere come in una società tradizionale come quella del Medioevo nulla sfuggisse all’influenza della religione. Ne deriva, da un lato una «provvidenziale» separazione di competenze, atta a meglio permettere che ogni uomo si orienti secondo la sua particolare natura; e dall’altro una necessaria gerarchizzazione fra i due ambiti, tale da assicurare all’exoterismo la possibilità di attingere con tranquillità alla fonte della sua stessa ragion d’essere. Nessuna contrapposizione potrebbe, dunque, essere ammessa, se non nel caso di deviazione e di incomprensione da parte degli uomini che si richiamano ai due ambiti; infatti, non si potrebbe mai parlare di contrasti, di opposizioni o di incomprensioni fra gli ambiti esoterico ed exoterico, di per sé, in quanto questi derivano direttamente dal «provvidenziale» e «giusto» adattamento allo stato di cose, sopraggiunto come normale; piuttosto sono gli uomini, che a questi ambiti si rifanno, che sono soggetti all’incomprensione: come, per esempio, è accaduto per degli esoteristi, se è lecito usare questo termine, che avendo mal compreso la dottrina iniziatica perché non debitamente qualificati, hanno poi preteso di «confrontarsi» con l’exoterismo, confondendo cose che attenevano a «posti» differenti; e come accade per degli exoteristi, che avendo perduto di vista il fatto che una dottrina tradizionale è necessariamente di derivazione non-umana e che quindi deve anche comportare una comprensione ed una «partecipazione» quantomeno distanti dalle «comuni» possibilità, soprattutto ove si pensi a cosa corrisponde oggi l’accezione di «uomo comune», non si rendono conto che ogni negazione di tale possibilità, andante dalla «visione della verità» fino alla «conoscenza della verità», equivale alla negazione stessa della causa prima dell’exoterismo. Ed in effetti non si è mai trattato di incompatibilità o di opposizione, se non negli ultimi secoli. In ogni caso, si giunge fino al XIII secolo con una tacita convivenza fra i rappresentanti dei due ambiti, che qualche volta manifestano fra loro critiche e diffidenze, ma per il resto vivono quel rapporto di simbiosi implicito nella loro natura. Non diversamente si spiegherebbe l’esistenza degli «Ordini contemplativi», di certi rami della Cavalleria, come i Templari, o di gruppi come i «Fedeli d’Amore» ed i «costruttori di cattedrali»; d’altronde, è allo stesso modo che si spiegano i rapporti di fraternità fra Carlo Magno e Harun El-Rashid, fra i Cavalieri del Tempio e gli Ismailiti o fra i centri «culturali» ebraici, islamici e cristiani. A nulla valgono le superficiali «ricostruzioni» degli storici, che alla fin fine non riescono a conciliare coerentemente, per esempio, la «cacciata dei Mori» con gli scambi spirituali, «culturali» e persino «scientifici» fra la Cristianità e l’Islam. Nei rapporti allora esistenti fra esoterismo ed exoterismo cristiano, così come nei rapporti esistenti fra le due forme tradizionali del Cristianesimo e dell’Islam, il contrasto nelle contingenze non poteva impedire, e non impediva infatti, l’accordo sui principi. Nel frattempo, però, continuano a presentarsi i fenomeni di incomprensione e di distorsione, simili a quelli dei primi secoli, anche se l’aggravata incomprensione generale fa scaturire «eresie» che appaiono puerili se raffrontate a certe deviazioni cosiddette «gnostiche». Pur nondimeno, esse intaccano l’unità della Cristianità, già di per sé debole, pur nella sua persistenza; l’esoterismo cristiano finisce così con l’essere addirittura misconosciuto e perfino negato, e si profila la strana concezione, che si affermerà più tardi per effetto di semplificazione e di superficialità, che pretende di identificare esoterismo ed eresia. È negli anni fra il XIII ed il XIV secolo che l’esoterismo cristiano è costretto a ricorrere decisamente a delle precauzioni e a dei mezzi di dissimulazione mai adottati prima, e ad irrigidire i rapporti con gli ambiti diversi dal suo: per quanto era possibile, si doveva impedire l’accesso ad elementi che avrebbero finito per capire male e per divulgare poi delle «eresie», e si doveva anche impedire che i rappresentanti dell’exoterismo scambiassero sbrigativamente il «ricercatore della verità» col «fomentatore di disordine». Ciò nonostante, non si è ancora giunti alla condanna dell’esoterismo, tant’è che nel corso dei secoli successivi, monaci, prelati ed alcuni papi dimostrano, anche se non in maniera esplicita, che non solo si interessano alla comprensione esoterica della dottrina ma ne sostengono di fatto i fautori che ancora sussistono in seno a gruppi apparentemente staccati dall’organismo «ecclesiale», inteso nel suo senso originario: basti per tutti l’esempio dei gruppi esoterici dei «costruttori di cattedrali», che fino al XVIII secolo erano strutturati in maniera tale da richiedere ai loro componenti la completa fedeltà alla Chiesa, la pratica imprescindibile della religione e la indispensabile presenza fra loro di un prelato. È solo nel XVIII secolo che si viene a determinare una netta rottura fra i rappresentanti dell’exoterismo ed i resti confusi di qualche ramo dell’esoterismo; da entrambi le parti si manifestano i sintomi di un’accresciuta incomprensione dei comuni principi e si giunge perfino all’«anticlericalismo» protestanteggiante da una parte, ed alla «scomunica» formale dall’altra; mentre in entrambi gli ambiti si insinua perniciosa la fisima modernista del coinvolgimento nel «sociale», vale a dire, per l’esattezza, nel «profano». In altri termini, sia l’esoterismo che l’exoterismo rimangono coinvolti, per difetto di comprensione, nella manovra «oscura» di capovolgimento definitivo della normalità, e al posto di essere loro ad informare e ad «illuminare» gli aspetti più umili della «vita ordinaria», è quest’ultima, assurta, di per sé, a sinonimo di «normalità», a richiedere loro di abbandonare i principi e di dedicarsi esclusivamente ai «bisogni» materiali degli uomini. È in tale contesto che si situa quella che è stata chiamata la «funzione» di René Guénon, cioè il tentativo di richiamare all’attenzione dei pochi rimasti la preminenza imprenscindibile dei principi, la preminenza cioè dello spirituale sul materiale, dell’essenziale sul contingente, dell’immanente sul transeunte; di modo che, se ancora possibile, si potesse salvare il salvabile. È difficile dire quanto e come questo tentativo sia riuscito, fatto è che molte persone, anche quando solo in termini di semplice acquisizione teorica, grazie alla sua opera costante di chiarimento e di «memento», opera che ha decisamente i connotati della Carità» e dell’«Amore», sono riusciti a comprendere il vero senso della tradizione e a riscoprire il valore tradizionale degli insegnamenti dei Padri della Chiesa e di alcuni «mistici» medioevali, nonché a comprendere il valore tradizionale della comune origine delle attuali religioni e la funzione «provvidenziale» della Chiesa Cattolica, nonostante tutto. È grazie all’opera di René Guénon che tanti sono riusciti a fare uno spiraglio di luce, riscoprendola lì ove è sempre stata e liberandola dagli elementi che la occultavano. René Guénon auspicava la costituzione di un’«élite» che, senza necessità di organizzarsi, si ponesse il compìto silenzioso di frenare la corsa «satanica» dell’Occidente verso la dissoluzione finale; ed anche in ordine a questa sua primaria preoccupazione è difficile comprendere fino a che punto essa possa essersi concretizzata, anche perché non sarebbe possibile dirlo per chiunque, come noi, è fuori da ogni ambito come quello proprio a tale «élite»; ma anche solo limitandoci ai riavvicinamenti alla tradizione cristiana operati, con più o meno consapevolezza, da più persone, riavvicinamenti che con più esattezza potremmo definire, queste sì, «conversioni»; e considerando anche i più ampi orizzonti di comprensione che, pur entro limiti molto contenuti, si sono manifestati in seno a ciò che rimane in Occidente dell’esoterismo; ci sembra che si trattò e si tratta di un’opera immane, che non ha pari negli ultimi quattro secoli di storia dell’Occidente. Certo, il «testimone della tradizione» René Guénon non ha bisogno dei nostri riconoscimenti, ma volevamo solo sottolineare l’importanza dello «studio» della sua intera opera, poiché essa non è suscettibile di «divisione» o di «classificazione». È nel trattare degli insegnamenti tradizionali nel loro complesso, cosa questa che è l’unico oggetto della sua intera opera, che René Guénon tratta, naturalmente, del Cristianesimo; ed è quindi dallo studio della sua intera opera che si possono trarre le indicazioni circa il senso dell’esoterismo e dell’exoterismo cristiano. Ciò posto, nulla osta a che si possano segnalare alcuni titoli ove sono contenute delle considerazioni più dirette: ne L’Esoterismo di Dante egli approfondisce il problema dell’esoterismo cristiano a cavallo fra il XII ed il XIII secolo; nel Re del Mondo tratta anche della perfetta ortodossia tradizionale del Cristianesimo; in Iniziazione e Realizzazione Spirituale molti articoli sono dedicati alla comprensione della portata tradizionale dell’exoterismo ed alla necessità di «aderirvi» realmente, per chiunque voglia mantenere foss’anche il minimo legame con la tradizione. C.C.
CAPITOLO PRIMO
A PROPOSITO DELLE LINGUE SACRE [Pubblicato su Etudes Traditionnelles, aprile-maggio 1947].
Tempo fa [Les «Racines des plantes», su Etudes Traditionnelles, sett, 1946; divenuto poi Le «Radici delle piante», cap. 62 di «Simboli della Scienza sacra»], facevamo notare casualmente che il mondo occidentale non ha a sua disposizione altra lingua sacra che l’ebraico; in verità la cosa appare molto strana e richiede alcune osservazioni che, senza la pretesa di voler risolvere i vari problemi relativi all’argomento, rivestono tuttavia un certo interesse. È evidente che se l’ebraico può giuocare in Occidente un tale ruolo è in forza della filiazione diretta che esiste fra la tradizione giudaica e quella cristiana, nonché dell’incorporazione delle Scritture ebraiche nei Libri sacri del Cristianesimo; ma ci si può chiedere come mai quest’ultimo non abbia una sua propria lingua sacra, cosa che, nell’ambito delle diverse tradizioni, appare come veramente eccezionale. A questo riguardo è necessario, innanzi tutto, non confondere le lingue sacre con le lingue semplicemente liturgiche [Ciò è tanto più importante, dal momento che abbiamo notato come un orientalista abbia qualificato di «lingua liturgica», l’arabo, che in realtà è una lingua sacra; e come lo abbia fatto con l’intenzione nascosta, ma tuttavia ben chiara per chi sa comprendere, di sminuire la tradizione islamica. Ciò, d’altronde, è in stretto rapporto con la campagna da lui promossa in seno ai paesi di lingua araba, al fine di far loro adottare la scrittura a caratteri latini, campagna condotta peraltro senza successo]: perché una lingua possa svolgere quest’ultimo ruolo è sufficiente, in fondo, che essa sia «fissa», cioè esente dalle continue variazioni che necessariamente subiscono le lingue comunemente parlate [Preferiamo usare il termine di «lingua fissa», piuttosto che quello di «lingua morta», come si usa fare, poiché fintanto che una lingua è impiegata per usi rituali non è possibile dire, dal punto di vista tradizionale, che sia effettivamente morta]; le lingue sacre, invece, sono esclusivamente quelle nelle quali sono state formulate le Scritture delle diverse tradizioni. Va da sé che ogni lingua sacra è al tempo stesso, e a maggior ragione, la lingua liturgica e rituale della tradizione a cui appartiene [Diciamo «liturgica o rituale» poiché il primo termine si riferisce propriamente alle forme religiose, mentre il secondo ha un significato più generale e si adatta a tutte le tradizioni indistintamente], mentre non è vero l’inverso; è così che il greco o il latino possono giustamente, al pari di altre lingue antiche [In particolare il siriaco, il copto e lo slavo antico, in uso presso diverse chiese orientali], svolgere il ruolo di lingue liturgiche del Cristianesimo [Sia ben chiaro che ci riferiamo solo ai rami regolari ed ortodossi del Cristianesimo; per il Protestantesimo, sotto tutte le sue forme, dal momento che usa solo delle lingue volgari, per ciò stesso, non è possibile parlare propriamente di liturgia], ma esse non sono al fatto delle lingue sacre; quand’anche si volesse supporre che esse abbiano avuto un tempo un tale carattere [Il fatto che non conosciamo dei Libri sacri scritti in queste lingue non consente di scartare in modo definitivo una tale supposizione, poiché nell’antichità sono certamente esistite parecchie cose che non ci sono pervenute; vi sono delle questioni che certo sarebbe difficile risolvere attualmente, come, per esempio, quella relativa alla tradizione romana e riguardante il vero carattere dei Libri sibillini e la lingua nella quale erano redatti], ciò sarebbe relativo a delle tradizioni scomparse e con le quali il Cristianesimo non ha evidentemente alcun rapporto di filiazione. L’assenza della lingua sacra nel Cristianesimo diviene ancora più evidente allorché si considera che per quanto riguarda le Scritture ebraiche, di cui comunque esiste il testo originario, ci si serve «ufficialmente» della traduzione greca o latina [La versione dei Settanta e la Volgata]. Per quanto riguarda il Nuovo Testamento, si sa che il testo conosciuto è in greco ed è su di esso che sono state condotte tutte le versioni nelle diverse lingue, compreso l’ebraico ed il siriaco; ora, quantomeno per i Vangeli, è certo impossibile ammettere che la loro vera lingua sia stata il greco, la lingua cioè nella quale sono state pronunciate le parole stesse di Cristo. Tuttavia, è possibile che essi non siano mai stati scritti effettivamente se non in greco, essendo stati precedentemente trasmessi oralmente nella loro lingua originale [Questa semplice considerazione a proposito della trasmissione orale, dovrebbe bastare a vanificare tutte le discussioni dei «critici» sulla presunta datazione dei Vangeli, ed effettivamente essa sarebbe sufficiente se non fosse che i difensori del Cristianesimo sono essi stessi più o meno affetti dallo spirito antitradizionale del mondo moderno]; ma, ci si può allora chiedere, come mai allorché venne effettuata la loro fissazione a mezzo della scrittura, ciò non sia avvenuto usando semplicemente la stessa lingua: è questa una questione alla quale sarebbe molto difficile rispondere. Comunque sia, tutto ciò finisce col sollevare alcuni inconvenienti, sotto diversi aspetti, poiché una lingua sacra è la sola che possa assicurare, con rigore, l’invariabilità del testo delle Scritture; le traduzioni variano necessariamente da una lingua all’altra e, per di più, possono essere solo approssimative, dal momento che ogni lingua ha dei propri modi di espressione che non corrispondono esattamente a quelli delle altre lingue [Questo stato di cose finisce col favorire gli attacchi degli «esegeti» modernisti: se esistessero dei testi in lingua sacra, ciò non impedirebbe certo a costoro di discuterne egualmente, da quei profani che sono, ma in questo caso, per tutti coloro che conservano ancora un po’ dello spirito tradizionale, sarebbe almeno più facile non sentirsi obbligati a tenere in conto le loro pretese]: anche quando rendono nel miglior modo possibile il senso esteriore e letterale, le traduzioni comportano in ogni caso delle difficoltà in ordine alla penetrazione degli altri significati più profondi [Ciò è particolarmente evidente a riguardo delle lingue sacre le cui lettere hanno un valore numerico o propriamente geroglifico, cosa che, da questo punto di vista, assume spesso una grande importanza e di cui una traduzione qualunque non lascia evidentemente sussistere niente]. Ci si può render conto, così, di alcune delle difficoltà del tutto speciali che presenta lo studio della tradizione cristiana, per coloro che volessero limitarsi alle semplici apparenze, più o meno superficiali. Ben inteso, tutto ciò non vuole affatto significare che non ci siano delle ragioni perché il Cristianesimo abbia questo carattere eccezionale che ne fa una tradizione senza una lingua sacra, al contrario, ve ne sono sicuramente, ma bisogna riconoscere che esse non appaiono chiaramente ad un primo esame e, senza dubbio, per riuscire ad individuarle occorrerebbe un lavoro considerevole che noi non pensiamo di intraprendere; del resto, quasi tutto ciò che riguarda le origini del Cristianesimo e dei suoi primi anni e sfortunatamente avvolto nella più grande oscurità. Ci si potrebbe anche chiedere se non vi sia qualche rapporto tra questa caratteristica ed un’altra, non meno singolare: il Cristianesimo non possiede neanche la parte propriamente «legale» delle altre tradizioni; tant’è che per rimediarvi ha dovuto adattare a sé l’antico diritto romano, facendovi peraltro delle aggiunte che, pur essendo sue proprie, non derivano tuttavia dalle Scritture [Si potrebbe dire, servendosi di un termine proprio alla tradizione islamica, che il Cristianesimo non ha una shariyah, e ciò è tanto più notevole se si pensa che, in seno alla filiazione tradizionale che possiamo chiamare «abramica», esso si colloca fra il Giudaismo e l’Islamismo, che invece hanno entrambi una shariyah molto sviluppata]. Accostando questi due fatti e considerando, come abbiamo fatto notare in altre occasioni, che alcuni riti cristiani appaiono in qualche modo, come una «esteriorizzazione» di riti iniziatici, ci si potrebbe anche chiedere se il Cristianesimo originario non fosse in realtà qualcosa di molto diverso da quello che si può pensare attualmente, se non in quanto alla dottrina in sé [Piuttosto, forse, si dovrebbe dire: a quella parte della dottrina che è rimasta e che è stata generalmente conosciuta fino ad oggi; questa certo non è cambiata ma è possibile che vi fossero anche degli altri insegnamenti, e certe allusioni dei Padri della Chiesa sembra non possano essere compresi se non in questa chiave. Gli sforzi fatti dai moderni per sminuire la portata di queste allusioni provano solo i limiti propri alla loro mentalità], per lo meno in reazione ai fini in vista dei quali venne costituito [Lo studio di tali questioni condurrebbe anche ai problemi sollevati dai rapporti fra Cristianesimo primitivo ed Essenismo; quest’ultimo, d’altronde, è assai mal conosciuto, ma perlomeno si sa che costituiva un’organizzazione esoterica collegata al Giudaismo. Su tale questione sono state dette molte cose fantasiose, ma essa è un’altra di quelle che meriterebbe di essere esaminata seriamente]. Per quanto ci riguarda, abbiamo voluto semplicemente porre degli interrogativi, ai quali però non pretendiamo affatto di dare una risposta, ma, dato l’interesse che essi presentano sotto diversi aspetti, sarebbe parecchio auspicabile che qualcuno, in possesso del tempo e dei mezzi adatti a condurre le necessarie ricerche, apportasse, un giorno o l’altro, alcuni chiarimenti.
CAPITOLO SECONDO
CRISTIANESIMO ED INIZIAZIONE [Pubblicato su Etudes Traditionnelles, Parigi, settembre, ottobre-novembre e dicembre 1949].
Non intendiamo ritornare qui sulle questioni relative al carattere proprio del Cristianesimo, poiché pensiamo che ciò che abbiamo detto in diverse occasioni, se pure più o meno incidentalmente, sia quantomeno sufficiente a fugare ogni equivoco in proposito [Siamo rimasti stupiti nel notare che alcuni ritengono che «Considerazioni sulla Via Iniziatica» sia, fra i nostri libri, quello che tratta più direttamente ed in modo prevalente del Cristianesimo; possiamo loro assicurare che lì, come altrove, abbiamo inteso parlarne nella misura in cui era strettamente necessario per la comprensione delle nostre esposizioni e, se così si può dire, in funzione delle diverse questioni che dovevamo trattare. È ugualmente stupefacente che dei lettori, che tuttavia assicurano di aver seguito attentamente e costantemente tutto ciò che abbiamo scritto, abbiano creduto di trovare in questo libro qualcosa di nuovo sull’argomento, mentre invece in tutti quei passi che ci sono stati segnalati noi non abbiamo fatto altro che riprodurre, puramente e semplicemente, delle considerazioni che avevamo già sviluppato in alcuni dei nostri articoli apparsi in precedenza su Le Voile d’Isis e su Etudes Traditionnelles]. Sfortunatamente abbiamo dovuto constare, in questi ultimi tempi, che non è così e che, invece, nello spirito di un gran numero di nostri lettori sono sorte delle confusioni piuttosto incresciose, per cui abbiamo sentito la necessità di apportare nuovamente delle precisazioni su alcuni punti. D’altronde, ci siamo decisi a farlo malvolentieri poiché dobbiamo confessare che non abbiamo mai provato alcuna inclinazione a trattare in modo particolare questo argomento, e ciò per svariati motivi, primo fra tutti l’oscurità pressoché impenetrabile che avvolge tutto quanto concerne le origini ed i primi anni del Cristianesimo, oscurità che, a ben riflettere, sembra non possa essere semplicemente considerata come accidentale, ma piuttosto come espressamente voluta; tale considerazione, del resto, è da collegare con quanto diremo in seguito. Nonostante tutte le difficoltà derivanti dalla suddetta considerazione, vi è tuttavia almeno un punto sul quale sembra non sussistano dubbi e che, peraltro, non è stato contestato da nessuno di coloro che ci hanno sottoposto le loro osservazioni, anzi è proprio su di esso che alcuni hanno poggiato certe loro obiezioni: si tratta del fatto che, lungi dall’essere solo la religione o la tradizione exoterica che si conosce attualmente, il Cristianesimo delle origini aveva, in forza dei suoi riti e della sua dottrina, un carattere essenzialmente esoterico e quindi iniziatico. Se ne può avere conferma dal fatto che la tradizione islamica considera il Cristianesimo primitivo proprio come una tariqah, cioè come una via iniziatica, e non come una shariyah, cioè come una legislazione di tipo sociale e rivolta a tutti; e ciò è così vero che, in un secondo momento, si dovette rimediare con la costituzione di un diritto «canonico» [A questo proposito non è forse privo di interesse segnalare che, in arabo, il termine qanun, derivato dal greco, è impiegato per designare tutte le leggi adottate per dei motivi puramente contingenti e che non fanno parte integrante della shariyah o della legislazione tradizionale], che in realtà fu solo un adattamento dell’antico diritto romano, dunque qualcosa che veniva interamente dal di fuori e non certo uno sviluppo di quanto da sempre contenuto nel Cristianesimo stesso. Del resto, è evidente che nel Vangelo non si trova alcuna prescrizione che possa essere considerata come avente un vero carattere legislativo, nel vero senso della parola; la ben nota frase: «Date a Cesare quel che è di Cesare…» ci sembra del tutto significativa, a riguardo, poiché essa implica formalmente, per tutto quanto di ordine esteriore, l’accettazione di una legislazione del tutto estranea alla tradizione cristiana, legislazione che, molto semplicemente, è quella esistente di fatto nell’ambito che vide nascere il Cristianesimo stesso, ambito che allora faceva parte dell’Impero romano. Un tale fatto si configurerebbe sicuramente come una lacuna delle più gravi se il Cristianesimo fosse stato fin d’allora ciò che è divenuto più tardi. L’esistenza stessa di una tale lacuna sarebbe, non solo inspiegabile, ma veramente inconcepibile per una tradizione ortodossa e regolare, sia che effettivamente questa tradizione dovesse comportare un exoterismo al pari di un esoterismo, sia che dovesse applicarsi, si potrebbe dire, innanzi tutto al dominio exoterico. Se invece il Cristianesimo aveva il carattere che abbiamo detto, la cosa si spiega con facilità, poiché non si tratta affatto di una lacuna ma di una intenzionale astensione di intervento in un dominio che, per definizione, non poteva competergli, in siffatte condizioni. Perché questo sia possibile è necessario che la Chiesa cristiana, nei primi tempi, fosse un’organizzazione chiusa o riservata, nella quale non venivano ammessi tutti indistintamente, ma solo coloro che possedevano le qualificazioni necessarie per ricevere validamente una iniziazione che si potrebbe chiamare «cristica»; senza dubbio si potrebbero ancora rintracciare degli indizi che dimostrano che fu effettivamente così, quantunque nella nostra epoca essi siano generalmente incompresi, non solo, ma a causa della tendenza moderna a negare l’esoterismo, si cerca troppo spesso, in maniera più o meno cosciente, di stravolgere il loro vero significato [Abbiamo avuto spesso occasione di constatare una procedura del genere nella interpretazione attuale dei Padri della Chiesa ed in particolare dei Padri greci: ci si sforza, nei limiti del possibile, di sostenere che si avrebbe torto allorché si volessero trovare delle allusioni esoteriche nei loro scritti; e quando ciò diventa del tutto impossibile, non si esita a fargliene una colpa e a dichiarare che in tali casi hanno dimostrato una deplorevole debolezza!]. Questa Chiesa, insomma, è paragonabile, sotto questo aspetto, al Sangha buddhista, in cui l’ammissione aveva anche i caratteri di una vera iniziazione [Si veda: A.K. Coomaraswamy, L’ordination bouddhique est-elle une initiation?, nel n° del luglio 1939 di Etudes Traditionnelles], e che si usa assimilare ad un «ordine monastico»; cosa che è esatta, almeno nel senso che i suoi statuti particolari, al pari di quelli di un ordine monastico cristiano, non sono fatti per essere applicati all’insieme della società nella quale una tale organizzazione si viene a stabilire [È questa estensione illegittima che diede ulteriormente luogo, nel Buddhismo indiano, a certe deviazioni come quella della negazione delle caste: Buddha non aveva bisogno di tener conto di esse all’interno di una organizzazione chiusa ed i cui membri dovevano, quantomeno in linea di principio, essere al di là delle loro stesse distinzioni; ma il voler sopprimere questa distinzione nell’intero ambito sociale costituiva, dal punto di vista della tradizione indù, una formale eresia]. Il caso del Cristianesimo, dunque, non è affatto unico, da questo punto di vista, fra le differenti forme tradizionali conosciute, e questa constatazione ci sembra essere atta a calmare lo stupore di qualcuno; forse è più difficile spiegare come esso sia cambiato in seguito, ed in modo tanto complessivo, così come ci appare da tutto ciò che vediamo oggi intorno a noi; ma non è ancora il momento per esaminare quest’altra questione. Veniamo adesso all’obiezione che ci è stata sollevata ed alla quale alludevamo prima: dal momento che i riti cristiani, ed in particolare i sacramenti, ebbero un carattere iniziatico, com’è possibile che lo abbiano potuto perdere per diventare dei semplici riti exoterici? Ci è stato detto che ciò è impossibile ed anche contraddittorio, poiché il carattere iniziatico è permanente ed immutabile e non potrebbe mai essere cancellato, per cui è possibile ammettere solamente che, a causa delle circostanze e dell’ammissione di un grande maggioranza di individui non qualificati, ciò che originariamente era una iniziazione effettiva finì col limitarsi ad avere solo il valore di una iniziazione virtuale. In tutto ciò vi è un errore che ci sembra abbastanza evidente: l’iniziazione, così come abbiamo spiegato a più riprese, conferisce effettivamente, a coloro che la ricevono, un carattere acquisito una volta per tutte e che è veramente incancellabile, ma questa nozione della permanenza del carattere iniziatico si applica agli esseri umani che lo possiedono e non ai riti o all’azione dell’influenza spirituale a cui questi ultimi sono destinati a servire da veicolo; è assolutamente ingiustificato il volerla trasporre da un caso all’altro, cosa che equivarrebbe in realtà ad attribuirle un significato del tutto diverso, e noi siamo certi di non aver mai detto nulla che possa aver dato luogo ad una simile confusione. A sostegno di questa obiezione, si fa valere il fatto che l’azione esercitantesi a mezzo dei sacramenti cristiani è riferita allo Spirito Santo, cosa che è perfettamente esatta, ma del tutto fuori questione. Per altro, è ugualmente vero che l’influenza spirituale, sia essa designata in questo modo, in conformità col linguaggio cristiano, o in qualunque altro, a seconda della terminologia propria di tale o tal’altra tradizione, è per sua natura essenzialmente trascendente e sopraindividuale, poiché se così non fosse non è tanto di un’influenza spirituale che si tratterebbe, quanto di una semplice influenza psichica. Ma, fermo restando tutto ciò, cos’è che potrebbe impedire che la medesima influenza, o un’altra della stessa natura, agisca secondo modalità differenti ed in domini pur essi differenti? Ed inoltre, dal momento che questa influenza è di ordine trascendente, anche i suoi effetti devono esserlo necessariamente in ogni circostanza [Facciamo incidentalmente notare che questo comporterebbe, di conseguenza. la interdizione alle influenze spirituali della produzione di effetti che riguardano il semplice ordine corporale, come, per esempio, le guarigioni miracolose]? Non si capisce affatto perché dovrebbe essere così, ed anzi noi siamo certi del contrario; in effetti, abbiamo sempre avuto la massima cura nell’indicare che un’influenza spirituale interviene nei riti exoterici così come nei riti iniziatici, ma è ovvio che gli effetti da essa prodotti non potrebbero essere minimamente dello stesso ordine in entrambi i casi, pena l’annullamento della distinzione stessa fra i due domini [Se l’azione dello Spirito Santo si esercita solo nel dominio esoterico, poiché esso è il solo veramente trascendente, chiediamo ai nostri contraddittori, che sono cattolici, cosa bisogna allora pensare della dottrina secondo la quale Egli interviene nella formulazione dei dogmi, i più manifestamente exoterici]. Non comprendiamo inoltre perché sarebbe inammissibile che l’influenza che opera per mezzo dei sacramenti cristiani, dopo aver agito in un primo tempo nell’ordine iniziatico, abbia poi, in presenza di circostanze diverse e per le ragioni da esse derivanti, fatto intervenire la sua azione nel semplice dominio religioso ed exoterico, di modo che, da allora, i suoi effetti si siano limitati ad alcune possibilità di ordine esclusivamente individuale e aventi come fine la «salvezza»; e tutto ciò pur conservando, in quanto alle apparenze esterne, gli stessi supporti rituali, dal momento che questi erano di istituzione cristica e che quindi senza di essi non si sarebbe potuto trattare di una tradizione propriamente cristiana. In realtà è questo che si è verificato e, di conseguenza, allo stato attuale delle cose ed anche a partire da una certa epoca ben più lontana, non è più possibile considerare, in maniera alcuna, i riti cristiani come dei riti a carattere iniziatico; e su questo punto pensiamo che sia necessario insistere con maggiore precisione. Dobbiamo però far notare che, in realtà, è presente una certa improprietà di linguaggio allorché si dice che essi abbiano «perduto» questo carattere, come se questo fatto fosse avvenuto in maniera puramente accidentale. In verità, noi pensiamo che, al contrario, si sia trattato di un adattamento, il quale, malgrado le spiacevoli conseguenze venutesi a determinare inevitabilmente sotto certi aspetti, fu pienamente giustificato ed anche necessario, date le circostanze di tempo e di luogo. Se si considerano le condizioni del mondo occidentale, cioè dell’insieme dei paesi allora compresi nell’Impero romano, qual era all’epoca di cui si tratta, ci si può facilmente rendere conto che se il Cristianesimo non fosse «disceso» nel dominio exoterico, quel mondo, nel suo insieme, sarebbe rimasto ben presto sprovvisto di ogni tradizione, dal momento che quelle esistenti allora, ed in particolare la tradizione greco-romana che naturalmente era divenuta la predominante, erano giunte ad uno stato di estrema degenerescenza, la quale stava a significare che il loro ciclo di esistenza era lì per terminare [Sia ben chiaro che quando parliamo del mondo occidentale nel suo insieme, facciamo eccezione per una élite che non solo era in grado di comprendere ancora la propria tradizione, dal punto di vista esteriore, ma continuava a ricevere l’iniziazione ai misteri; il tal modo la tradizione avrebbe potuto ancora conservarsi, per un periodo più o meno lungo, entro un ambito sempre più ristretto; ma tutto ciò esula dalla questione che stiamo considerando adesso, poiché qui si tratta della generalità degli Occidentali ed è per essi che il Cristianesimo fu costretto a prendere il posto delle antiche forme tradizionali, proprio nel momento in cui queste, per la generalità degli Occidentali, finirono col diventare solo delle «superstizioni», nel senso etimologico del termine]. Questa discesa, lo ribadiamo, non fu dunque per niente un fatto accidentale o una deviazione, essa, al contrario, dev’essere considerata come avente un carattere veramente «provvidenziale», poiché impedì che l’Occidente piombasse allora in uno stato che, in definitiva, potrebbe essere paragonabile a quello in cui si trova attualmente. D’altronde, non era ancora giunto il momento nel quale doveva prodursi una perdita generale della tradizione, proprio come si verifica nei tempi moderni; era dunque necessario che si operasse un «raddrizzamento», e solo il Cristianesimo poteva farlo, ma a condizione di rinunciare al carattere esoterico e «riservato» che aveva all’origine [Sotto questo profilo si potrebbe dire che il passaggio dall’esoterismo all’exoterismo costituì, in questo caso, un vero «sacrificio», cosa che d’altronde è vera per ogni discesa dello spirito]; in effetti un tale «raddrizzamento» non solo era benefico per l’umanità occidentale, cosa fin troppo evidente per insistervi ulteriormente, ma era al tempo stesso in perfetto accordo con le stesse leggi cicliche, come lo è necessariamente ogni azione «provvidenziale» che interviene nel corso della storia. Probabilmente sarebbe impossibile assegnare una data precisa a questo cambiamento, che fece del Cristianesimo una religione, nel senso proprio del termine, ed una forma tradizionale rivolta a tutti indistintamente, ma, in ogni caso, è certo che fosse già un fatto compiuto all’epoca di Costantino e del Concilio di Nicea, tanto che quest’ultimo non ebbe che da «sanzionarlo», se così si può dire, inaugurando l’era delle formulazioni «dogmatiche», destinate a costituire una presentazione puramente exoterica della dottrina [Nello stesso tempo, la «conversione» di Costantino implicò, a mezzo di un atto in qualche modo ufficiale dell’autorità imperiale, il riconoscimento del fatto che la tradizione greco-romana doveva ormai essere considerata estinta, benché, naturalmente e per molto tempo ancora, continuassero ad esisterne dei resti che via via degenerarono sempre più inevitabilmente fino alla loro definitiva scomparsa, e furono tali resti ad essere designati, un po’ più tardi, con il termine spregiativo di «paganesimo»]. D’altronde, ciò non poteva avvenire senza qualche inevitabile inconveniente, poiché il fatto di costringere in tal modo la dottrina entro formule nettamente definite e limitate, rendeva molto più difficile, anche a coloro che ne fossero realmente capaci, penetrarne il senso profondo; inoltre, le verità di ordine propriamente esoterico, che per loro stessa natura erano fuori dalla portata dei più, ormai potevano essere presentate solo come dei «misteri», nel senso che questo termine ha assunto volgarmente, vale a dire che agli occhi dell’uomo comune non dovevano tardare ad apparire come qualcosa impossibile da comprendere e perfino proibito cercare di approfondire. Tuttavia, questi inconvenienti non erano tali da potersi opporre alla costituzione del Cristianesimo in una forma tradizionale exoterica o da inficiarne la legittimità, dato l’immenso vantaggio che doveva derivarne al mondo occidentale, nei termini in cui abbiamo detto; del resto, se il Cristianesimo, come tale, cessava per questo di essere iniziatico, rimaneva ancora la possibilità che sussistesse al suo interno una specifica iniziazione cristiana, riservata a quella élite che non poteva attenersi al solo punto di vista exoterico e contenersi entro i limiti ad esso inerenti. Ma questo è un altro dei punti che esamineremo più avanti. Peraltro, è da notare che questo cambiamento del carattere essenziale, e si potrebbe dire della natura stessa del Cristianesimo, spiega perfettamente, come dicevamo all’inizio, sia il fatto che tutto quanto lo avesse preceduto sia stato volontariamente avvolto nella oscurità, sia che non poteva essere altrimenti. È evidente, infatti che la natura del Cristianesimo originario, in quanto essenzialmente esoterica ed iniziatica, doveva restare del tutto nascosta a coloro che venivano ammessi nel Cristianesimo divenuto exoterico; quindi, tutto ciò che avrebbe potuto far conoscere, od anche solo far supporre, cosa esso fosse stato realmente ai suoi esordi, doveva essere avvolto, per costoro, in un velo impenetrabile. Beninteso, non spetta a noi individuare i mezzi con cui poté essere raggiunto un tale risultato, sarebbe piuttosto compito degli storici, se tuttavia riuscissero a porsi un simile problema, il quale, d’altra parte, apparirebbe loro come pressochè insolubile, non potendo applicarvi i loro metodi abituali e non potendo riferirsi a dei «documenti» che, chiaramente, in questo caso non potrebbero neanche esistere; ciò che qui ci interessa è la sola constatazione del fatto e la comprensione della sua vera ragione. Aggiungeremo solamente che, date le condizioni che abbiamo esposte, e contrariamente a ciò che potrebbero pensarne i cultori delle spiegazioni razionali, le quali sono sempre delle spiegazioni superficiali e «semplicistiche», non si può attribuire in maniera alcuna questo «oscuramento» delle origini, all’ignoranza, troppo manifestamente impossibile, di coloro che invece dovevano essere tanto più coscienti della trasformazione del Cristianesimo per quanto essi stessi vi presero parte in maniera più o meno diretta; né si può pretendere, secondo un pregiudizio assai diffuso fra i moderni, i quali prestano troppo facilmente agli altri la loro stessa mentalità, che si sia trattato di una manovra «politica» ed interessata da parte dei suddetti, dalla quale peraltro non vediamo bene quale profitto avrebbero potuto trarre effettivamente; la verità è, invece, che tutto ciò fu rigorosamente imposto dalla natura stessa delle cose, al fine di mantenere, in conformità con l’ortodossia tradizionale, la distinzione profonda fra i due domini, exoterico ed esoterico [Altrove, abbiamo fatto notare che la confusione fra questi due domini è una delle cause che, più frequentemente, genera le «sette» eterodosse, ed è fuori da ogni dubbio, infatti, che fra le antiche eresie cristiane ve ne sono un certo numero che ebbero proprio una tale origine; questo ci aiuta a meglio comprendere le precauzioni che furono prese, nei limiti del possibile, per evitare una tale confusione, e delle quali, da questo punto di vista, non si potrebbe minimamente contestare l’efficacia; anche se, da un’altra prospettiva, si è tentati di rimpiangere l’effetto secondario che esse hanno comportato, nel produrre delle difficoltà pressochè insormontabili per uno studio approfondito e completo del Cristianesimo]. Alcuni forse potrebbero chiedersi che ne è stato, per un simile cambiamento, degli insegnamenti di Cristo, i quali costituiscono, per definizione stessa, il fondamento del Cristianesimo, e dai quali esso non avrebbe potuto scostarsi senza perdere il suo stesso nome; senza contare che non si intravede che cosa avrebbe potuto sostituirvisi senza comprometterne il carattere «non umano», in mancanza del quale non vi è più alcuna tradizione autentica. In realtà, questi insegnamenti non sono stati né toccati dal sopraggiunto cambiamento, né modificati in alcun modo nella loro «espressione letterale», e la permanenza del testo dei Vangeli e degli altri scritti del Nuovo Testamento che con tutta evidenza risalgono al primo periodo del Cristianesimo ne costituisce una prova sufficiente [Anche a voler ammettere, e non è il nostro caso, le presunte conclusioni della «critica» moderna, la quale, con delle intenzioni fin troppo chiaramente antitradizionali, si sforza di attribuire a questi scritti le date più «tardive» possibili, queste rimangono ancora sicuramente anteriori alla trasformazione di cui stiamo parlando]; ciò che è cambiato è solo la loro comprensione o, se si preferisce, la prospettiva con la quale essi sono considerati ed il significato loro attribuito di conseguenza; senza, d’altronde, che si possa dire che vi sia alcunché di falso o di illegittimo in codesto significato, poiché è ovvio che le stesse verità sono suscettibili di ricevere applicazione entro domini differenti, in virtù delle corrispondenze che esistono fra i diversi ordini della realtà. In effetti, vi sono dei precetti riguardanti in modo specifico coloro che seguono una via iniziatica, e quindi applicabili solo in un ambiente ristretto e, in certo modo, qualitativamente omogeneo, che divengono di fatto impraticabili allorché si volesse estenderli all’insieme della società umana: è questo che viene esplicitamente riconosciuto nel considerarli solo come dei «suggerimenti di perfezione», ai quali non si attribuisce alcun carattere obbligatorio [Non ci riferiamo agli abusi a cui talvolta ha potuto dar luogo questa sorta di restrizione o di «minimizzazione», ma pensiamo alle reali necessità di un adattamento ad un ambiente sociale che comprende individui il cui livello spirituale è quanto mai differente ed ineguale, ed ai quali, tuttavia, un exoterismo deve rivolgersi allo stesso titolo e senza nessuna eccezione]; ciò equivale a dire che ognuno è tenuto a seguire la via evangelica, non solo in ragione delle sue capacità, cosa del tutto ovvia, ma anche in funzione di ciò che gli permettono le circostanze nelle quali si viene a trovare; e, in effetti, questo è tutto quello che si può ragionevolmente esigere da coloro che non mirano a superare la semplice pratica exoterica [Questa pratica exoterica si potrebbe definire come un minimum necessario e sufficiente per assicurare la «salvezza», poiché questo è l’unico scopo al quale essa è effettivamente destinata]. D’altra parte, per ciò che concerne la dottrina propriamente detta, vi sono delle verità che possono essere comprese, contemporaneamente, sia exotericamente che esotericamente, a seconda dei significati riferentisi ai diversi gradi della realtà; mentre ve ne sono altre che si evincono esclusivamente dall’esoterismo e che non hanno alcuna corrispondenza al di fuori di esso; queste, come abbiamo già avuto modo di dire, divengono del tutto incomprensibili quando si tenta di trasferirle nel dominio exoterico, ed allora ci si deve necessariamente limitare ad esprimerle, puramente e semplicemente, sotto forma di enunciazioni «dogmatiche», senza mai cercare di dar loro la minima spiegazione; sono queste verità che costituiscono propriamente ciò che si è convenuto chiamare i «misteri» del Cristianesimo. In verità, l’essenza stessa di questi «misteri» sarebbe del tutto ingiustificata se non si ammettesse il carattere esoterico del cristianesimo originario; tenendone conto, invece, essa si configura come una conseguenza normale ed inevitabile della «esteriorizzazione» con la quale il Cristianesimo, pur conservando la stessa forma esteriore nella sua dottrina e nei suoi riti, è divenuto la tradizione exoterica e specificamente religiosa che conosciamo oggi.
***
Fra i riti cristiani o, più esattamente, fra i sacramenti, che ne costituiscono la parte essenziale, quelli che presentano la maggiore similitudine con i riti di iniziazione e che quindi devono essere considerati come un’«esteriorizzazione» di quest’ultimi, posto che all’origine avessero effettivamente un tale carattere, sono, naturalmente e come abbiamo già fatto notare altrove, quelli che possono essere ricevuti una sola volta: primo fra tutti il battesimo [Allorché parliamo di riti di iniziazione intendiamo riferirci a quelli che hanno proprio lo scopo di trasmettere l’influenza iniziatica; è chiaro che oltre a questi possono esistere degli altri riti iniziatici, riservati ad una élite che ha già ricevuto l’iniziazione: così, ad esempio, si può pensare che l’Eucarestia sia stata. originariamente, un rito iniziatico, ma non un rito di iniziazione]. Per mezzo suo il neofita veniva ammesso nella comunità cristiana e, in certo modo, «incorporato» in essa; e fintanto che questa fu un’organizzazione iniziatica, il battesimo dovette costituire evidentemente la prima iniziazione, vale a dire l’inizio dei «piccoli misteri»; d’altronde, il carattere di «seconda nascita» che esso ha conservato pur nella sua discesa entro il dominio exoterico, anche se con una diversa applicazione, sta chiaramente ad indicare proprio quanto abbiamo appena detto. Aggiungiamo subito, per non ritornarvi dopo, che la cresima sembra indicare l’accesso ad un grado superiore, e, molto verosimilmente, essa doveva corrispondere, all’inizio, all’acquisizione dei «piccoli misteri»; per quanto riguarda l’ordinazione, che attualmente conferisce solo la possibilità di esercitare alcune funzioni, essa non può rappresentare che la «esteriorizzazione» di una iniziazione sacerdotale, come tale riferita ai «grandi misteri». Per rendersi conto che, in quello che potrebbe chiamarsi il secondo stadio del Cristianesimo, i sacramenti non hanno più alcun carattere iniziatico e che, molto realisticamente, sono solo dei riti puramente exoterici, basta considerare, in definitiva, il caso del battesimo, poiché tutto il resto ne consegue direttamente. Malgrado l’«oscuramento» di cui abbiamo parlato, si sa, quantomeno, che alla origine per conferire il battesimo venivano adottate delle rigorose precauzioni, e coloro che lo dovevano ricevere venivano sottoposti ad una lunga preparazione. Attualmente, in certo qual modo, si verifica esattamente l’opposto e sembra che sia stato fatto il possibile per facilitare al massimo il ricevimento di questo sacramento, dal momento che esso, non solo è amministrato a tutti indistintamente, senza che venga posto alcun problema di qualificazione e di preparazione, ma può essere anche conferito validamente da chiunque, mentre invece gli altri sacramenti possono esserlo solo da coloro, preti e vescovi, che esercitano una determinata funzione rituale. Al pari del fatto che i bambini vengono battezzati il più presto possibile dal momento della nascita, cosa questa che esclude evidentemente l’idea di una qualunque preparazione, queste facilitazioni possono spiegarsi solo attraverso un cambiamento radicale sopravvenuto in relazione alla concezione stessa del battesimo, cambiamento a seguito del quale esso fu considerato come una condizione indispensabile per la «salvezza» e pertanto doveva essere assicurato al maggior numero possibile di individui; mentre invece originariamente si trattava di tutt’altra cosa. Una tale prospettiva, per cui la «salvezza», che è lo scopo ultimo di tutti i riti exoterici, è legata necessariamente all’ammissione nella Chiesa cristiana, non è in fondo che una conseguenza di quella sorta di «esclusivismo» che, inevitabilmente, è inerente al punto di vista di ogni exoterismo, come tale. Non riteniamo utile insistervi ulteriormente, poiché è chiarissimo che un rito conferito a dei neonati, senza neanche preoccuparsi minimamente di determinare le loro qualificazioni con un mezzo qualunque, non potrebbe avere il carattere ed il valore di una iniziazione, essendo stata ridotta, questa, ad una condizione d’esistenza puramente virtuale; comunque ritorneremo presto sulla questione della possibile sopravvivenza di una iniziazione virtuale per mezzo dei sacramenti cristiani. In maniera accessoria, segnaleremo ancora un punto che non è senza importanza: nel Cristianesimo, così com’è attualmente e contrariamente a quanto avveniva all’inizio, tutti i riti, senza eccezione, sono pubblici; chiunque può assistere, anche a quelli che sembrerebbero dover essere più particolarmente «riservati», come l’ordinazione di un prete o la consacrazione di un vescovo o, a maggior ragione, un battesimo o una cresima. Ora, sarebbe questa una cosa inammissibile se si trattasse di riti di iniziazione, i quali normalmente possono essere compiuti solo in presenza di coloro che hanno già ricevuto la stessa iniziazione [In seguito all’articolo sull’ordinazione buddhista che abbiamo citato precedentemente (si veda la nota), noi rivolgemmo ad A.K. Coomaraswarny una domanda relativa a questo argomento; egli ci ha confermato che questa ordinazione non era mai conferita se non in presenza dei soli membri del Sangha, rappresentati unicamente da coloro che erano già stati ordinati, con l’esclusione, non solo degli estranei al Buddhismo, ma anche degli aderenti «laici», i quali in definitiva non erano che degli associati «esterni»]; evidentemente, fra la pubblicità, da una parte, e l’esoterismo e l’iniziazione, dall’altra, vi è incompatibilità. Tuttavia, se riteniamo secondario questo argomento è perché, nel caso in cui non vi fossero altri elementi da considerare, si potrebbe pretendere che in questo caso si tratta di un abuso dovuto ad una certa degenerescenza, come è accaduto talvolta ad una qualche organizzazione iniziatica, senza che essa abbia, per questo, perduto il carattere suo proprio; ma abbiamo visto che, per l’esattezza, la discesa del Cristianesimo nell’ordine exoterico non dev’essere minimamente considerata come una degenerescenza; e, per altro verso, le ulteriori ragioni che esporremo basteranno pienamente a dimostrare che, in realtà, non può più esservi in esso alcuna iniziazione. Se vi fosse ancora un’iniziazione virtuale, come è stato prospettato da alcuni, nelle obiezioni che ci sono state rivolte, e se quindi coloro che ricevono i sacramenti cristiani, o anche solo il battesimo, non avrebbero più bisogno di ricercare una qualunque altra forma di iniziazione [In verità, temiamo fortemente che, per molte persone, sia questo il motivo principale che le spinge a volersi persuadere che i riti cristiani abbiano conservato un valore iniziatico; in fondo, esse vorrebbero esimersi da ogni collegamento iniziatico regolare e, nondimeno, vorrebbero poter pretendere di ottenere dei risultati in questo ordine; anche quando ammettono che siffatti risultati potrebbero solo essere delle eccezioni, date le attuali condizioni, ognuno di essi ritiene volentieri di poter essere annoverato come un’eccezione; e ovvio che in questo caso ci si trova al cospetto di una deplorevole illusione], come si potrebbe spiegare l’esistenza di organismi iniziatici specificamente cristiani, come ve ne sono stati incontestabilmente durante tutto il Medioevo, e quale sarebbe esattamente la loro ragion d’essere dal momento che i loro particolari riti sarebbero in qualche modo un doppione dei riti ordinari del Cristianesimo? Si dirà che quest’ultimi costituiscono o rappresentano solo una iniziazione ai «piccoli misteri», di modo che, per coloro che avrebbero voluto andare oltre, ed accedere ai «grandi misteri», si sarebbe resa necessaria la ricerca di un’altra iniziazione; ma, a parte il fatto che è parecchio inverosimile, per non dire di più, che tutti coloro che entrarono in quelle organizzazioni fossero pronti ad accostarsi a quest’ultimo dominio, vi è un fatto decisivo che recita contro una tale supposizione: ed è l’esistenza dell’ermetismo cristiano; per definizione stessa, l’ermetismo attiene precisamente ai «piccoli misteri»; per non parlare poi delle iniziazioni di mestiere che attengono ugualmente a questo dominio e che, anche nei casi in cui non possono essere indicate come specificamente cristiane, richiedevano nondimeno ai loro membri e negli ambienti cristiani, la pratica dell’exoterismo corrispondente. A questo punto è necessario prevenire un altro equivoco, poiché certuni potrebbero essere tentati di trarre, da quanto precede, una conclusione errata e potrebbero pensare che, se i sacramenti non hanno più alcun carattere iniziatico, ne deriva che essi non potrebbero mai avere degli effetti in quest’ordine, cosa alla quale non mancherebbero certo di opporre alcuni casi ove chiaramente appare che le cose sono andate diversamente; la verità è che i sacramenti non possono produrre tali effetti di per sé, dato che la loro efficacia è proprio limitata al dominio exoterico, tuttavia, a tal proposito, vi sono altre cose da prendere in considerazione. In effetti, ovunque esistono delle iniziazioni particolarmente attinenti ad una determinata forma tradizionale e che poggiano nel suo stesso exoterismo, coloro che hanno ricevuto una tale iniziazione possono, in qualche maniera, trasporre i riti exoterici in un altro ordine, nel senso che se ne possono servire come dei supporti per lo stesso lavoro iniziatico e quindi, per essi, gli effetti relativi non saranno più limitati al solo ordine exoterico, come lo sono per la generalità degli aderenti alla forma tradizionale in questione; ciò vale per il Cristianesimo come per ogni altra tradizione, dal momento che si abbia o che si ebbe una iniziazione propriamente cristiana. Solo che, sia ben chiaro, lungi dal dispensare da una regolare iniziazione o dal sostituirla, un tale uso iniziatico dei riti exoterici la presuppone, invece, in modo essenziale, come la condizione necessaria per la sua stessa possibilità, condizione che non potrebbe essere sostituita nemmeno dalle qualificazioni più eccezionali, e senza la quale tutto ciò che supera il livello ordinario potrebbe tutt’al più sfociare nel misticismo, vale a dire in qualcosa che, in realtà, attiene ancora al dominio dell’exoterismo religioso. Da quanto abbiamo appena detto si può facilmente comprendere cosa deve pensarsi, in realtà, di coloro che nel Medioevo lasciarono degli scritti di ispirazione chiaramente iniziatica e che oggi si ha generalmente il torto di considerare dei «mistici», dal momento che non si conosce più nient’altro di diverso, mentre invece costoro furono sicuramente qualcosa del tutto diverso. È assolutamente impensabile che si sia trattato di casi di iniziazione «spontanea», o di casi eccezionali in cui un’iniziazione virtuale rimasta collegata ai sacramenti si sia potuta mutare in iniziazione effettiva, dal momento che vi era ogni possibilità di collegamento normale con qualcuna delle organizzazioni iniziatiche regolari che esistevano a quell’epoca, spesso anche sotto la copertura di ordini religiosi ed al loro interno, benché non si confondessero in alcun modo con essi. Non possiamo continuare ulteriormente, per non estendere indefinitamente la presente esposizione, ma faremo notare che è proprio dal momento in cui queste iniziazioni cessarono di esistere, o quantomeno dall’essere sufficientemente accessibili per poter offrire ancora realmente queste possibilità di ricollegamento, che nacque il misticismo propriamente detto, di modo che le due cose si presentano strettamente connesse [Non vogliamo affermare che alcune forme di iniziazione cristiana non si siano conservate fino ad epoche successive anzi, abbiamo motivo di pensare che attualmente qualcosa sussista ancora, ma in ambienti talmente riservati che, di fatto, li si può considerare come praticamente inaccessibili; come diremo più avanti, può dirsi lo stesso per alcuni rami del Cristianesimo diversi dalla Chiesa latina]. Ciò comunque è valido per la Chiesa latina, mentre invece è estremamente interessante notare che nelle Chiese d’Oriente non si è mai avuto del misticismo, nel senso in cui lo si intende nel Cristianesimo occidentale a partire dal XVI secolo; un tale l’atto può far pensare che in quelle Chiese si è dovuta mantenere una certa iniziazione, del tipo di quelle di cui dicevamo prima, ed effettivamente è quello che si riscontra nell’esicasmo, il cui carattere realmente iniziatico non sembra possa esser messo in dubbio, anche se, qui come in molti altri casi, esso si sia più o meno affievolito nel corso dei tempi moderni, a causa della naturale conseguenza delle generali condizioni di quest’epoca, all’influenza della quale possono solo sfuggire le iniziazioni che sono pochissimo diffuse, sia perché lo sono sempre state, sia che abbiano deciso volontariamente di «chiudersi» più che mai, onde evitare ogni degenerazione. Nell’esicasmo, l’iniziazione propriamente detta è essenzialmente costituita dalla trasmissione regolare di certe formule, paragonabile esattamente alla comunicazione dei mantra nella tradizione indù e dei wird nelle turuq islamiche; è anche presente tutta una «tecnica» dell’evocazione, come mezzo proprio del lavoro interiore [A tal proposito è interessante notare che questa invocazione, in greco, è designata col termine mnemé, «memoria» o «ricordo», che è l’esatto equivalente dell’arabo dhikr], mezzo ben distinto dai riti cristiani exoterici, quantunque questo lavoro possa trovare in essi un punto d’appoggio, come abbiamo già spiegato. Dal momento che insieme alle formule prescritte viene trasmessa validamente l’influenza alla quale esse servono da veicolo, ciò implica naturalmente l’esistenza di una catena iniziatica ininterrotta, poiché evidentemente è possibile trasmettere solo quello che si è a sua volta ricevuto [Vi è da notare che fra gli interpreti moderni dell’esicasmo, ve ne sono molti che si sforzano di «minimizzare» l’importanza della sua componente propriamente «tecnica», sia perché questo corrisponde effettivamente alle loro tendenze, sia perché pensano che così facendo possono evitare certe critiche basate su una completa incomprensione delle cose iniziatiche; in ogni caso è questo un esempio di quell’impoverimento di cui parliamo così spesso]. Queste cose comunque possiamo solo limitarci a segnalarle sommariamente, ma il fatto che l’esicasmo, ai nostri giorni, sia ancora vivente ci fa pensare che sarebbe possibile trovare in questa direzione certi chiarimenti circa i caratteri ed i metodi di altre iniziazioni cristiane che sfortunatamente appartengono al passato. Per concludere, infine, possiamo dire che malgrado le origini iniziatiche del Cristianesimo, esso nelle sue attuali condizioni è sicuramente nient’altro che una religione, vale a dire una tradizione di ordine esclusivamente exoterico, ed in esso non esistono altre possibilità che quelle di tutti gli exoterismi. D’altronde, il Cristianesimo attuale non pretende di essere nient’altro giacche si pone un solo scopo: ottenere la salvezza. Naturalmente un’iniziazione può sovrapporsi e ciò potrebbe essere anche cosa normale perché la tradizione sia veramente completa, venendo a possedere così, effettivamente sia l’aspetto exoterico sia quello esoterico; ma questa iniziazione, quantomeno nella sua forma occidentale, in effetti attualmente non esiste più. D’altronde, sia chiaro che l’osservanza dei riti exoterici è pienamente sufficiente per ottenere la salvezza, e questo è già tanto, certamente, ed è anche tutto quello a cui può legittimamente aspirare, oggi più che mai, l’immensa maggioranza degli esseri umani; ma cosa dovranno fare, in simili condizioni, quelli per i quali, secondo un’espressione di alcuni mutacawwufin, «il Paradiso è ancora solo una prigione».
CAPITOLO TERZO
I GUARDIANI DELLA TERRA SANTA [Pubblicato su Le Voile d’Isis, Parigi, agosto-settembre 1929] {Simboli della scienza sacra – Cap. 11: I Custodi della Terra Santa}
Fra gli attributi degli Ordini cavallereschi, ed in particolare dei Templari, uno dei più conosciuti, anche se in generale non dei meglio compresi, è quello di «guardiani della Terra Santa». Sicuramente, se ci si attiene al significato più esteriore, si trova una immediata spiegazione di ciò nel nesso che esiste fra l’origine di questi Ordini e le Crociate, poiché per i Cristiani, come per gli Ebrei, sembra che la «Terra Santa» non indichi altro che la Palestina. Tuttavia, la questione diventa più complessa allorché si consideri che diverse organizzazioni orientali, di indubbio carattere iniziatico, come gli Assassini e i Drusi, avevano parimenti assunto lo stesso attributo di «guardiani della Terra Santa». Qui, in effetti, non può più trattarsi della Palestina; d’altronde, è da notare che queste organizzazioni presentano un gran numero di tratti in comune con gli Ordini cavallereschi occidentali e, per di più, alcune di esse sono state, anche in termini storici, in relazione con quest’ultimi. Cosa bisogna intendere, dunque, con il termine «Terra Santa» e a cosa corrisponde esattamente questo ruolo di «guardiani», il quale sembra collegato con un particolare tipo di iniziazione che è possibile chiamare «cavalleresca», dando a questo termine un’estensione più ampia di quanto si faccia ordinariamente, ma che comunque è ampiamente giustificato dalle analogie esistenti fra le differenti forme di cui stiamo trattando? Altrove, ed in particolare ne Il Re del Mondo, abbiamo indicato che l’espressione «Terra Santa» ha un certo numero di sinonimi: «Terra Pura», «Terra dei Santi», «Terra dei Beati», «Terra dei Viventi», «Terra d’Immortalità», e che queste designazioni equivalenti si riscontrano nelle tradizioni di tutti i popoli e che si applicano essenzialmente ad un centro spirituale la cui localizzazione in una determinata regione può essere intesa, a seconda dei casi, sia in senso letterale che simbolico, oppure in entrambi i sensi. Ogni «Terra Santa» è anche designata con espressioni come: «Centro del Mondo» o «Cuore del Mondo», e ciò richiede alcuni chiarimenti, poiché, quantunque diversamente applicate, queste designazioni uniformi potrebbero facilmente comportare delle confusioni. Se consideriamo, per esempio, la tradizione ebraica, vediamo che nel Sepher Ietsirah si parla del «Santo Palazzo» o «Palazzo Interiore» che è il vero «Centro del Mondo», nel senso cosmogonico; e vediamo anche che questo «Santo Palazzo» si riflette, nel mondo umano, nella residenza in un certo luogo della Shekinah, che è la «presenza reale» della Divinità [Si vedano i nostri articoli su Le Coeur du Monde dans la Kabbale hébraique e La Terre Sante et le Coeur du Monde, su Regnabit, luglio-agosto e settembre-ottobre 1926. Cfr. anche il cap. IV del Simbolismo della Croce]. Per il popolo di Israele, questa residenza della Shekinah era il Tabernacolo (Mishkan) il quale, per questo motivo ed in forza di questa presenza, era considerato il «Cuore del Mondo», poiché era effettivamente il centro spirituale della sua tradizione. D’altronde, questo centro non fu un luogo fisso fin dall’inizio; quando si tratta di un popolo nomade, come in questo caso, il suo centro spirituale deve spostarsi con esso, rimanendo tuttavia sempre identico nel corso degli spostamenti. «La residenza della Shekinah – dice Vulliaud – divenne fissa solo il giorno in cui fu costruito il Tempio, per il quale Davide aveva preparato l’oro, l’argento e tutto quanto sarebbe stato necessario a Salomone per compiere l’opera [È il caso di notare che le espressioni usate qui, ricordano l’assimilazione frequentemente stabilita fra la costruzione del tempio, considerata nel suo significato ideale, e la «Grande Opera» degli ermetisti]. Il Tabernacolo della Santità di Iehovah, la residenza della Shekinah, è il Santo dei Santi, che è il cuore del Tempio, che è a sua volta il Centro di Sion (Gerusalemme), come la santa Sion è il centro della Terra d’Israele e questa è il centro del mondo» [La Kabbale juive, Parigi, 1923, t. I, p. 509]. È facile notare che qui è presente una serie di estensioni graduali all’idea del centro, in funzione delle applicazioni successive che vengono fatte, di modo che l’appellativo di «Centro del Mondo» o di «Cuore del Mondo» è infine esteso all’intera Terra d’Israele in quanto viene considerata come la «Terra Santa»; occorre aggiungere che, nella stessa ottica, essa riceve anche, fra le altre denominazioni, quella di «Terra dei Viventi». Si parla della «Terra dei Viventi che comprende sette terre» e Vulliaud osserva che «questa Terra è Chanaan ove vi erano sette popoli» [La Kabbale juive, Parigi, 1923, t. II, p. 116], cosa che è esatta nel senso letterale, anche se è ugualmente possibile una interpretazione simbolica. Questa espressione di «Terra dei viventi» è un esatto sinonimo di «soggiorno di immortalità», e la liturgia cattolica la applica al soggiorno celeste degli eletti, che in effetti era rappresentato dalla Terra promessa, poiché Israele giungendo in essa doveva vedere la fine delle sue tribolazioni. Ancora, da un altro punto di vista, la Terra d’Israele, in quanto centro spirituale, era un’immagine del Cielo, poiché, secondo la tradizione giudaica, «tutto ciò che fanno gli Israeliti sulla terra è compiuto secondo i modelli di ciò che avviene nel mondo celeste» [La Kabbale juive, Parigi, 1923, t. I, p. 501]. Ciò che è detto qui per gli Israeliti può essere parimenti detto per tutti i popoli che sono in possesso di una tradizione veramente ortodossa; infatti, il popolo d’Israele non è il solo ad aver assimilato una sua terra al «Centro del Mondo» e ad averla considerata come un’immagine del Cielo, due idee che, del resto, sono in realtà una sola. L’uso dello stesso simbolismo si ritrova presso altri popoli che possiedono anch’essi una «Terra Santa», cioè un luogo ove era posto un centro spirituale che per essi aveva un ruolo paragonabile a quello del Tempio di Gerusalemme per gli Ebrei. Sotto questo profilo, la «Terra Santa» è l’equivalente dell’Omphalos, che era, anch’esso l’immagine visibile del «Centro del Mondo» per il popolo che abitava la regione in cui era posto [Si veda il nostro articolo su Les Pierres de Foudre, in Le Voile d’Isis, Parigi, maggio 1929, (oggi: Le Pietre del Fulmine, cap. XXV di Simboli della Scienza Sacra)]. Il simbolismo in questione si riscontra in particolare presso gli antichi Egizi; infatti, secondo Plutarco, «gli Egizi danno alla loro regione il nome di Chémia [Kémi, in egizio, significa «terra nera», designazione di cui si trova l’equivalente anche presso altri popoli, da questo termine è derivato quello di alchimia (ove al è l’articolo arabo), che originariamente designava la scienza ermetica, cioè la scienza sacerdotale dell’Egitto] e la paragonano ad un cuore» [Iside e Osiride, 33; (traduzione francese di Mario Meunier, Parigi, 1924)]. Il motivo addotto da questo autore è molto strano: «Questa regione è infatti calda e umida, compresa nella zona meridionale delle terre abitate, essa si estende a mezzogiorno, come nel corpo umano il cuore si trova a sinistra», poiché «gli Egizi considerano l’Oriente come il volto del mondo, il Nord come la destra e il Mezzogiorno come la sinistra» [Iside e Osiride, 32; – In India, invece, il Mezzogiorno è indicato come «la parte destra» (dakshina); ma nonostante le apparenze, si tratta della stessa cosa, poiché per parte destra bisogna intendere quella che si trova alla destra di chi guarda ad Oriente, ed inversamente, per chi è posto di fronte, diventa facile considerare la stessa parte del mondo come estendentesi alla sua sinistra, così come accade a due persone poste una di fronte all’altra]. Queste similitudini, in realtà, sono molto superficiali e la vera ragione dev’essere tutt’altra, poiché lo stesso raffronto con il cuore è stato ugualmente applicato a tutte le terre alle quali veniva attribuito un carattere sacro e «centrale», in senso spirituale, al di la della loro posizione geografica. D’altronde, secondo lo stesso Plutarco, il cuore mentre rappresentava l’Egitto, al tempo stesso rappresentava il Cielo: «Gli Egizi – egli dice – raffigurano il Cielo, che non potrebbe invecchiare perché è eterno, con un cuore posto su un braciere la cui fiamma ne alimenta l’ardore» [Iside e Osiride, 10; – Si noterà che questo simbolo, con il significato che qui gli è dato, sembra poter essere accostato a quello della fenice]. Cosicché il cuore è, ad un tempo, il geroglifico dell’Egitto e quello del Cielo, tanto più se si considera che è anche raffigurato con un vaso, il quale è poi lo stesso di quello che le leggende del Medioevo occidentale dovevano indicare col nome di «Santo Graal». Da queste considerazioni si può concludere che vi sono tante «Terre Sante» particolari, per quante sono le forme tradizionali regolari poiché esse ne rappresentano i centri spirituali corrispondenti; ma il motivo per cui lo stesso simbolismo si applica uniformemente a tutte le «TerreSante» è che questi centri spirituali hanno tutti un’analoga costituzione, spesso fin nei minimi particolari, poiché essi sono altrettante immagini di uno stesso centro unico e supremo, che è, esso solo, il vero «Centro del Mondo», ed è da esso che tutti gli altri traggono i loro attributi, in quanto partecipano della sua natura per mezzo di una comunicazione diretta. nella quale trova fondamento l’ortodossia tradizionale; mentre, al tempo stesso, essi lo rappresentano effettivamente, in maniera più o meno esteriore, in determinati tempi e luoghi. In altri termini, esiste una «Terra Santa» per eccellenza, prototipo di tutte le altre; centro spirituale a cui sono subordinati tutti gli altri centri; sede della Tradizione primordiale da cui tutte le tradizioni particolari sono derivate per adattamento a tali o tal’altre condizioni definite, quali quelle di un popolo o di un’epoca. Questa «Terra Santa» per eccellenza è la «contrada suprema», secondo il significato del termine sanscrito Paradesha, da cui i Caldei hanno derivato il Pardes e gli Occidentali il Paradiso; essa è in effetti il «Paradiso terrestre», che è esattamente il punto di partenza di tutte le tradizioni, avente al suo centro la fonte unica da cui si dipartono i quattro fiumi che scorrono verso i quattro punti cardinali [Questa fonte è identica alla «fontana d’insegnamento», alla quale abbiamo più volte fatto allusione (si veda il cap. IV); ed è anche il «soggiorno d’immortalità», come ci se ne può facilmente rendere conto dai primi capitoli della Genesi [Ciò è possibile perché la «fontana d’insegnamento» è identica alla «fontana della giovinezza» (fons juventutis), dal momento che colui che vi si abbevera è liberato dalla condizione temporale; d’altronde, essa è posta ai piedi dell’«Albero della Vita» (si veda il nostro studio su «Le Langage secret de Dante et des Fidèles d’Amour» su Le Voile d’Isis, febbraio 1929 (Qui come cap. IV), e le sue acque si identificano, in modo evidente, con l’«elisir di lunga vita» degli ermetisti (per i quali l’idea di «longevità» ha lo stesso significato che nelle tradizioni orientali) o con la «bevanda d’immortalità» di cui si parla dappertutto sotto nomi diversi]. Non possiamo ritornare qui su tutte le questioni riguardanti il centro supremo, che abbiamo già trattato altrove, più o meno esaurientemente: la sua conservazione, in una maniera più o meno nascosta, a seconda dei periodi, dall’inizio alla fine del ciclo, cioè dal «Paradiso terrestre» fino alla «Gerusalemme celeste» che ne rappresentano le due fasi estreme; i molteplici nomi con i quali è indicato, come Tula, Luz, Salem, Agartha; i diversi simboli che lo raffigurano, come la montagna, la caverna, l’isola e molti altri ancora, che in maggioranza hanno una relazione immediata col simbolismo del «Polo» o dell’«Asse del Mondo». Qui, a queste raffigurazioni, possiamo aggiungere quelle che ne fanno una città, una roccaforte, un tempio o un palazzo, a seconda dell’aspetto sotto cui lo si considera in maniera più particolare; e con l’occasione, ricordiamo anche, oltre al Tempio di Salomone che si ricollega più direttamente al presente argomento, la triplice cinta di cui abbiamo parlato recentemente come di una rappresentazione della gerarchia iniziatica di certi centri tradizionali [Si veda il nostro articolo su La Triple Enceinte Druidique, ne Le Voile d’Isis, Parigi, giugno 1929 (oggi: La Triplice Cinta druidica, cap. X di Simboli della Scienza Sacra); in esso abbiamo proprio segnalato il rapporto esistente fra questa figura, nelle sue due forme circolare e quadrata, ed il simbolismo del «Paradiso terrestre» e della «Gerusalemme celeste» (Per i vari simboli, qui solamente richiamati da R. Guénon, si veda in particolare: Simboli della Scienza Sacra).]; nonché il misterioso labirinto che, sotto una forma più complessa, si ricollega ad una concezione similare, con la differenza che, nel suo caso, viene soprattutto evidenziata l’idea di un «cammino difficoltoso» verso il centro nascosto [Il labirinto di Creta era il palazzo di Minosse (Minos), nome identico a quello di Manu, con cui si designa il Legislatore primordiale. D’altra parte, da quanto diciamo qui, si può comprendere il motivo per cui, nel Medioevo, percorrere il labirinto tracciato sul pavimento di alcune chiese era considerato come sostitutivo del pellegrinaggio in terra Santa, per chi non fosse in condizione di compierlo; occorre ricordare che il pellegrinaggio è precisamente una delle figurazioni dell’iniziazione, di modo che il «pellegrinaggio in Terra Santa» è, in senso esoterico, la stessa cosa della «ricerca della Parola perduta» o della «cerca del Santo Graal»]. A questo punto dobbiamo aggiungere che il simbolismo della «Terra Santa» ha un duplice significato: che la si riferisca al Centro supremo o ad un centro subordinato, essa rappresenta non solo questo stesso centro ma per associazione, d’altronde del tutto naturale, anche la tradizione che da esso emana o che in esso è conservata, vale a dire, nel primo caso la Tradizione primordiale, e nel secondo una certa particolare forma tradizionale [Analogicamente, dal punto di vista cosmogonico, il «Centro del Mondo» è il punto originario da cui proferisce il Verbo creatore ed è altresì lo stesso Verbo]. Questo duplice significato si ritrova parallelamente, ed in maniera molto netta, nel simbolismo del «Santo Graal», che è, ad un tempo, un vaso (grasale) ed un libro (gradale o graduale); quest’ultimo aspetto indica chiaramente la tradizione, così come l’altro concerne più direttamente lo stato corrispondente al possesso effettivo di questa tradizione, e cioè lo «stato edenico» allorché si tratta della Tradizione primordiale; e colui che è pervenuto ad un tale stato è, per ciò stesso, reintegrato nel Pardes, per cui è possibile dire che la sua dimora è ormai nel «Centro del Mondo» [A tal proposito, è importante ricordare che in tutte le tradizioni, i luoghi simboleggiano essenzialmente gli stati. D’altra parte, facciamo notare che vi è un’evidente parentela fra il simbolo del vaso o della coppa e quello della fontana, di cui abbiamo parlato prima, ed abbiamo anche visto come, per gli Egizi, il vaso fosse il geroglifico del cuore, centro vitale dell’essere. Ricordiamo infine quello che abbiamo già detto in altre occasioni a proposito del vino, come sostitutivo del Soma vedico e come simbolo della dottrina nascosta; in tutto ciò, sotto una forma o l’altra, si tratta sempre della «bevanda d’immortalità» e della restaurazione dello «stato primordiale»]. Non è senza motivo che accostiamo qui questi due simbolismi, giacché la loro stretta similitudine dimostra che quando si parla della «cavalleria del Santo Graal» o dei «guardiani della Terra Santa», con queste due espressioni bisogna intendere esattamente la stessa cosa. Rimane da spiegare, nei limiti del possibile, in che consista propriamente la funzione di questi «guardiani» funzione che fu, in particolare, quella dei Templari [Saint-Yves d’Alveydre, per indicare i «guardiani» del Centro supremo, usa l’espressione «Templari dell’Agartha»; le considerazioni che esporremo mostreranno l’esattezza di questa espressione, di cui lo stesso autore, forse, non aveva colto pienamente il significato]. Per comprenderne bene il significato, occorre distinguere tra i detentori della tradizione, che hanno la funzione di conservarla e di trasmetterla, e coloro che, per gradi diversi, ne ricevono solamente una comunicazione e, potremmo dire, una partecipazione. I primi, che sono i depositari ed i dispensatori della dottrina, rimangono alla fonte, che è propriamente il centro stesso; da qui la dottrina si comunica e si distribuisce gerarchicamente ai diversi gradi iniziatici, secondo le correnti rappresentate dai fiumi del Pardes, oppure, se ci si vuoi riferire alla figurazione che abbiamo esaminato [Si veda la nota 14 {sulla Tripla cinta}], secondo i canali che, dall’interno verso l’esterno, collegano fra loro le cinte successive che corrispondono a questi diversi gradi. Tutti coloro che partecipano della tradizione, dunque, non sono pervenuti allo stesso grado, né svolgono la stessa funzione. È altresì necessario distinguere fra queste due cose, le quali, benché generalmente corrispondano in una certa misura, non sono tuttavia strettamente solidali, poiché può accadere che un uomo sia intellettualmente qualificato per raggiungere i gradi più elevati ma non per questo sia adatto a svolgere tutte le funzioni presenti nell’organizzazione iniziatica. Qui noi prenderemo in considerazione solo le funzioni e, da questo punto di vista, diciamo che i «guardiani» rimangono al limite del centro spirituale, inteso nel senso più ampio, o all’ultima cinta tramite la quale questo centro è, nel contempo, separato ed in contatto col «mondo esterno». Di conseguenza, questi «guardiani» hanno una doppia funzione: per un verso sono propriamente i difensori della «Terra Santa», nel senso che ne interdicono l’accesso a coloro che non possiedono le qualificazioni richieste per potervi accedere, costituendo così ciò che noi abbiamo chiamato la sua «copertura esterna», nel senso che essi la nascondono agli sguardi profani; per l’altro verso essi assicurano, tuttavia, alcune regolari relazioni con l’esterno, così come spiegheremo più avanti. È evidente che il ruolo di difensori e, per esprimersi nel linguaggio della tradizione indù, una funzione da Kshatriya, e precisamente ogni iniziazione «cavalleresca» è essenzialmente adattata alla natura propria degli uomini che appartengono alla casta guerriera, cioè degli Kshatriya. È da ciò che derivano i caratteri speciali di questa iniziazione, il particolare simbolismo che essa usa e, in modo peculiare, l’intervento di un elemento affettivo, indicato in modo esplicito con il termine «Amore»; ci siamo già sufficientemente spiegati su tale argomento, tanto da poterci esimere dal farlo qui [Si veda il successivo cap. V]. Ma, nel caso dei Templari vi è qualcosa di più da prendere in considerazione: benché la loro iniziazione fosse essenzialmente «cavalleresca», come conveniva alla loro natura ed alla loro funzione, essi avevano un duplice carattere, ad un tempo militare e religioso, ed è così che doveva essere se essi erano, come per diverse ragioni noi pensiamo dei «guardiani» del Centro supremo, ove l’autorità spirituale ed il potere temporale sono riuniti nel loro comune principio, ed ove l’impronta di tale riunione viene trasmessa a tutto ciò che gli è direttamente collegato. Nel mondo occidentale, ove lo spirituale ha assunto una forma specificamente religiosa, i veri «guardiani della Terra Santa», fino a quando ebbero un’esistenza in qualche modo «ufficiale»dovevano essere dei cavalieri che fossero al tempo stesso dei monaci, ed è questo che in effetti furono i Templari. Ciò ci conduce direttamente alla seconda funzione dei «guardiani» del centro supremo, funzione che consiste, come abbiamo detto, nell’assicurare alcune relazioni esterne, e soprattutto nel mantenere i legami fra la Tradizione primordiale e le tradizioni secondarie e derivate. Perché ciò sia possibile è necessario che, per ogni forma tradizionale, si abbia una o più organizzazioni costituite in base a questa stessa forma, secondo tutte le apparenze, ma composte da uomini che abbiano coscienza di ciò che è al di là di tutte le forme, vale a dire della dottrina unica che è la fonte e l’essenza di tutte le altre, la quale non è nient’altro che la Tradizione primordiale. In un mondo a tradizione giudeo-cristiana una tale organizzazione doveva, in un modo del tutto naturale, avere per simbolo il Tempio di Salomone; questo, d’altronde, avendo cessato d’esistere materialmente ormai da lungo tempo, non poteva avere allora che un significato del tutto ideale, essendo solo un’immagine del Centro supremo, come lo è ogni centro spirituale subordinato; la stessa etimologia del nome Gerusalemme indica abbastanza chiaramente che essa è solo un’immagine visibile della misteriosa Salem di Mechisedec. Se tale fu il carattere dei Templari, per ricoprire il ruolo loro assegnato, che era relativo ad una determinata tradizione, quella dell’Occidente, essi dovevano rimanere collegati esternamente alla forma di questa tradizione, ma, al tempo stesso, l’aver coscienza della vera unità dottrinale li rendeva capaci di comunicare con i rappresentanti di altre tradizioni [Ciò si riferisce a quello che è stato chiamato simbolicamente il «dono delle lingue»; su tale argomento rimandiamo al nostro articolo contenuto nel numero speciale di Le Voile d’Isis dedicato ai Rosacroce. (Inserito come cap. XXXVII in Considerazioni sulla Via Iniziatica)]: è questo che spiega le loro relazioni con certe organizzazioni orientali e soprattutto, com’è naturale, con quelle che altrove svolgevano un ruolo simile al loro. Ciò posto, si può comprendere, peraltro, come la distruzione dell’Ordine del Tempio abbia comportato per l’Occidente la rottura delle regolari relazioni col «Centro del Mondo»; ed è proprio al XIV secolo che occorre far risalire la deviazione che inevitabilmente doveva comportare una tale rottura, deviazione che gradualmente è andata accentuandosi fino ai nostri giorni. Tuttavia, non è possibile affermare che ogni legame sia stato reciso d’un sol colpo; per molto tempo ancora fu possibile, in una certa misura, mantenere delle relazioni, ma solo in maniera nascosta, per mezzo di organizzazioni come la Fede Santa o i «Fedeli d’Amore», o come la «Massenia del Santo Graal» e senza dubbio molte altre ancora, tutte eredi dello spirito dell’Ordine del Tempio e per la maggior parte ad esso collegate a mezzo di una filiazione più o meno diretta. Coloro che conservarono vivo questo spirito e che ispirarono queste organizzazioni, senza mai costituire essi stessi alcun organismo definito, si chiamano Rosacroce; ma venne un giorno in cui gli stessi Rosacroce dovettero lasciare l’Occidente, le cui condizioni erano divenute tali da impedire che la loro azione potesse ancora esercitarsi, e si dice che a quel punto essi si ritirarono in Asia, riassorbiti in qualche modo nel Centro supremo di cui erano come un’emanazione. Per il mondo occidentale non vi è più una «Terra Santa» da custodire, poiché la via che conduce ad essa è ormai interamente smarrita; quanto tempo ancora durerà una tale situazione? Ed è possibile sperare che, prima o poi, la comunicazione possa essere ristabilita? Sono questi degli interrogativi ai quali non spetta a noi dare una risposta: a parte il fatto che noi non vogliamo arrischiare alcuna predizione, la soluzione dipende solo dall’Occidente stesso, poiché solo ritornando alle normali condizioni e ritrovando lo spirito proprio della sua tradizione, se ne ha ancora in sé la possibilità, l’Occidente potrà vedere riaprirsi la via che conduce al «Centro del Mondo».
CAPITOLO QUARTO
IL LINGUAGGIO SEGRETO DI DANTE E DEI «FEDELI D’AMORE» [Articolo pubblicato su Le Voile d’Isis, febbraio 1929]
Con il titolo: Il Linguaggio Segreto di Dante e dei «Fedeli d’Amore» [Roma, casa Ed. Optima, 1928], Luigi Valli, a cui si debbono parecchi studi sul significato dell’opera di Dante, ha pubblicato un nuovo lavoro che è troppo importante perché noi ci si accontenti di segnalarlo con una semplice nota bibliografica. La tesi lì sostenuta può essere riassunta brevemente così: le diverse «donne» celebrate dai poeti si riallacciano alla misteriosa organizzazione dei «Fedeli d’Amore», e per Dante, Guido Cavalcanti ed altri loro contemporanei, fino a Boccaccio ed a Petrarca, non sono affatto delle donne realmente vissute su questa terra ma, con i nomi più diversi, sono tutte una sola e medesima «Donna» simbolica, che rappresenta l’Intelligenza trascendente (la Madonna Intelligenza di Dino Compagni) o la Saggezza Divina. In appoggio a questa tesi l’autore presenta una documentazione formidabile ed una serie di argomentazioni adattissime a colpire i più scettici: in particolare, egli dimostra che le poesie più {in}intelligibili, dal punto di vista letterale, diventano perfettamente chiare se si accetta l’ipotesi dell’esistenza di un «gergo» o linguaggio convenzionale, del quale egli è riuscito a tradurre i termini principali; e fra altri casi simili egli ricorda quello dei Sufi persiani, i quali dissimulavano ugualmente dei significati similari sotto le apparenze di una semplice poesia amorosa. È impossibile riassumere tutte le argomentazioni, basate su dei dati precisi e che conferiscano al libro tutto il suo valore; a coloro che fossero interessati all’argomento possiamo solo consigliare di riferirsi direttamente al libro. A dire il vero, tutto questo ci era sempre apparso come un fatto evidente ed incontestabile, tuttavia ci rendiamo conto che una tale tesi ha bisogno di essere solidalmente sostenuta. In effetti, Valli prevede che le sue conclusioni saranno contestate da diverse categorie di avversari: innanzi tutto dalla sedicente critica «positiva» (che egli ha il torto di qualificare come «tradizionale», quando invece essa è all’opposto dello spirito tradizionale); poi dallo spirito di parte, sia cattolico che anticattolico, che non potrà minimamente compiacersene; ed infine dalla critica «estetica» e dalla «retorica romantica» che, in fondo, non sono nient’altro di diverso di quello che si potrebbe chiamare spirito «letterario». Si tratta, insomma, di un ammasso di pregiudizi che si opporranno sempre fortemente alla ricerca del significato profondo di certe opere; ma, in presenza di lavori come questo del Valli, le persone di buona fede e libere da ogni partito preso potranno vedere facilmente da che parte sta la verità. Da parte nostra dobbiamo solo sollevare delle obiezioni circa alcune interpretazioni, ma esse non intaccano minimamente la tesi generale; del resto, l’autore non ha avuto la pretesa di offrire una soluzione definitiva a tutte le Con il titolo: Il Linguaggio Segreto di Dante e dei «Fedeli d’Amore» [Roma, casa Ed. Optima, 1928], Luigi Valli, a cui si debbono parecchi studi sul significato dell’opera di Dante, ha pubblicato un nuovo lavoro che è troppo importante perché noi ci si accontenti di segnalarlo con una semplice nota bibliografica. La tesi lì sostenuta può essere riassunta brevemente così: le diverse «donne» celebrate dai poeti si riallacciano alla misteriosa organizzazione dei «Fedeli d’Amore», e per Dante, Guido Cavalcanti ed altri loro contemporanei, fino a Boccaccio ed a Petrarca, non sono affatto delle donne realmente vissute su questa terra ma, con i nomi più diversi, sono tutte una sola e medesima «Donna» simbolica, che rappresenta l’Intelligenza trascendente (la Madonna Intelligenza di Dino Compagni) o la Saggezza Divina. In appoggio a questa tesi l’autore presenta una documentazione formidabile ed una serie di argomentazioni adattissime a colpire i più scettici: in particolare, egli dimostra che le poesie più {in}intelligibili, dal punto di vista letterale, diventano perfettamente chiare se si accetta l’ipotesi dell’esistenza di un «gergo» o linguaggio convenzionale, del quale egli è riuscito a tradurre i termini principali; e fra altri casi simili egli ricorda quello dei Sufi persiani, i quali dissimulavano ugualmente dei significati similari sotto le apparenze di una semplice poesia amorosa. È impossibile riassumere tutte le argomentazioni, basate su dei dati precisi e che conferiscano al libro tutto il suo valore; a coloro che fossero interessati all’argomento possiamo solo consigliare di riferirsi direttamente al libro. A dire il vero, tutto questo ci era sempre apparso come un fatto evidente ed incontestabile, tuttavia ci rendiamo conto che una tale tesi ha bisogno di essere solidalmente sostenuta. In effetti, Valli prevede che le sue conclusioni saranno contestate da diverse categorie di avversari: innanzi tutto dalla sedicente critica «positiva» (che egli ha il torto di qualificare come «tradizionale», quando invece essa è all’opposto dello spirito tradizionale); poi dallo spirito di parte, sia cattolico che anticattolico, che non potrà minimamente compiacersene; ed infine dalla critica «estetica» e dalla «retorica romantica» che, in fondo, non sono nient’altro di diverso di quello che si potrebbe chiamare spirito «letterario». Si tratta, insomma, di un ammasso di pregiudizi che si opporranno sempre fortemente alla ricerca del significato profondo di certe opere; ma, in presenza di lavori come questo del Valli, le persone di buona fede e libere da ogni partito preso potranno vedere facilmente da che parte sta la verità. Da parte nostra dobbiamo solo sollevare delle obiezioni circa alcune interpretazioni, ma esse non intaccano minimamente la tesi generale; del resto, l’autore non ha avuto la pretesa di offrire una soluzione definitiva a tutte le l’impiego continuo di termini come «setta» e «settario», i quali, allorché vengono usati per indicare un’organizzazione iniziatica (e non religiosa) e ciò che vi si riferisce, sono del tutto impropri e decisamente sgradevoli [Non è la stessa cosa per il termine «gergo», checché taluni ne possano pensare; questo, come abbiamo già indicato (Le Voile d’Isis ottobre 1928), era un termine «tecnico» prima di passare nel linguaggio volgare, ove ha assunto un significato negativo. Con l’occasione, facciamo notare che il termine «profano» è da noi parimenti impiegato sempre nel suo senso tecnico, che, beninteso, non ha niente di ingiurioso]; e ciò ci conduce direttamente al più grave difetto che abbiamo notato nell’opera di Valli. Questo difetto consiste nella costante confusione dei due punti di vista, «iniziatico» e «mistico», e nell’assimilazione ad una dottrina «religiosa» delle cose prese in esame, mentre invece l’esoterismo, anche quando prende come punto di partenza delle forme religiose (come nel caso dei Sufi e dei «Fedeli d’Amore»), appartiene in realtà ad un ordine del tutto diverso. Una tradizione veramente iniziatica non può essere «eterodossa», ed il qualificarla così (p. 393) significa invertire il rapporto normale e gerarchico che esiste fra l’interiore e l’esteriore. L’esoterismo non è contrario all’«ortodossia» (p. 104), anche se intesa semplicemente in senso religioso; esso è al di sopra o al di là del punto di vista religioso, e ciò, evidentemente, non è affatto la stessa cosa; ed in effetti, l’accusa ingiustificata di «eresia» fu spesso un comodo mezzo per sbarazzarsi di certa gente che poteva essere imbarazzante per tutt’altri motivi. Rossetti ed Aroux non hanno torto nel pensare che le espressioni teologiche di Dante nascondono qualcos’altro, ma sono in errore allorché credono che occorra interpretarle «a rovescio» (p. 389); l’esoterismo si sovrappone all’exoterismo, ma non vi si oppone, poiché non si trova al suo stesso piano, ed esso dà alle medesime verità un significato più profondo, trasponendole in un ordine superiore. Certo si constata che Amor è il rovescio di Roma [A titolo di curiosità, se si scrive questa semplice frase: «In Italia è Roma», e la si legge a rovescio, essa diventa: «Amore ai Latini»; il «caso» è talvolta di un’ingegnosità sorprendente!], ma non se ne può concludere, come si è voluto fare talvolta, che esso indichi qualcosa che è l’antitesi di Roma, bensì che è qualcosa di cui Roma è solo un riflesso o una immagine visibile, necessariamente invertita, come lo è l’immagine di un oggetto in uno specchio (ed è questa l’occasione per ricordare il «per speculum in aenigmate» di San Paolo). Per ciò che riguarda Rossetti ed Aroux, ed alcune riserve che è opportuno fare su certe loro interpretazioni, aggiungiamo che non è possibile dire che un metodo è «inaccettabile perché incontrollabile» (p. 389), senza rischiare di ricadere nei pregiudizi della critica «positiva»; perché allora bisognerebbe rigettare tutto ciò che si ottiene per conoscenza diretta e, in special modo, per mezzo della regolare comunicazione di un insegnamento tradizionale, il quale, in effetti, è incontrollabile… per i profani! [Bisogna proprio pensare che è molto difficile non lasciarsi influenzare dallo spirito dell’epoca: infatti, la qualificazione di certi libri biblici come «pseudo-salomonici» e «mistico-platonici» (p. 80) ci sembra proprio una spiacevole concessione all’esegesi moderna, cioè a quella stessa «critica positiva» contro la quale l’autore si leva a buona ragione]. La confusione fatta da Valli, fra esoterismo ed «eterodossia» è tanto più stupefacente se si pensa che egli ha quantomeno compreso, molto meglio dei suoi predecessori, che la dottrina dei «Fedeli d’Amore» non è affatto «anticattolica» (essa era invece, al pari di quella dei Rosacroce, rigorosamente «cattolica», nel vero senso della parola) e non aveva niente in comune con le correnti profane da cui sarebbe derivata la Riforma (pp. 79-80 e 409). Ma, dove ha visto il Valli che la Chiesa abbia fatto conoscere al volgo il senso profondo dei «misteri» (p. 101)? Al contrario, l’insegna così poco che si può dubitare che ne abbia conservato coscienza Essa stessa; ed è precisamente in questa «perdita dello spirito» che consisterebbe la «corruzione» già denunciata da Dante e dai suoi associati [La testa della Medusa, che trasforma gli uomini in «pietre» (parola che giuoca un ruolo molto importante nel linguaggio dei «Fedeli d’Amore»), rappresenta la corruzione della Saggezza; i suoi capelli (che secondo i Sufi simboleggiano i misteri divini) diventano dei serpenti, intesi naturalmente in senso negativo, poiché nel senso opposto il serpente è anche un simbolo della Saggezza stessa]. D’altronde, quand’essi parlavano di questa «corruzione», la più elementare prudenza esigeva che non lo facessero a chiare lettere, ma non se ne può concludere necessariamente che l’uso di una terminologia simbolica non ha altra ragion d’essere che la volontà di dissimulare il senso vero di una dottrina: vi sono delle cose che, per la loro stessa natura, possono essere espresse solo in questa forma; e questo aspetto del problema, che è della massima importanza, non sembra affatto che sia stato intravisto dall’autore. Vi è anche un terzo aspetto, in qualche modo intermedio, per il quale si tratta certo di prudenza, ma nell’interesse della stessa dottrina, e non più nell’interesse di coloro che la espongono; esso è quello a cui si riferisce, in particolare, il simbolo del vino presso i Sufi (il cui insegnamento, lo diciamo di sfuggita, può essere qualificato di «panteismo» solo per un errore tipicamente occidentale); nell’allusione a proposito di questo simbolo (pp. 72 e 104) il Valli non indica chiaramente che «vino» significa «mistero», cioè dottrina segreta o riservata, così come in ebraico iain e sod sono numericamente equivalenti e nell’esoterismo mussulmano il vino è la «bevanda dell’élite» che non può essere usata impunemente dagli uomini volgari [La proverbiale espressione «bere come un Templare», che il volgo ha inteso nel senso più grossolanamente letterale, trae sicuramente origine da qui: il «vino» che bevevano i Templari era lo stesso di quello bevuto dai Kabbalisti]. Ma torniamo alla confusione fra il punto di vista «mistico, e quello «iniziatico»: essa è solidale con la precedente, poiché è proprio la falsa assimilazione delle dottrine esoteriche al misticismo, il quale è relativo al dominio religioso, che conduce fino a porre sullo stesso piano esoterismo ed exoterismo, ed a volerli come in opposizione. Comprendiamo perfettamente, in questo caso, il perché di tale confusione: una tradizione «cavalleresca» (p. 146), per adattarsi alla natura propria degli uomini a cui è particolarmente destinata, comporta sempre la prevalenza di un principio che si configura come femminile (Madonna) [L’«intelletto attivo», rappresentato dalla Madonna, è il «raggio celeste» che costituisce il legame fra Dio e l’uomo e che conduce l’uomo a Dio (p. 54): esso è la Buddhi indù. Peraltro, occorre considerare che «Saggezza» e «Intelligenza» non sono esattamente la stessa cosa, si tratta di due aspetti complementari che vanno distinti (Hokmah e Binah nella Kabbala)], così come l’intervento di un elemento affettivo (Amore). L’accostamento fra una tale forma tradizionale e quella rappresentata dai Sufi persiani è del tutto esatta, ma occorre aggiungere che questi due casi sono lontani dall’essere i soli ove è presente il culto della «donna-divinità», cioè dell’aspetto femminile del Divino: lo si ritrova anche nell’India, ove questo aspetto è designato come la Shakti, equivalente per certi aspetti alla Shekinah ebraica, ed è opportuno notare che il culto della Shakti concerne soprattutto gli Kshatriya. Per l’esattezza, una tradizione «cavalleresca» non è altro che una forma tradizionale ad uso degli Kshatriya, ed è per questo che essa non è una via puramente intellettuale, come quella dei Brahmani; quest’ultima è la «via secca» degli alchimisti, mentre l’altra è la «via umida» [In un altro senso e secondo un’altra correlazione, queste due vie potrebbero essere anche quella degli iniziati in generale e quella dei mistici, ma quest’ultima è «irregolare» e non può essere considerata quando ci si attiene strettamente alla norma tradizionale], ove l’acqua simboleggia il femminile, come il fuoco simboleggia il maschile, corrispondendo, la prima all’emotività e la seconda all’intellettualità, le quali predominano rispettivamente nella natura degli Kshatriya e dei Brahmani. Ecco perché una tale tradizione può sembrare mistica, esteriormente, anche quando in effetti è iniziatica; tanto che si potrebbe anche pensare che il misticismo, nel senso ordinario del termine, è come un vestigio o una «sopravvivenza» di tale tradizione, vestigio rimasto, in una civiltà come l’occidentale, dopo la sparizione di ogni altra organizzazione tradizionale regolare. Il ruolo del principio femminile in certe forme tradizionali si constata anche nell’exoterismo cattolico, attraverso l’importanza che in esso è data al culto della Vergine. Valli sembra stupirsi nel vedere la Rosa Mystica figurare nelle litanie della Vergine (p. 393); tuttavia, in queste litanie, vi sono ben altri simboli propriamente iniziatici e sembrerebbe che egli non sospetti neanche che la loro applicazione è perfettamente giustificata dalle relazioni esistenti fra la Vergine, la Saggezza e la Shekinah [Bisogna anche ricordare che, in certi casi, gli stessi simboli rappresentano sia la Vergine che il Cristo; si tratta di un enigma degno di essere proposto alla sagacia dei ricercatori, e la cui soluzione risulterebbe dalla considerazione dei rapporti fra la Shekinah e Metatron]. A questo proposito notiamo anche che San Bernardo, di cui si conosce la stretta relazione con i Templari, si presentava come un «cavaliere della Vergine», che egli chiamava «mia donna», ed a lui si attribuisce l’origine stessa del vocabolo «Notre-Dame», che è pure Madonna e che, in uno dei suoi aspetti si identifica con la Saggezza, dunque con la stessa Madonna dei «Fedeli d’Amore»; ecco ancora un accostamento che l’autore non ha sospettato, come sembra non sospettare le ragioni per cui il mese di maggio è consacrato alla Vergine. Vi è una cosa che avrebbe dovuto indurre Valli a pensare che le dottrine in questione non hanno niente a che vedere col «misticismo»: ed è che egli stesso constata l’importanza quasi esclusiva che in esse è data alla «conoscenza» (pp. 421-422), cosa questa che è totalmente estranea al punto di vista mistico. D’altra parte, egli finisce solo col trarne delle conseguenze errate: l’importanza data alla «conoscenza» non è una speciale caratteristica dello «gnosticismo», ma è un carattere comune a tutti gli insegnamenti iniziatici, al di là della forma che essi possano assumere; la conoscenza è sempre lo scopo unico, e tutto il resto è solo un mezzo per pervenire ad essa. Bisogna guardarsi bene dal confondere «Gnosi», che significa «conoscenza», con «gnosticismo», nonostante quest’ultimo termine derivi evidentemente dal primo; d’altronde la denominazione di «gnosticismo» è assai vaga, ed in effetti sembra che sia applicata indistintamente a delle cose molto diverse [Valli dice che la «critica» apprezza poco i dati tradizionali degli «gnostici» contemporanei (p. 422); per una volta la «critica» ha ragione, poiché questi «neo-gnostici» non hanno mai ricevuto alcunché a mezzo di una qualunque trasmissione, e si tratta solo di un tentativo di «ricostruzione» fatto sulla base di documenti, d’altronde molto frammentari, che sono alla portata di tutti; si può ben credere alla testimonianza di chi ha avuto l’occasione di osservare queste cose da molto vicino e di conoscere quindi di cosa realmente si tratta]. Non bisogna lasciarsi imprigionare dalle forme esteriori, qualunque esse siano; i «Fedeli d’Amore» erano in grado di andare al di là di queste forme, ed eccone una prova: in una delle prime novelle del Decamerone di Boccaccio, Melchisedec afferma che tra il Giudaismo, il Cristianesimo e l’Islamismo, «nessuno sa quale sia la vera fede». Valli ha visto giusto interpretando questa affermazione nel senso che «la vera fede è nascosta fra gli aspetti esterni delle diverse credenze» (p. 433); ma quello che è da sottolineare in modo particolare, e che l’autore non ha notato, è che queste parole siano poste in bocca a Melchisedec, che è precisamente il rappresentante della tradizione unica, nascosta sotto tutte queste forme esteriori; e si tratta qui di qualcosa che dimostra a sufficienza come alcuni, in Occidente ed in quell’epoca, sapessero ancora che cos’è il vero «Centro del Mondo». Comunque sia, l’impiego di un linguaggio «affettivo», come è spesso quello dei «Fedeli d’Amore» è anch’esso qualcosa di esteriore da cui non bisogna farsi ingannare, esso può benissimo nascondere qualcosa di ben più profondo, ed in particolare, la parola «Amore», in virtù della trasposizione analogica, può significare tutt’altra cosa che il sentimento che esso indica ordinariamente. Questo senso profondo dell’«Amore», in connessione con le dottrine degli Ordini cavallereschi, potrebbe risultare, specialmente, dall’accostamento delle seguenti indicazioni: innanzitutto, le parole di San Giovanni: «Dio è Amore»; poi, il grido di guerra dei Templari: «Viva Dio Santo Amore»; ed infine, l’ultimo verso della Divina Commedia: «L’Amor che muove il Sole e l’altre stelle» [A proposito degli ordini cavallereschi, la «Chiesa giovannita» indica la riunione di tutti coloro che a qualunque titolo si riallacciano a ciò che nel Medioevo fu chiamato il «Regno del Prete Gianni», al quale abbiamo accennato nel nostro studio su Il Re del Mondo]. A questo proposito, un altro punto interessante è quello del rapporto che, nel simbolismo dei «Fedeli d’Amore», esiste fra l’«Amore» e la «Morte»; esso è un rapporto duplice, poiché la parola «Morte» ha essa stessa un duplice significato. Per un verso, fra l’«Amore» e la «Morte» vi è un accostamento e quasi un’associazione (p. 159), la seconda è intesa allora come «morte iniziatica»; e questo accostamento sembra si sia mantenuto in seno a quella corrente da cui sono nate, alla fine del Medioevo, le raffigurazioni della «danza macabra» [In un antico cimitero del XV secolo, abbiamo visto dei capitelli nelle cui sculture sono curiosamente riuniti gli attributi dell’Amore e della Morte]; per l’altro, vi è anche un’antitesi, fissata attraverso un altro punto di vista (p. 166), la quale si può spiegare, in parte, attraverso la stessa costituzione dei due termini: in entrambi è presente la radice mor, ma in a-mor essa è preceduta dalla a privativa, come nel sanscrito a-mara, a-mrita, di modo che «Amore» può interpretarsi come una sorta di equivalente geroglifico di «immortalità». Seguendo allora lo stesso senso, i «morti», in generale, possono essere considerati come i profani, mentre i «viventi», o coloro che hanno ottenuto l’«immortalità», sono gli iniziati; e qui è il caso di ricordare che l’espressione «Terra dei Viventi» è sinonimo di «Terra Santa» o «Terra dei Santi», «Terra Pura», ecc., mentre la stessa opposizione da noi indicata equivale, sotto questo profilo, a quella fra l’Inferno, che è il mondo profano, ed i Cieli, che sono i gradi della gerarchia iniziatica. Per quanto riguarda la «vera fede», di cui si parla continuamente, è essa che viene designata come Fede Santa, espressione che, al pari della parola Amore, si applica anche alla stessa organizzazione iniziatica. Questa Fede Santa, di cui Dante era Kadosch, è la fede dei «Fedeli d’Amore» ed è anche la Fede dei Santi, cioè l’Emunah dei Kadosch, così come abbiamo spiegato ne L’Esoterismo di Dante. Questa designazione degli iniziati come dei «Santi», di cui Kadosch è l’equivalente ebraico, si comprende perfettamente attraverso il significato dei «Cieli», così come l’abbiamo indicato precedentemente, poiché i Cieli sono, in effetti, descritti come il soggiorno dei santi; e tale designazione dev’essere accostata a molte altre analoghe, come Puri, Perfetti, Catari, Sufi, Ikhwan-es-Safa, ecc., tutte prese nello stesso senso; ciò permette anche di comprendere cosa sia veramente la «Terra Santa» [Non è forse senza interesse segnalare, inoltre, che le iniziali F.S. possono essere anche lette Fides Sapientia, esatta traduzione della Pistis Sophia gnostica]. Questo ci induce a segnalare un altro punto, al quale Valli allude solo troppo brevemente (pp. 323-324): si tratta del significato segreto dei pellegrinaggi, riferito alle peregrinazioni degli iniziati, i cui itinerari, d’altronde, spesso coincidevano in realtà con quelli dei comuni pellegrini, con i quali potevano così confondersi esteriormente, tanto da poter dissimulare meglio le vere ragioni dei loro viaggi. Del resto, a questo proposito, occorre anche tenere conto della ubicazione dei luoghi di pellegrinaggio, la quale, come per i santuari dell’antichità, ha un valore esoterico [Grillot de Givry ha pubblicato sull’argomento uno studio dal titolo: Les Foyers du mysticisme populaire, ne Le Voile d’Isis, Parigi, aprile 1920]; ciò è in diretta relazione con quello che abbiamo chiamato «geografia sacra», e dev’essere accostato a quanto abbiamo scritto a proposito dei Compagnoni e degli Zingari [Le Compagnonnage et les Bohémiens, ne Le Voile d’Isis, Parigi, ottobre 1928 (Oggi: Il Compagnonaggio e gli Zingari, inserito nella raccolta di Studi sulla Massoneria)]. Sull’argomento, forse, ritorneremo in altra occasione. La questione della «Terra Santa» potrebbe anche fornire la chiave per comprendere i rapporti fra Dante, i «Fedeli d’Amore» ed i Templari; è questo un altro degli argomenti che Valli ha trattato in modo incompleto. Egli considera giustamente che questi rapporti con i Templari (pp. 423-426), ed anche con gli alchimisti (p. 248), siano di una realtà incontestabile, e fornisce alcuni accostamenti interessanti, come, per esempio, quello dei nove anni di probazione dei Templari con l’età simbolica di nove anni nella Vita Nuova (p. 274); ma avrebbe potuto dire ben altre cose sull’argomento. Così, a proposito della residenza centrale dei Templari, stabilita a Cipro (pp. 261 e 425), sarebbe curioso studiare il significato del nome di quest’isola, i suoi rapporti con Venere ed il «terzo cielo», nonché il simbolismo del rame, da cui deriva lo stesso nome; tutte cose sulle quali, per il momento, non possiamo soffermarci e che ci limitiamo a segnalare. Anche a proposito dell’obbligo imposto ai «Fedeli d’Amore» di impiegare nei loro scritti la forma poetica (p. 155), sarebbe il caso di chiedersi perché gli antichi chiamavano la poesia: la «lingua degli Dei»; perché Vates in latino era sia il poeta che il divinatore o il profeta (d’altronde, gli oracoli erano enunciati in versi); perché in latino i versi erano chiamati carmina (ammaliamenti, incantamenti; termine identico al Karma sanscrito, inteso nel senso tecnico di «atto rituale») [Rita, in sanscrito, è ciò che è conforme all’ordine, senso che è rimasto nell’avverbio latino rite; l’ordine cosmico è qui rappresentato a mezzo della legge del ritmo]; e perché di Salomone e di altri saggi è detto, in particolare nella tradizione mussulmana, che comprendessero la «Lingua degli uccelli», la quale, per quanto strano possa sembrare, non è che un altro nome della «lingua degli Dei» [La stessa cosa si ritrova anche nelle leggende germaniche]. Prima di ultimare queste note, dobbiamo spendere qualche parola sull’interpretazione della Divina Commedia che Valli ha sviluppato in altre opere e che qui ha solo riassunto: le simmetrie della Croce e dell’Aquila (pp. 382-384), su cui è interamente basata tale interpretazione, chiariscono certamente una parte del significato del poema (d’altronde conforme alla conclusione del De Monarchia) [Cfr. Autorità Spirituale e Potere Temporale, cap. VIII], ma in esso vi sono molte altre cose che con tali simmetrie non potrebbero essere spiegate completamente, basta pensare all’impiego dei numeri simbolici; sembra che l’autore, a torto, le consideri come una chiave unica, sufficiente a risolvere tutte le difficoltà. D’altra parte, l’uso di queste «connessioni strutturali» (p. 388) gli appare come un’originalità di Dante, quando invece in questa «architettura» simbolica vi è qualcosa di essenzialmente tradizionale, che, pur non facendo parte, forse, degli abituali modi di esposizione dei «Fedeli d’Amore» propriamente detti, nondimeno esisteva in seno a delle organizzazioni più o meno strettamente apparentate con la loro e si riallacciava alla stessa arte dei costruttori [Segnaliamo l’espressione massonica «pezzo d’architettura», che si applica, nel senso più vero, all’opera di Dante]; tuttavia, sembra che l’autore abbia intuito qualcosa di questi rapporti, allorché suggerisce che «lo studio del simbolismo nelle arti figurative» (p. 406) potrebbe essere d’aiuto per le ricerche di cui si tratta. D’altronde, occorrerebbe che in questo caso, come per tutto il resto, si mettesse da parte ogni preoccupazione «estetica» (p. 389), solo allora si potrebbero scoprire ben altre comparazioni, talvolta parecchio inaspettate [Pensiamo in particolare ad alcune delle considerazioni contenute nel curiosissimo libro di Pierre Piobb su Le Secret de Nostradamus, Parigi, 1927]. Se ci siamo tanto dilungati sul libro di Luigi Valli è perché esso è uno di quelli che merita veramente di essere preso in considerazione, e se noi ne abbiamo soprattutto segnalato le lacune è perché, così facendo, abbiamo avuto modo di indicare, all’autore o ad altri, delle nuove direzioni di ricerca, suscettibili di completare felicemente i risultati già raggiunti. Sembra che sia giunto il tempo in cui finalmente si svelerà il vero significato dell’opera di Dante; se le interpretazioni di Rossetti e di Aroux non furono prese sul serio nella loro epoca, ciò forse non fu dovuto al fatto che gli spiriti fossero meno preparati di adesso, ma piuttosto perché era previsto che il segreto rimanesse nascosto per sei secoli (il Naros caldeo); Valli parla spesso di questi sei secoli durante i quali Dante non è stato compreso, ma evidentemente senza vedervi alcun particolare significato, e ciò prova ancora una volta che per gli studi di questo genere è necessaria una conoscenza delle «leggi cicliche», così del tutto dimenticate dall’Occidente moderno.
CAPITOLO QUINTO
IL LINGUAGGIO SEGRETO DI DANTE E DEI «FEDELI D’AMORE» II [Articolo pubblicato su Le Voile d’Isis, Parigi, marzo 1932]
Abbiamo già parlato dell’importante opera pubblicata nel 1928, con lo stesso titolo, da Luigi Valli; nel 1931 abbiamo appreso della improvvisa e prematura morte dell’autore, dal quale ci aspettavamo altri studi non meno degni di interesse; nel frattempo ci è pervenuto un secondo volume dallo stesso titolo, che contiene, insieme alle risposte alle obiezioni sollevate contro la tesi da lui sostenuta nel primo volume, un certo numero di note complementari [Il Linguaggio Segreto di Dante e dei Fedeli d’Amore, vol. II (Discussione e note aggiuntive), Roma, Casa Ed. «Optima», 1930]. Le obiezioni, che testimoniano una incomprensione di cui non siamo affatto sorpresi, possono essere ricondotte, come facilmente prevedibile, quasi tutte a due categorie: una relativa ai «critici letterari», imbevuti di ogni sorta di pregiudizi scolastici ed universitari; l’altra legata agli ambienti cattolici, ove non si vuole ammettere che Dante sia appartenuto ad una organizzazione iniziatica; insomma, sono tutti d’accordo, sia pure per motivi diversi, nel negare l’esistenza dell’esoterismo, anche lì ove esso appare con la più eclatante delle evidenze. L’autore sembra attribuire una maggiore importanza alle prime, su cui si intrattiene più a lungo che sulle altre, noi saremmo stati tentati di fare esattamente il contrario, dal momento che consideriamo le seconde come un sintomo ben più grave della deformazione della mentalità moderna; ma questa differenza di prospettiva si spiega in base allo speciale punto di vista dal quale Valli ha voluto porsi, che è unicamente quello del «ricercatore» e dello storico. Da tale punto di vista. troppo esteriore, derivano un ceno numero di lacune e di inesattezze di linguaggio che noi abbiamo già segnalato; e proprio riferendosi a quanto da noi scritto, Valli riconosce che «egli non ha mai avuto contatti con tradizioni iniziatiche di alcun genere» e che «la sua formazione mentale è nettamente critica»; ciò pone ancor più in risalto il fatto che egli sia giunto a delle conclusioni così lontane da quelle della «critica» ordinaria, conclusioni che stupiscono se si pensa, anche, che sono formulate da chi esprime la volontà di voler essere «un uomo del XX secolo». Nondimeno, rincresce che egli, per partito preso, si rifiuti di comprendere il concetto di ortodossia tradizionale, che persista nell’applicare il termine peggiorativo di «sette» a delle organizzazioni a carattere iniziatico e non religioso, che neghi di aver fatto confusione fra «mistico» ed «iniziatico», pur continuando a farlo nel corso di questo secondo volume; ma questi difetti non devono affatto impedirci di riconoscere il gran merito che egli ha, da quel «profano» che ha voluto essere e rimanere, nell’aver intravisto una buona parte della verità, a dispetto di tutti gli ostacoli che la sua formazione doveva naturalmente frapporre, e nell’averla poi enunciata, senza temere gli attacchi che questo gli avrebbe procurato da parte di tutti coloro che hanno dell’interesse a che essa rimanga ignorata. Faremo notare solo due o tre esempi tipici dell’incomprensione dei «critici» universitari: alcuni sono arrivati a pretendere che una poesia, in quanto bella, non può essere simbolica; sono quindi convinti che un’opera d’arte può essere ammirata solo se non significa niente: l’esistenza di un significato profondo ne distruggerebbe il valore artistico! Espressa nel modo più chiaro possibile, ecco dunque la concezione «profana» da noi segnalata ultimamente, a più riprese, sia a proposito dell’arte in generale che della poesia in particolare, concezione del tutto opposta al carattere che le arti e le scienze avevano in origine ed hanno sempre avuto in tutte le civiltà tradizionali. A questo proposito, notiamo una formula molto interessante citata da Valli: in tutta l’arte medioevale, al contrario dell’arte moderna, «si tratta dell’incarnazione di un’idea, non dell’idealizzazione di una realtà»; noi diremmo, di una realtà di ordine sensibile, poiché l’idea è anch’essa una realtà, ed anzi di un grado superiore; questa «incarnazione dell’idea» in una forma non è nient’altro che lo stesso simbolismo. Altri hanno espresso una obiezione veramente comica: essi pretendono che sarebbe «vile» scrivere in «gergo», cioè in linguaggio convenzionale. Evidentemente essi considerano ciò una sorta di bassezza e di dissimulazione. A onor del vero, forse lo stesso Valli ha insistito troppo unilateralmente, come abbiamo già fatto notare, sulla volontà dei «Fedeli d’Amore» di nascondersi per motivi di prudenza; non è contestabile la reale esistenza di una tale componente, si trattava infatti di una necessità loro imposta dalle circostanze, ma essa non è che la più piccola e la più esteriore delle ragioni che giustificano l’impiego di un linguaggio che non è solo convenzionale ma anche, e soprattutto simbolico. Si ritrovano esempi analoghi in tutt’altre circostanze, ove, se fosse stato possibile parlare chiaramente, questo non avrebbe costituito pericolo alcuno; si può dire invece che, anche in questi casi, era più utile sviare coloro che non erano «qualificati», cosa questa che rivela tutt’altra preoccupazione che la semplice prudenza; ma ciò che occorre notare soprattutto è il fatto che le verità di un certo ordine, per loro stessa natura, possono essere espresse solo simbolicamente. Infine, ve ne sono altri che ritengono inverosimile l’esistenza della poesia simbolica dei «Fedeli d’Amore», perché si tratterebbe di un «caso unico», mentre Valli si era preoccupato di dimostrare che, proprio nella stessa epoca, la stessa cosa accadeva in Oriente, ed in particolare con la poesia persiana. Si potrebbe anche aggiungere che questo simbolismo dell’amore è stato talvolta impiegato anche in India e, per limitarsi al mondo mussulmano, è assai singolare che, a questo proposito, si parli quasi sempre in modo esclusivo della poesia persiana, mentre invece si possono facilmente trovare degli esempi simili nella poesia araba, di un carattere non meno esoterico, per esempio, in Omar ibn El-Farid. Aggiungiamo anche che nelle espressioni poetiche del Sufismo sono stati impiegati, ugualmente, ben altri «veli» [Feirefiz – La via del cuore – testi dell’esoterismo islamico – Arktos Carmagnola (nota aggiunta dall’editore)], ivi compreso quello dello scetticismo, per il quale si possono citare, a mo’ d’esempio: Omar El-Khayyam e Abu-l-Alà El-Maari; soprattutto per quest’ultimo ben pochi sanno che in realtà era un iniziato d’alto rango; e cosa particolarmente curiosa, dato l’argomento di cui stiamo trattando, è il fatto che finora non abbiamo visto nessuno che abbia segnalato come la sua opera, Risàlatul-Ghufràn, potrebbe essere considerata una delle principali «fonti» islamiche della Divina Commedia. Per quanto riguarda l’obbligo imposto a tutti i membri di una organizzazione iniziatica di scrivere in versi, esso si accordava perfettamente con il carattere di «lingua sacra» che aveva la poesia, come dice molto giustamente Valli, si trattava di tutt’altra cosa che del «fare della letteratura», scopo questo che non è mai stato quello di Dante e dei suoi contemporanei, i quali, aggiunge Valli ironicamente, «hanno il torto di non aver letto i libri della critica moderna». Ancora in un’epoca molto recente, in certe confraternite esoteriche mussulmane, tutti gli anni ognuno doveva comporre, in occasione del mulid dello Sheikh, un poema in cui si doveva sforzare, anche a scapito della perfezione della forma, di includere un significato dottrinale più o meno profondo. Per quanto riguarda le nuove annotazioni fatte da Valli, e che aprono la possibilità di nuove ricerche, una di queste riguarda i rapporti fra Gioacchino da Fiore ed i «Fedeli d’Amore»: Fiore è uno dei simboli più usati, nella poesia di quest’ultimi, come sinonimo di Rosa, e con il titolo di Fiore è stato scritto un adattamento italiano del Roman de la Rose, da un fiorentino chiamato Durante, che quasi sicuramente è lo stesso Dante [Dante è in realtà una contrazione di Durante, che era il suo vero nome]. D’altra parte, la denominazione del convento di San Giovanni in Fiore, da cui Gioacchino da Fiore prese il suo nome, non figurava in nessun posto prima di lui; fu lui stesso a dargliela? E perché scelse questo nome? Cosa notevole, Gioacchino da Fiore, nelle sue opere, parla di una «vedova» simbolica, esattamente come Francesco da Barberino e come Boccaccio, che appartenevano entrambi ai «Fedeli d’Amore»; e noi aggiungiamo che, ancor oggi, questa «vedova» è ben conosciuta nel simbolismo massonico. A questo proposito è spiacevole che delle preoccupazioni politiche sembra abbiamo impedito a Valli di fare alcuni accostamenti che, nondimeno, sono alquanto sorprendenti; senza dubbio egli ha ragione quando dice che le organizzazioni iniziatiche di cui si tratta non sono la Massoneria, ma il legame fra quest’ultima e le prime non è per questo meno certo; non è curioso, per esempio, che il «vento», nel linguaggio dei «Fedeli d’Amore», abbia esattamente lo stesso significato che ha la pioggia nel linguaggio della Massoneria? Un altro punto importante è quello relativo ai rapporti fra i «Fedeli d’Amore» e gli alchimisti: nei Documenti d’Amore di Francesco da Barberino, si trova un simbolo che, a riguardo, è molto significativo. Si tratta di una figura in cui dodici personaggi disposti simmetricamente e formanti sei coppie, che rappresentano altrettanti gradi iniziatici, convergono verso un unico personaggio posto al centro; questi, che ha in mano la rosa simbolica, ha due teste, una maschile ed una femminile ed è chiaramente identico al Rebis ermetico. La sola differenza che risalta, rispetto alle figure che si trovano nei trattati alchemici, è che mentre in questi ultimi la parte destra è maschile e la parte sinistra è femminile, qui invece la disposizione è rovesciata; questo particolare sembra sia sfuggito a Valli il quale, dimostrando di non essersene accorto, ne dà la spiegazione dicendo che «l’uomo con il suo intelletto passivo è riunito all’Intelligenza attiva rappresentata dalla donna», mentre invece, in genere, è il maschile che simboleggia l’elemento attivo ed il femminile quello passivo. Ciò che è più notevole è il fatto che questa sorta di rovesciamento del rapporto abituale lo si riscontra nel simbolismo impiegato dal tantrismo indù; e l’accostamento si impone a maggior ragione allorché notiamo che Cecco d’Ascoli dice: «onde io son ella», esattamente come gli Shaktas che dicono Sà’ham, «Io sono Lei», invece di dire So’ham, «Io sono Lui» (l’Ana Hoa dell’esoterismo islamico). D’altra parte, Valli fa notare che a fianco del rebis raffigurato nel Rosarium Philosophorum si vede una sorta di albero che porta sei coppie di visi disposti simmetricamente ai lati del fusto ed un unico viso alla sommità, ed egli identifica questi visi con i personaggi della figura di Francesco da Barberino; in effetti sembra che, in entrambi i casi, si tratti di una gerarchia iniziatica di sette gradi, ove l’ultimo grado è caratterizzato dalla ricostruzione dell’Androgine ermetico, vale a dire, quindi, dalla restaurazione dello «stato primordiale»; e questo si accorda con quello che abbiamo avuto occasione di dire a proposito del significato del termine «Rosa-Croce», che indica la perfezione dello stato umano. A proposito dell’iniziazione in sette gradi, nel nostro studio su L’Esoterismo di Dante, noi abbiamo parlato della scala a sette gradini; è vero che generalmente questi sette gradini sono posti in relazione con i sette cicli planetari, i quali si riferiscono a degli stati sopra-umani, ma, per ragioni d’analogia, in un sistema iniziatico si deve avere una similare ripartizione gerarchica fra «piccoli misteri» e «grandi misteri». D’altra parte, l’essere reintegrato al centro dello stato umano, per ciò stesso, è pronto ad elevarsi agli stati superiori ed egli domina già le condizioni d’esistenza di questo mondo, di cui è divenuto maestro; è per questo che il Rebis del Rosarium Philosophorum ha sotto i suoi piedi la Luna, e quello di Basilio Valentino il drago; questo significato è stato completamente misconosciuto da Valli, il quale vi ha solo scorto dei simboli della dottrina corrotta o dell’«errore che opprime il mondo», mentre in realtà la Luna rappresenta il dominio delle forme (il simbolismo è il medesimo di quello del «camminare sulle acque») ed il drago raffigura il mondo elementare. Valli, pur non avendo alcun dubbio sui rapporti fra Dante ed i Templari, su cui esistono diversi indizi, solleva una obiezione a proposito della medaglia del museo di Vienna, della quale abbiamo parlato ne L’Esoterismo di Dante; egli ha voluto esaminarla ed ha constatato che le sue due facce erano state riunite in un secondo momento e che prima erano dovute appartenere a due medaglie diverse; d’altronde, egli stesso riconosce che questa strana operazione non può essere stata eseguita senza un valido motivo. Quanto alle iniziali F.S.K.I.P.F.T., che figurano sul retro, secondo lui esse sono quelle delle sette virtù: Fides, Spes, Karitas, Iustitia, Prudentia, Fortitudo, Temperantia, benché vi sia un’anomalia nel fatto che sono disposte su due linee, per quattro e per tre, invece che per tre e per quattro, come avrebbe dovuto essere in base alla distinzione fra le tre virtù teologali e le quattro virtù cardinali; dal momento, però che esse sono accompagnate da rami d’alloro e d’ulivo, «che sono proprio le due piante sacre degli iniziati», egli ammette che la sua interpretazione non esclude necessariamente l’esistenza di un altro significato più nascosto; e noi aggiungiamo che l’anomala ortografia di Karitas, al posto di Charitas, potrebbe essere stata necessitata proprio da questo doppio significato. Del resto, noi abbiamo anche segnalato, nel nostro studio, il ruolo iniziatico assegnato alle tre virtù teologali, ruolo che è stato conservato nel 18’ grado della Massoneria scozzese [Nel 17° grado, «Cavaliere d’Oriente e d’Occidente», vi è anche una divisa formata da sette iniziali, che sono quelle di un settenario di attributi divini la cui enumerazione è tratta da un passo dell’Apocalisse. (Vedi S. Farina – Rituali del Rito Scozzese Antico Accettato – Ediz. Arktos 1984 – aggiunta dall’editore)]; inoltre, il settenario delle virtù è formato da un ternario superiore e da un quaternario inferiore, e questo indica a sufficienza che esso è costituito in base a dei principi esoterici; ed infine, esso può corrispondere, esattamente come quello delle «arti liberali» (anch’esso diviso in trivium e quadrivium), ai sette gradini ai quali accennavamo prima, tanto più che, in effetti, la «Fede» (la Fede Santa) figura sempre sul gradino più alto della «scala misteriosa» dei Kadosch; tutto ciò forma dunque un insieme molto più coerente di quanto possano pensare gli osservatori superficiali. Per altro verso, Valli ha scoperto, sempre nel museo di Vienna, la medaglia originale di Dante, il cui rovescio presenta ancora una figura molto strana ed enigmatica: un cuore posto al centro di un sistema di cerchi, che ha l’apparenza di una sfera celeste, ma che in realtà non lo è, e che non è accompagnato da alcuna iscrizione [Questo cuore, in questa posizione, ci ricorda la figura, altrettanto interessante e misteriosa. del cuore di Saint-Denis d’Orques, raffigurato al centro dei cerchi planetari e zodiacale; figura che è stata esaminata da L. Charbonneau-Lassay nella rivista Regnabit]. Vi sono tre cerchi meridiani e quattro cerchi paralleli, che Valli riconduce ancora alle tre virtù teologali ed alle quattro virtù cardinali; quello che ci induce a pensare che questa interpretazione debba essere esatta, è soprattutto la giustezza dell’applicazione del senso verticale e del senso orizzontale; questi due sensi sono in rapporto con la via contemplativa e la via attiva, o con l’autorità spirituale ed il potere temporale, che l’una e l’altra reggono, e ad esse corrispondono i due gruppi di virtù; il cerchio obliquo che completa la figura (e che forma con gli altri il numero 8, che è quello dell’equilibrio), riunisce poi gli altri sette in una perfetta armonia, sotto l’irraggiamento della «dottrina d’amore»), rappresentata dal cuore [Sull’argomento ci si potrà riferire a ciò che abbiamo detto del De Monarchia di Dante, in Autorità Spirituale e Potere temporale, cap. VIII]. Un’ultima nota riguarda il nome segreto che i «Fedeli d’Amore» davano a Dio: Francesco da Barberino, nel suo Tractatus Amoris, si è fatto rappresentare in atto di adorare la lettera I; nella Divina Commedia, Adamo dice che il primo nome di Dio fu I [Paradiso, XXVI, 133] ed El fu il nome successivo. Questa lettera I, che Dante chiama la «nona figura» secondo il posto da essa occupato nell’alfabeto latino (e si sa quale importanza simbolica avesse per lui il numero 9), non è altro, evidentemente, che lo iod, benché questo sia la decima lettera dell’alfabeto ebraico; infatti lo iod, oltre ad essere la prima lettera del Tetragramma, costituisce di per sé un nome divino, sia se isolato che se ripetuto tre volte [È una semplice coincidenza che il cuore di Saint-Denis d’Orques, di cui abbiamo appena parlato, porta una ferita (o ciò che sembra tale) a forma di iod? E non vi sarebbe motivo di supporre che le antiche raffigurazioni del «Sacro Cuore», precedenti la sua adozione «ufficiale»da parte della Chiesa, abbiano potuto avere certi rapporti con la dottrina dei «Fedeli d’Amore» o dei loro continuatori?]. E lo stesso iod che nella Massoneria è diventato la lettera G, per assimilazione con God (poiché fu in Inghilterra che avvenne tale trasformazione); questo senza che vengano pregiudicati gli altri molteplici significati che, in un secondo momento, hanno finito col condensarsi nella stessa lettera G, e che qui non ci proponiamo di esaminare. Nel deplorare la scomparsa di Luigi Valli, c’è da sperare, vivamente, che in questo campo di ricerche, così vasto e finora così poco esplorato, si trovino dei continuatori; e sembra che sia così, poiché egli stesso ci informa che, in questa direzione, è già stato seguito da Gaetano Scarlata, il quale ha dedicato un’opera [Le origini della letteratura italiana nel pensiero di Dante, Palermo, 1930] allo studio specifico del trattato De Vulgari Eloquentia di Dante, trattato «pieno di misteri», come Rossetti ed Aroux avevano opportunamente notato, e che mentre sembra occuparsi semplicemente dell’idioma italiano, in realtà si riferisce alla lingua segreta; secondo un procedimento ugualmente in uso nell’esoterismo islamico, ove, come abbiamo segnalato in altra occasione, un’opera iniziatica può rivestire l’apparenza di un semplice trattato di grammatica. Senza dubbio si faranno ancora ben altre scoperte in questa direzione, ed anche se coloro che si dedicheranno a queste ricerche lo faranno solo con una personale mentalità «profana» (a condizione comunque che siano imparziali) e le considereranno solo come oggetto di una sorta di curiosità storica, i risultati ottenuti non saranno per questo, meno suscettibili di contribuire efficacemente ad una restaurazione dello spirito tradizionale, e questo sia per il valore che tali ricerche potranno avere di per sé, sia per mezzo di coloro che ne sapranno comprendere la reale portata: questi lavori, non si riallacciano, foss’anche inconsciamente ed involontariamente, alla «ricerca della Parola perduta», che è poi la stessa cosa della «cerca del Graal»?
CAPITOLO SESTO
NUOVE CONSIDERAZIONI SUL LINGUAGGIO SEGRETO DI DANTE [Articolo pubblicato su Le Voile d’Isis. Parigi, luglio 1932]
Parlando precedentemente dei due volumi dell’ultima opera di Luigi Valli, abbiamo citato il lavoro che, sempre nello stesso ordine di idee, Gaetano Scarlata ha dedicato al trattato De Vulgari Eloquentia di Dante, o piuttosto, come egli preferisce chiamarlo (giacché il titolo non è mai stato fissato con esattezza), De Vulgari Eloquentia Doctrina, secondo l’espressione impiegata da Dante stesso per definirne l’oggetto fin dall’inizio, ed al fine di mettere in evidenza la sua intenzione circa il contenuto dottrinale della poesia in lingua volgare [Le Origini della Letteratura Italiana nel Pensiero di Dante, Palermo, 1930]. In effetti, quelli che Dante chiama poeti volgari sono coloro i cui scritti avevano, come lui dice, verace intendimento, vale a dire contenevano un senso nascosto, in conformità col simbolismo dei «Fedeli d’Amore», infatti egli li contrappone ai litterali (e non litterati, come talvolta è stato detto in modo inesatto), cioè a coloro che scrivevano solamente in senso letterale. I primi sono, per lui, i veri poeti, ed egli li chiama anche trilingues doctores, cosa che, da un punto di vista esteriore, si può intendere col fatto che tale poesia esisteva nelle tre lingue, italiana, provenzale (e non «francese», come dice erroneamente Scarlata) e spagnola, ma che in realtà significa (nessun poeta ha mai scritto infatti in tutte e tre le lingue) che essa doveva essere interpretata secondo un triplice senso [Senza dubbio, occorre intendere che si tratta di tre significati superiori a quello letterale, di modo che, con quest’ultimo, si avrebbero i quattro significati di cui Dante parla nel Convito, così come abbiamo indicato all’inizio del nostro studio su L’Esoterismo di Dante]; e Dante, a proposito di questi trilingues doctores dice che «maxime conveniunt in hoc vocabulo quod est Amor», che è un’allusione abbastanza evidente alla dottrina dei «Fedeli d’Amore». Parlando di quest’ultimi, Scarlata fa un’osservazione molto giusta: egli pensa che non abbiano mai costituito un’associazione in forma rigorosamente definita, più o meno simile a quella della Massoneria moderna, per esempio, con un potere centrale e con quelle «filiali» nelle diverse località; e noi, in appoggio a questa osservazione, possiamo aggiungere che in seno alla stessa Massoneria non è mai esistito niente del genere prima della costituzione della Gran Loggia d’Inghilterra, nel 1717. Del resto, non sembra che Scarlata abbia inteso la reale portata di un fatto come questo, che egli crede di dover semplicemente attribuire alle circostanze, poco favorevoli all’esistenza di un’istituzione che si presentasse con i connotati di una maggiore stabilità; in realtà, come spesso abbiamo detto, un’organizzazione veramente iniziatica non può essere una «società» nel senso moderno dei termine, con tutto il formalismo esteriore che ciò comporta; allorché incominciano a comparire degli statuti, dei regolamenti scritti o altre cose del genere, si può essere certi di trovarsi al cospetto di una degenerazione che conferisce all’organizzazione un carattere «semi-profano», se è possibile esprimersi così. Ma, per quanto riguarda la dimensione propriamente iniziatica, Scarlata non ha approfondito l’argomento e sembra anche che vi si accosti ancora meno di L. Valli; egli guarda soprattutto all’aspetto politico, e quindi del tutto accessorio, e parla continuamente di «sette», punto sul quale ci siamo ampiamente spiegati nei nostri precedenti capitoli; nelle sue considerazioni, dall’affermazione della dottrina (esoterica e non eretica) dell’amor sapientiae egli trae ben poche conseguenze, e tuttavia questa dottrina è l’essenziale, mentre il resto attiene solo alle contingenze storiche. D’altronde, è possibile che l’oggetto di questo studio si sia prestato molto facilmente a ciò che ci appare come un errore di prospettive: il De Vulgari Eloquentia Doctrina ha uno stretto rapporto con il De Monarchia e quindi si riallaccia a quella parte del lavoro di Dante ove le applicazioni sociali occupano lo spazio maggiore; ma queste stesse applicazioni possono essere ben comprese se non le si riconduce continuamente al loro principio? Ciò che più dispiace è che Scarlata, quando passa a delle considerazioni storiche d’insieme, si lasci trasportare da interpretazioni più che contestabili: non arriva infatti fino a fare di Dante e dei «Fedeli d’Amore» degli avversari dello spirito del Medioevo e dei precursori delle idee moderne, animati da uno spirito «laico» e «democratico» che in realtà è quanto di più «anti-iniziatico» ci possa essere? Questa seconda parte del suo libro sarebbe da rivedere sulla scorta di una maggiore conformità con il senso tradizionale, anche se contiene comunque delle indicazioni interessanti, in particolare per ciò che riguarda le influenze orientali alla corte di Federico II e nel movimento francescano; in verità essa è presentata solamente come un «primo tentativo di ricostruzione storica», chissà se l’autore, nel corso delle sue ulteriori ricerche, finirà col rettificarla da sé? Una delle cause dell’errore di Scarlata risiede, forse, nel modo in cui Dante contrappone l’uso del vulgare a quello del latino, lingua ecclesiastica, nonché l’espressione simbolica dei poeti, secondo il verace intendimento, a quella dei teologi (dal momento che quest’ultima è piuttosto una semplice allegoria); ma è solo agli occhi degli avversari di Dante o di coloro che non lo comprendono (che in questo caso equivale alla stessa cosa) che il vulgare può apparire come il sermo laicus, mentre invece per lui era tutt’altra cosa; d’altra parte, dal punto di vista strettamente tradizionale, la funzione degli iniziati non è più esattamente «sacerdotale» di quella di un «clero» exoterista che possiede solo la lettera e si limita solo alla «scorza» della dottrina [Secondo l’ordine gerarchico normale, l’iniziato è al di sopra del «chierico» ordinario (foss’anche un teologo), così come il «laico» è naturalmente al di sotto di questi]? In tutto questo la cosa essenziale è comprendere ciò che Dante intende con l’espressione vulgare illustre, che può sembrare strana ed anche contraddittoria se ci si attiene al significato ordinario dei termini, ma che si spiega se si tiene conto che egli considera il termine vulgare come sinonimo di naturale: essa è la lingua che l’uomo apprende direttamente per trasmissione orale (come il bambino, che dal punto di vista iniziatico rappresenta il neofita, apprende la lingua materna), vale a dire, simbolicamente, la lingua che serve da veicolo alla tradizione e che, sotto questo profilo, può identificarsi con la lingua primordiale ed universale. Tutto ciò, come è possibile notare, tocca da vicino la questione della misteriosa «lingua siriaca» (loghah suryaniyah) di cui abbiamo parlato in altri articoli [Les Science des Lettres, febbraio 1931, e La Langue des Oiseaux, novembre 1931, pubblicati ne Le Voile d’Isis, Parigi. (Oggi: La Scienza delle Lettere e La Lingua degli Uccelli, rispettivamente cap. VI e VII di Simboli della Scienza sacra)]; è vero che per Dante questa «Lingua della rivelazione», sembra sia stata l’ebraico, ma, come abbiamo detto allora, una tale affermazione non dev’essere presa alla lettera, in quanto che si può affermare la stessa cosa per tutte le lingue che hanno un carattere «sacro», vale a dire per tutte le lingue nelle quali si esprimono le diverse forme tradizionali regolari [È ovvio che quando si oppone «lingue volgari» a «lingue sacre», il termine «volgare» è assunto nel suo significato abituale; se invece lo si volesse intendere nel senso che gli dà Dante, l’espressione «lingue volgari» non sarebbe più utilizzabile e, per evitare ogni equivoco, bisognerebbe allora parlare di «lingue profane»]. Secondo Dante, la lingua parlata dal primo uomo, e creata direttamente da Dio, fu mantenuta di suoi discendenti fino all’edificazione della torre di Babele; in seguito, «hanc forman locutionis hereditati sunt filii Heber…; hiis solis post confusionem remansi»; ma questi «figli di Heber», piuttosto che un popolo determinato, non sono tutti coloro che hanno conservato la tradizione? Il nome di «Israele» non è stato spesso impiegato per indicare, anche, l’insieme degli iniziati, qualunque fosse la loro origine etnica? E costoro, che di fatto costituiscono realmente «il popolo eletto», non possiedono la lingua universale che permette a tutti loro di comprendersi, vale a dire, non possiedono la conoscenza della tradizione unica che è celata sotto tutte le forme particolari [Sull’argomento, si veda il cap. XXXVII di Considerazioni sulla Via Iniziatica, dal titolo: Il Dono delle Lingue]? D’altronde, se Dante avesse pensato che si trattava realmente della lingua ebraica, non avrebbe potuto dire che la Chiesa (indicata col nome enigmatico di Petramala) crede di parlare la lingua di Adamo, perché essa non parla l’ebraico, ma il latino, per il quale non sembra che qualcuno abbia mai rivendicato la qualità di lingua originaria; ma, se con ciò che dice Dante si intende che la Chiesa crede di insegnare la vera dottrina della rivelazione, ecco che tutto diventa perfettamente comprensibile. Inoltre, anche ammettendo che i primi Cristiani, che possedevano questa vera dottrina, abbiano effettivamente parlato l’ebraico (cosa che sarebbe storicamente inesatta, perché l’aramaico non è l’ebraico, più di quanto l’italiano non sia il latino), i «Fedeli d’Amore», che si consideravano i loro continuatori, non hanno mai preteso di riprendere questa lingua per opporla al latino, come sarebbe stato logico che facessero se ci si volesse attenere alla interpretazione letterale [Aggiungiamo anche che, come ha notato Scarlata, l’idea della continuità della lingua primitiva è contraddetta dalle parole che lo stesso Dante, nella Divina Commedia, fa dire ad Adamo (Paradiso, XXVI, 124). Queste parole, d’altronde, possono spiegarsi tenendo conto dei periodi ciclici: la lingua originaria fu tutta spenta dalla fine del Krita-Yuga, quindi da molto prima della vicenda del «popolo di Nemrod», che corrisponde solo all’inizio del Kali-Yuga]. Tutto questo è molto lontano dal significato puramente «filologico» che abitualmente viene attribuito a questo trattato di Dante e, in sostanza, si tratta di ben altro che dell’idioma italiano; ed anche ciò che realmente si riferisce ad esso può avere, contemporaneamente, un valore simbolico. Del pari, allorché Dante contrappone una città o una regione ad un’altra, non si tratta semplicemente di una opposizione linguistica; o quando cita certi nomi come: Petramala, Papienses, Aquilegienses, in queste sue scelte (anche a voler trascurare la considerazione di un simbolismo geografico propriamente detto) vi sono delle intenzioni fin troppo trasparenti, come già aveva fatto notare Rossetti; e naturalmente, per comprendere il vero senso di questo o di quel termine, apparentemente insignificante, occorre spesso rifarsi alla terminologia convenzionale dei «Fedeli d’Amore». Scarlata fa osservare, molto giustamente, che quasi sempre sono gli esempi che danno la chiave del contesto (compresi quegli esempi che sembrano avere solo un valore puramente retorico o grammaticale); in effetti, si trattava di un eccellente mezzo per distogliere l’attenzione dei «profani», i quali potevano solo scorgervi delle frasi qualsiasi e senza importanza; si potrebbe dire che questi esempi giuocano qui un ruolo paragonabile a quello dei «miti» nei dialoghi di Platone, e basta considerare a cosa, i «critici» universitari, hanno ridotto quest’ultimi, per comprendere l’efficacia del procedimento, che consiste nel mettere «fuori causa», se così si può dire, proprio ciò che è invece più importante. Insomma, sembra che Dante mirasse essenzialmente alla costituzione di un linguaggio che, per mezzo della sovrapposizione di molteplici significati, fosse atto ad esprimere, nei limiti del possibile, la dottrina esoterica; e se la codificazione di un tale linguaggio può essere qualificata come «retorica», si tratta in ogni caso di una retorica di un genere alquanto speciale, tanto lontana da quello che oggi si intende con questo termine, per quanto lo è la poesia dei «Fedeli d’Amore» da quella dei moderni; quest’ultimi, infatti, hanno come loro predecessori quei litterali a cui Dante. rimprovera di rimare «stoltamente», senza includere nei loro versi alcun significato profondo [Accade la stessa cosa per i predecessori dei chimici moderni che non sono i veri alchimisti, ma i «soffiatori»; si tratti delle scienze o delle arti, la concezione puramente «profana» dei moderni è sempre il risultato di una simile degenerazione]. Secondo l’espressione di L. Valli, che abbiamo già citato, Dante si proponeva tutt’altro che di «fare della letteratura», e ciò equivale col dire che egli era esattamente tutto il contrario di un moderno; la sua opera, lungi dall’opporsi allo spirito del Medioevo, ne è una delle sintesi più perfette, allo stesso titolo di quella dei costruttori di cattedrali, ed i più elementari dati iniziatici permettono di comprendere facilmente che in questo accostamento vi sono delle ragioni molto profonde.
CAPITOLO SETTIMO
«FEDELI D’AMORE» E «CORTI D’AMORE» [Articolo pubblicato su Le Voile d’Isis, Parigi, luglio 1933]
Le ricerche sui «Fedeli d’Amore» continuano a dar luogo, in Italia, a dei lavori interessanti: Alfonso Ricolfi, che aveva già scritto diversi articoli sull’argomento, ha pubblicato adesso uno studio, che sarà seguito da altri, e dove egli esprime l’intenzione di riprendere il lavoro che L. Valli ha lasciato incompiuto [Studi sui «Fedeli d’Amore» – I -: Le «Corti d’Amore» in Francia ed i loro riflessi in Italia, Roma, Biblioteca della Nuova Rivista Storica, Società Editrice Dante Alighieri, 1933]. Tuttavia, è pensabile che egli lo faccia, forse con qualche eccessiva riserva, poiché ritiene che L. Valli, in alcuni punti, abbia «esagerato», specialmente quando, in contrasto con l’opinione più diffusa, rifiuta la reale esistenza di tutte le donne cantate dai poeti che si riallacciano ai «Fedeli d’Amore»; ma, a onor del vero, questa questione ha, senza dubbio, meno importanza di quanto egli sembra credere almeno quando ci si pone al di là del punto di vista del semplice curiosità storica, e comunque non intacca minimamente la vera interpretazione. In effetti, non v’è niente d’impossibile nel fatto che alcuni, nel designare con un nome femminile la Saggezza divina, abbiano adoperato, a titolo puramente simbolico, il nome di una persona realmente vissuta; e per un fatto del genere possono valere almeno due ragioni la prima, come dicevamo proprio ultimamente, è che, a seconda della natura degli individui, qualunque cosa può rappresentare l’occasione ed il punto di partenza per uno sviluppo spirituale, potrebbe proprio trattarsi di un amore terreno esattamente come di una qualunque altra circostanza (tanto più che non bisogna dimenticare che qui noi abbiamo a che fare, in fondo, con quello che può essere definito come una via di Kshatriya); la seconda è che il vero significato legato ad una tale designazione finiva con l’essere più difficile da penetrare, da parte dei profani, i quali, naturalmente, si limitavano così al senso letterale; e questo vantaggio, quantunque d’ordine contingente, non era forse del tutto trascurabile. Questa osservazione ci porta a considerare un altro punto, strettamente connesso al precedente: Ricolfi ritiene che occorra distinguere fra «Corti d’Amore» e «Corti d’amore», ed una tale distinzione non è una semplice sottigliezza, come potrebbe sembrare a prima vista. In effetti, per «Corte d’Amore» bisogna intendere un’assemblea simbolica presieduta da una personificazione dell’Amore stesso, mentre una «Corte d’amore» è solo una riunione umana, che costituisce una sorta di tribunale chiamato a pronunciarsi su dei casi più o meno complessi; che questi casi siano stati, d’altronde, reali o supposti, o, in altri termini, che si sia trattato di effettiva giurisprudenza o di un semplice giuoco (ed in effetti si è potuto trattare di entrambe le cose), dal punto di vista in cui noi ci poniamo è poco importante. Le «Corti d’amore», se veramente si occupavano solo di questioni relative all’amore profano, non erano affatto le assemblee dei veri «Fedeli d’Amore» (a meno che, talvolta, questi non abbiano assunto una tale apparenza per meglio dissimularsi), avranno potuto esserne solo un’imitazione e quasi una parodia, nata dalla incomprensione dei non iniziati; esattamente come, alla stessa epoca, esistevano incontestabilmente dei poeti profani che, celebrando nei loro versi delle donne reali, immettevano in essi niente di più che il senso letterale; al pari dei «soffiatori» che esistevano allora a fianco dei veri alchimisti. In questi casi occorre evitare di confondere gli uni con gli altri, e non è sempre facile farlo senza un esame approfondito, poiché, esteriormente, il loro linguaggio può essere il medesimo; d’altronde, questa stessa confusione, nel primo come nel secondo caso, è potuta servire talvolta a sviare delle ricerche indiscrete. Ciò che è inammissibile è il fatto di attribuire una sorta di priorità o di anteriorità a ciò che è solo una contraffazione o una degenerazione, e Ricolfi ci sembra disposto ad ammettere, con troppa facilità, che il significato profondo abbia potuto essere aggiunto, a posteriori, a qualcosa che inizialmente avrebbe avuto un carattere del tutto profano. A questo proposito ci limiteremo a ricordare quanto da noi detto, tante volte, sull’origine iniziatica di tutte le scienze e di tutte le arti, il cui carattere propriamente tradizionale ha potuto perdersi in seguito solo a causa di quella incomprensione di cui parlavamo prima; d’altronde, supporre il contrario significherebbe ammettere un’influenza del mondo profano sul mondo iniziatico, vale a dire un rovesciamento dei veri rapporti gerarchici che sono inerenti alla natura stessa delle cose. Nel caso in specie, ciò che può trarre in inganno è il fatto che l’imitazione profana ha dovuto essere sempre più in vista che non la vera organizzazione dei «Fedeli d’Amore», organizzazione che, del resto, bisognerebbe guardarsi bene dal concepire come una «società», così come abbiamo già spiegato parlando delle organizzazioni iniziatiche in generale [Cfr. Considerazioni sulla Via Iniziatica, cap. XII], se essa, agli occhi dello storico ordinario, ha potuto sembrare inafferrabile, ciò prova non tanto la sua inesistenza ma, al contrario, il suo carattere veramente serio e profondo [A questo proposito, ribadiamo che non può trattarsi in alcun modo di una «setta»: il dominio iniziatico non è quello della religione exoterica, e la formazione delle «sette» religiose è stata, in queste circostanze, un altro dei casi di degenerazione profana; ci dispiace di dover ritrovare ancora, in Ricolfi, una certa confusione fra i due domini, cosa che nuoce parecchio alla comprensione di ciò di cui realmente si tratta]. Uno dei principali meriti del lavoro di Ricolfi è che ha apportato delle nuove indicazioni circa l’esistenza dei «Fedeli d’Amore» nella Francia settentrionale; e, a questo riguardo, il poema poco conosciuto di Jacques de Baisieux sui Fiefs d’Amour (identificati ai «feudi celesti» per opposizione ai «feudi terrestri»), sul quale egli si sofferma a lungo, è particolarmente significativo. Le tracce di una tale organizzazione sono sicuramente molto più rare nel nord della Francia che in Linguadoca ed in Provenza [Ed è per una semplice coincidenza che nel Compagnonaggio il «Tour de france» esclude tutta la regione settentrionale e comprende solo i paesi situati a sud della Loira? O non bisogna scorgervi qualcosa la cui origine può risalire molto indietro e le cui ragioni, cosa del tutto scontata, sono oggi completamente dimenticate?]; tuttavia non bisogna dimenticare che, un po’ più tardi, in questa regione è comparso il Roman de la Rose; e peraltro gli stretti rapporti con la «Cavalleria del Graal» (alla quale allude esplicitamente lo stesso Jacques de Baisieux) sono suggeriti dal fatto che Chrestien de Troyes tradusse la Ars amandi di Ovidio, la quale, a questo punto, potrebbe avere benissimo, anch’essa, qualche altro significato oltre al senso letterale (e non ci sarebbe da stupirsene dato che si tratta dell’autore delle Metamorfosi). Sicuramente si è ben lontani dall’aver detto tutto sull’organizzazione della «cavalleria errante», la cui stessa idea si riallaccia a quella dei «viaggi» iniziatici; per il momento possiamo solo richiamare tutto quello che è stato già scritto sull’argomento, noi aggiungiamo solamente che l’espressione «cavalieri selvaggi», segnalata da Ricolfi, meriterebbe da sola tutto uno studio particolare. Nel libro di André, cappellano del re di Francia, vi sono, anche lì, delle cose assai strane; sfortunatamente esse, in gran parte, sono sfuggite a Ricolfi che ne riporta solo alcune, senza vedervi niente di straordinario. Per esempio, vi è detto che il palazzo dell’Amore si innalza «al centro dell’Universo», che ha quattro lati e quattro porte, la porta d’Oriente è riservata a Dio e quella a Nord è sempre chiusa. Ora, è importante notare che il Tempio di Salomone, che simboleggia il «Centro del Mondo», ha anch’esso, nella tradizione massonica, la forma di un quadrilatero o «quadrilungo», con delle porte che si aprono su tre lati e solo a Nord non vi è alcuna apertura; vi è solo una leggera differenza (la porta chiusa contro l’assenza di una quarta apertura), ma il simbolismo è esattamente lo stesso, il Nord è sempre la parte oscura, quella che non è illuminata dalla luce del Sole [Nella tradizione cinese, è questa la parte dello yin, mentre la parte opposta è quella dello yang. Questa considerazione potrebbe aiutare a risolvere la controversa questione della rispettiva posizione delle due colonne simboliche: quella del Nord deve normalmente corrispondere al principio femminile e quella del Sud al principio maschile]. Per di più, qui Amore appare sotto forma di un re che porta sul capo una corona d’oro: non è così che lo vediamo rappresentato, nella Massoneria scozzese, nel grado di «Principe di Mercede»? [Si veda L’Esoterismo di Dante, cap. III. – In uno dei suoi articoli sul Corriere Padano, Ricolfi ha esaminato il significato particolare dato dai «Fedeli d’Amore» alla parola Merzé, che sembra sia stata proprio una delle designazioni enigmatiche della loro organizzazione]. E non si potrebbe dire, allora, che egli è il «re pacifico», che è il significato stesso del nome Salomone? Vi è ancora un altro accostamento, altrettanto sorprendente: in diversi poemi e favolelli la «Corte d’Amore» è descritta come composta interamente da uccelli che a turno prendono la parola; ora, noi abbiamo già detto cos’è che bisogna intendere con la «lingua degli uccelli» [Si veda il nostro articolo di pari oggetto ne Le Voile d’Isis, Parigi, 1931 (Oggi: La Lingua degli Uccelli, inserito come cap. VII in Simboli della Scienza sacra)], sarebbe allora ammissibile vedere solo una pura coincidenza nel fatto che, come abbiamo indicato, è proprio in riferimento a Salomone che, nel Corano, si trova menzionata questa «lingua degli uccelli»? Possiamo ancora aggiungere un altro particolare che è altrettanto importante e che ci aiuta a stabilire ulteriori concordanze: in questa «Corte d’Amore», i ruoli principali sembra siano generalmente attribuiti all’usignolo ed al pappagallo; ora, si conosce l’importanza data all’usignolo nella poesia persiana, della quale L. Valli ha già segnalato i punti di contatto con quella dei «Fedeli d’Amore», ma forse è meno noto il fatto che il pappagallo è il vahana, o veicolo simbolico, di Kama, vale a dire dell’Eros indù; tutto ciò non sembra essere tale da indurre a riflettere? E, dal momento che stiamo parlando degli uccelli, non è curioso che Francesco da Barberino, nei suoi Documenti d’Amore, rappresenti l’Amore stesso con i piedi di falco o di sparviero, l’uccello emblematico dell’Horus egizio, il cui simbolismo è in stretta relazione con quello del «Cuore del Mondo»? [L. Charbonneau-Lassay ha dedicato uno studio all’argomento nella rivista Regnabit]. A proposito di Francesco da Barberino, Ricolfi ritorna sulla figura, di cui abbiamo già parlato [Si veda il precedente cap. Il Linguaggio Segreto di Dante e dei «Fedeli d’Amore» – II], ove sei coppie di personaggi disposti simmetricamente ed un tredicesimo personaggio, androgino, al centro, rappresentano abbastanza chiaramente sette gradi iniziatici; la sua interpretazione è leggermente diversa da quella di L. Valli, ma solo per quanto riguarda alcuni dettagli che non cambiano per niente il significato essenziale. Egli, inoltre, riproduce un’altra figura che rappresenta una «Corte d’Amore» e dove i personaggi sono distribuiti su undici gradini; questo fatto sembra che non abbia attirato la sua attenzione ma, se ci si riferisce a quanto abbiamo detto, altrove, sul ruolo che il numero undici ha nell’opera di Dante, in rapporto con il simbolismo di alcune organizzazioni iniziatiche [Si veda L’Esoterismo di Dante, cap. VII. – Ricolfi sembra assai disposto, d’altronde, ad ammettere i rapporti fra i «Fedeli d’Amore» ed i «Templari», nonostante vi alluda di sfuggita, dato che l’argomento esula dal soggetto che si è proposto di trattare], se ne comprenderà facilmente tutta l’importanza. Del resto, sembra che l’autore dei Documenti d’Amore non fosse estraneo a certe conoscenze tradizionali di un genere molto particolare, come la spiegazione del significato delle parole per mezzo dello sviluppo dei loro elementi costituitivi; si legga infatti con attenzione la seguente frase, con la quale egli definisce una delle dodici virtù alle quali corrispondono le dodici parti della sua opera (e questo numero ha la sua ragion d’essere: si tratta di uno zodiaco in cui l’Amore è il Sole), frase che Ricolfi cita senza alcun commento: «Docilitas, data novitiis vilitate abstinere»; non vi è qui qualcosa che richiama, per esempio, il Cratilo di Platone? [In un’epoca più recente, ritroviamo ancora un procedimento simile, impiegato in maniera più appariscente, nel trattato ermetico di Cesare della Riviera: Il Mondo Magico degli Heroi (Ediz. Arktos 1982) – (si veda la nostra recensione ne Le Voile d’Isis, ottobre 1932 – oggi inserito in Recensioni). Del pari, quando Jacques de Baisieux dice a-mor significa «senza morte», non è certo il caso di affrettarsi a dichiarare, come fa Ricolfi, che si tratta di una «falsa etimologia»: in realtà, non si tratta affatto di etimologia, ma di un procedimento di interpretazione paragonabile al nirukta della tradizione indù, noi stessi abbiamo suggerito questa spiegazione, senza conoscere il poema in questione, e vi abbiamo aggiunto un accostamento con le parole sanscrite a-mara e a-mrita, allorché scrivemmo il primo articolo sui lavori di L. Valli (Si veda il precedente cap. Il Linguaggio Segreto di Dante e dei «Fedeli d’Amore» – I)]. Sempre in riferimento a Francesco da Barberino, segnaliamo ancora un errore assai curioso commesso da Ricolfi, a proposito della detta figura androgina: essa è decisamente ermetica e non ha assolutamente niente di «magico», sono queste due cose completamente differenti; a riguardo, egli parla anche di «magia bianca», mentre vedrebbe della «magia nera» nel caso del Rebis di Basilio Valentino, a causa del drago, che invece, come abbiamo già detto [Si veda il precedente cap. Il linguaggio Segreto di Dante e dei «Fedeli d’Amore» – II], rappresenta, molto semplicemente, il mondo elementare e che, d’altronde, è posto sotto i piedi del Rebis, quindi è da questi dominato. Ma, cosa ancora più spassosa, egli pensa di poter parlare qui di «magia nera» a causa della squadra e del compasso (che il Rebis tiene nelle mani, e ciò per delle ragioni che è fin troppo facile indovinare e che derivano sicuramente molto più dalle contingenze politiche che da considerazioni di ordine iniziatico! E, per finire, poiché Ricolfi sembra avere dei dubbi sul carattere esoterico della figura in cui Francesco da Barberino, sotto le apparenze di una semplice «lettera ornata» si è fatto rappresentare in adorazione davanti alla lettera I, precisiamo ulteriormente il significato di tale lettera che, secondo Dante, fu il primo nome di Dio: essa designa propriamente l’«Unità divina» (fra l’altro, ecco perché è il primo nome di Dio: l’unità dell’essenza precede necessariamente la molteplicità degli attributi). In effetti, non solo essa è l’equivalente dello iod ebraico, geroglifico del Principio, ma lo iod è esso stesso principio di tutte le altre lettere dell’alfabeto, ed il suo valore numerico, 10, riconduce all’unità (è l’unità sviluppata nel quaternario: 1+2+3+4 = 10, o il punto centrale che produce, con la sua espansione, il cerchio della manifestazione universale); non solo la stessa lettera I rappresenta l’unità nella numerazione latina, in ragione della sua forma di linea retta, che è la più semplice di tutte le forme geometriche (essendo, il punto, «senza forma»), ma, per di più, nella lingua cinese, la parola i significa «unità» e Tai-i è la «Grande Unità», che è rappresentata simbolicamente come residente nella stella polare; e ciò è ulteriormente ricco di significato poiché, ritornando alla lettera I degli alfabeti occidentali, ci si accorge che, essendo una retta verticale, essa è, per ciò stesso, idonea a simboleggiare l’«Asse del Mondo», di cui si conosce bene l’importanza in tutte le dottrine tradizionali [Nella Massoneria operativa, il filo a piombo, figura dello «Asse del Mondo», è sospeso alla stella polare o alla lettera G, che in questo caso ne occupa il posto, e che è a sua volta, come abbiamo già detto, un sostituto dello iod ebraico. – Cfr. La Grande Triade, cap. XXV]; il fatto, poi, che questa lettera sia indicata come il «primo nome di Dio», ci ricorda anche l’anteriorità del simbolismo «polare» rispetto al simbolismo «solare». Naturalmente qui noi ci siamo soffermati su quei punti ove le spiegazioni di Ricolfi sono palesemente insufficienti, poiché pensiamo che era questa la cosa più utile da fare; ma, va da sé, che sarebbe ingiusto rimproverare a degli specialisti di «storia della letteratura», del tutto impreparati ad affrontare il dominio iniziatico, la mancanza dei dati necessari per comprendere ed interpretare correttamente tutti i simboli iniziatici. Al contrario, bisogna riconoscere loro il merito di aver osato contraddire le opinioni ufficialmente accettate e le interpretazioni antitradizionali imposte dallo spirito profano che domina il mondo moderno; e bisogna essere loro grati per il fatto che, esponendo imparzialmente i risultati delle loro ricerche, mettono a nostra disposizione dei documenti nei quali possiamo trovare ciò che loro non hanno potuto scorgere; e ci auguriamo di veder apparire al più presto altri lavori dello stesso genere, in grado di apportare nuovi chiarimenti sulla questione così misteriosa e così complessa delle organizzazioni iniziatiche del Medioevo occidentale.
CAPITOLO OTTAVO IL SANTO GRAAL [Articolo pubblicato su Le Voile d’Isis, febbraio e marzo 1934] {in Simboli della Scienza Sacra – cap. 4} Arthur Edward Waite ha pubblicato un’opera sulle leggende del Santo Graal [The Holy Grail, its legends and symbolism, Londra, Rider and Co., 1933], imponente sia per dimensioni che per numero di ricerche presentate, e nella quale tutti coloro che si interessano di questo argomento potranno trovare una esposizione completa e metodica del contenuto dei molteplici testi che vi si riferiscono, così come delle diverse teorie che sono state avanzate per spiegare l’origine ed il significato di queste leggende, molto complesse e, talvolta, anche contraddittorie in alcuni loro elementi. Occorre aggiungere che Waite non ha inteso fare solo un lavoro di erudizione, e questo è degno ugualmente di lode, poiché siamo completamente d’accordo con lui sul poco valore di quei lavori che non vanno oltre un tale punto di vista ed il cui interesse si riduce ad essere solo «documentario»; egli ha voluto estrarre il senso reale ed «interiore» del simbolismo del Santo Graal e della «cerca». Sfortunatamente, dobbiamo dire che questa parte della sua opera è quella che ci sembra la meno soddisfacente; le conclusioni alle quali egli giunge sono anche piuttosto deludenti, soprattutto se si pensa a tutto il lavoro di ricerca da lui compiuto; ed è proprio su queste conclusioni che vogliamo formulare alcune osservazioni, le quali, d’altronde, si ricollegano, naturalmente, a delle questioni che abbiamo trattato in altre occasioni. Non crediamo di offendere Waite se diciamo che la sua opera è un po’ one-sighted; dobbiamo tradurre in francese con «parziale»? Forse questo non è proprio esatto e, in ogni caso, non intendiamo dire che lo sia volutamente; piuttosto si tratterebbe di uno di quei difetti così frequenti in coloro che, essendosi «specializzati» in un certo campo di studi, sono portati a ricondurvi qualunque cosa o a trascurare ciò che non vi si lascia ricondurre. Che la leggenda del Graal sia cristiana non è certo contestabile, e Waite ha ragione di affermarlo, ma questo impedisce forse che essa sia contemporaneamente qualcosa d’altro? Coloro che hanno coscienza dell’unità fondamentale di tutte le tradizioni non vedrebbero, in questo caso, nessuna incompatibilità; ma Waite, in un certo modo, riesce a scorgere solo quello che è specificamente cristiano, limitandosi così ad una forma tradizionale particolare, per cui non riesce a cogliere i rapporti fra gli altri ambiti e quello cristiano, rapporti che sono assicurati proprio dall’aspetto «interiore» del Cristianesimo. Non è che egli neghi l’esistenza di elementi di altra provenienza, probabilmente anteriori al Cristianesimo, poiché questo sarebbe contrario ad ogni evidenza, ma accorda loro una ben ridotta importanza e sembra considerarli come «accidentali», come se si fossero sovrapposti alla leggenda «dal di fuori» e solo a causa dell’ambiente in cui questa è stata elaborata. Cosicché questi elementi sono da lui considerati come derivanti da quello che si è convenuto chiamare folklore, non sempre in senso spregiativo, come potrebbe far supporre la parola stessa, ma piuttosto per soddisfare una sorta di «moda» dei nostri tempi, senza rendersi sempre conto delle intenzioni che si trovano implicate in tale moda. Riteniamo quindi che non sarà inutile soffermarci su questo punto. La stessa concezione di folklore, così come lo si intende abitualmente, si fonda su un’idea radicalmente falsa, l’idea che vi siano delle «creazioni popolari», prodottesi spontaneamente dalla massa del popolo; e si nota subito lo stretto rapporto fra questo modo di vedere ed i pregiudizi «democratici». Come è stato detto molto giustamente, «il profondo interesse che posseggono tutte le tradizioni cosiddette popolari risiede soprattutto nel fatto che esse non sono di origine popolare» [Luc Benoist, La Cuisine des Anges, une esthétique de la pensée, Parigi, 1932, p. 74]; e noi aggiungiamo che, allorquando si tratta, come quasi sempre accade, di elementi tradizionali nel vero senso della parola, pur deformati, ridotti o frammentari che possano essere, tutto ciò, lungi dall’essere d’origine popolare, non è neanche di origine umana. Quando questi elementi appartengono a delle forme tradizionali scomparse, ciò che può essere popolare è unicamente il fatto della «sopravvivenza». A riguardo, il termine folklore assume un significato molto vicino a quello di «paganesimo», al di là della etimologia di quest’ultimo e senza la sua intenzione «polemica» ed ingiuriosa. È così che, senza comprenderle, il popolo conserva i resti di antiche tradizioni, che talvolta risalgono ad un passato così lontano che sarebbe impossibile da determinare, e che per questo ci si accontenta di collocare nell’ambito oscuro della «preistoria»; esso svolge così la funzione di una sorta di memoria collettiva più o meno «sub-cosciente», il cui contenuto proviene chiaramente dal di fuori [È questa una funzione essenzialmente «lunare», ed è interessante notare che, secondo l’astrologia, la massa popolare corrisponde effettivamente alla Luna, cosa che, al tempo stesso, esprime bene il suo carattere puramente passivo, incapace di iniziativa o di spontaneità]. La cosa più sorprendente è che, se si esamina tale folklore con la dovuta attenzione, si constata che quanto si è così conservato contiene soprattutto, sotto una forma più o meno velata, un numero considerevole di dati di ordine esoterico, vale a dire proprio di tutto ciò che vi è di meno popolare per sua natura; e questo suggerisce da sé una spiegazione che cercheremo di indicare in poche parole. Allorché una forma tradizionale è sul punto di estinguersi, i suoi ultimi rappresentanti possono benissimo affidare volontariamente, a questa memoria collettiva di cui abbiamo parlato, ciò che diversamente si perderebbe per sempre; si tratta, insomma, del solo mezzo per salvare, in una certa misura, il salvabile; al tempo stesso, l’incomprensione naturale della massa è una garanzia sufficiente perché tutto ciò che possiede un carattere esoterico non venga alterato, ed anzi, come una sorta di testimonianza dei passato, si conservi solo per coloro che, in tempi diversi, saranno capaci di comprenderlo. Detto ciò, non vediamo perché si debba annoverare come folklore, senza alcun attento esame, tutto quello che è appartenuto a delle tradizioni diverse dal Cristianesimo, facendo eccezione solo per esso; tale sembra essere l’intenzione di Waite, allorché accetta questa denominazione per gli elementi «pre-cristiani» ed in particolare per gli elementi celtici che si riscontrano nelle leggende del Graal. Sotto questo profilo non esistono delle forme tradizionali privilegiate; la sola distinzione da fare è quella fra forme scomparse e forme ancora viventi, e quindi tutta la questione si ridurrebbe nel sapere se la tradizione celtica aveva realmente cessato di esistere al tempo in cui si formarono le leggende in argomento. Il che è quanto meno contestabile: per un verso, questa tradizione può essersi conservata più a lungo di quanto generalmente si creda, con una organizzazione più o meno nascosta; per l’altro, queste stesse leggende potrebbero essere molto più antiche di quanto pensino i «critici», non in quanto siano potuti esistere dei testi oggi scomparsi, ai quali non crediamo al pari di Waite, ma in forza di una trasmissione orale che può essere durata parecchi secoli; cosa questa che è lungi dall’essere un fatto eccezionale. Da parte nostra pensiamo che si tratti della testimonianza di un «raccordo» fra due forme tradizionali, l’una vecchia e l’altra nuova: la tradizione celtica e la tradizione cristiana; raccordo per mezzo del quale ciò che doveva essere conservato della prima fu, in qualche modo, incorporato nella seconda, senza dubbio subendo una certa modifica esteriore a causa dell’adattamento e dell’assimilazione, ma certo non fino a trasporsi su un piano diverso, come pretenderebbe Waite, poiché esistono delle equivalenze in seno a tutte le tradizioni regolari; siamo quindi in presenza di ben altro che una semplice questione di «fonti», nel senso in cui l’intendono gli eruditi. Forse sarebbe difficile precisare esattamente il luogo ed il giorno in cui avvenne un tale raccordo, ma ciò ha solo un interesse secondario e quasi unicamente storico; d’altronde, è facile comprendere che queste sono cose che non lasciano delle tracce in «documenti» scritti. A riguardo, la «Chiesa celtica» o «culdea» meriterebbe forse più attenzione di quella che sembra sia disposto a concedergli Waite; la sua stessa denominazione dovrebbe già suggerirla; e non v’è niente di inverosimile nel fatto che alle sue spalle vi sia stato qualcosa di ordine non più religioso ma iniziatico, poiché, come tutto ciò che si riferisce ai legami esistenti fra le diverse tradizioni, anche questo «raccordo» compete necessariamente al dominio iniziatico o esoterico. L’exoterismo, sia esso religioso o no, non va mai oltre i limiti della forma tradizionale alla quale propriamente appartiene; ciò che oltrepassa questi limiti non può appartenere ad una «Chiesa» come tale, questa può solo costituire il «supporto» esterno; ed è questo un punto sul quale, in seguito, avremo occasione di ritornare. Occorre adesso che facciamo un’osservazione concernente, in particolare, il simbolismo: vi sono dei simboli che sono comuni alle forme tradizionali più diverse e più distanti fra loro, non tanto a seguito degli «imprestiti», che in molti casi sarebbero del tutto impossibili, ma perché essi appartengono in realtà alla Tradizione primordiale, da cui queste diverse forme sono tutte derivate, direttamente o indirettamente. Il simbolo del vaso o della coppa è precisamente uno di questi; perché, quando si tratta di tradizioni «precristiane», tutto quello che ad esso si riferisce sarebbe solo folklore, e invece solo nel Cristianesimo sarebbe un simbolo essenzialmente «eucaristico»? In questo caso sono da respingere, non tanto le assimilazioni di Burnouf o di altri, quanto le interpretazioni «naturaliste» che essi hanno voluto estendere al Cristianesimo, come a tutto il resto, e che in realtà non sono valide in nessun caso. Occorrerebbe dunque fare, qui, esattamente il contrario di ciò che fa Waite, il quale, attenendosi a delle spiegazioni esteriori e superficiali, e che accetta fiducioso fin tanto che non si tratta del Cristianesimo, individua dei significati radicalmente diversi e senza relazione fra loro, lì ove si tratta invece di aspetti molteplici di uno stesso simbolo o delle sue diverse applicazioni; senza dubbio le cose sarebbero state diverse se egli non fosse stato condizionato dalla sua idea preconcetta che il Cristianesimo è qualcosa di eterogeneo rispetto alle altre tradizioni. Per ciò che riguarda la leggenda del Graal, Waite rifiuta anche, molto giustamente, le teorie che si rifanno ai presunti «dei della vegetazione»; ma è spiacevole il fatto che sia molto meno deciso allorché si tratta dei Misteri antichi, i quali non hanno mai avuto niente in comune con questo «naturalismo» di invenzione tutta moderna; gli «dei della vegetazione» ed altre storie dello stesso genere sono solo esistiti nell’immaginazione di Frazer e dei suoi simili, le cui intenzioni antitradizionali sono d’altronde fuori da ogni dubbio. A dire la verità, sembra anche che Waite sia più o meno influenzato da un certo «evoluzionismo»; in particolare egli tradisce questa tendenza quando dichiara che la cosa più importante non è tanto l’origine della leggenda, quanto l’ultimo stadio al quale essa è poi pervenuta; e sembra credere che, da una fase all’altra, si sia determinato una sorta di progressivo perfezionamento. In realtà, se si tratta di qualcosa che possiede un vero carattere tradizionale, essa dovrà contenere tutti i suoi componenti fin dall’inizio, e gli eventuali sviluppi successivi possono solo renderli più espliciti, senza alcuna aggiunta di elementi nuovi e venuti dal di fuori. Waite sembra ammettere una sorta di «spiritualizzazione», in base alla quale un significato superiore avrebbe potuto innestarsi su qualcosa che all’inizio non lo conteneva; in effetti, ciò che generalmente accade è proprio il contrario, mentre questa sua concezione ricorda, un po’ troppo, le vedute profane degli «storici delle religioni». A proposito dell’alchimia, infatti, troviamo un esempio molto chiaro di questa sorta di inversione: Waite pensa che l’alchimia materiale abbia preceduto l’alchimia spirituale, e che quest’ultima sarebbe comparsa solo con Khunrath e Jacob Boehme; se egli conoscesse certi trattati arabi, ben anteriori rispetto a questi due autori, sarebbe obbligato, anche in base ai documenti scritti, a modificare questa sua opinione; per di più, dal momento che riconosce che il linguaggio impiegato è lo stesso in entrambi i casi, potremmo chiedergli come fa ad essere sicuro che in tal testo o nell’altro si parla solo di operazioni materiali. La verità è che non sempre si è ritenuto necessario dichiarare espressamente che si trattava di qualcosa di diverso da quello che appariva, anzi, al contrario, questo qualcosa doveva essere velato proprio per mezzo del simbolismo utilizzato; e se in seguito si è giunti al punto che alcuni lo abbiano dichiarato, ciò è accaduto soprattutto in seguito a delle degenerazioni, dovute al fatto che vi fu della gente che, ignorando il valore dei simboli, prese tutto alla lettera ed in un senso esclusivamente materiale: costoro furono i «soffiatori», i precursori della chimica moderna. Supporre che si possa dare ad un simbolo un nuovo significato, che non possedeva già di per sé, equivale quasi a negare il simbolismo, poiché significa trasformarlo in qualcosa di artificiale, se non addirittura di completamente arbitrario, ed in ogni caso in qualcosa di puramente umano. Seguendo quest’ordine di idee, Waite arriva perfino a dire che ciascuno trova in un simbolo ciò che lui stesso vi immette, tanto che il suo significato cambierebbe a seconda della mentalità di un’epoca; ritroviamo qui le teorie «psicologiche» care a gran parte dei nostri contemporanei; e non avevamo dunque ragione a parlare di «evoluzionismo»? L’abbiamo detto spesso e non basterà mai ripeterlo: ogni vero simbolo porta con sé i suoi molteplici significati e fin dall’origine, poiché esso non è costituito, come tale, in virtù di una convenzione umana, ma in virtù della «legge di corrispondenza» che collega tra loro tutti i mondi; che taluni riescano a vedere questi significati, mentre altri non vi riescono o vi riescono solo in parte, non toglie nulla al fatto che essi sono tutti contenuti nel simbolo; tutta la differenza sta nell’«orizzonte spirituale» di ognuno. Il simbolismo è una scienza esatta e non una fantasticheria ove possono liberamente fluire le fantasie individuali. In questo ambito, noi non crediamo alle «invenzioni dei poeti», a cui Waite sembra invece essere disposto a concedere un vasto credito; queste invenzioni, lungi dal condurre all’essenziale, non fanno altro che nasconderlo, volontariamente o no, avviluppandolo con le apparenze ingannatrici di una «finzione» qualunque; e talvolta tali finzioni lo nascondono fin troppo bene, poiché, quando si fanno troppo invadenti, finisce che diventa quasi impossibile riscoprire il significato profondo ed originario; non è così che, presso i Greci, il simbolismo degenerò in «mitologia»? Questo pericolo si paventa soprattutto quando lo stesso poeta non ha coscienza del valore reale dei simboli, poiché è evidente che questa è un’eventualità che può presentarsi benissimo; l’apologo dell’«asino che porta le reliquie» si applica qui allo stesso titolo che in altri casi: il poeta svolge, allora, un ruolo analogo a quello della moltitudine profana, che conserva e trasmette, a sua insaputa, dei dati iniziatici, così come abbiamo detto prima. Qui la questione si pone in maniera particolare: gli autori dei romanzi del Graal appartennero a quest’ultima categoria o, al contrario, avevano coscienza, in un modo o nell’altro, del significato profondo di ciò che esprimevano? Certo, non è facile rispondere con esattezza, poiché, ancora una volta, le apparenze possono indurre in errore: in presenza di un miscuglio di elementi insignificanti ed incoerenti si è tentati di pensare che l’autore non sapesse di che cosa parlava; tuttavia, non è necessariamente così, poiché molto spesso si è verificato che le oscurità e le stesse contraddizioni fossero decisamente volute, e che i dettagli inutili avessero proprio lo scopo di sviare l’attenzione dei profani, allo stesso modo che un simbolo può essere intenzionalmente dissimulato in un motivo ornamentale più o meno complicato; gli esempi di questo genere abbondano, soprattutto nel Medioevo, non foss’altro che presso Dante ed i «Fedeli d’Amore». Il fatto che il senso superiore traspaia meno in Chrestien de Troyes, per esempio, che in Robert de Boron, non prova dunque necessariamente che il primo ne sia stato meno cosciente del secondo; e né tampoco si potrebbe concludere che questo senso superiore sia assente dai suoi scritti: si tratterebbe di un errore paragonabile a quello che si commette nell’attribuire agli antichi alchimisti delle preoccupazioni di ordine unicamente materiale per il solo motivo che essi non ritennero opportuno scrivere a chiare lettere che la loro scienza era in realtà di natura spirituale [Se, come sembra, Waite crede che certe cose siano troppo «materiali» per essere compatibili con l’esistenza di un significato superiore, nei testi ove esse si riscontrano, potremmo chiedergli che ne pensa, per esempio, di Rabelais e di Boccaccio]. Dopo tutto, la questione dell’«iniziazione» degli autori dei romanzi è forse meno importante di quanto si potrebbe pensare di prim’acchito, poiché in ogni caso essa non cambia niente delle apparenze con cui viene presentato il soggetto; ci si trova, in effetti, al cospetto di un’«esteriorizzazione» di dati esoterici che non potrebbe essere, in alcun modo, una «volgarizzazione», ed è facile comprendere che doveva essere solo così. Diremo di più: per effettuare una tale «esteriorizzazione», un profano poteva anche servire da «portaparola» ad una organizzazione iniziatica, che lo avrebbe scelto, a questo scopo, semplicemente per le sue doti di poeta o di scrittore o per qualunque altra ragione contingente. Dante scriveva con perfetta cognizione di causa; Chrestien de Troyes, Robert de Borron e molti altri furono probabilmente molto meno coscienti di ciò che esprimevano e forse alcuni fra loro non lo furono del tutto; ma in fondo poco importa, poiché se dietro di essi vi era un’organizzazione iniziatica, qualunque essa fosse d’altronde, il pericolo di una deformazione dovuta alla loro incomprensione veniva ad essere, per ciò stesso, eliminato: questa organizzazione poteva guidarli costantemente, senza che essi se ne accorgessero, sia per mezzo di alcuni suoi membri che fornivano gli elementi da inserire nella loro opera, sia per mezzo di suggerimenti e di influenze di altro genere, più sottili e meno tangibili, ma non per questo meno reali e meno efficaci. È facile comprendere che tutto questo non ha niente a che vedere con la sedicente «ispirazione» poetica, così com’è intesa dai moderni, la quale, in realtà è della pura e semplice immaginazione; né con la «letteratura», nel senso profano del termine; e aggiungiamo subito che non si tratta nemmeno di «misticismo». Ma quest’ultimo punto è strettamente connesso ad altre questioni che affronteremo nella seconda parte di questo studio. *** Ci sembra che, senza dubbio, le origini della leggenda del Graal debbano essere ricercate nella trasmissione di elementi tradizionali, di ordine iniziatico, dal Druidismo al Cristianesimo; e dato che tale trasmissione venne effettuata regolarmente, qualunque siano state le modalità, questi elementi, da allora, divennero parte integrante dell’esoterismo cristiano. Noi concordiamo con Waite su questo secondo punto, ma ci sembra che egli non abbia afferrato il primo. L’esistenza dell’esoterismo cristiano nel Medioevo è cosa assolutamente certa; le prove di ogni genere abbondano e le negazioni dovute all’incomprensione moderna, che provengano da sostenitori o da avversari del Cristianesimo, non possono far nulla contro questo fatto; abbiamo avuto occasione di parlare abbastanza spesso di questa questione, per dovervi insistere adesso. Ma, fra quegli stessi che ammettono l’esistenza di questo esoterismo, ve ne sono molti che ne hanno una concezione più o meno inesatta, e fra costoro sembra esserci Waite, a giudicare dalle sue conclusioni; in esse vi sono anche delle confusioni e dei malintesi che è necessario chiarire. Innanzi tutto, si noti bene che noi diciamo «esoterismo cristiano» e non «cristianesimo esoterico», infatti non si tratta per niente di una speciale forma di Cristianesimo, ma dell’aspetto «interno» della tradizione cristiana; ed è facile comprendere che parliamo di molto più che di una semplice sfumatura. Inoltre, allorché in una forma tradizionale si pone il caso di distinguere, come qui, due diversi aspetti, l’uno exoterico e l’altro esoterico, dev’essere ben chiaro che essi non si riferiscono allo stesso dominio, sicché non è possibile che fra di essi si instauri conflitto o opposizione di alcun genere; in particolare, allorché l’exoterismo riveste un carattere specificamente religioso, come in questo caso, il corrispondente esoterismo, pur assumendo il primo come base e supporto, di per sé non ha niente a che vedere col dominio religioso e si colloca su un piano del tutto diverso. Ne consegue, in modo evidente, che questo esoterismo non può, in nessun caso, essere rappresentato da «Chiese» o da «sette» di alcun genere, le quali, per definizione stessa, sono sempre qualcosa di religioso, quindi di exoterico. Quest’ultimo aspetto della questione è stato da noi trattato in altre occasioni, è sufficiente quindi ricordarlo sommariamente: alcune «sette» sono nate come il risultato di una confusione fra questi due domini, e di una «esteriorizzazione» erronea di dati esoterici, mal compresi e male applicati; ma le vere organizzazioni iniziatiche, nel mantenersi scrupolosamente entro l’ambito loro proprio, rimasero necessariamente estranee a queste deviazioni, e la loro stessa «regolarità» le obbligava a riconoscere solo ciò che presentava un carattere d’ortodossia, foss’anche nell’ordine exoterico. Con questo, dunque, appare certo che coloro i quali vogliono riferire a delle «sette» ciò che riguarda l’esoterismo e l’iniziazione sono sulla falsa strada e non possono che perdersi; e non servono certo più ampi esami per scartare ogni ipotesi del genere. Se in alcune «sette» si ritrovano degli elementi che possono sembrare di natura esoterica, bisogna dedurne non tanto che questi traggano origine dalle «sette» stesse, ma, al contrario, che in esse ne è stato distorto il vero significato. Ciò posto, alcune apparenti difficoltà si trovano ben presto risolte, o per meglio dire, ci si accorge che non sono mai esistite; così, non è neanche il caso di chiedersi qual è la posizione, rispetto all’ortodossia cristiana intesa in senso ordinario, di una linea di trasmissione al di fuori della «successione apostolica», come quella di cui si tratta in certe versioni della leggenda del Graal; se ci si trova di fronte ad una gerarchia iniziatica, la gerarchia religiosa non viene ad essere minimamente intaccata da questa sua esistenza, e d’altronde, la stessa gerarchia religiosa non deve affatto riconoscerla «ufficialmente», se così si può dire, poiché essa esercita la sua legittima giurisdizione solo nel dominio exoterico. Lo stesso vale allorché si tratta di una formula segreta in relazione con certi riti; detto francamente, coloro che si chiedono se la perdita o l’omissione di questa formula non rischi di impedire che la celebrazione della Messa possa essere considerata valida, danno prova di una singolare ingenuità; la Messa, così com’è, è un rito religioso e fu un rito iniziatico, ciascuno valido nel proprio ordine; ed anche se entrambi hanno in comune un carattere «eucaristico», ciò non cambia nulla di questa essenziale distinzione, esattamente come uno stesso simbolo che può essere interpretato simultaneamente dai due diversi punti di vista, exoterico ed esoterico, senza che questi smettano di essere estremamente distinti e di essere attinenti a dei domini totalmente differenti. Nonostante le eventuali rassomiglianze esteriori, che d’altronde si spiegano in base a certe corrispondenze, la portata e lo scopo dei riti iniziatici sono del tutto diversi da quelli dei riti religiosi. A maggior ragione, non è il caso di indagare se la formula misteriosa di cui si tratta possa essere identificata con una formula in uso in tale o tal’altra Chiesa, che è in possesso di rituali più o meno speciali; intanto, dal momento che si tratta di Chiese tutte rientranti nell’ortodossia, le varianti del rituale sono del tutto secondarie e non possono per niente vertere su qualcosa di essenziale; poi, questi rituali non potrebbero essere nient’altro che religiosi e, come tali, perfettamente equivalenti, per cui la presa in considerazione dell’uno o dell’altro di essi non ci avvicinerebbe di un passo al punto di vista iniziatico; quante ricerche e discussioni inutili si risparmierebbero se, innanzi tutto, si fosse ben a conoscenza dei prìncipi! Ora, il fatto che gli scritti riguardanti la leggenda del Graal furono ispirati, direttamente o indirettamente, da una organizzazione iniziatica, non vuole affatto dire che costituiscono un rituale di iniziazione, come supposto bizzarramente da qualcuno; ed è curioso notare che una simile ipotesi non è stata mai avanzata, almeno a quanto ne sappiamo, nei confronti di opere che, tuttavia, descrivono molto più chiaramente un percorso iniziatico, come la Divina Commedia o il Roman de la Rose; è chiaro che tutti gli scritti che presentano un carattere esoterico non sono, per questo, dei rituali. Waite, che molto giustamente rigetta questa supposizione, ne mette in risalto le inverosimiglianze: tale è, in particolare, il fatto che il preteso recipiendario avrebbe una domanda da porre, invece di dover rispondere alle domande dell’iniziatore, così come avviene generalmente; e noi potremmo aggiungere che le differenze che esistono fra le diverse versioni sono incompatibili con il carattere di un rituale, il quale necessariamente ha una forma fissa e ben definita; ma, tutto ciò in che modo impedisce che la leggenda si ricolleghi, a qualche altro titolo, a ciò che Waite chiama Instituted Mysteries, e che noi chiamiamo, più semplicemente, organizzazioni iniziatiche? Il fatto è che lui, a proposito di quest’ultime, ha un’idea troppo limitata e, per molti aspetti, inesatta: per un verso, sembra concepirle come qualcosa di quasi esclusivamente «cerimoniale», il che, lo diciamo di sfuggita, corrisponde ad un modo di vedere tipicamente anglosassone; per l’altro, seguendo un errore molto diffuso e sul quale abbiamo già insistito molto spesso, egli se le raffigura, più o meno, come delle «società», mentre invece se alcune di esse hanno finito con l’assumere una tale forma, si tratta solo della conseguenza di una sorta di degenerazione del tutto moderna. Senza dubbio egli ha conosciuto, per esperienza diretta, un buon numero di queste associazioni pseudo-iniziatiche che pullulano oggi in Occidente, e, anche se sembra esserne rimasto piuttosto deluso, nondimeno, in un certo senso, è rimasto influenzato da ciò che vi ha visto: vogliamo dire che dal momento che non è in grado di percepire chiaramente la differenza fra l’iniziazione autentica e la pseudo-iniziazione, egli attribuisce alle vere organizzazioni iniziatiche dei caratteri paragonabili a quelli delle contraffazioni con cui si è trovato in contatto; e questo errore comporta anche delle altre conseguenze che, come vedremo, intaccano direttamente le conclusioni positive del suo studio. In realtà, è evidente che tutto ciò che è di ordine iniziatico non potrebbe, in alcun modo, rientrare in un quadro così ristretto come è quello delle «società» costituite alla maniera moderna; ma, proprio quando Waite non trova più niente che assomigli, da vicino o da lontano, a queste «società», ecco che si perde e finisce con l’ammettere la supposizione fantastica di una iniziazione che può esistere al di fuori di ogni organizzazione e di ogni regolare trasmissione, e, a questo punto, non possiamo far altro che rinviare agli articoli da noi dedicati a tale questione [(Questi articoli sono stati poi raccolti ed ordinati, da R. Guénon, in Considerazioni sulla Via Iniziatica)]. Il fatto è che, al di fuori di queste «società» egli, chiaramente, non vede altra possibilità che quella rappresentata da un qualcosa di vago e di indefinito che chiama «Chiesa segreta» o «Chiesa interiore», secondo delle espressioni tratte da mistici come Eckartshausen e Lopoukine, e nelle quali lo stesso termine di «Chiesa» sta ad indicare che, in realtà, ci si trova ricondotti, puramente e semplicemente, al punto di vista religioso; e niente cambia anche quando si trattasse di qualcuna di quelle varietà, più o meno aberranti, nelle quali il misticismo tende spontaneamente a svilupparsi, una volta sfuggito al controllo di una rigorosa ortodossia. Effettivamente Waite è, anche lui, uno di quelli, sfortunatamente così numerosi al giorno d’oggi, che per diverse ragioni confondono misticismo e iniziazione; ed egli, in qualche modo, finisce col parlare indifferentemente dell’una o dell’altra cosa, incompatibili fra loro, come se fossero quasi dei sinonimi. Ciò che lui crede sia iniziazione, in definitiva, si riduce ad essere una semplice «esperienza mistica»; e ci chiediamo anche se, in fondo, egli non concepisca tale «esperienza» come qualcosa di «psicologico», il che ci condurrebbe ad un livello inferiore a quello del misticismo inteso nel suo vero significato, poiché i veri stati mistici esulano completamente dal dominio della psicologia, a dispetto di tutte le moderne teorie del tipo di quelle di William James, che ne è il rappresentante più conosciuto. Quanto agli stati interiori la cui realizzazione dipende dall’ordine iniziatico, essi non sono né degli stati psicologici né tampoco degli stati mistici, essi sono qualcosa di più profondo e, nello stesso tempo, non sono affatto di quelle cose di cui non si riesce a dire bene da dove vengono né cosa siano esattamente, ma, al contrario, essi implicano una conoscenza esatta ed una tecnica precisa; sentimentalità ed immaginazione, in questo caso, non svolgono più la sia pur minima parte. Trasporre le verità di ordine religioso nell’ordine iniziatico non significa affatto dissolverle fra i fumi di un «ideale» qualunque, ma, al contrario, corrisponde a penetrarne il senso più profondo e, al tempo stesso, più «positivo», eliminando tutti gli offuscamenti che bloccano o circoscrivono la visione intellettuale dell’umanità ordinaria. A dire il vero, in una concezione come quella di Waite non si tratta tanto di trasposizione ma, tutt’al più, se si vuole, di una sorta di prolungamento o di estensione in «orizzontale», poiché tutto ciò che è misticismo fa parte del dominio religioso e non va al di là di esso; per andare effettivamente al di là occorre ben altro che l’aggregazione ad una «Chiesa» qualificata come «interiore», soprattutto perché, a quanto sembra, questa non ha che un’esistenza semplicemente «ideale», cosa che, tradotta in termini più chiari, equivale col dire che, in effetti, è un’organizzazione immaginaria. Il «segreto del Graal» non potrebbe consistere, realmente, in cose di questo genere, e ciò vale per qualunque reale segreto iniziatico; se si vuol sapere dove si trova questo segreto bisogna riferirsi alla costituzione, molto «positiva», dei centri spirituali, così come l’abbiamo indicata, molto esplicitamente, nel nostro studio su «Re del Mondo. A questo proposito, ci limiteremo a far notare che Waite sfiora talvolta delle cose di cui sembra gli sfugga la portata: a più riprese, egli giunge fino a parlare di cose «sostituite», che possono essere delle parole o degli oggetti simbolici; ora, questi possono riferirsi sia ai diversi centri secondari, in quanto immagini o riflessi del Centro supremo, sia alle fasi successive dell’«oscuramento» che, in conformità con le leggi cicliche, si produce gradualmente nella manifestazione di questi stessi centri, in rapporto al mondo esteriore. D’altronde, il primo di questi due casi rientra, in un certo senso, nel secondo, poiché la costituzione stessa dei centri secondari, corrispondendo a particolari forme tradizionali, qualunque esse siano, segna già un primo grado di oscuramento nei confronti della Tradizione primordiale; in effetti, il Centro supremo, da allora, non è più in contatto diretto con l’esterno, ed il legame è mantenuto per mezzo dei centri secondari. D’altra parte, se uno di questi centri finisce con lo scomparire, si può dire che, in qualche modo, viene riassorbito dal Centro supremo, di cui era solo un’emanazione; ed anche in questa fase, del resto, bisogna tenere conto di una certa gradualità: può accadere che un tale centro divenga solamente più nascosto e più chiuso, e questo fatto può essere rappresentato per mezzo dello stesso simbolismo che indicherebbe la sua completa sparizione, poiché ogni allontanamento dall’esteriore è, al tempo stesso ed in misura equivalente, un ritorno verso il Principio. È chiaro che noi alludiamo al simbolismo della sparizione del Graal: che questo sia stato assunto in Cielo, secondo certe versioni, o che sia stato trasportato nel «Regno del Prete Gianni», secondo certe altre, significa esattamente la stessa cosa, ma Waite sembra che non lo sospetti neanche [Dal fatto che una lettera attribuita al Prete Gianni sia chiaramente apocrifa, Waite ritiene di poter concludere che non sia mai esistito; argomentazione questa che è perlomeno singolare. La questione dei rapporti fra la leggenda del Graal e l’Ordine del Tempio è da lui trattata in maniera altrettanto sommaria; sembra che abbia, senza dubbio inconsciamente, una certa fretta di scartare queste cose troppo significative ed inconciliabili con il suo «misticismo». Per ciò che riguarda le versioni tedesche della leggenda, ci sembra che, in generale, essi meritino un’attenzione maggiore di quanta gliene abbia accordata Waite]. Infatti si tratta sempre dello stesso ritrarsi dall’esteriore verso l’interiore, a causa delle condizioni del mondo in una data epoca o, per essere più esatti, delle condizioni di quella parte del mondo che è in relazione con la forma tradizionale considerata; d’altronde, in questo caso, il ritrarsi è riferito solo alla parte esoterica della tradizione, poiché la parte exoterica, il Cristianesimo, è rimasta senza apparenti cambiamenti; ma è proprio per mezzo della parte esoterica che si stabiliscono e si mantengono i legami effettivi e coscienti con il Centro supremo. Tuttavia, fintanto che questa forma tradizionale exoterica resta vivente, qualcosa della parte esoterica deve continuare a sussistere necessariamente, anche se, in qualche modo, invisibilmente; e non potrebbe essere altrimenti, perché allora equivarrebbe col dire che lo «spirito» si è completamente ritirato e non resta solo che un corpo morto. Si dice che il Graal non fu più visto come prima, ma non è detto che nessuno lo abbia più visto; sicuramente, almeno in linea di principio, esso è sempre presente per coloro che sono «qualificati»; ma, in effetti, costoro sono diventati sempre più rari, al punto da costituire solo un’infima eccezione; e, questi stessi, dall’epoca in cui si dice che i Rosacroce si ritirarono in Asia, letteralmente o simbolicamente che sia, quali probabilità di pervenire all’iniziazione possono trovare ancora aperte nel mondo occidentale? [Vedi introduzione in Feirefiz «La via del cuore», Ediz. Arktos (nota aggiunta dall’editore)].
CAPITOLO NONO
IL SACRO CUORE E LA LEGGENDA DEL SANTO GRAAL [Articolo pubblicato su Regnabit, 1925] {in Simboli della Scienza Sacra – cap. 3}
In uno dei suoi ultimi articoli [Regnabit, giugno 1925] Charbonneau-Lassay segnala, molto giustamente, che la leggenda del Graal è collegata a ciò che si potrebbe chiamare la «preistoria del Cuore Eucaristico di Gesù», poiché questa leggenda, scritta nel XII secolo ma dalle origini ancor più remote, è in realtà un adattamento cristiano di antichissime tradizioni celtiche. L’idea di questo accostamento ci era già venuta in occasione dell’articolo precedente, estremamente interessante dal punto di vista in cui noi ci poniamo, e intitolato Le coeur humain et la notion du Coeur de Dieu dans la religion de l’ancienne Egypte [Regnabit, novembre 1924], dal quale riportiamo il seguente passo: «Nei geroglifici, scrittura sacra ove spesso l’immagine della cosa rappresenta la parola stessa che la designa, il cuore fu invece rappresentato solo con un emblema: il vaso. In effetti, il cuore dell’uomo non è un vaso ove si elabora continuamente la sua vita tramite il suo sangue?». È proprio questo vaso, assunto come simbolo del cuore e ad esso sostituito nella ideografia egizia, che ci aveva fatto pensare immediatamente al Santo Graal, tanto più che in quest’ultimo, oltre al senso generale del simbolo (considerato d’altronde contemporaneamente sia sotto l’aspetto umano che divino), noi scorgiamo anche una speciale e molto precisa relazione con lo stesso Cuore di Cristo. In effetti, il Santo Graal è la coppa che contiene il prezioso sangue di Cristo, e lo contiene perfino due volte: una volta in occasione della cena, poi quando Giuseppe d’Arimatea vi raccoglie il sangue e l’acqua che sgorgano dalla ferita aperta sul fianco del Redentore dalla lancia del centurione. Questa coppa si sostituisce dunque, in un certo senso, al Cuore di Cristo, come ricettacolo del suo sangue; essa, per così dire, ne prende il posto e diviene un suo simbolo equivalente; ed allora, accanto a tutto questo, non è ancora più notevole che già anticamente il vaso fosse un emblema del cuore? D’altronde, la coppa, sotto una forma o l’altra, giuoca, al pari del cuore stesso, un ruolo molto importante in tante antiche tradizioni, e senza dubbio fu così anche presso i celti, poiché è da essi che deriva ciò che costituisce la base stessa o, quantomeno, la trama della leggenda del Graal. Dispiace il fatto che non si possa conoscere con precisione quale fosse la forma di questa tradizione, anteriormente al Cristianesimo, come si verifica del resto per tutto ciò che concerne le dottrine celtiche, per le quali l’unico modo di trasmissione usato fu l’insegnamento orale; comunque, esistono parecchie concordanze perché si possa almeno essere informati sul significato dei principali simboli in esse contenuti, e, in fondo, questa è la cosa essenziale. Ma veniamo alla leggenda, nella forma in cui ci è pervenuta; ciò che vi è detto circa l’origine stessa del Graal è particolarmente degno di attenzione: questa coppa sarebbe stata intagliata, dagli angeli, in uno smeraldo caduto dalla fronte di Lucifero al momento della sua cacciata. Questo smeraldo ricorda in maniera sorprendente l’urna, la perla frontale che, nell’iconografia indù, occupa spesso il posto del terzo occhio di Shiva e che rappresenta ciò che si potrebbe chiamare il «senso dell’eternità». Questo accostamento ci sembra più adatto di tanti altri a chiarire perfettamente il simbolismo del Graal; con esso si può anche cogliere una relazione in più con il cuore, il quale, per la tradizione indù come per molte altre, ma forse in una maniera più precisa, è il centro dell’essere integrale e quindi ad esso dev’essere direttamente riferito il «senso dell’eternità». Il Paradiso terrestre, infatti, era veramente il «Centro del Mondo», ovunque assimilato simbolicamente al Cuore divino; e non si può dire che Adamo, fintanto che rimase nell’Eden, viveva veramente nel Cuore di Dio? Ciò che segue è più enigmatico: Seth ottenne di rientrare nel Paradiso terrestre e poté così recuperare il prezioso vaso; ora, Seth è una delle figure del Redentore, tanto più che il suo stesso nome esprime l’idea di fondamento e di stabilità e annuncia, in qualche modo, la restaurazione dell’ordine primordiale distrutto dalla caduta dell’uomo. Da quel momento, dunque, si veniva ad avere, quantomeno, una restaurazione parziale, nel senso che Seth e coloro che dopo di lui avrebbero posseduto il Graal potevano stabilire, per ciò stesso, in qualche parte della terra, un centro spirituale che era come una immagine del Paradiso perduto. D’altronde, la leggenda non dice dove e da chi fu conservato il Graal fino all’epoca di Cristo, né come ne fu assicurata la trasmissione; ma l’origine celtica che gli si riconosceva, probabilmente deve lasciar intendere che i Druidi vi presero parte e devono essere annoverati fra i conservatori regolari della tradizione primordiale. In ogni caso, l’esistenza di un tale centro spirituale, o anche di più centri simultanei e successivi, non sembra che possa essere messa in dubbio, qualunque cosa si possa pensare della loro localizzazione; ciò che occorre notare è che a questi centri, sempre e dovunque, venne rivolta, fra le altre, la denominazione di «Cuore del Mondo», e che, in tutte le tradizioni, le descrizioni che ad essi si riferiscono, sono basate su un identico simbolismo, che è possibile seguire fin nei più piccoli dettagli. Tutto ciò non mostra a sufficienza che il Graal, o ciò che è così rappresentato, aveva già, anteriormente al Cristianesimo ed anche prima di ogni epoca, un legame strettissimo con il Cuore divino e con l’Emmanuel, cioè con la manifestazione, virtuale o reale a seconda delle età, ma pur sempre presente, del Verbo eterno in seno all’umanità terrestre? Dopo la morte di Cristo, il Santo Graal, secondo la leggenda, fu trasportato in Gran Bretagna da Giuseppe d’Arimatea e da Nicodemo; da quel momento incomincia a svolgersi la storia dei Cavalieri della Tavola Rotonda e delle loro imprese. La Tavola Rotonda era destinata a ricevere il Graal nel momento in cui uno dei Cavalieri fosse riuscito a conquistarlo ed a trasportarlo dalla Gran Bretagna in Armorica; questa tavola è anche un simbolo verosimilmente molto antico, uno di quelli che furono associati all’idea dei centri spirituali di cui abbiamo parlato. La forma circolare della tavola, d’altronde, è legata al «ciclo zodiacale» (ancora un simbolo che meriterebbe di essere studiato in modo particolare) per la presenza, intorno ad essa, dei dodici personaggi principali, particolarità che si ritrova nella costituzione di tutti i centri in questione. Ciò posto, non si deve scorgere nel numero dei dodici Apostoli un segno, fra moltissimi altri, della perfetta conformità del Cristianesimo alla tradizione primordiale, alla quale il nome di «pre-cristiana» converrebbe altrettanto esattamente? D’altra parte, a proposito della Tavola Rotonda, abbiamo notato una strana concordanza nelle rivelazioni simboliche fatte a Marie des Vallées (si veda Regnabit, nov. 1924); in esse si parla di «una tavola rotonda di diaspro che rappresenta il Cuore di Nostro Signore», a proposito di «un giardino che è il Santo Sacramento dell’altare», il quale, con le sue «quattro fontane di acqua viva», si identifica misteriosamente col Paradiso terrestre; non si tratta ancora di una conferma assai sorprendente ed inattesa dei rapporti di cui dicevamo prima? Naturalmente, queste brevissime note non potrebbero avere la pretesa di costituire uno studio completo su una questione così poco conosciuta; per il momento, noi ci dobbiamo limitare a fornire delle semplici indicazioni, e ci rendiamo perfettamente conto che suggeriamo delle considerazioni che, di prim’acchito, possono sorprendere un po’ coloro che non hanno famigliarità con le antiche tradizioni e con le loro abituali espressioni simboliche; ma ci riserviamo di svilupparle e di giustificarle più ampiamente in seguito, con degli articoli ove pensiamo di poter affrontare anche molti altri punti non meno degni di interesse. Per intanto, segnaliamo ancora, in relazione alla leggenda del Graal, una strana complicazione di cui non abbiamo ancora tenuto conto: per una di quelle assimilazioni verbali che nel simbolismo giuocano spesso un ruolo non trascurabile, e che d’altronde hanno forse delle motivazioni più profonde di quel che si potrebbe pensare a prima vista, il Graal è, al tempo stesso, un vaso (grasale) ed un libro (gradale o graduale). In certe versioni, i due sensi si trovano anche particolarmente accostati, poiché il libro, in certi casi, diventa un’iscrizione tracciata da Cristo o da un angelo sulla coppa stessa. Per adesso non vogliamo trarre alcuna conclusione, benché si potrebbero fare facilmente degli accostamenti con il «Libro della Vita» e con certi elementi del simbolismo apocalittico. Aggiungiamo anche che la leggenda associa al Graal altri oggetti, ed in particolare una lancia che, nell’adattamento cristiano, si identifica con quella del centurione Longino; ma ciò che è abbastanza curioso è la preesistenza di questa lancia, o di qualunque dei suoi equivalenti, come simbolo in qualche modo complementare della coppa, nelle antiche tradizioni. D’altra parte, presso i Greci, la lancia d’Achille era considerata come capace di guarire le ferite che aveva causato, e la leggenda medioevale attribuisce precisamente la stessa virtù alla lancia della Passione. E questo ci ricorda un’altra similitudine dello stesso genere: nel mito di Adone (il cui nome, del resto, significa «Il Signore»), allorché l’eroe viene colpito a morte dal grifo di un cinghiale (che in questo caso è un sostituto della lancia), il suo sangue, spargendosi in terra, fa nascere un fiore; ora, Charbonneau-Lassay ha segnalato «un ferro da ostie, del XII secolo, ove si vede il sangue delle piaghe del Crocifisso cadere in piccole gocce che si trasformano in rose, e la vetrata del XII secolo della Cattedrale di Angers, ove il sangue divino, scorrendo in rivoli, fiorisce anche informa di rose» [Regnabit, gennaio 1925]. Ritorneremo fra poco sul simbolismo floreale, considerato sotto un aspetto un po’ diverso, ma nonostante la molteplicità di significati presente in quasi tutti i simboli, tutto ciò si completa e si armonizza perfettamente e questa stessa molteplicità, lungi dall’essere un inconveniente o un difetto, è, al contrario, per chi sa comprenderla, uno dei principali vantaggi di un linguaggio che è molto meno limitato del linguaggio ordinario. Per completare queste note, indicheremo alcuni simboli che, nelle diverse tradizioni, si sostituiscono talvolta a quello della coppa e che, in fondo, sono ad essa identici; ciò non significa uscire dall’argomento, poiché lo stesso Graal, come è facile rendersene conto da quanto abbiamo avuto modo di dire, all’origine ha il medesimo significato che generalmente ha il vaso sacro, ovunque lo si incontri, come in particolare in Oriente, la coppa sacrificale contenente il Soma vedico (o l’Haoma mazdeo), che è una straordinaria «prefigurazione» eucaristica, su cui forse ritorneremo in qualche altra occasione. Ciò che il Soma raffigura propriamente è la «bevanda d’immortalità» (l’Amrita degli Indù e l’Ambrosia dei Greci, due parole etimologicamente simili), che conferisce o restituisce, a coloro che la ricevono in base alle disposizioni richieste, quel «senso dell’eternità» di cui dicevamo prima. Uno dei simboli di cui vogliamo anche parlare è il triangolo con la punta in basso; esso è una sorta di rappresentazione schematica della coppa sacrificale, e a questo titolo lo si riscontra in certi Yantras, o simboli geometrici, dell’India. D’altra parte, dal nostro attuale punto di vista, è importante notare che la stessa figura è anche un simbolo del cuore, di cui riproduce, d’altronde, la forma in maniera semplificata; il «triangolo del cuore» è un’espressione ricorrente nelle tradizioni orientali. Questo ci porta ad una considerazione altrettanto interessante: la raffigurazione del cuore inscritto in un triangolo con la punta in basso è, di per sé, una cosa perfettamente legittima, si trattasse del cuore umano o del Cuore divino, ed essa è anche assai significativa allorché la si confronta con gli emblemi usati da certi ermetisti cristiani del Medioevo, le cui intenzioni furono sempre pienamente ortodosse. Se talvolta, nei tempi moderni, si è voluto attribuire ad una tale rappresentazione un significato blasfemo [Regnabit, agosto-settembre 1924] è perché, coscientemente o no, si è alterato il significato primario dei simboli, fino ad invertire il loro valore normale; è questo un fenomeno di cui si potrebbero citare numerosi esempi e che d’altronde trova spiegazione nel fatto che certi simboli sono effettivamente suscettibili di una doppia interpretazione, in quanto presentano come due facce opposte. Il serpente, per esempio, ed anche il leone, non significano contemporaneamente, a seconda dei casi, Cristo e Satana? Non possiamo esporre qui, a riguardo, una teoria generale che ci condurrebbe molto lontano, ma si comprenderà che in tutto questo vi è qualcosa che rende assai delicata la manipolazione dei simboli e che quindi è necessaria un’attenzione tutta speciale allorché si tratta di scoprire il significato reale di certi emblemi e di tradurli correttamente. Un altro simbolo che spesso equivale a quello della coppa è il simbolo floreale: il fiore, in effetti, con la forma, non evoca un «ricettacolo»? E non si parla sempre del «calice», in un fiore? In Oriente, il fiore simbolico per eccellenza è il loto, in Occidente, invece, è la rosa che svolge spesso lo stesso ruolo. Ben inteso, non intendiamo certo dire che questo è l’unico significato della rosa, o anche del loto, poiché invece noi stessi ne abbiamo indicato un altro poco prima; ma certo guardiamo con piacere alla rosa del disegno ricamato sulla cartagloria dell’abbazia di Fontevrault [Regnabit, gennaio 1925, figura pag. 106]; qui essa è posta ai piedi di una lancia, lungo la quale scorrono delle gocce di sangue, e compare associata alla lancia esattamente come lo è altrove la coppa, per di più sembra proprio che essa raccolga le gocce di sangue piuttosto che provenire dalla trasformazione di una di esse; d’altronde però, i due significati si completano ancor più che opporsi, poiché queste gocce, cadendo sulla rosa, la vivificano e la fanno sbocciare. Si tratta della «rugiada celeste», secondo la figurazione così spesso impiegata in relazione con l’idea della Redenzione o con le idee, strettamente collegate, di rigenerazione e di resurrezione; ma anche questo richiederebbe lunghe spiegazioni, pur se ci limitassimo a metterne in rilievo la concordanza con le diverse tradizioni. D’altra parte, dal momento che si è parlato della Rosa-Croce a proposito del sigillo di Lutero [Regnabit, gennaio 1925], facciamo rilevare che questo emblema ermetico fu, all’inizio, specificamente cristiano, qualunque siano le false spiegazioni più o meno «naturaliste» che ne sono state date a partire dal secolo XVII; e non è interessante notare che la rosa occupi qui, al centro della croce, lo stesso posto del Sacro Cuore? A parte le rappresentazioni ove le cinque piaghe del Crocifisso sono raffigurate con altrettante rose, la rosa centrale, quando appare da sola, può benissimo identificarsi col Cuore stesso, col vaso che contiene il sangue e che è il centro della vita ed anche il centro dell’intero essere. Vi è ancora almeno un altro equivalente simbolico della coppa ed è la falce di Luna; ma la sua spiegazione comporterebbe degli sviluppi che sarebbero del tutto estranei all’oggetto del presente studio; la segnaliamo solo per non trascurare nessun aspetto della questione. Da tutti gli accostamenti che abbiamo segnalato si può già trarre una prima conseguenza, che noi speriamo di poter rendere più manifesta in futuro: allorché si trovano dappertutto concordanze simili, non si è in presenza di qualcosa di più che un semplice indizio dell’esistenza di una tradizione primordiale? E come spiegare allora che molto spesso coloro che, in un primo tempo, si credono obbligati ad ammetterla, in seguito non se ne danno più pensiero e di fatto ragionano esattamente come se questa non fosse mai esistita o, quantomeno, come se nulla se ne fosse conservato nel corso dei secoli? Se si vuole ben riflettere su ciò che vi è d’anormale in un simile atteggiamento, si riuscirà forse a non stupirsi più tanto di certe considerazioni che, in verità, possono apparire strane solo in forza delle abitudini mentali proprie della nostra epoca. D’altronde, basta cercare un po’, a patto di non trascinarsi dietro alcun partito preso, per scoprire in ogni dove dei precisi segni di questa essenziale unità dottrinale, la consapevolezza della quale ha potuto talvolta oscurarsi, agli occhi dell’umanità, ma che non è mai completamente sparita; e via via che ci si inoltra in tale ricerca, i punti di raffronto si moltiplicano quasi da soli e ad ogni istante compaiono nuove prove; certo il Quaerite et invenietis del Vangelo non è parola vana.
CAPITOLO DECIMO
CRISTO SACERDOTE E RE [Articolo apparso nel fascicolo di maggio-giugno 1927 della rivista cattolica Le Christ-Roi (Paray-le-Monial). (Il presente articolo è stato pubblicato in italiano, per la traduzione di T. Masera, nel fascicolo n° 25 della Rivista di Studi Tradizionali di Torino, di ottobre-dicembre 1967)].
Tra i numerosi simboli che sono stati attribuiti a Cristo, e dei quali molti si riallacciano alle più antiche tradizioni, diversi rappresentano soprattutto l’autorità spirituale nei suoi vari aspetti, ma anche ve ne sono che, nell’impiego abituale, fanno più o meno allusione al potere temporale; così, per fare un esempio, è frequente trovare nella mano del Cristo il «Globo del Mondo», insegna dell’Impero cioè della Regalità Universale. Sta di fatto che nella persona di Cristo le due funzioni sacerdotale e reale, a cui rispettivamente si riferiscono l’autorità spirituale e il potere temporale, sono veramente inseparabili l’una dall’altra: entrambe gli appartengono, eminentemente e per eccellenza, come al principio comune da cui l’una e l’altra procedono in tutte le loro manifestazioni. Senza dubbio può sembrare che alla funzione sacerdotale di Cristo sia stata data in genere una maggiore evidenza, e ciò è comprensibile data la superiorità dello spirituale sul temporale e la necessità di rispettare tale rapporto gerarchico tra le funzioni ad essi rispettivamente corrispondenti. La regalità è veramente di «diritto divino» solo se riconosce la propria subordinazione nei confronti dell’autorità spirituale, perché questa sola può conferirle l’investitura e la consacrazione che le dà la piena e completa legittimità. Sotto un certo aspetto, tuttavia, le due funzioni sacerdotale e reale possono anche essere viste come in qualche modo complementari l’una dell’altra, e però, benché in verità la seconda abbia il proprio principio immediato nella prima, si trova in esse, considerate nella fattispecie come separate, una sorta di parallelismo. In altri termini, dal momento che abitualmente il sacerdote non è nel contempo re, occorre che il sacerdote ed il re traggano i loro poteri da una sorgente comune: la differenza gerarchica tra i due consiste nel fatto che il sacerdote riceve il suo potere direttamente da tale sorgente, mentre il re, a causa del carattere più esteriore e propriamente terrestre della sua funzione, non può riceverne il suo se non tramite il sacerdote. Questi, in effetti, svolge veramente la funzione di «mediatore» tra il Cielo e la Terra; e non è senza ragione che la pienezza del sacerdozio ha ricevuto il nome simbolico «pontificato», perché, come afferma San Bernardo, «Il Pontefice, dall’etimologia stessa del suo nome, è una specie di ponte tra Dio e l’uomo» [Tractatus de moribus et officio episcoporum, III, 9]. Se quindi si vuole risalire all’origine prima dei poteri del sacerdote e del re, è soltanto nel mondo celeste che la si può trovare; tale sorgente primordiale, da cui deriva ogni autorità legittima, questo Principio nel quale risiedono ad un tempo il Sacerdozio e la Regalità supreme, non può essere che il Verbo Divino. Di conseguenza, Cristo, manifestazione del Verbo in questo mondo, deve realmente essere sacerdote e re insieme; ma, cosa che a prima vista può sembrare strana, la sua filiazione umana sembra designarlo prima di tutto per la funzione reale piuttosto che per quella sacerdotale. Egli è chiamato il «Leone della tribù di Giuda»: cosicché il leone, animale solare ed emblema regale di questa tribù, e specie della famiglia di Davide che è la sua, diventa il suo emblema personale. Se il sacerdozio ha la preminenza sulla regalità, come si spiega che il Cristo provenga da quella tribù reale di Giuda e da quella famiglia di Davide, e non dalla tribù sacerdotale di Levi e dalla famiglia di Aronne? Siamo di fronte ad un mistero che San Paolo si spiega in questi termini: «Se il sacerdozio di Levi, sotto il quale il popolo ha ricevuto la legge, avesse potuto rendere gli uomini giusti e perfetti, che bisogno ci sarebbe stato dell’avvento di un altro prete, chiamato tale nell’ordine di Melchisedec e non in quello di Aronne? Orbene, essendo cambiato il sacerdozio, anche la legge doveva necessariamente cambiare. In effetti, colui per cui valgono queste predizioni è di un’altra tribù di cui mai nessuno ha servito all’altare, poiché è certo che nostro Signore proviene da Giuda, tribù alla quale Mosè non ha mai attribuito il Sacerdozio. E ciò appare tanto più chiaro per il fatto che si assiste all’avvento di un altro sacerdote nell’ordine di Melchisedec, il quale non è affatto stabilito attraverso la legge di un ordine o di una successione carnale, bensì attraverso la potenza della sua vita immortale come lo afferma la scrittura con queste parole: «Tu sei eternamente sacerdote secondo l’ordine di Melchisedec» [Epistola agli Ebrei, VII, 11-17]. Così Cristo è sacerdote, ma puramente per diritto spirituale; lo è secondo l’ordine di Melchisedec, e non secondo l’ordine di Aronne o per effetto di successione carnale; per virtù di questa è la regalità che gli appartiene, e ciò è conforme alla natura delle cose. D’altronde, il sacerdozio secondo l’ordine di Melchisedec implica in se stesso anche la regalità; ed è appunto qui che l’uno e l’altra appaiono inseparabili, poiché anche Melchisedec è sacerdote e re ad un tempo, per cui egli raffigura realmente il Principio in cui i due poteri sono uniti, così come il sacrificio che egli offre con il pane e con il vino raffigura propriamente l’Eucarestia. È in virtù di questa doppia prefigurazione che è applicabile al Cristo la parola dei Salmi: «Tu es sacerdos in aetermum secundum ordinem Melchissedec» [Salmi, CIX, 4]. Ricordiamo il testo del passaggio biblico ove è narrato l’incontro di Melchisedec con Abramo: «E Melchisedec, re di Salem, fece portare del pane e del vino; ed egli era sacerdote di Dio l’Altissimo. Ed egli benedisse Abramo [È soltanto più tardi che il nome Abram fu cambiato in Abraham (Genesi XVIII)] dicendo: «Benedetto sia Abramo da parte di Dio l’Altissimo possessore dei Cieli e della Terra; e benedetto sia Dio l’Altissimo che ha consegnato i tuoi nemici fra le tue mani. E Abramo gli diede la decima di tutto quanto aveva preso» [Genesi XVI, 18-20]. Ed ecco in quali termini San Paolo commenta il testo: «Questo Melchisedec, re di Salem, sacerdote di Dio l’Altissimo, che si presentò davanti ad Abramo mentre questi tornava dalla disfatta dei re, che lo benedisse e a cui Abramo diede la decima di tutto il bottino, che è anzitutto, secondo il significato del suo nome, re di giustizia [È in effetti il significato letterale di Melki-Tsedeq in ebraico], poi re di Salem, cioè re della Pace; che è anche senza padre, senza madre, senza genealogia, la cui vita non ha inizio né fine, ma che così è fatto simile al Figlio di Dio, questo Melchisedec resta sacerdote in perpetuità» [Epistola agli Ebrei VII, I-3]. Ora, Melchisedec viene rappresentato come superiore ad Abramo poiché lo benedice, e, «inoppugnabilmente, è l’inferiore ad essere benedetto dal superiore» [Ibid. VII]; Abramo, dal canto suo, riconosce tale superiorità poiché gli dà la decima, cosa questa che rappresenta il segno della sua dipendenza. Ne risulta che il sacerdozio secondo l’ordine di Melchisedec è superiore al sacerdozio secondo l’ordine di Aronne, poiché è da Abramo che deriva la famiglia di Levi e per conseguenza la famiglia di Aronne. E quel che afferma ancora San Paolo: «qui (nel sacerdozio levitico), sono gli uomini mortali a percepire le decime; ma là si tratta di un uomo di cui si attesta che è vivente. E proprio Levi, che percepisce la decima (sul popolo d’Israele), l’ha pagata per così dire nella persona di Abramo, poiché egli era ancora in Abramo, suo avo, quando Melchisedec si presentò davanti a questo patriarca» [Ibid. VII, 8-10]. E questa superiorità corrisponde a quella della Nuova Alleanza sulla Legge Antica: «in quanto consta che tale sacerdozio non è stato stabilito senza giuramento (infatti mentre gli altri sacerdoti sono stati stabiliti senza giuramento, questo lo è stato con giuramento), avendogli detto Dio: «Il Signore ha e l’alleanza di cui Gesù è il mediatore e il garante è più perfetta della prima» [Ibid. VII, 20-22]. Abbiamo tenuto a ricordare qui questi testi essenziali, senza peraltro pretendere, cosa che ci porterebbe troppo lungi, di sviluppare tutti i significati in essi contenuti, perché vi si trovano verità d’ordine molto profondo e che non si lasciano penetrare di primo acchito; San Paolo stesso ce ne avverte dicendo: «Su questo soggetto abbiamo molte cosa da dire, e cose difficili da spiegare per voi che siete diventati lenti a capire» [Ibid. V, 11]. Che mai potrebbe dire oggi che le cose di questo genere sono divenute completamente estranee all’immensa maggioranza degli uomini, uomini il cui spirito è rivolto esclusivamente alle realtà del mondo materiale ignorando per partito preso tutto ciò che supera tale dominio strettamente limitato? Soprattutto, abbiamo voluto far vedere come l’ordine di Melchisedec sia ad un tempo sacerdotale e reale, e che per conseguenza l’applicare a Cristo queste parole della Scrittura ad esso riferite, costituisce l’espressa affermazione di questo doppio carattere; ed anche che l’unione dei due poteri in una stessa persona rappresenta un principio superiore all’uno e all’altro degli ordini ove rispettivamente si esercitano questi due poteri considerati separatamente; ed è perciò che Melchisedec è veramente, per tutto ciò che di lui è detto, «fatto simile al Figlio di Dio» [L’unione dei due poteri, in virtù dei loro rispettivi rapporti con i due ordini divino ed umano, potrebbe anche essere considerata, in un certo senso, come prefigurazione dell’unione delle due nature divina ed umana nella persona del Cristo]. Ma Cristo, essendo egli stesso Figlio di Dio, non è soltanto la rappresentazione del principio dei due poteri; egli è anche quel principio in tutta la sua realtà trascendente «per la potenza della sua vita immortale»; ogni autorità ha in lui la sua sorgente perché egli è il «Verbo Eterno da cui sono fatte tutte le cose», come afferma San Giovanni all’inizio del suo Vangelo, «e niente di ciò che è stato, è stato fatto senza di lui». A queste considerazioni fondamentali aggiungeremo solo qualche osservazione complementare: anzitutto è importante osservare che la Giustizia e la Pace, le quali, come si è visto, sono gli attributi di Melchisedec secondo il significato stesso del suo nome e del titolo che gli viene attribuito, sono anche attributi che convengono eminentemente a Cristo, chiamato in particolare «Sole di Giustizia» e «Principe della Pace». inoltre, bisogna dire che le idee di Giustizia e di Pace, sia nel Cristianesimo, come nelle antiche tradizioni, e pure nella tradizione giudaica ove esse sono frequentemente associate, hanno un significato molto diverso da quello profano, e che richiederebbe uno studio approfondito [Tale differenza è nettamente affermata da certi testi evangelici come per esempio questo: «Vi lascio la pace; vi do la mia pace, non ve la do come la dà il mondo» – San Giovanni XIV, 27.14)]. Un’altra osservazione che può apparire singolare a chi non conosca il genio della lingua ebraica, ma che non per ciò è meno importante, è la seguente: Melchisedec è sacerdote di Dio l’Altissimo, El Elion; e El Elion è l’equivalente di Emmanuel avendo questi due nomi esattamente lo stesso numero [In ebraico ogni lettera dell’alfabeto ha un valore numerico; ed il valore numerico di un nome è la somma di quelli delle lettere di cui è formato; così il numero dei due nomi El Elion ed Emmanuel è 197]. Tale equivalenza sta ad indicare che si tratta di due designazioni dello stesso principio divino soltanto sotto due rapporti diversi: nel mondo celeste esso è El Elion mentre nella sua manifestazione nel mondo terrestre è Emmanuel («Dio con noi» o «Dio in noi»). Ne risulta questa conseguenza: il sacerdozio di Melchisedec è il sacerdozio di El Elion; il sacerdozio cristiano, che è una partecipazione del sacerdozio stesso del Cristo, è quello di Emmanuel; se dunque El Elion e Emmanuel non sono che un solo ed unico principio, anche questi due sacerdozi non fanno che uno, ed il sacerdozio cristiano, che del resto comporta essenzialmente l’offerta eucaristica nella fattispecie del pane e del vino, è veramente «secondo l’ordine di Melchisedec». Infine Melchisedec non è il solo personaggio che appaia nelle Scritture con il doppio carattere di sacerdote e di re; nel Nuovo testamento infatti, ritroviamo queste due funzioni unite nei Re Magi, il che può far pensare che vi sia uno stretto legame tra essi e Melchisedec, o, in altri termini, che in entrambi i casi si tratti di rappresentanti di una sola e stessa autorità. Orbene, i re Magi, attraverso l’omaggio che essi rendono a Cristo attraverso i presenti che gli offrono, riconoscono espressamente in lui la sorgente di questa autorità ovunque essa si eserciti: il primo gli offre l’oro e lo saluta come re; il secondo gli offre l’incenso e lo saluta come sacerdote; il terzo infine gli offre la mirra o balsamo di incorruttibilità [Gli alberi produttori di gomme o resine incorruttibili svolgono una funzione importante nel simbolismo, col significato di resurrezione ed immortalità; a questo titolo, essi sono stati talora impiegati come emblemi del Cristo. È vero che alla mirra è stato dato anche un altro significato riferito esclusivamente all’umanità del Cristo, ma noi pensiamo che si tratti di un’interpretazione tutta moderna e di valore assai contestabile dal punto di vista tradizionale] e lo saluta come profeta o maestro spirituale per eccellenza, il che corrisponde direttamente al principio comune dei due poteri sacerdotale e reale. In questo modo viene reso omaggio a Cristo, già dalla nascita, nei «tre mondi» di cui parlano tutte le dottrine orientali: il mondo terrestre, il mondo intermedio ed il mondo celeste; e coloro che gli rendono omaggio non sono altro che gli autentici depositari della Rivelazione fatta all’umanità fin dal Paradiso Terrestre. O perlomeno, questa è la conclusione che, per noi, si ricava nettamente paragonando le testimonianze concordanti che si incontrano, a questo proposito, presso tutti i popoli; e del resto, nelle diverse forme ch’essa ha rivestito nel corso dei tempi, sotto i veli più o meno spessi che talora la dissimularono agli sguardi di coloro che restano fermi alle apparenze esteriori, quella grande Tradizione primordiale fu sempre, in realtà, l’unica vera religione di tutta l’umanità. Il modo di procedere dei rappresentanti di questa Tradizione, come ce lo riporta il Vangelo, non dev’essere forse riguardato, a ben comprendere di che si tratta, come una delle più belle prove della divinità del Cristo, e contemporaneamente come il riconoscimento decisivo del Sacerdozio e della Regalità supreme che veramente gli appartengono «secondo l’ordine di Melchisedec»?
SAN BERNARDO
NOTA Paul Chacornac (La vie simple de René Guénon, Editions Traditionnelles, Parigi, 1958 (1982)) riporta che «Nel 1927, la Librairie de France, oggi scomparsa, predisponeva la pubblicazione di un’opera collettiva dedicata ai grandi santi cattolici; René Guénon accettò di scrivere un breve studio su San Bernardo, la cui personalità lo interessava particolarmente». Il testo in questione venne poi pubblicato in un fascicolo dalle Editions Traditionnelles, Parigi. Fra le grandi figure del Medioevo ve ne sono poche il cui studio è più appropriato di quello di San Bernardo per dissipare certi pregiudizi cari allo spirito moderno. In effetti, cosa c’è di più sconcertante, per quest’ultimo, che il constatare come un contemplativo puro, che ha sempre voluto essere e rimanere tale, fosse chiamato a svolgere un ruolo preponderante nella conduzione degli affari della Chiesa e dello Stato, e riuscisse spesso laddove aveva fallito tutta la prudenza dei politici e dei diplomatici di professione? Secondo la maniera ordinaria di giudicare le cose, cosa c’è di più sorprendente e di più paradossale che il vedere un mistico, il quale prova solo disdegno per ciò che egli chiama «le arguzie di Platone e le finezze di Aristotele», trionfare tuttavia senza sforzo sui dialettici più sottili del suo tempo? Tutta la vita di San Bernardo potrebbe sembrare destinata a dimostrare, con l’esempio eclatante, che per risolvere i problemi di ordine intellettuale, ed anche di ordine pratico, esistono dei mezzi del tutto diversi da quelli che, ormai da troppo tempo, si è abituati a considerare come i soli efficaci, senza dubbio perché questi sono i soli alla portata di una saggezza puramente umana, che non è neanche l’ombra della vera saggezza. Questa sua vita appare così, in qualche modo, come un’anticipata confutazione di quegli errori, apparentemente opposti ed in realtà solidali, che sono: il razionalismo ed il pragmatismo; e al tempo stesso, per chi la esamina in modo imparziale, essa supera e capovolge tutte le idee preconcette degli storici «scientisti», i quali, con Renan, ritengono che «la negazione del sovrannaturale costituisce l’essenza stessa della critica», cosa che d’altronde noi ammettiamo molto volentieri, in quanto che in tale incompatibilità vediamo tutto il contrario di ciò che vi vedono loro, e cioè la condanna della stessa «critica», non certo quella del sovrannaturale. In verità, nella nostra epoca, quali lezioni potrebbero essere più proficue di queste? *** Bernardo nacque nel 1090, a Fontaines-les-Dijon, i suoi genitori appartenevano all’alta nobiltà della Borgogna, ed annotiamo questo fatto in quanto che ci sembra che alcuni tratti della sua vita e della sua dottrina, dei quali parleremo in seguito, possano, fino ad un certo punto, essere collegati a questa origine. Non vogliamo dire che è solo con questo fatto che è possibile spiegare l’ardore, talvolta bellicoso, del suo zelo o la violenza che egli apportò, a più riprese, nelle polemiche in cui fu trascinato, la quale d’altronde era del tutto superficiale, poiché il suo carattere era basato incontestabilmente sulla bontà e sulla dolcezza; ciò a cui invece intendiamo soprattutto alludere sono i suoi rapporti con l’istruzione e l’ideale cavallereschi, ai quali, del resto, occorre sempre accordare una grande importanza se si vogliono comprendere gli avvenimenti e lo spirito stesso del Medioevo. È verso i vent’anni che Bernardo decise di ritirarsi dal mondo ed in poco tempo egli riuscì a far condividere le sue vedute a tutti i suoi fratelli, ad alcuni dei suoi parenti e ad un certo numero di suoi amici. In questo suo primo apostolato, la sua forza di persuasione, a dispetto della sua giovane età, fu tale che ben presto «egli divenne – dice il suo biografo – il terrore delle madri e delle spose; gli amici temevano nel vederlo intrattenere i loro amici». E già in questo vi è qualcosa di straordinario e per spiegare una simile influenza sarebbe sicuramente insufficiente invocare la potenza del «genio», inteso nel senso profano del termine; non è qui il caso di riconoscere l’azione della grazia divina che, penetrando in qualche modo tutta la persona dell’apostolo ed emanando all’esterno per la sua sovrabbondanza, si comunicava a mezzo suo come per un canale, secondo il paragone che lui stesso impiegherà più tardi applicandolo alla Santa Vergine e che, restringendone più o meno la portata, si può anche applicare a tutti i santi? È, dunque, accompagnato da una trentina di giovani che Bernardo, nel 1112, entrò nel monastero di Citeaux, che egli aveva scelto per il rigore con cui si osservava la regola, rigore che contrastava con il rilassamento che s’era introdotto in tutti gli altri rami dell’Ordine Benedettino. Tre anni più tardi i suoi superiori non esitavano ad affidargli, nonostante la sua inesperienza e la sua salute vacillante, la guida di dodici religiosi con i quali fondò una nuova abbazia, quella di Chiaravalle, che governerà fino alla morte, rifiutando sempre gli onori e gli alti uffici che gli verranno spesso offerti nel corso della sua carriera. La fama di Chiaravalle non tardò a diffondersi fin nei posti più lontani e lo sviluppo che essa ben presto raggiunse fu veramente prodigioso: alla morte del suo fondatore si dice che accogliesse circa settecento monaci ed essa aveva dato vita a più di sessanta nuovi monasteri.
***
La cura che Bernardo mise nell’amministrazione di Chiaravalle, regolando lui stesso perfino i più piccoli particolari della vita di tutti i giorni; il ruolo che assunse nella direzione dell’Ordine cistercense, come capo di una delle prime abbazie; l’abilità ed il successo dei suoi interventi per appianare le difficoltà che sorgevano di frequente con gli Ordini rivali; tutto ciò basta a provare che quel che si chiama senso pratico può benissimo accompagnarsi, talvolta, alla più alta spiritualità. Vi era di che assorbire l’intera attività di un uomo ordinario, e tuttavia Bernardo vide, ben presto, aprirsi davanti a lui un diverso campo d’azione; molto suo malgrado, d’altronde, poiché non paventò mai nulla quanto l’essere obbligato ad uscire fuori dal suo chiostro per mescolarsi agli affari del mondo, da cui aveva creduto di potersi isolare per sempre, per dedicarsi interamente all’ascesi ed alla contemplazione, senza che niente venisse a distrarlo da quello che ai suoi occhi era, secondo il motto evangelico, «la sola cosa necessaria». In questo s’era sbagliato di molto; ma tutte le «distrazioni», nel senso etimologico, alle quali non poté sottrarsi e di cui giunse a dolersi con un po’ d’amarezza, non gli impediranno affatto di giungere ai vertici della vita mistica. Ciò è particolarmente degno di nota, come il fatto che, malgrado tutta la sua umiltà e tutti gli sforzi che fece per restare nell’ombra, si fece appello alla sua collaborazione in tutte le questioni importanti; e che nonostante egli non fosse niente nei confronti del mondo ordinario, tutti, compresi i più alti dignitari civili ed ecclesiastici, si inchinarono sempre spontaneamente al cospetto della sua autorità tutta spirituale, e noi non sappiamo se questo fatto vada più in lode del santo o dell’epoca in cui egli visse. Quale contrasto fra questi nostri tempi e quelli, ove un semplice monaco poteva diventare in qualche modo, per il solo fulgore delle sue eminenti virtù, il centro dell’Europa e della Cristianità, l’arbitro incontestato di tutti i conflitti in cui era in giuoco il pubblico interesse, sia politico che religioso, il giudice dei maestri più famosi della filosofia e della teologia, il restauratore dell’unità della Chiesa, il mediatore fra il Papato e l’Impero, ed infine, vedere eserciti di parecchie centinaia di migliaia di uomini levarsi alla sua predicazione!
***
Bernardo cominciò ben presto a denunciare il lusso nel quale viveva allora la maggior parte dei membri del clero secolare ed anche i monaci di certe abbazie; le sue rimostranze provocarono delle conversioni clamorose, fra cui quella di Sugerio, illustre abate di Saint-Denis che, senza portare ancora il titolo di primo ministro del re di Francia, ne assolveva già le funzioni. Fu questa conversione che fece conoscere a corte il nome dell’abate di Chiaravalle, ove sembra che venisse considerato con un misto di rispetto e di timore, perché si vedeva in lui l’irriducibile avversario di ogni abuso e di ogni ingiustizia; ed in effetti, lo si vide ben presto intervenire nei conflitti sorti fra Luigi il Grosso e diversi vescovi, e protestare con forza contro le usurpazioni dei diritti della Chiesa da parte del potere civile. A dire il vero, si trattava ancora di questioni locali che interessavano solo qualche monastero e qualche diocesi; ma, nel 1130, sopraggiunsero degli avvenimenti di ben altra gravità, che misero in pericolo la Chiesa intera, divisa dallo scisma dell’antipapa Anacleto II; ed è in questa occasione che la fama di Bernardo si diffuse in tutta la Cristianità. Non è necessario che rivediamo qui la storia di questo scisma in tutti i suoi particolari: i cardinali, divisi in due fazioni rivali, avevano eletto prima Innocenzo II e poi Anacleto II; il primo, costretto a fuggire da Roma, non disperò del suo diritto e si appellò alla Chiesa universale. Fu la Francia a rispondere per prima; al concilio convocato dal re a Etampes, Bernardo, come dice il suo biografo, apparve fra i vescovi ed i signori riuniti «come un vero inviato di Dio»; tutti seguirono il suo parere circa la questione in esame e riconobbero la validità dell’elezione di Innocenzo II. Questi si trovava allora sul suolo francese, e fu nell’abbazia di Cluny che Sugerio andò a comunicargli la decisione del concilio; attraversò le principali diocesi e fu accolto dappertutto con entusiasmo, di modo che un tale movimento si avviava a riscuotere l’adesione di quasi tutta la Cristianità. L’abate di Chiaravalle si recò dal re d’Inghilterra, e trionfò prontamente delle sue esitazioni e, forse, intervenne anche, almeno indirettamente, nel riconoscimento di Innocenzo II da parte del re Lotario e del clero tedesco. Si recò poi in Aquitania per combattere l’influenza del vescovo Gérard d’Angouléme, fautore di Anacleto II; ma è solo nel corso di un secondo viaggio in questa regione, nel 1135, che riuscì a sopprimervi lo scisma, operando la conversione del conte di Poitiers. Nel frattempo s’era dovuto recare in Italia, chiamatovi da Innocenzo II, che vi era ritornato con l’appoggio di Lotario, ma che era stato bloccato da difficoltà impreviste dovute alle ostilità fra Pisa e Genova; bisognava trovare un accordo fra le due città rivali e farglielo accettare; Bernardo fu incaricato di questa difficile missione e riuscì a compierla con grande successo. Innocenzo II poté infine rientrare a Roma, ma Anacleto II rimase trincerato in San Pietro, di cui fu impossibile impadronirsi; Lotario, incoronato imperatore in San Giovanni in Laterano, si ritirò ben presto col suo esercito e, dopo la sua partenza, l’antipapa riprese l’offensiva, per cui il legittimo pontefice dovette nuovamente fuggire da Roma e rifugiarsi a Pisa. L’abate di Chiaravalle, che era rientrato nel suo chiostro, apprese con costernazione queste novità; poco dopo gli giunse anche voce dell’attività intrapresa da Ruggero, re di Sicilia, per guadagnare tutta l’Italia alla causa di Anacleto II e per assicurarvi la propria supremazia. Bernardo scrisse subito agli abitanti di Pisa e di Genova per incoraggiarli a rimanere fedeli a Innocenzo II; ma questa fedeltà era solo un appoggio assai debole e per riconquistare Roma si poteva sperare solo nell’efficace aiuto della Germania. Sfortunatamente l’Impero era sempre in preda alla divisione e Lotario non poteva ritornare in Italia se non prima di aver assicurato la pace nel suo paese. Bernardo partì per la Germania e si adoperò per la riconciliazione degli Hohenstaufen con l’imperatore, ed anche stavolta i suoi sforzi furono coronati dal successo e ne vide consacrata la riuscita alla dieta di Bamberga, che egli lasciò poi per recarsi al concilio convocato a Pisa da Innocenzo II. In questa occasione dovette indirizzare delle rimostranze a Luigi il Grosso, che si era opposto alla partenza dei vescovi del suo regno; il divieto fu tolto ed i principali membri del clero francese poterono rispondere all’appello del capo della Chiesa. Bernardo fu l’anima del Concilio; nell’intervallo fra le sedute – racconta uno storico del tempo – la sua porta era assediata da coloro che avevano dei grossi problemi da sottoporgli, come se questo umile monaco avesse il potere di risolvere, a suo piacimento, tutti i problemi ecclesiastici. Inviato poi a Milano, per ricondurre questa città dalla parte di Innocenzo II e di Lotario, venne acclamato dal clero e dai fedeli che, in una manifestazione spontanea di entusiasmo, volevano fare di lui il loro arcivescovo, e dovette faticare parecchio per sottrarsi a tale onore. Egli aspirava solo a ritornare nel suo monastero, e vi rientrerà, in effetti, ma non per lungo tempo. All’inizio del 1136, Bernardo dovette abbandonare ancora una volta la sua solitudine per raggiungere in Italia, secondo il desiderio del papa, l’esercito tedesco, comandato dal duca Enrico di Baviera, genero dell’imperatore. Era sorta la discordia fra questi e Innocenzo II; Enrico, che poco si curava dei diritti della Chiesa, dimostrava in ogni circostanza di volersi solo occupare degli interessi dello Stato. Così, l’abate di Chiaravalle ebbe il suo da fare per ristabilire la concordia fra i due poteri e conciliare le loro pretese rivali, in particolare per ciò che riguardava alcuni problemi di investitura, per i quali sembra avere costantemente svolto un ruolo di moderatore. Tuttavia, Lotario, che aveva assunto personalmente il comando dell’esercito, sottomise tutta l’Italia meridionale, ma ebbe il torto di respingere le proposte di pace del re di Sicilia, che non tardò a riprendersi la rivincita, mettendo tutto a ferro e fuoco. Bernardo non esitò allora a presentarsi al campo di Ruggero, il quale accolse abbastanza malamente le sue parole di pace, ed a cui predisse una sconfitta che, in effetti, si verificò; in seguito lo seguì e lo raggiunse a Salerno, ove si sforzò di allontanarlo dallo scisma a cui lo aveva indotto la sua ambizione. Ruggero acconsentì di ascoltare, in contraddittorio, i fautori di Innocenzo II e di Anacleto II, ma mentre sembrava condurre l’inchiesta con imparzialità, in realtà cercava solo di guadagnare tempo e rifiutava di prendere una decisione; nondimeno, questo dibattito sortì il felice risultato della conversione di uno dei principali autori dello scisma, il cardinale Pietro di Pisa, che Bernardo condusse con sé da Innocenzo II. Questa conversione arrecò un terribile colpo alla causa dell’antipapa; Bernardo seppe approfittarne e nella stessa Roma, per mezzo della sua ardente e convincente eloquenza, riuscì in pochi giorni a distogliere dal partito di Anacleto II la maggior parte dei dissidenti. Ciò accadeva nel 1137, all’epoca delle feste di Natale; un mese più tardi, Anacleto II moriva improvvisamente. Alcuni dei cardinali più impegnati nello scisma elessero un nuovo antipapa, col nome di Vittorio IV, ma la loro resistenza non poteva durare a lungo e, all’ottava di Pentecoste, fecero tutti atto di sottomissione; la settimana successiva l’abate di Chiaravalle riprese il cammino verso il suo monastero. Questo rapido riassunto, basta a dare un’idea di quella che si potrebbe chiamare l’attività politica di San Bernardo, la quale d’altronde, non si fermò qui: dal 1140 al 1144 dovette protestare contro l’abusiva ingerenza del re Luigi il Giovane nelle elezioni episcopali, poi intervenne in un grave conflitto sorto fra questo stesso re ed il conte Thibaut di Champagne; ma sarebbe fastidioso dilungarsi su questi avvenimenti. Insomma, si può dire che la condotta di Bernardo fu sempre determinata dalle medesime intenzioni: difendere il diritto, combattere l’ingiustizia e soprattutto mantenere l’unità del mondo cristiano. È questa costante preoccupazione dell’unità che lo sorresse nella lotta contro lo scisma, ed è sempre questa che gli fece intraprendere, nel 1145, un viaggio in Linguadoca per ricondurre alla Chiesa gli eretici neo-manichei che incominciavano a diffondersi in quella regione. Sembra aver avuto incessantemente presente queste parole del Vangelo: «affinché siano tutti una cosa sola, come tu sei in me, o Padre, ed io in te». *** L’abate di Chiaravalle, tuttavia, non dovette lottare solamente nel dominio politico ma anche nel dominio intellettuale, ove i suoi trionfi non furono meno vistosi, poiché furono contrassegnati dalla condanna di due eminenti avversari: Abelardo e Gilberto Porretano. Il primo s’era conquistata, per i suoi insegnamenti e per i suoi scritti, la reputazione di uno dei più abili dialettici, e ne abusava anche, poiché invece di considerare la dialettica per ciò che essa è realmente, cioè un semplice mezzo per pervenire alla conoscenza della verità, egli la vedeva quasi come qualcosa di fine a se stessa, tanto da sfociare, naturalmente, in una sorta di verbalismo. Sembra anche che in lui fosse presente, sia per il metodo che per le idee di base, una ricerca dell’originalità che lo avvicina un po’ ai filosofi moderni; e in un’epoca in cui l’individualismo era una cosa quasi sconosciuta, questo difetto non correva certo il rischio di passare per una qualità, come accade ai nostri giorni. Così, alcuni furono ben presto infastiditi da questa novità, che non conduceva a niente di più che a creare una vera confusione fra il dominio della ragione e quello della fede; per essere esatti, non è che Abelardo fosse un razionalista, come si è preteso talvolta, poiché non vi sono stati certo dei razionalisti prima di Cartesio, ma egli non seppe distinguere fra ciò che deriva dalla ragione e ciò che le è superiore, fra la filosofia profana e la saggezza sacra, fra il sapere puramente umano e la conoscenza trascendente, e sta proprio in questo la causa di tutti i suoi errori. Non arrivò a sostenere che i filosofi e i dialettici godono di una ispirazione abituale paragonabile all’ispirazione sovrannaturale dei profeti? Si comprende con facilità, quindi, perché San Bernardo, non appena venne richiamata la sua attenzione su simili teorie, si sia levato contro di esse con forza ed anche con un certo furore, e si capisce, altresì, come mai abbia rimproverato acerbamente al loro autore di aver insegnato che la fede non era che una semplice opinione. La controversia fra questi uomini così diversi, iniziata con alcuni colloqui privati, ebbe ben presto un’enorme risonanza nelle scuole e nei monasteri; Abelardo, confidando nella sua abilità a condurre il ragionamento, chiese all’arcivescovo di Sens di riunire un concilio in seno al quale si sarebbe giustificato pubblicamente, pensava di poter manovrare la discussione in modo da indurre facilmente in confusione il suo avversario. Le cose andarono in tutt’altro modo: l’abate di Chiaravalle, infatti, considerava il concilio come un tribunale, davanti al quale il teologo sospetto sarebbe comparso in giudizio; in una seduta preparatoria, egli produsse le opere di Abelardo, di cui mostrò le proposizioni più temerarie, provandone l’eterodossia; l’indomani, appena fu introdotto l’autore e dopo aver enunciato le dette proposizioni, gli intimò di ritrattarle o di giustificarle. Abelardo, prevedendo già una condanna, non attese il giudizio del concilio e ben presto dichiarò che si appellava alla corte di Roma; il processo seguì comunque il suo corso e, non appena venne pronunciata la condanna, Bernardo scrisse ad Innocenzo II ed ai cardinali delle lettere di una incalzante eloquenza, di modo che, sei settimane dopo, la sentenza venne confermata a Roma. Ad Abelardo non restava che sottomettersi; egli si rifugiò a Cluny, da Pietro il Venerabile, che gli procurò un incontro con l’abate di Chiaravalle e riuscì a farli riconciliare. Il concilio di Sens ebbe luogo nel 1140; nel 1147, Bernardo ottenne, al concilio di Reims, anche la condanna degli errori di Gilberto Porretano, vescovo di Poitiers; errori che riguardavano il mistero della Trinità e derivavano dal fatto che l’autore applicava a Dio la distinzione reale dell’essenza dall’esistenza, la quale è applicabile solo agli esseri creati. Gilberto, d’altronde, ritrattò senza difficoltà e quindi gli fu solamente interdetta la lettura e la trascrizione della sua opera fino a quando non l’avesse corretta; e, a parte i punti particolari che erano stati oggetto della questione, la sua autorità non venne meno e la sua dottrina mantenne un gran credito nelle scuole, per tutto il Medioevo. *** Due anni prima di quest’ultimo avvenimento, l’abate di Chiaravalle aveva avuto la gioia di veder ascendere al trono pontificale uno dei suoi vecchi monaci, Bernardo da Pisa, che aveva preso il nome di Eugenio III e che mantenne sempre, con lui, le più affettuose relazioni; fu questo nuovo papa che, all’inizio del suo pontificato, lo incaricò di predicare la seconda crociata. Fino a quel momento, la Terra Santa aveva occupato un posto molto limitato fra le preoccupazioni di San Bernardo, almeno in apparenza; tuttavia sarebbe un errore credere che egli sia rimasto del tutto estraneo a ciò che era ad essa relativo, e la prova la si ha da una vicenda sulla quale generalmente si insiste molto meno di quanto ad essa converrebbe. Ci riferiamo alla parte da lui svolta nella costituzione dell’Ordine del Tempio, il primo Ordine militare per data e per importanza e che servì da modello a tutti gli altri. Fu nel 1128, circa dieci anni dopo la sua fondazione, che quest’Ordine ricevette la sua regola, al concilio di Troyes, e fu Bernardo, in qualità di segretario del concilio, che venne incaricato di redigerla o, quantomeno, di fissarne i primi lineamenti, poiché sembra che solo più tardi venne chiamato a completarla, e riuscirà a farlo solo nel 1131. Egli commentò poi questa regola nel trattato De laude novae militiae, ove espose, con una magnifica eloquenza, la missione e l’ideale della cavalleria cristiana, che egli chiamava la «milizia di Dio». Questi rapporti fra l’abate di Chiaravalle e l’Ordine del Tempio, che gli storici considerano solo come un episodio alquanto secondario della sua vita, ebbero sicuramente ben altra importanza agli occhi degli uomini del Medioevo, e noi abbiamo indicato altrove che essi costituiscono, senza dubbio, la ragione per cui Dante scelse San Bernardo come sua guida negli ultimi cerchi del Paradiso.
***
Fin dal 1145, Luigi VII aveva progettato di andare in aiuto dei principati latini d’Oriente, minacciati dall’emiro di Aleppo, ma l’opposizione dei suoi consiglieri lo aveva costretto a rimandare, e la decisione definitiva era stata demandata ad un’assemblea plenaria che doveva attenersi a Vèzelay, durante le feste di Pasqua del 1146. Eugenio III, trattenuto in Italia dalla rivolta fomentata a Roma da Arnaldo da Brescia, incaricò l’abate di Chiaravalle di rappresentarlo in quell’assemblea; Bernardo, dopo aver dato lettura della bolla che invitava la Francia ad andare alla crociata, pronunciò un discorso che, a giudicare dall’effetto che produsse, fu la più grande azione oratoria della sua vita: tutti i presenti si precipitarono a ricevere la croce dalle sue mani. Incoraggiato da questo successo, Bernardo percorse le città e le campagne predicando ovunque la crociata con uno zelo infaticabile; lì ove non poteva recarsi personalmente, inviava delle lettere non meno eloquenti dei suoi discorsi. Passò in seguito in Germania, ove la sua predicazione ebbe gli stessi risultati che in Francia; l’imperatore Corrado, dopo aver tergiversato un po’, dovette cedere alla sua influenza e partecipare alla crociata. Verso la metà dell’anno 1147 gli eserciti francese e tedesco si avviarono per questa grande spedizione e a dispetto della loro apparente imponenza, andarono incontro ad un disastro. Le cause di questo scacco furono molteplici, e sembra che le più importanti siano state: il tradimento dei Greci e la mancanza d’intesa fra i capi della crociata; ma alcuni tentarono, molto ingiustamente, di rigettare la responsabilità sull’abate di Chiaravalle; Questi dovette scrivere una vera apologia della sua condotta, che fu, al tempo stesso, una giustificazione dell’azione della Provvidenza; in essa egli mostrava come i mali sopraggiunti fossero da addebitare alle mancanze dei Cristiani e che quindi «1e promesse di Dio rimangono intatte, poiché esse non obbligano contro i diritti della sua giustizia»; questa apologia è contenuta nel De Considerazione, indirizzata ad Eugenio III, che è come il testamento di San Bernardo e contiene, in particolare, le sue vedute circa i doveri del papato. D’altronde, non tutti si abbandonarono allo sconforto e Sugerio preparò ben presto il progetto per una nuova crociata, il cui capo avrebbe dovuto essere lo stesso abate di Chiaravalle; ma la morte del grande ministro di Luigi VII ne arrestò l’esecuzione. San Bernardo morì poco dopo, nel 1153, e le sue ultime lettere testimoniano che egli si preoccupò fino alla fine della liberazione della Terra Santa. Se lo scopo immediato della crociata non era stato raggiunto, se ne deve concludere che una tale spedizione era del tutto inutile e che gli sforzi di San Bernardo non erano serviti a niente? Noi pensiamo di no, malgrado quello che ne possono pensare gli storici, che si attengono solo alle apparenze, poiché in questi grandi movimenti del Medioevo, a carattere politico e contemporaneamente religioso, vi erano delle ragioni più profonde, di cui una, la sola che vogliamo qui far notare, era quella di mantenere in seno alla Cristianità una viva coscienza della sua unità. La Cristianità si identificava con la civiltà occidentale, fondata allora su basi essenzialmente tradizionali, come ogni civiltà normale, ed essa raggiunse il suo apogeo nel XIII secolo; alla perdita di questo carattere tradizionale doveva necessariamente seguire la rottura dell’unità stessa della Cristianità. Questa rottura, che nel dominio religioso fu portata a termine dalla Riforma, nel dominio politico fu causata dalla instaurazione delle nazionalità, preceduta dalla distruzione del regime feudale; e a quest’ultimo proposito, si può dire che colui che inferse il primo colpo all’edificio grandioso della Cristianità medioevale fu Filippo il Bello, lo stesso che, per una coincidenza che sicuramente non è affatto fortuita, distrusse l’Ordine del tempio, attaccando così, direttamente, l’opera stessa di San Bernardo. *** Nel corso di tutti i suoi viaggi, San Bernardo sostenne costantemente la sua predicazione con numerose guarigioni miracolose, che per la folla erano come dei segni visibili della sua missione; questi fatti sono stati riferiti da testimoni oculari ma lui ne parlava poco volentieri. Forse questa riservatezza gli era imposta dalla sua stessa modestia, ma indubbiamente egli attribuiva a questi miracoli una importanza solo secondaria e li considerava solo come una concessione accordata dalla divina misericordia alla debolezza della fede della maggior parte degli uomini, conformemente alle parole di Cristo: «Beati coloro che credono senza vedere!». Questa attitudine si accorda con il disprezzo che in genere egli manifestò nei confronti dei mezzi esteriori ed emozionali, come la pompa nelle cerimonie e l’abbellimento delle Chiese. Gli si è potuto perfino rimproverare, con qualche parvenza di verità, di non aver avuto che disprezzo per l’arte religiosa, ma coloro che avanzano questa critica dimenticano una distinzione indispensabile, quella che lui stesso stabilì fra ciò che chiamò: architettura episcopale ed architettura monastica; e solo a quest’ultima deve applicarsi l’austerità da lui auspicata; è solo ai religiosi ed a coloro che seguono il cammino della perfezione che egli interdisse il «culto degli idoli», vale a dire delle forme, delle quali invece proclamò l’utilità, in quanto mezzo educativo, per i semplici e gli imperfetti. Se protestò contro l’abuso delle raffigurazioni prive di significato ed aventi solo un valore puramente ornamentale, con questo non ha inteso prescrivere il simbolismo dell’arte architettonica, come è stato falsamente preteso, mentre invece lui stesso ne fece un uso frequente nei suoi sermoni. *** La dottrina di San Bernardo è essenzialmente mistica; con ciò intendiamo dire che egli considerava le cose divine soprattutto sotto l’aspetto dell’amore, che peraltro sarebbe erroneo interpretare qui in un senso semplicemente affettivo, come fanno i moderni psicologi. Come molti dei grandi mistici, egli fu attratto in modo particolare dal cantico dei Cantici, che commentò in numerosi sermoni, i quali compongono una serie proseguita lungo tutta la sua carriera; questo commentario, che rimase sempre incompiuto, descrive tutti i gradi dell’amore divino, fino alla pace suprema alla quale l’anima perviene nell’estasi. Lo stato estatico, così come egli lo intende e come sicuramente lo ha provato, è una sorta di morte alle cose di questo mondo; insieme alle immagini sensibili, sparisce ogni sentimento naturale, tutto è puro e spirituale nell’anima stessa come nel suo amore. Questo misticismo doveva naturalmente riflettersi nei suoi trattati dogmatici; il titolo di uno dei principali, De diligendo Deo, mostra infatti a sufficienza quale posto vi occupi l’amore; ma si avrebbe torto nel credere che questo vada a detrimento della vera intellettualità. Se l’abate di Chiaravalle volle sempre rimanere estraneo alle vane sottigliezze delle scuole è perché non aveva alcun bisogno dei laboriosi artifici della dialettica; egli risolveva d’un sol colpo le questioni più ardue, poiché non procedeva attraverso una lunga serie di operazioni discorsive; ciò che i filosofi si sforzano di raggiungere per via indiretta e quasi a tentoni, egli lo otteneva immediatamente, per mezzo dell’intuizione intellettuale, senza la quale non è possibile nessuna reale metafisica, ed al di fuori della quale non si può cogliere che un’ombra della verità. *** Un ultimo tratto della fisionomia di San Bernardo, anch’esso importante da segnalare, è il posto eminente che, nella sua vita e nelle sue opere, occupa il culto della Santa Vergine, e che ha dato luogo al fiorire di tutta una serie di leggende, le quali, forse, sono quelle che lo hanno reso popolare nel tempo. Egli amava dare alla Santa Vergine il titolo di «Notre-Dame», l’uso del quale si è diffuso a partire dalla sua epoca e senza dubbio, grazie per lo più, alla sua influenza; il fatto è che egli era, come è stato detto, un vero «cavaliere di Maria», che egli considerava veramente come la sua «dama», nel senso cavalleresco del termine. Se si accosta questo fatto al ruolo che giuoca l’amore nella sua dottrina e che giuocava anche, sotto forme più o meno simboliche, nelle concezioni proprie degli Ordini cavallereschi, si comprenderà facilmente perché ci siamo preoccupati di parlare delle sue origini famigliari. Divenuto monaco egli rimase sempre cavaliere, come lo erano tutti quelli della sua stirpe; e, per lo stesso motivo, si può dire che fosse, in qualche modo, predestinato a svolgere, come fece in tante circostanze, il ruolo di intermediario, di conciliatore e di arbitro fra il potere religioso ed il potere politico, in forza del fatto che portava in sé come una partecipazione della natura dell’uno e dell’altro. Monaco e cavaliere, questi che erano i due caratteri dei membri della «milizia di Dio», dell’Ordine del Tempio, furono anche, fin dall’inizio, i caratteri dell’autore della loro regola, del grande santo che è stato definito l’ultimo Padre della Chiesa, e nel quale molti hanno inteso vedere, non senza ragione, il prototipo di Galaad, il cavaliere ideale e senza macchia, l’eroe vittorioso della «Cerca del Santo Graal».

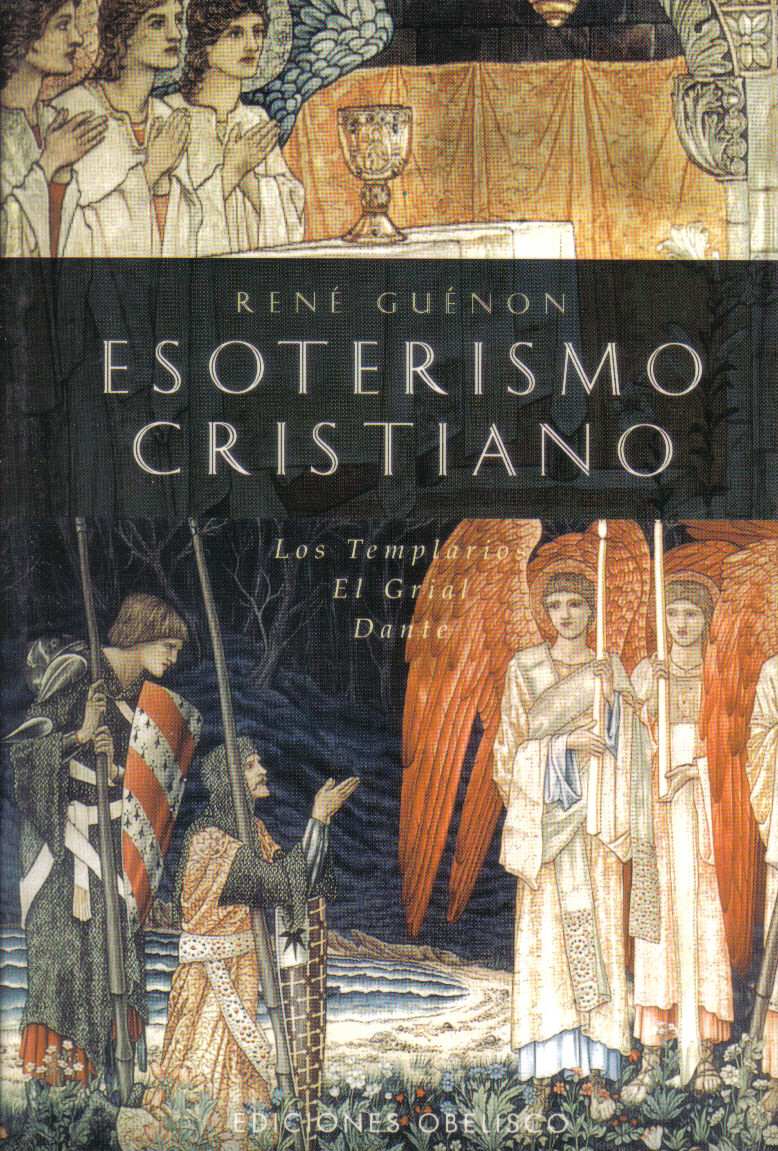
ダイエット成功の秘訣は、何よりも身体を動かすことに尽きると思いる。確かに食事の量を減らしたりすれば、それなりに体重は減るとは思いるが、食事をきちんと摂れないのは楽しくありませんよね。
何よりも身体を動かすことに尽きると思いる。確かに食事の量を減らしたりすれば、それなりに体重は減るとは思いるが、食事をきちんと摂れないのは楽しくありませんよね。