INDICE.
Presentazione.
Prefazione.
Introduzione: Oriente e Occidente nell’Ellenismo.
a) L’apporto dell’occidente.
– La cultura greca alla vigilia delle conquiste di Alessandro – Cosmopolitismo e nuova colonizzazione greca – L’ellenizzazione dell’Oriente – Ellenismo posteriore: la trasformazione della cultura profana in cultura religiosa – I quattro stadi della cultura greca.
b) L’apporto dell’Oriente.
– L’Oriente alla vigilia delle conquiste di Alessandro – Inizi del sincretismo religioso – Inizi dell’astrazione teologica nella religione ebraica, babilonese e persiana – L’Oriente durante l’ellenismo – L’Oriente sommerso – Concettualizzazione greca del pensiero orientale – Il «sottofondo» orientale – La ricomparsa dell’Oriente – La novità del pensiero orientale risorto – Principali manifestazioni dell’ondata orientale nel mondo ellenistico – L’unità sottostante: capacità rappresentativa del pensiero gnostico.
PARTE PRIMA – LETTERATURA GNOSTICA. PRINCIPI FONDAMENTALI. LINGUAGGIO SIMBOLICO.
CAP. 1 – Il significato della gnosi e la portata del movimento gnostico.
a) Clima spirituale dell’epoca.
b) Il termine «gnosticismo».
c) L’origine dello gnosticismo.
d) La natura della «conoscenza» gnostica.
e) Rassegna delle fonti.
– Fonti secondarie o indirette – Fonti primarie o dirette.
f) Sommario dei fondamentali princìpi gnostici.
– Teologia – Cosmologia – Antropologia – Escatologia – Morale.
CAP. 2 – Immaginazione gnostica e linguaggio simbolico.
a) Lo «straniero».
b) «Al di là», «fuori», «questo mondo» e «l’altro mondo».
c) Mondi di eoni.
d) L’abitazione cosmica e il soggiorno dello straniero.
e) «Luce», «tenebre», «vita» e «morte».
f) «Mescolanza» e «dispersione», «l’uno» e «i molti».
g) «Caduta», «affondamento», «cattura».
h) Abbandono, paura, nostalgia.
i) Torpore, sonno, ebbrezza.
j) Il rumore del mondo.
k) La «chiamata dal di fuori».
l) L’uomo straniero.
m) Il contenuto della chiamata.
n) La risposta alla chiamata.
o) Allegoria gnostica.
– Eva e il serpente – Caino e il Creatore – Prometeo e Zeus.
Appendice al Cap. 2, Glossario di termini mandei.
PARTE SECONDA – SISTEMI GNOSTICI DI SPECULAZIONE.
CAP. 3 – Simon Mago.
CAP. 4 – «L’inno della Perla».
a) Il testo.
b) Commento.
– Serpente, mare, Egitto – Il vestito impuro – La lettera – La vittoria sul serpente e l’ascesa – La veste celeste; l’immagine – L’io trascendentale – La Perla.
CAP. 5 – Gli Angeli che hanno fatto il mondo – Il Vangelo di Marcione.
a) Gli angeli che hanno creato il mondo.
Il Vangelo di Marcione.
– La posizione singolare di Marcione nel pensiero gnostico – La redenzione secondo Marcione – I due dèi – «La grazia data liberamente» – La moralità ascetica di Marcione – Marcione e la Scrittura.
CAP. 6 – Il «POIMANDRES» di Ermete Trismegisto.
a) Il testo.
Commento.
– L’origine dell’Uomo divino – La discesa dell’uomo; l’anima planetaria – L’unione dell’uomo con la natura, il tema di Narciso – L’ascesa dell’anima – I primi inizi.
CAP. 7 – La speculazione Valentiniana.
a) Il principio speculativo del valentinianismo.
b) Il sistema.
– Lo svolgimento del Pleroma – La crisi nel Pleroma – Conseguenze della crisi. Funzione del Limite – Restaurazione del Pleroma – Accadimenti all’esterno del Pleroma – Sofferenze della Sophia inferiore – Origine della Materia – Derivazione degli elementi singoli – Il Demiurgo e la creazione del mondo – La salvezza.
Appendice 1 al Cap. 7 – La posizione del fuoco fra gli elementi.
Appendice 2 al Cap. 7 – Il sistema dell’«Apocrifo di Giovanni».
– Il primo Dio – Barbelo e gli Eoni (Pleroma) – Sophia e Ialdabaoth – Gli Arconti e gli Angeli – Pentimento, sofferenza e correzione della Sophia – L’infusione dell’uomo pneumatico (Adamo psichico) – Mozione e contromozione – Creazione di Eva – Il combattimento per l’uomo: Spirito e Spirito contrastante – Istituzione dell’«heimarméne».
CAP. 8 – Creazione, storia del mondo e salvezza secondo Mani.
a) Il metodo di Mani; la sua vocazione.
b) Il sistema.
– I princìpi primordiali – L’attacco della Tenebra – Il pacifismo del mondo della Luce – La prima creazione: l’Uomo Primordiale – La sconfitta dell’Uomo Primordiale – Il sacrificio e l’adulterazione dell’Anima – La seconda creazione; lo Spirito Vivente; la liberazione dell’Uomo Primordiale – Creazione del macrocosmo – La terza creazione: il Messaggero – Origine delle piante e degli animali – Creazione di Adamo ed Eva – Missione del Gesù Luminoso; il Gesù «patibilis» – Conclusioni pratiche; la moralità ascetica di Mani – La dottrina delle ultime realtà.
c) Ricapitolazione: due tipi di dualismo nella speculazione gnostica.
PARTE TERZA – GNOSTICISMO E PENSIERO CLASSICO.
CAP. 9 – Il cosmo nella concezione greca e gnostica.
a) L’idea di «cosmo» e la posizione dell’uomo in esso.
– La posizione greca – La pietà cosmica come posizione di ritiro – La rivalutazione gnostica – La reazione greca.
b) Il destino e le stelle.
– Forme della pietà astrale nel mondo antico – Monoteismo solare – Pluralismo astrologico – La religione filosofica delle stelle – La rivalutazione gnostica – La reazione greca; la fraternità dell’uomo e delle stelle – La fratellanza acosmica di salvezza.
CAP. 10 – Virtù e anima nel pensiero greco e gnostico.
a) Il concetto di virtù: sua assenza nello gnosticismo.
b) La morale gnostica.
– Nichilismo e libertinismo – L’ascetismo, la rinunzia di sé e la nuova «virtù» – «Areté» e le «virtù» cristiane – La virtù in Filone Giudeo.
c) Psicologia gnostica.
– L’interpretazione demonologica dell’interiorità.
– L’anima come parte femminile – Illuminazione estatica.
d) Conclusione: il Dio sconosciuto.
CAP. 11 – Le recenti scoperte nel campo dello gnosticismo.
1. Osservazioni sulla biblioteca di Chenoboskhion.
– L’ipostasi degli Arconti e l’Origine del mondo.
a) Natura della colpa.
b) Conseguenze della colpa.
c) La passione della Sophia.
2. Il Vangelo di Verità.
Postilla al Cap. 11.
EPILOGO – GNOSTICISMO, ESISTENZIALISMO E NICHILISMO.
Avvertenza.
Abbreviazioni.
Nota sull’autore e Bibliografia.
PRESENTAZIONE.
1. Hans Jonas, allievo di Bultmann che già nel 1933 lasciò la Germania e attualmente insegna a New York, si impose all’attenzione degli studiosi di storia del cristianesimo e di storia delle religioni con la pubblicazione, nel 1934, del primo volume di “Gnosis und spätantiker Geist” (Gnosi e spirito della tarda antichità), cui nel 1954 aggiunse la prima parte di un secondo volume. L’opinione ormai prevalente che riconosceva nella gnosi (o meglio nello gnosticismo) un fenomeno religioso di carattere sincretistico con apporti iranici greci giudei cristiani facilmente induceva gli studiosi a considerare tale fenomeno soltanto come degenerazione delle religioni antiche e a risolvere i tanti problemi che esso proponeva soltanto mercé l’identificazione delle sue varie componenti, ponendo l’accento sull’una o sull’altra quale ingrediente dominante del composto. A tale indirizzo Jonas reagì affermando energicamente l’esigenza di studiare lo gnosticismo come un fenomeno religioso dotato di profonda originalità, tale da ridurre a unità le diverse componenti culturali in esso ravvisabili e da dare loro un nuovo significato: il principio animatore dello gnosticismo Jonas ravvisò nello spirito di rivolta che spinse ambienti di origine e formazione soprattutto orientale a reagire contro la concezione fondamentale ottimista del mondo così come lo concepiva la filosofia ellenista: ecco l’origine e il significato dell’anticosmismo gnostico.
Due altri caratteri fondamentali sono ravvisabili nello studio di Jonas: il primo consiste nell’interpretazione esistenzialista del fenomeno gnostico. In questo senso egli applica allo gnosticismo gli stessi parametri che il suo maestro Bultmann stava applicando all’interpretazione del Nuovo Testamento. E rispetto a tale tentativo, egli ha il vantaggio di poter prendere le mosse da una innegabile affinità fra gli stati d’animo fondamentali che sono alla base rispettivamente dell’esperienza esistenzialista e dell’esperienza gnostica: il senso di alienazione per cui l’uomo si sente isolato, indifeso, estraneo nelle sue più intime esigenze rispetto ad un mondo che lo circonda e lo opprime e dal quale egli cerca in qualche modo di evadere per poter realizzare il suo io più autentico.
L’altro carattere distintivo dell’indagine di Jonas è ravvisabile nella evidente tendenza a dilatare al massimo l’estensione del fenomeno gnostico e perciò la sua area di diffusione e di influenza, con netta propensione a ravvisare negli apporti di origine iranica gli elementi più caratteristici del movimento – secondo l’opinione prevalente allora fra gli studiosi tedeschi – e perciò nei documenti provenienti di lì o di lì influenzati i testimoni più autentici dello spirito che animò il movimento. In tal senso Jonas non esita a far rientrare nell’ambito dell’esperienza gnostica non soltanto gli scritti del “Corpus Hermeticum”, gli scritti alchimistici, il mandeismo, il marcionismo, il manicheismo, ma addirittura scrittori come Origene e Plotino che degli gnostici furono accaniti e irriconciliabili avversari.
2. Mi sono un po’ dilungato a fissare i caratteri distintivi di questo primo saggio di Jonas sullo gnosticismo perché il volume di cui qui presentiamo la traduzione, “The Gnostic Religion”, anche se di un ventennio posteriore, a quei caratteri resta tenacemente fedele. Infatti le critiche che da varie parti furono mosse a Jonas allorché apparve il precedente volume hanno, sì, spinto l’autore ad attenuare alcune punte radicali del suo discorso e a riesaminarne alcuni aspetti, ma non hanno avuto la forza di spingerlo a dubitare della fondamentale bontà della sua impostazione. Quello che differenzia in maniera profonda “Gnosis und spätantiker Geist” da “The Gnostic Religion” è il modo con cui la materia è presentata, e a tutto vantaggio del secondo volume. Infatti qui l’autore non soltanto ha ripartito con maggiore ordine e organicità il complesso materiale – pur adeguatamente sfrondato – che nel primo volume e nella prima parte del secondo dava a volte l’impressione di essere stato ammassato un po’ caoticamente, ma ha anche rinunciato a certe prese di posizione troppo critiche e soprattutto è riuscito a liberare perfettamente la sua prosa da quelle complicazioni e oscurità che rendono così difficile e indigesto il primo saggio: forse un benefico risultato del trapianto dell’autore dalla Germania negli Stati Uniti. Da tale profondo lavoro di revisione risulta la linea semplice e rettilinea del libro: una prima parte – dopo un’introduzione che situa il fenomeno gnostico nel mondo antico – tratta alcuni peculiari aspetti della sensibilità gnostica attraverso l’esame di varie immagini-chiave ricorrenti nei testi gnostici; la seconda parte descrive e analizza alcuni importanti documenti o sistemi gnostici; la terza approfondisce lo studio del contrasto fra il pensiero greco e il pensiero gnostico e abbozza un raffronto fra l’esperienza gnostica e quella esistenzialista.
Un problema delicato ed imbarazzante ha dovuto affrontare Jonas, come ogni altro studioso che si è occupato di gnosticismo, soprattutto con studio di ampio respiro, a partire dagli anni cinquanta: alludo alla scoperta della biblioteca gnostica di Nag-Hamadi (confronta l’ultimo capitolo del volume) e soprattutto all’abnorme, ingiustificabile lentezza con cui procedeva la pubblicazione di questi testi, lentezza dovuta a motivi tutt’altro che chiari e confessabili e che perciò giustamente l’autore biasima con amarezza. In linea teorica, poteva sembrare azzardato tracciare una sintesi del pensiero e dell’esperienza gnostica senza attendere la pubblicazione di questi testi originali, la cui conoscenza potrebbe rivoluzionare chi sa quanto profondamente la nostra conoscenza in materia. Ma dato il ritmo lentissimo con cui procedeva la pubblicazione dei testi, in linea pratica diventava impossibile sospendere ogni lavoro in attesa della pubblicazione dell’intero “corpus” o di almeno buona parte di esso. Nella prima edizione del suo volume Jonas ha fatto in tempo ad utilizzare l'”Evangelium Veritatis” e ne ha fatto largo uso; nella seconda ha aggiunto un capitolo finale in cui dà ragguagli di carattere generale sui testi di Nag-Hamadi, con notizie più dettagliate su alcuni testi.
La vastità della materia compresa in “The Gnostic Religion”, la padronanza e la competenza con cui l’autore la presenta, la chiarezza della sua esposizione, la profonda simpatia per l’argomento che tratta e la capacità di metterne in evidenza gli aspetti più poetici e cattivanti fanno del volume di Jonas lo strumento insieme più perspicuo e più completo, fra i tanti attualmente a nostra disposizione, da consigliare a chi voglia accostarsi a questo importante fenomeno religioso del mondo antico. Le considerazioni che seguono hanno solo il compito di lumeggiare meglio certe fondamentali impostazioni dell’autore nell’ambito della più recente problematica concernente il problema gnostico.
3. Gli studiosi moderni non riescono a mettersi d’accordo in merito ad una definizione soddisfacente del fenomeno gnostico, tale cioè da rilevare tutti e solo quei caratteri per cui una determinata manifestazione del pensiero religioso e filosofico dell’antichità possa essere definita a ragione gnostica: il colloquio tenuto a Messina nel 1966 ha dato fin troppo evidente manifestazione di tale disaccordo. In certi ambienti si tende ad accettare la distinzione fra una prima fase in cui cominciarono a circolare e a diffondersi nell’Oriente ellenizzato e romanizzato certi concetti di natura gnostica, ma non ancora articolati in maniera da costituire un vero e proprio organico sistema di pensiero e di espressione (gnosi e pregnosi), da un momento successivo, non anteriore al secondo secolo d.C. in cui sorsero le prime sette gnostiche esattamente caratterizzante per dottrina e anche per culto (gnosticismo). Ma anche su questo punto, per altro piuttosto generico, si è ancora ben lungi dal raggiungere una certa unanimità o almeno maggioranza di consensi. Vi si oppongono soprattutto gli studiosi che, accentuando nello gnosticismo l’incidenza di elementi di provenienza iranica (dualismo fra luce e tenebre, eccetera), preferiscono parlare di protognosticismo, come di un sistema di pensiero già organizzato prima del secondo secolo e al di fuori dell’area cristiana.
In questo secondo gruppo di studiosi è facile ricondurre anche Jonas, sia per il valore decisivo che egli assegna alla componente iranica nella formazione della sensibilità e della dottrina gnostica sia per l’ampiezza, già sopra rilevata, che egli assegna al fenomeno gnostico, per cui gli è facile ravvisarne la presenza in ambienti e in dottrine filosofiche e religiose molto disparate. In “The Gnostic Religion” egli descrive e analizza dettagliatamente sei fra testi e sistemi gnostici: di essi solo due rientrano nell’ambito dei sistemi gnostici tradizionalmente considerati tali, più o meno connessi con la religione cristiana: si tratta delle gnosi simoniana e valentiniana. Dato che ormai nessuno più esita a considerare lo gnosticismo fenomeno non ristretto in area cristiana, appare più che giustificata l’inserzione, fra i sistemi gnostici, di quello rappresentato dal primo trattato del “Corpus Hermeticum”, il famoso “Poimandres”. Ma le altre testimonianze sono tutte e tre discutibili: è vero che il manicheismo presenta elementi ereditati dallo gnosticismo, soprattutto il suo anticosmismo; ma il carattere di religione vera e propria che Mani gli volle imprimere, facendovi confluire cristianesimo, mazdeismo iraniano e buddismo, fa eccedere di gran lunga al manicheismo, sotto il profilo tipologico, l’ambito angusto della tradizionale setta gnostica. Fra i testi gnostici per i quali Jonas dimostra più simpatia e attrazione è senz’altro il cosiddetto “Canto della perla”, che nel volume è analizzato con finezza e gusto: d’altra parte, recentemente uno studioso dello gnosticismo certo non meno qualificato di Jonas, cioè G. Quispel, ha dato di questa bella composizione un’interpretazione che esclude quasi del tutto ogni traccia di gnosticismo, scorgendovi soltanto un prezioso prodotto del cristianesimo siriaco di tendenza encratita, che aveva per centro l’Edessa del secondo secolo (1).
Sul marcionismo il discorso è più impegnativo, in quanto è da tempo che si discute se questo movimento religioso debba essere considerato oppure no di carattere gnostico. In un recente importante articolo (2) Jonas ha cercato di fissare e perciò di circoscrivere i caratteri peculiari del fenomeno gnostico: emanatismo quanto all’origine degli esseri divini l’uno dall’altro in decrescendo di perfezione; carattere mitologico della dottrina; dualismo fra l’uomo e il mondo e, nell’interno dell’uomo, fra lo spirito consustanziale con la divinità, e la carne; soteriologia impostata sul concetto di rivelazione (= gnosi) destinata a pochi eletti. Prendendo in considerazione il marcionismo su questa base Jonas si è accorto che pressoché nessuno degli elementi che egli aveva fissato come caratteristici del fenomeno gnostico era ravvisabile in quell’importante movimento religioso: vi ha ravvisato però il netto contrasto fra il Dio sommo e il Demiurgo inferiore, creatore del mondo, e l’ascetico ribelle rifiuto del mondo stesso. Tanto è bastato per fargli considerare il marcionismo come una forma di gnosticismo «nello spirito se non nella lettera».
Non è questa la sede per approfondire l’argomento: ci limitiamo perciò a questi pochi cenni per rilevare quanto problematica sia la questione e quanto discutibile sia la posizione di Jonas, che da un lato cerca di delimitare con esattezza e rigore l’ambito del fenomeno gnostico, ma dall’altro sembra accontentarsi della presenza di soltanto qualcuno dei vari caratteri che egli considera peculiari di quel fenomeno per far rientrare nell’area gnostica documenti e dottrine della più varia provenienza. Oltre che a Marcione, si pensi a Plotino, ricondotto all’influenza gnostica per la dottrina emanatista della derivazione del Nous dall’Uno e dell’anima del mondo dal Nous; e ad Origene che dallo gnosticismo avrebbe derivato la linea fondamentale del suo sistema articolato sul concetto della frattura e della reintegrazione dell’Unità originaria della natura razionale.
Basterà accennare soltanto a due altre conseguenze che derivano insieme dall’ampiezza che Jonas attribuisce al fenomeno gnostico e dalla propensione a scorgerne il carattere più genuino in testimonianze di origine orientale: 1) per illustrare certi atteggiamenti e certi concetti tipici della sensibilità gnostica egli si serve soprattutto di testi mandei e manichei. E’ fuor di dubbio che si tratta di testi ben scelti, il cui colorito fantastico, non di rado poetico, sottolinea e rileva con evidenza il sottofondo di carattere affettivo che l’autore tanto valorizza come elemento costitutivo della sensibilità gnostica. D’altra parte egli stesso riconosce che solo in ambiente greco, soprattutto nella scuola di Valentino, lo gnosticismo ha saputo darsi l’impronta di vero e proprio sistema di pensiero organicamente e logicamente costruito. Mi sembra perciò discutibile la scelta di passi operata da Jonas, tanto più che per sistemi gnostici riportabili all’area ellenica la nostra documentazione rimonta con facilità al secondo secolo, là dove i testi manichei sono evidentemente più tardi e altrettanto dicasi per quelli mandei, anche se studiosi dei nostri giorni cercano di dimostrarne l’arcaicità di tradizione.
2) Gli studi più recenti sulle origini e i caratteri peculiari dello gnosticismo da qualche decennio sono orientati nel senso di valorizzare al massimo la componente giudaica ravvisabile in tutta l’area gnostica, anche considerata con la larghezza che caratterizza l’interpretazione di Jonas. Si insiste sul racconto biblico della creazione dell’uomo come elemento costitutivo dell’esperienza e della dottrina gnostica. E in ambito ebraico ha la sua origine non soltanto il personaggio di Sophia, anch’esso centrale nella dottrina gnostica, ma anche quello dell’Uomo celeste, che vi è altrettanto significativo. Ovviamente Jonas conosce bene questo orientamento di studi e nel suo volume tocca variamente i tratti gnostici di origine giudaica: ma la sua impostazione metodologica e filosofica lo porta, come abbiamo visto, a valorizzare soprattutto l’eredità orientale dello gnosticismo; e perciò egli annette alla componente giudaica molto meno significato di quanto non si faccia usualmente ai nostri giorni. E’ di ieri una sua presa di posizione in questo senso che ha provocato una dura replica da parte di Quispel (3). E d’altra parte Jonas ha dalla sua la constatazione che i sostenitori dell’origine giudaica dello gnosticismo si trovano in evidenti difficoltà allorché debbono spiegare il tono violentemente antigiudaico che anima lo spirito gnostico della sua recisa opposizione al Dio creatore della “Genesi” e a tutta l’economia veterotestamentaria.
Tocchiamo qui il punto nevralgico della problematica sull’origine dello gnosticismo: da una parte si mettono sempre più in evidenza all’interno del movimento i caratteri di origine giudaica come essenziali e costitutivi della sua economia; ma dall’altra non si riesce a spiegare, restando nell’ambito del giudaismo, come e perché tali caratteri siano stati deformati e reinterpretati proprio in senso antigiudaico. Proprio questa evidente aporia spiega la fortuna che presso studiosi anche qualificati ha avuto l’avventurosa ipotesi di Grant, che ha voluto spiegare l’origine dello gnosticismo come reazione antijahvistica e antilegalistica avvenuta, all’interno del giudaismo, a causa del crollo delle speranze apocalittiche ed escatologiche di liberazione e di rivincita sui nemici di Israele in conseguenza della presa e della distruzione di Gerusalemme da parte dei Romani. In definitiva sembra più sul solido Jonas allorché, nel già ricordato articolo, propone come zona d’origine dello gnosticismo un territorio limitrofo alla Giudea, da questa influenzato ma ad essa ostile (si pensi alla Samaria, patria di Simone, considerato tradizionalmente il primo gnostico).
4. Abbiamo sopra accennato che è stato merito di Jonas sottolineare l’esigenza di considerare lo gnosticismo non come degenerazione di antiche religioni e risultato di mera aggregazione di componenti di disparata origine, ma come movimento di pensiero animato da un motivo profondo e potente, tale da ridurre a salda unità gli elementi di disparata origine. Tale motivo animatore e unificatore egli ha scorto nel reciso anticosmismo che caratterizza ogni esperienza gnostica.
Tutto il volume di Jonas fa perno su questo motivo: ma è soprattutto nell’introduzione e poi nell’ultima parte della trattazione che esso viene inserito, con tutto il suo decisivo significato, in ambito storico e culturale, là dove l’autore lo contrappone in maniera recisa all’ottimistica concezione del mondo che era peculiare della cultura greca intorno all’èra volgare. Per il greco colto di questo periodo il Kosmos, come dice la stessa parola, era concepito soprattutto come ordine, regolarità, bellezza, come complesso di norme attuantisi senza turbamento ed errore, tale da assicurare il governo provvidenziale di Dio su tutto l’universo. L’ineluttabilità di tali leggi si imponeva all’uomo come un fato cui egli non poteva sottrarsi; ma si trattava non di un destino cieco e irrazionale, bensì provvidenziale e benefico, ordinato al bene di tutti gli esseri compresi nel mondo. In tal senso, per lo stoico, fato e provvidenza divina si identificavano in quello che, prendendo a prestito la famosa espressione di Leibnitz, possiamo definire come il migliore dei mondi possibili: e allora di buon grado il sapiente comprendeva che la sua volontà doveva liberamente adattarsi alla superiore volontà divina immanente del Kosmos.
A tale ottimistica concezione lo gnostico ne contrappose una perfettamente antitetica: anch’egli vedeva il mondo come complesso di leggi regolare e ineluttabile; ma ben lungi dal considerarlo quale espressione di una benefica provvidenza divina lo sentiva come costrizione, come destino malefico e ineluttabile regolato e controllato da divinità sostanzialmente ostili alle creature del mondo, soprattutto all’uomo. Proprio la regolarità delle leggi governanti il moto degli astri diventa ora l’espressione della ineluttabilità del destino che sovrasta, da nemico, ogni uomo e lo costringe fatalmente. E unica possibilità di salvezza lo gnostico ravvisa nella convinzione che tale tirannia si esercita soltanto sulla parte materiale della sua persona, sì che la scintilla divina che alberga in lui potrà un giorno spezzare la ferrea prigionia delimitata dall’ambito della volta celeste e raggiungere l’autentico mondo divino situato al di là, quel mondo da cui il suo spirito è originario e la cui esistenza è ignota alle potenze avverse che governano il Kosmos materiale.
Questa contrapposizione Jonas volentieri definisce come coscienza rivolta della nuova mentalità gnostica contro la dottrina filosofica e religiosa dominante nel mondo greco-romano, come rifiuto ascetico di quel che il greco considerava il massimo bene e che invece lo gnostico considera il massimo male. In suggestive pagine dell’Introduzione l’autore interpreta questa contrapposizione e questa rivolta come conseguenza del riemergere dello spirito e della vitalità orientali, per secoli coartate e condizionate dalla superiore cultura imposta dalla conquista greca e ribadita da quella romana. Giovandosi proprio dell’assimilazione dei parametri e delle strutture di pensiero e d’espressione caratteristiche di quella cultura dominante, dopo una lunga fase di sotterranea preparazione, lo spirito orientale sarebbe riemerso alla ribalta della storia con una serie di espressioni religiose e culturali variamente fra loro collegate e interferenti: il giudaismo alessandrino, il cristianesimo, le religioni misteriche, l’astrologia babilonese, lo gnosticismo. Proprio quest’ultimo, col suo più risentito spirito di opposizione e di rivalsa rispetto al mondo ellenistico, avrebbe rappresentato l’aspetto più autentico e significativo di tale reazione orientale.
Non v’ha dubbio che questa interpretazione, delineata con mano abile, si presenti al lettore avvincente, direi affascinante. Il suo punto debole sta, a mio avviso, in una certa maniera un po’ impressionistica di presentare i fatti culturali, sia nell’accostarli sia nel contrapporli, senza sentire l’esigenza di stringere da presso l’argomento su più solida base documentaria e con più vigile senso filologico. Mi riferisco innanzi tutto all’accostamento, sopra riferito, fra i numerosi fenomeni che caratterizzerebbero la reazione dell’Oriente, disparati fra loro sotto l’aspetto culturale, oltre che cronologico e topografico, sì che pare arbitrario riportarli ad una sola matrice, per di più rappresentata, nella forma più autentica, dall’esperienza gnostica: tra Filone e lo gnosticismo, nonostante i tentativi di accostamento che opera Jonas, ci corre molto e le esigenze che stanno alla base dell’uno e dell’altro non sembrano affatto riconducibili alla stessa matrice, nel senso che lo spirito che animò il tentativo filoniano di sintesi fra ellenismo e giudaismo non presenta nulla in comune con lo spirito ribelle dello gnosticismo, soprattutto se presentato nella maniera così accentuata che è propria di Jonas. La fine analisi che egli fa del concetto di virtù presso i Greci, i cristiani, Filone e gli gnostici gli permette di accostare, almeno parzialmente, questi tre ultimi in contrapposizione ai Greci: ma si tratta di accostamento che, soprattutto in riferimento a Filone e agli gnostici, attiene ad un aspetto marginale del loro pensiero e non esclude la decisa contrapposizione di fondo.
L’altro punto discutibile della presentazione di Jonas è nella troppo recisa opposizione fra grecità e gnosticismo. Sotto il punto di vista dell’atteggiamento nei confronti del Kosmos tale opposizione può sembrare legittima, ma solo a patto di trascurare il dualismo deciso con cui alcuni dialoghi di Platone contrappongono il mondo delle idee al mondo materiale di quaggiù ( = “kosmos”). Come ha ben dimostrato Festugière, l’eredità platonica è stata duplice e i suoi scritti hanno potuto favorire uno sviluppo in senso sia favorevole sia ostile al Kosmos. Ma è soprattutto al livello antropologico che l’opposizione ravvisata da Jonas mi sembra discutibile. Nel mondo greco, anche quando la speculazione del vecchio Platone, del giovane Aristotele e degli Stoici impose l’ottimistica concezione di un Kosmos divinizzato, sul piano antropologico restò sempre largamente dominante la fondamentale intuizione platonica della contrapposizione fra anima e corpo, sentiti come entità eterogenee e contrastanti fra loro. Sulla base di questo assunto consideriamo ora che l’esperienza gnostica fu orientata fondamentalmente, per non dire esclusivamente, in senso soteriologico; e in tal senso la liberazione consisteva per lo gnostico proprio nella separazione del pneuma divino (= anima o “nous” alla maniera platonica) dal corpo materiale che l’opprimeva e l’imprigionava.
In altri termini, il dualismo antropologico degli gnostici non deve essere considerato soltanto come riflesso del dualismo cosmologico bensì come esperienza fondamentale e costitutiva della sensibilità e perciò della dottrina gnostica. Ciò considerato, il netto contrasto che Jonas istituisce fra la concezione del mondo rispettivamente greca e gnostica perde buona parte del suo significato, in quanto non sorretta da altrettanto netta opposizione sul piano antropologico. E d’altra parte, il rapporto fra dualismo cosmologico e dualismo antropologico non è nel pensiero gnostico così chiaro e immediato come Jonas vorrebbe far credere. Se alle origini del dualismo antropologico è facile ravvisare l’influsso del Platone del “Fedone” e dialoghi affini, molto più oscura è l’origine dell’anticosmismo gnostico. Fino a che punto e in quale modo preciso esso è connesso con la reinterpretazione deformante in senso negativo dei dati della religione veterotestamentaria? Finché non sarà risolto questo problema, non sarà agevole situare questo caratteristico “theologoumenon” gnostico nell’economia del sistema in giusta prospettiva. Prendiamo ad esempio Marcione, che proprio sulla base dell’anticosmismo Jonas rivendica all’ambito gnostico. Noi sappiamo quanto profondamente il pensiero di Marcione fu nutrito dalla lettura e dalla meditazione delle lettere di Paolo: sotto questo punto di vista, tutto il sistema di Marcione può agevolmente essere considerato quale forma radicale di paolinismo, per cui la contrapposizione fra la legge del Vecchio e la grazia del Nuovo Testamento sarebbe stata esasperata fino a proiettarsi, sul piano antropologico, molto al di là dei limiti della contrapposizione paolina fra spirito e carne, sia per superficiale comprensione dei reali termini paolini sia sotto l’urgenza delle tendenze encratite forti in certi ambienti del cristianesimo primitivo, e trasferita sul piano cosmologico, ormai del tutto al di fuori dell’intuizione paolina, avrebbe portato alla contrapposizione fra il Dio sommo e il Demiurgo e al rifiuto dell’opera di quest’ultimo, cioè del mondo.
Ho detto che questa “può” essere un’interpretazione di Marcione: in effetto essa non tien conto della componente antigiudaica del pensiero gnostico contemporaneo all’eresiarca, che certo avrà influito su di lui. Ma com’è possibile stabilire in Marcione l’incidenza precisa delle due componenti (Paolo e la gnosi) e individuarne il preciso rapporto? Possiamo concludere che soltanto una soddisfacente soluzione del problema proposto dalla presenza, nello gnosticismo, di un’importante componente giudaica reinterpretata in senso negativo potrà darci l’esatta dimensione prospettica dell’anticosmismo gnostico in senso storico-culturale.
E questo interrogativo è destinato a riproporsi nei più svariati contesti. E’ stato merito di Jonas sottolineare le affinità di fondo fra la sensibilità gnostica e quella esistenzialista nel comune senso di alienazione nei confronti del mondo che ci circonda. Ma le cause prossime e remote dell’alienazione esistenzialista (e, possiamo aggiungere ora, del rifiuto programmatico del mondo moderno ad opera della contestazione giovanile) sono chiaramente individuabili nelle dimensioni oppressive e disumane che ormai ha assunto in ogni campo la massificazione operata dalla civiltà tecnologica della produzione e dei consumi. Ma per l’alienazione gnostica non possiamo addurre con chiarezza nessun motivo e nessuna causa precisa, perché se da una parte non soddisfano i recenti tentativi, specifici e puntuali, prospettati da Grant e da Adam (4), dall’altra è troppo generico parlare, con Jonas, di un’ipotetica rivalsa dell’Oriente contro l’oppressione occidentale.
La sensibilità e la formazione di Jonas sembrano portate all’apprezzamento tipologico del fenomeno gnostico e allo studio, a larghi tratti, dei suoi aspetti caratteristici e delle sue forme espressive più valide, piuttosto che all’approfondimento sistematico del momento filologico della ricerca. In questi limiti leggiamo e apprezziamo il suo volume come un’affascinante ricostruzione dei momenti più significativi del pensiero e soprattutto dell’esperienza gnostica.
MANLIO SIMONETTI
NOTE.
1. Confronta “Le origini dello gnosticismo” (colloquio di Messina, 13-18 aprile 1966), p.p. 625 s.s.
2. Confronta “Le origini dello gnosticismo” p.p. 90 s.s.
3. Confronta rispettivamente “The Bible in Modern Scholarship», p. 288 e “Kyriakon” (Festschríft J. Quasten), p.p. 271 s.s.
4. Confronta “Le origini dello gnosticismo”, p. 291. Adam ipotizza come possibile motivo ispiratore remoto del pessimismo gnostico il senso di frustrazione degli scribi babilonesi privati delle loro funzioni di interpreti e messaggeri della volontà degl’imperatori persiani (e poi di Alessandro Magno) in materia religiosa, a causa del frazionamento dell’impero.
AVVERTENZA ALLA SECONDA EDIZIONE.
La presente traduzione è stata condotta sulla quarta edizione inglese dell’opera “The Gnostic Religion”, apparsa nel 1972, presso la Casa Editrice Beacon Press di Boston.
Questa seconda edizione della traduzione italiana conserva il titolo della precedente, preciso e determinato, «Lo Gnosticismo». Avrei preferito restituirlo, per così dire, all’originale ambiguità del titolo inglese “The Gnostic Religion”, aperto a più interpretazioni, secondo il pensiero più genuino dell’autore dell’opera (1). Ciò avrebbe tuttavia creato problemi di tipo tecnico e commerciale e, soprattutto, creato confusione nell’ambito accademico e nel settore bibliografico.
Il testo è stato accuratamente rivisto e corretto soprattutto dalle mende tipografiche.
E’ stata conservata la Presentazione del Prof. Manlio Simonetti, che precisa i limiti e i meriti della pubblicazione. A lui va il ringraziamento del curatore e dell’editore.
E’ stata aggiunta alla fine del volume una Postfazione, contenente una nota bio-bibliografica sull’autore e una scelta, eppur dettagliata, bibliografia riguardante lo gnosticismo e i principali temi trattati nel volume.
RAFFAELE FARINA
Roma, 15 novembre 1990
NOTA.
1. Confronta FILORAMO GIOVANNI, “Il risveglio della gnosi ovvero diventare Dio” in Quadrante 33 (Bari-Roma, Laterza 1990) 150, n. 30.
PREFAZIONE.
Agli albori nebulosi della nostra èra appare un corteo di mitiche figure i cui lineamenti imponenti e sovrumani potrebbero popolare le pareti e il soffitto di un’altra Cappella Sistina. Il loro aspetto e i loro gesti, le parti che sono state loro assegnate, il dramma che rappresentano, potrebbe suscitare immagini diverse da quelle bibliche, a cui è stata abituata l’immaginazione dello spettatore, immagini tuttavia a lui stranamente familiari e toccanti in modo inquietante. La scena sarebbe la stessa, il tema ugualmente trascendente: la creazione del mondo, il destino dell’uomo, la caduta e la redenzione, la realtà iniziale e quella finale. Ma quanto più numerosi sarebbero i personaggi, quanto più bizzarro il simbolismo, quanto più strane le emozioni!
Quasi tutta l’azione si svolge nell’alto, nel regno divino o angelico o demoniaco, un dramma di personaggi pre-cosmici nel mondo soprannaturale di cui il dramma dell’uomo nel mondo naturale non è che un’eco lontana. E tuttavia quel dramma trascendentale anteriore ai tempi, raffigurato nelle azioni e passioni di personaggi quasi umani, desterebbe un’intensa simpatia umana: la divinità sottoposta a tentazione, l’inquietudine che circola tra i beati Eoni, la Sapienza fallibile di Dio, la Sophia, che vaga in preda alla sua follia, errante nel vuoto e nel buio da essa creato, che cerca incessantemente, che si lamenta, soffre, si pente, dibattendosi verso la materia, soffrendo un ardente desiderio verso l’anima; un Creatore cieco e arrogante che si crede l’Altissimo e domina la creazione, prodotto, come egli stesso, dell’errore e dell’ignoranza; l’Anima, impigliata e smarrita nel labirinto del mondo, che cerca di sfuggirne e, spaventata, è respinta dai guardiani della prigione cosmica, i terribili arconti; un Salvatore proveniente dalla Luce dell’aldilà che si avventura nel basso mondo, illuminando le tenebre, aprendo un cammino, risanando la divina infrazione: un racconto di luce e tenebre, di conoscenza e ignoranza, di serenità e passione, di egoismo e pietà, sulla scala non dell’uomo, ma degli esseri eterni che non sono esenti dalla sofferenza e dall’errore.
Il racconto non ha ancora trovato un Michelangelo, né un Dante, né un Milton che lo narrassero. La severa disciplina della fede biblica ha resistito alla tempesta di quei giorni, e restarono soltanto il Vecchio e il Nuovo Testamento a informare la mente e l’immaginazione degli uomini dell’Occidente. Quelle dottrine che, nell’ora febbrile di transizione, hanno sfidato, tentato, cercato di pervertire la nuova fede, sono dimenticate e la loro testimonianza scritta è sepolta nei volumi di coloro che l’hanno confutata o nelle sabbie di antiche contrade. La nostra arte e la nostra letteratura e molte altre cose sarebbero state differenti, se fosse prevalso il messaggio dello gnosticismo. Dove il pittore e il poeta rimangono silenziosi, lo studioso deve ricostruire dai suoi frammenti un mondo scomparso e con i propri deboli mezzi riportarne in vita la struttura. Può farlo molto meglio ora che in altri tempi, perché le sabbie hanno cominciato a restituire qualche cosa del deposito sepolto. Tale ricostruzione non ha solo un interesse per l’antico: nonostante tutta la sua stranezza, la violenza fatta alla ragione, i suoi eccessi di giudizio, quel mondo di sentimento, di visione e di pensiero, ha la sua profondità e senza la sua voce, le sue intuizioni e persino i suoi errori, la testimonianza dell’umanità non sarebbe completa. Per quanto rifiutato, rappresenta una delle possibilità che si presentarono allora nell’incrocio di credenze diverse. Il suo splendore getta luce sugli inizi del cristianesimo, i dolori del parto del nostro mondo; e gli eredi di una decisione presa molto tempo fa comprenderanno meglio la loro eredità conoscendo ciò che una volta fu in lotta con essa per l’anima dell’uomo.
Le ricerche sullo gnosticismo sono quasi altrettanto antiche quanto lo gnosticismo stesso. Soprattutto per sua propria iniziativa – essendo l’aggressore – fu fin dall’inizio una causa combattuta e per tale motivo fu oggetto di esame da parte di coloro la cui causa minacciava di sovvertire. L’esame condotto nel calore del conflitto, fu quello d’un pubblico accusatore. Attori dell’accusa furono i Padri della Chiesa primitiva, che in lunghe opere stesero l’accusa contro le eresie (non abbiamo alcun documento della difesa, seppure ve ne furono); ed essi ricercarono i predecessori spirituali dello gnosticismo nel compito di mostrarne chiaramente l’errore. I loro scritti perciò ci forniscono non soltanto la principale – fino a poco tempo fa, la sola – fonte di conoscenza dell’insegnamento gnostico, ma anche la prima teoria circa la sua natura e la sua origine. Per essi la scoperta che lo gnosticismo, o ciò che in essi deformava la verità cristiana, proveniva dalla filosofia ellenica, equivaleva ad un capo d’accusa; per noi ha ancora valore come ipotesi, tra alternative diverse, importante per la diagnosi storica del fenomeno, e deve essere presa in considerazione in ciò che ha di positivo.
L’ultimo tra i più grandi studiosi di eresie, che si occupò estesamente delle sètte gnostiche, Epifanio di Salamina, scrisse nel quarto secolo d.C. Da allora, passato il pericolo e spento l’interesse polemico, tutta la questione cadde in dimenticanza fino a che l’interesse storico del diciannovesimo secolo si riportò ad esso in uno spirito di ricerca spassionata. Per sua natura l’argomento divenne dominio dei teologi, come tutto ciò che è connesso con gli inizi del cristianesimo. Ma i teologi protestanti (soprattutto tedeschi) impegnati nella nuova indagine affrontarono il loro compito come storici che non hanno parte nel conflitto, sebbene le tendenze intellettuali del loro tempo possano avere influenzato le loro simpatie e i loro giudizi.
Fu allora che cominciarono a sorgere diverse scuole circa la natura storica dello gnosticismo. Naturalmente la tesi dei Padri della Chiesa sulla derivazione ellenica e più particolarmente «platonica» tornò in vigore, e non soltanto per la loro autorità, ma anche perché aspetti suggestivi dei documenti letterari, compreso l’uso gnostico dei termini filosofici, come pure le probabilità generali dell’epoca, indicavano al principio quasi inevitabilmente quella direzione. In realtà difficilmente avrebbe potuto essere scelta un’alternativa diversa fintanto che il pensiero giudeo-cristiano e quello greco erano considerati come le sole forze capaci di esercitare una certa influenza in quel periodo. Però dividendo la realtà che è lo gnosticismo per questi fattori conosciuti, ne rimane una parte troppo grande, e fin dal principio del diciannovesimo secolo la scuola «ellenica» fu contrastata da una «orientale», che sosteneva che lo gnosticismo derivasse da una più antica «filosofia orientale».
Sebbene questa posizione riflettesse un’intuizione giusta, risultò indebolita perché operava con una grandezza mal definita e in realtà sconosciuta, ossia quella filosofia orientale la cui natura ed esistenza erano supposte in base ai dati dello gnosticismo stesso piuttosto che dimostrate indipendentemente. La posizione tuttavia guadagnò più stabile terreno, appena fu riconosciuto il carattere mitologico piuttosto che filosofico di ciò che era considerato orientale nello gnosticismo, e la ricerca della filosofia misteriosa fu abbandonata. Si può dire in generale che fino ad oggi l’enfasi «greca» o «orientale» si sposta in un senso o nell’altro secondo che viene considerato come determinante l’aspetto filosofico o mitologico, razionale o irrazionale del fenomeno. Il punto culminante della tesi greca e razionale si può trovare alla fine del secolo nella famosa formula di Adolfo von Harnack che lo gnosticismo è l’«ellenizzazione acuta del cristianesimo».
Nel frattempo tuttavia la situazione scientifica mutò, quando lo studioso classico e l’orientalista penetrarono nel campo tenuto in precedenza solo dal teologo. Le ricerche sullo gnosticismo divennero parte di uno studio più ampio su tutto il periodo della tarda antichità, quando una varietà di discipline si trovarono a contatto. E fu la più giovane scienza dell’orientalista a poter dare un maggior contributo a quanto la teologia e la filologia classica avevano da offrire. Il concetto vago di pensiero «orientale» in modo generico fu sostituito da una conoscenza concreta di parecchie tradizioni nazionali che si mescolavano nella cultura del tempo; e il concetto di ellenismo stesso veniva modificato includendo influenze eterogenee e distinte nel quadro greco fino allora prevalente.
Quanto allo gnosticismo in particolare, la conoscenza di codesto materiale soprattutto mitologico, quali i testi copti e mandei, portò un duro colpo alla posizione «greco-filosofica», dal quale questa non si riprese mai più, sebbene non possa essere del tutto abbandonata per la natura stessa del fenomeno in esame. La diagnosi dello gnosticismo fu fatta in gran parte in base alla genealogia, e riguardo a quest’ultima il campo fu spalancato; ad una ad una, o variamente combinate, le diverse derivazioni orientali – babilonese, egiziana, iranica -, suggerite da una realtà così ricca di sfumature, furono elaborate per determinare il principale «da dove» o il «che cosa» della gnosi, con il risultato generale di renderne la rappresentazione sempre più sincretistica.
L’ultima svolta nella ricerca di una linea predominante di derivazione è di far provenire lo gnosticismo dal giudaismo: doverosa correzione di una precedente trascuratezza, ma con molta probabilità non più adeguata al fenomeno integrale delle altre spiegazioni parziali o parzialmente vere. In realtà, fin dove è possibile seguire le tracce dei vari elementi costitutivi, tutte le indagini particolareggiate esperite durante l’ultimo mezzo secolo sono risultate divergenti anziché convergenti, e ci portano a un ritratto dello gnosticismo nel quale caratteristica saliente sembra essere la mancanza di un dato unificatore. Ma queste stesse indagini hanno gradualmente allargato il campo del fenomeno al di là del gruppo di eresie cristiane originariamente comprese sotto questo nome, e per la sua maggiore ampiezza, come pure per la sua maggiore complessità, lo gnosticismo cominciò a rivelare sempre di più la totalità della civiltà nella quale sorse e il cui tratto principale era il sincretismo.
Sia la ricchezza dei particolari storici, sia la suddivisione del soggetto nei motivi derivanti da tradizioni separate, si trovano riflesse nell’opera di Wilhelm Bousset del 1907, “Hauptprobleme der Gnosis” (Problemi principali dello Gnosticismo), che ha caratterizzato tutta una scuola e per lungo tempo ha dominato il campo. Il presente lavoro non è precisamente nella stessa linea. Quando molti anni fa, sotto la guida di Rudoy Bultmann, mi accostai per la prima volta allo studio dello gnosticismo, trovai un terreno ricco dei frutti concreti della filologia e della sorprendente messe del metodo genetico. A tutto ciò non avevo la pretesa né l’intenzione di aggiungere alcunché; il mio scopo, alquanto diverso dalla ricerca precedente e che tuttora continua, ma che può essere di complemento ad essa, era di natura filosofica: comprende lo spirito che parla per mezzo di queste voci e alla sua luce ricostruire un’unità intelligibile dalla molteplicità ingannevole delle sue espressioni.
Che vi fosse un tale spirito gnostico, e perciò un’essenza dello gnosticismo nel suo complesso, fu l’impressione che mi colpì al mio primo incontro con i documenti e crebbe col crescere dell’intimità. Esplorare e interpretare tale essenza divenne una questione di interesse non soltanto storico, in quanto aggiunge sostanzialmente qualcosa alla nostra conoscenza di un periodo cruciale dell’umanità dell’Occidente, ma anche di interesse intrinsecamente filosofico, in quanto ci pone a faccia a faccia con una delle più fondamentali risposte dell’uomo alla sua specifica situazione e con le intuizioni che soltanto una posizione così radicale può produrre, ed è perciò di considerevole apporto alla nostra umana conoscenza in generale.
I risultati di questi studi prolungati sono stati pubblicati in tedesco col titolo “Gnosis und spätantiker Geist” (Gnosi e spirito della tarda antichità); il primo volume è apparso nel 1934, il secondo – a causa delle circostanze di quel periodo – soltanto nel 1954, ed il terzo ed ultimo deve ancora essere pubblicato. Il presente volume, pur mantenendo il punto di vista dell’opera più vasta e riaffermando molti dei suoi argomenti, è differente per l’ampiezza, la sistematizzazione e l’intenzione letteraria. In primo luogo, si mantiene nel campo che per consenso generale è chiamato gnosticismo ed evita di sconfinare nel dominio più ampio e controverso in cui l’altra opera, per estensione di significato, cerca di scoprire la presenza di un «principio gnostico» trasformato, in manifestazioni del tutto diverse da quelle primarie (come nei sistemi di Origene e di Plotino).
Tale limitazione della mia visuale non è dovuta ad un cambiamento di vedute, ma al semplice fatto che questo libro è di un genere diverso. Perciò la maggior parte della trattazione filosofica troppo difficile, con il suo linguaggio tecnico – causa di molte lamentele nei volumi tedeschi – è stata eliminata in questo lavoro che si sforza di raggiungere sia il lettore di normale cultura, sia lo studioso. Per lo stesso motivo sono state evitate discussioni metodologiche e controversie di specialisti (tranne occasionalmente nelle note).
D’altra parte, sotto certi aspetti il presente volume va oltre la primitiva presentazione: alcuni testi sono più completamente interpretati; come negli estesi commenti all’«Inno della Perla» e al “Poimandres”; ed è stato possibile includervi il nuovo materiale delle recenti scoperte. Inevitabilmente, sebbene questo sia un nuovo libro e non una traduzione, esso ripete con qualche formulazione nuova alcune parti dell’opera tedesca.
Tutte le fonti sono date in traduzione. Le traduzioni dal greco e dal latino sono mie, a meno che non sia specificato altrimenti. I testi mandei sono resi sulla scorta della traduzione tedesca di Lidzbarski, e analoga procedura è stata adottata per i testi copti, siriaci, persiani ed altri, in base alle traduzioni moderne; dove esistevano parecchie traduzioni (come per la maggior parte del materiale manicheo orientale e per l’«Inno della Perla») ne ho ricavato, secondo il mio giudizio e facendo una sinossi, una versione combinata che mi è sembrata la migliore.
Ringrazio i miei editori tedeschi, Vandenhoeck e Ruprecht di Göttinga, che in una questione così delicata, come quella delle coincidenze di questa trattazione con quella precedente, mi hanno lasciato interamente libero di seguire il mio giudizio e senso di opportunità. Ancora un ringraziamento alla signorina Jay Macpherson del Victoria College di Toronto, studiosa e poetessa, che con grande pazienza e sicuro tatto linguistico mi ha aiutato a formulare il mio pensiero in inglese, commentando, approvando e disapprovando durante tutta la stesura di questo libro, senza però impormi uno stile che non fosse a me confacente.
HANS JONAS
Introduzione.
ORIENTE E OCCIDENTE NELL’ELLENISMO.
Qualsiasi descrizione dell’epoca ellenistica deve iniziare con Alessandro Magno; la sua conquista dell’Oriente (334-323 a.C.) segna una svolta nella storia del mondo antico. Dalle condizioni che essa creò, sorse una unità culturale più vasta di ogni altra esistita precedentemente, unità che doveva durare per quasi un millennio fino a che a sua volta fu distrutta dalle conquiste dell’Islam.
Il nuovo fatto storico reso possibile, e in realtà voluto, da Alessandro fu l’unione dell’Occidente e dell’Oriente. «Occidente» significa qui il mondo greco riunito intorno all’Egeo; «Oriente», l’area delle antiche civiltà orientali, che si estendevano dall’Egitto ai confini dell’India. Sebbene la creazione politica di Alessandro si sia sfasciata dopo la sua morte, la fusione delle civiltà continuò indisturbata durante i secoli seguenti, sia come processo regionale di fusione tra i numerosi regni dei Diadochi, sia come nascita di una cultura essenzialmente sopra-nazionale, ellenistica, comune a tutti questi. Quando infine Roma fece sparire le entità politiche separate e le trasformò in province dell’Impero, dette semplicemente forma a quell’omogeneità che di fatto aveva prevalso da tempo indipendentemente dalle frontiere dinastiche.
Nell’ampia inquadratura geografica dell’Impero romano, i termini «Oriente» e «Occidente» assunsero nuovi significati: «Oriente» fu la metà greca del mondo romano e «Occidente» la metà latina. La metà greca tuttavia comprese tutto il mondo ellenistico nel quale la Grecia propriamente detta era divenuta la parte minore; ossia comprese tutta quella parte dell’eredità di Alessandro che non era ritornata sotto il dominio «barbarico». Perciò nella prospettiva ingrandita dell’Impero, l’Oriente è costituito dall’unione di ciò che prima era distinto in Occidente ellenico e Oriente asiatico.
Nella divisione di Roma in un Impero d’Oriente e un Impero d’Occidente, stabilita fin dal tempo di Teodosio, la situazione culturale trovò una definitiva espressione politica: sotto Bisanzio la metà orientale del mondo unificata venne finalmente a formare quell’Impero greco che Alessandro aveva previsto e l’ellenismo aveva reso possibile, sebbene la rinascita persiana al di là dell’Eufrate ne avesse diminuita l’estensione geografica. L’analoga divisione della cristianità in una Chiesa latina e una Chiesa greca riflette e rende stabile la stessa situazione culturale nel campo religioso.
E’ questa unità spazio-culturale, creata da Alessandro e rappresentata successivamente dai regni dei Diadochi, dalle province romane orientali, dall’Impero bizantino, e rispettivamente dalla Chiesa greca, unità tenuta insieme nella sintesi ellenistico-orientale, che può fornire il quadro per quei movimenti spirituali che vogliamo trattare in questo libro. In questo capitolo introduttivo dobbiamo definir lo sfondo dicendo qualcosa di più sull’ellenismo in genere e chiarendo da una parte alcuni aspetti delle sue due componenti, ossia Ellade e Asia, e dall’altra la maniera del loro incontro, della loro unione e dello sviluppo comune.
a) L’apporto dell’Occidente.
Quali furono le condizioni storiche e le circostanze dello sviluppo che abbiamo accennato? L’unità che le conquiste di Alessandro iniziarono, era stata preparata da entrambe le parti. Oriente e Occidente avevano precedentemente progredito fino al massimo grado di unificazione, ciascuno nel suo proprio campo, e naturalmente soprattutto nel campo politico: l’Oriente era stato unificato sotto la dominazione persiana, il mondo greco sotto l’egemonia macedone. Perciò la conquista della monarchia persiana da parte del Macedone fu un evento che coinvolse tutto «l’Oriente» e tutto «l’Occidente».
Lo sviluppo culturale non aveva preparato meno ciascuna parte, sebbene in maniere completamente differenti, per i compiti che erano destinate ad assumere nella nuova combinazione. Le civiltà possono meglio mescolarsi quando il pensiero di ciascuna si è sufficientemente emancipato dalle particolari condizioni ambientali, sociali e nazionali, tanto da assumere un certo grado di validità generale e quindi divenire trasmissibile e scambievole. Allora non è più legato a fatti storici specifici quali la polis ateniese o la divisione della società orientale in caste, ma si è sviluppato in una forma più libera di princìpi astratti che può pretendere di applicarsi a tutto il genere umano, che può essere appresa, può essere sostenuta da argomenti e competere con altre forme sul terreno della discussione razionale.
– La cultura greca alla vigilia delle conquiste di Alessandro.
All’apparire di Alessandro, l’Ellade aveva raggiunto, sia di fatto che nella propria coscienza, lo stadio di maturità cosmopolita, e ciò fu una condizione positiva del suo successo. Tuttavia nel mondo orientale il successo fu contrastato da una condizione negativa, nonostante che per oltre un secolo tutta l’evoluzione della cultura greca era stata in tale direzione. In realtà, gli ideali di un Pindaro difficilmente avrebbero potuto essere trapiantati alla corte di un Nabucodonosor o di un Artaserse o innestati sulle burocrazie dei loro regni.
Fin dai tempi di Erodoto, il «padre della storia» (quinto secolo a.C.), la curiosità greca si era interessata alle usanze e alle opinioni dei «barbari»; ma l’uso ellenico era concepito per i Greci e adatto soltanto ad essi e tra di loro solo a quelli che erano nati liberi e pienamente cittadini. Gli ideali morali e politici, e persino l’idea del sapere, erano legati a definite condizioni sociali e non avevano la pretesa di applicarsi agli uomini in genere – in realtà il concetto di «uomo in sé» per scopi pratici non era ancora affiorato. – Tuttavia la riflessione filosofica e lo sviluppo della civiltà urbana nel secolo precedente ad Alessandro portò gradualmente al suo sorgere e alla sua formulazione esplicita.
L’illuminismo sofistico del quinto secolo aveva contrapposto l’individuo allo Stato e alle sue norme, e con la concezione dell’opposizione tra natura e legge aveva privato quest’ultima della sua antica santità non considerandola che effetto di convenzione: le norme morali e politiche sono relative. Contro tale sfida scettica, la risposta socratico-platonica si appellava, in realtà, non alla tradizione, ma alla conoscenza intellettuale dell’intelligibile, ossia alla storia razionale; e il razionalismo porta con sé il germe dell’universalismo. I Cinici predicavano una rivalutazione delle norme esistenti di condotta, autosufficienza dell’individuo privato, indifferenza ai valori tradizionali della società, come il patriottismo, e libertà da ogni pregiudizio. Il declino interno delle antiche città-stato insieme alla perdita dell’indipendenza esterna finirono di attenuare l’aspetto particolaristico della loro cultura, mentre rafforzarono la coscienza di ciò che in essa aveva generale validità spirituale.
In breve, al tempo di Alessandro l’evoluzione della concezione ellenica di cultura era giunta al punto in cui era possibile dire che si era greci non per nascita ma per educazione, cosicché chi era nato barbaro poteva diventare un vero greco. L’esaltazione della ragione come la parte più elevata nell’uomo aveva condotto alla scoperta dell’uomo come tale e nello stesso tempo alla concezione della “maniera” ellenica come cultura umanistica generale. L’ultimo passo in questo senso fu fatto quando gli Stoici in seguito affermarono che la libertà, quel bene supremo dell’etica greca, è una pura qualità interiore, indipendente dalle condizioni esterne, cosicché vera libertà si può trovare anche in uno schiavo, purché saggio.
Tutto ciò che è greco diventa oggetto di un atteggiamento e di una qualità mentale per cui il parteciparne è possibile ad ogni essere ragionevole, ossia a tutti gli uomini. La teoria che prevale non pone più l’uomo principalmente nel contesto della polis, come fecero Platone e ancora Aristotele, ma in quello del cosmo che viene talvolta chiamato «la vera e grande polis per tutti». Essere un buon cittadino del cosmo, un “cosmopolita”, è il fine morale dell’uomo; e il diritto a tale cittadinanza proviene dal possesso del “logos” o ragione, e da niente altro, cioè da quel principio che distingue l’uomo come tale e lo mette in rapporto immediato col principio stesso che governa l’universo. Il pieno sviluppo di tale ideologia cosmopolita fu raggiunto sotto l’Impero romano, ma essa nei suoi lineamenti essenziali quale stadio universalistico del pensiero greco era presente già dai tempi di Alessandro. E questa svolta della mente collettiva ispirò le gesta di lui e fu a sua volta potentemente rinforzata dal suo successo.
– Cosmopolitismo e nuova colonizzazione greca.
Questa fu l’ampiezza dello spirito che Alessandro portò in tutto il mondo. Da allora in poi l’Ellade si trovò dovunque la vita urbana, nelle sue istituzioni e organizzazioni fioriva sul modello greco. In questa vita le popolazioni indigene potevano entrare con uguali diritti per mezzo di un’assimilazione culturale e linguistica.
Il che segna un’importante differenza dalla primitiva colonizzazione greca della costa mediterranea che stabilì solo colonie greche ai limiti dell’esteso territorio «barbaro» e non prese in considerazione la possibilità di amalgamazione tra coloni e indigeni. La colonizzazione che seguì, sulle orme di Alessandro, si propose fin da principio, in realtà come parte del suo programma politico, una simbiosi di un genere del tutto nuovo, simbiosi che pur essendo un’ellenizzazione dell’Oriente richiedeva per la sua attuazione una certa reciprocità. Nella nuova area geopolitica l’elemento greco non era più legato ad una continuità geografica con la madrepatria e in genere con ciò che era stato una volta il mondo greco, ma si diffuse in tutta la distesa continentale dell’Impero ellenistico. A differenza delle primitive colonie, le città così fondate non erano città-figlie di singole metropoli, ma erano alimentate dalla riserva della nazione greca cosmopolita. Esse non mantenevano relazioni né tra loro né con la distante città-madre, ma ciascuna agiva come un centro di cristallizzazione nel suo proprio ambiente, ossia in rapporto ai suoi vicini indigeni.
Soprattutto, queste città non erano più stati sovrani, ma facevano parte di regni amministrati centralmente. Ciò cambiava il rapporto degli abitanti con l’insieme politico. La classica città-stato impegnava il cittadino negli interessi di stato ed egli poteva considerarli come suoi propri, poiché per mezzo delle leggi della sua città governava se stesso. Le vaste monarchie elleniche non richiedevano e non permettevano tale identificazione; e proprio come esse non imponevano ai loro sudditi un comportamento morale, così l’individuo se ne sentiva distaccato, e come cittadino privato (condizione difficilmente ammessa nel primitivo mondo ellenico) poteva soddisfare i suoi bisogni sociali in associazioni volontarie, basate sulla comunità di idee, religione e occupazione.
I nuclei delle città di nuova fondazione erano di regola costituiti da persone di nazionalità greca; ma fin dall’inizio l’annessione di popolazioni indigene fece parte del piano e del privilegio per cui ciascuna città sorse. In molti casi tali gruppi di indigeni vennero trasformati in popolazioni cittadine per la prima volta e quindi in popolazioni di città organizzate e amministrate in modo autonomo alla maniera greca.
Quanto Alessandro stesso abbia compreso appieno la sua politica di fusione anche in termini razziali, è chiaramente mostrato dalla famosa celebrazione dei matrimoni di Susa, quando in ossequio alla sua volontà diecimila dei suoi ufficiali e soldati macedoni sposarono donne persiane.
– L’ellenizzazione dell’Oriente.
Il potere assimilatore di un’entità quale la città ellenica deve essere stato irresistibile. Partecipando alle sue istituzioni e ai suoi modi di vita, i cittadini non greci subirono una rapida ellenizzazione, chiaramente visibile nella loro adozione della lingua greca: e ciò nonostante il fatto che probabilmente all’inizio i non-greci sorpassavano in numero gli elementi greci o macedoni.
La susseguente e impressionante crescita di alcune di queste città, come Alessandria o Antiochia, può essere spiegata soltanto col continuo afflusso di popolazioni orientali indigene, che tuttavia non mutò il carattere ellenico delle comunità. Infine sotto il regno dei Seleucidi, in Siria e Asia Minore, anche città originariamente orientali si trasformarono in città di tipo greco, adottando la costituzione corporativa ellenica e introducendo palestre e altre tipiche istituzioni, e ricevettero dal governo centrale la patente che accordava i diritti e i doveri di tali città. Fu questa una specie di rifondazione, che mise in evidenza il progresso dell’ellenizzazione e nello stesso tempo aggiunse forza ad essa. Oltre alle città anche l’amministrazione di lingua greca delle monarchie fu naturalmente un agente ellenizzatore.
L’invito suggerito dalla formula che si è greci non per nascita ma per educazione fu accolto con calore dai più responsabili tra i figli del conquistato Oriente. Già nella generazione seguente ad Aristotele li vediamo attivi nei santuari stessi della sapienza greca. Zenone, figlio di Mnaseas (ossia Manasseh), fondatore della scuola stoica, era di origine fenicio-cipriota: egli apprese il greco come una lingua di adozione e il suo accento forestiero si fece sempre notare durante la sua lunga carriera di insegnante ad Atene.
Da allora sino alla fine dell’antichità, l’Oriente ellenistico produsse una messe continua di uomini, spesso di origine semita, che sotto nomi greci e nello spirito e nella lingua greca contribuirono alla civiltà dominante. Gli antichi centri dell’Egeo rimasero in piedi, ma il centro di gravità della cultura greca, ormai cultura universale, si era spostato verso le nuovi regioni. Le città elleniche del Vicino Oriente ne erano il suo fertile vivaio: tra queste prevaleva Alessandria in Egitto. E’ impossibile determinare nella maggioranza dei casi se un autore di Apamea o Byblos in Siria, o di Gadara in Transgiordania, fosse di razza greca o semita, poiché in genere i nomi erano ellenizzati; ma in queste regioni di fusione dell’ellenismo la questione risulta di nessuna importanza: una terza entità era nata.
Nelle città greche di nuova fondazione il risultato della fusione fu greco fin dal principio. In altri luoghi il processo fu graduale e continuò nel periodo della tarda antichità: gli individui si convertivano all’ellenismo come se avessero cambiato il proprio partito o la propria fede, e ciò si protrasse fino ad un periodo in cui si potevano già avvertire movimenti di rinascita delle lingue e delle letterature nazionali. Il primo esempio, in realtà ancronistico, di tale situazione è dato dagli eventi noti del periodo dei Maccabei in Palestina, nel secondo secolo a.C. Ancora nel terzo secolo d.C., dopo cinque secoli di civilizzazione ellenica, troviamo un cittadino dell’antica città di Tiro, Malco figlio di Malco, divenuto un eminente scrittore greco di filosofia, il quale a imitazione dei suoi amici ellenici cambiò (o permise loro di cambiare) il suo nome semitico prima col greco “Basileus” (1) e in seguito con “Porfirio” (2) manifestando con ciò simbolicamente la sua adesione alla causa ellenistica e insieme la sua origine fenicia. Il punto interessante in questo caso sta nel fatto che contemporaneamente acquistava forza nella sua regione d’origine un movimento contrario – la creazione di una letteratura in vernacolo siriaco che è legata ai nomi di Bardesane, Mani ed Ephrem. Tale movimento e quelli paralleli in altre regioni erano parte del processo che portava al sorgere delle nuove religioni popolari contro le quali l’ellenismo era costretto a difendersi.
– Ellenismo posteriore: la trasformazione della cultura profana in cultura religiosa.
Per la situazione che abbiamo sopra indicato, il concetto di ellenismo subì un cambiamento significativo. Nella tarda antichità l’universalismo indiscusso dei primi secoli ellenistici fu sostituito da un’epoca di nuova differenziazione, fondata principalmente su questioni spirituali e soltanto secondariamente di carattere nazionale, regionale e linguistico. La cultura secolare fu sempre più influenzata da un atteggiamento mentale che si esprimeva in termini religiosi, fino al punto che si arrivò allo spezzamento della primitiva unità in tanti campi esclusivi. In queste nuove condizioni, «ellenico», termine usato come contrassegno all’interno di un mondo già fortemente ellenizzato, distingueva una causa avversata dai suoi oppositori cristiani o gnostici, i quali per lingua e forma letteraria facevano non meno parte dell’ambiente greco.
Su questo terreno comune ellenismo divenne sinonimo di conservativismo e si cristallizzò in una definita dottrina nella quale l’intera tradizione dell’antichità pagana, sia religiosa che filosofica, fu per l’ultima volta sistematizzata. Sia i suoi aderenti, sia i suoi oppositori vivevano dappertutto, cosicché il campo di battaglia si estese a tutto il mondo civilizzato. Ma la marea crescente della religione aveva assorbito lo stesso pensiero «greco» e trasformato il suo carattere specifico: la cultura secolare ellenistica si mutò in una cultura con forte accentuazione pagano-religiosa, sia per sua difesa contro il cristianesimo sia per sua necessità interna. Ciò significa che in un’epoca nella quale sorsero le religioni mondiali lo stesso ellenismo divenne una particolare religione. E fu così che Plotino e ancor più Giuliano l’Apostata concepirono la loro causa ellenistica, ossia pagana, che nel neoplatonismo fondò poi una specie di chiesa con i suoi dogmi e la sua apologetica. L’ellenismo condannato veniva ad assumere l’aspetto di una causa particolare proprio nel suo terreno di origine.
Nell’ora del suo crepuscolo il concetto di ellenismo si allargò e si restrinse nello stesso tempo. Si estese nel senso che nella sua ultima delimitazione dovette includere, nella tradizione ellenistica da difendere, anche le creazioni puramente orientali come le religioni di Mitra o di Attis; si restrinse, perché la sua causa divenne una causa di partito, e più ancora, quella di un partito di minoranza. Tuttavia, come è stato detto, tutta la lotta si svolse all’interno del mondo ellenistico e nell’ambito dell’unica cultura e lingua ellenistica universale. Cosicché il vincitore ed erede in tale lotta, la Chiesa cristiana d’Oriente, fu principalmente una Chiesa greca: l’opera di Alessandro Magno trionfava anche in questa disfatta dello spirito classico.
– I quattro stadi della cultura greca.
Possiamo di conseguenza distinguere quattro fasi storiche della cultura greca: 1) prima di Alessandro, la classica fase della cultura nazionale; 2) dopo Alessandro, l’ellenismo come cultura secolare cosmopolita; 3) l’ellenismo posteriore come cultura religiosa pagana; 4) il periodo bizantino come cultura greca cristiana.
Il passaggio dalla prima alla seconda fase può essere spiegato in gran parte come uno sviluppo greco autonomo. Nella seconda fase (300 a.C. – primo sec. a.C.) lo spirito greco fu espresso dalle grandi scuole rivali di filosofia, l’Accademia, gli Epicurei, e soprattutto gli Stoici, mentre nello stesso tempo progrediva la sintesi greco-orientale. La transizione da questa alla terza fase, ossia la trasformazione dell’antica civiltà come un tutto, e con essa del pensiero greco, in una forma religiosa, su opera di forze profondamente non greche, sviluppatesi in Oriente, che entrarono nella storia come fattori nuovi. Tra il prevalere della cultura secolare ellenistica e la posizione finale di difesa del tardo ellenismo divenuto religioso si ebbero tre secoli di movimenti spirituali rivoluzionari che operarono tale trasformazione e tra i quali occupa un posto preminente il movimento gnostico. Su di essi ci soffermeremo in seguito.
b) L’apporto dell’Oriente.
Abbiamo considerato fino ad ora la parte avuta dalla Grecia nella fusione dell’Oriente e dell’Occidente e a questo intento siamo partiti dalle condizioni interne che permisero alla cultura ellenica di diventare una civiltà mondiale in seguito alle conquiste di Alessandro. Tali condizioni erano naturalmente controbilanciate da condizioni analoghe dalla parte orientale, ciò che spiega la parte avuta dall’Oriente nella combinazione cui abbiamo accennato: la sua apparente o reale passività, docilità e disposizione all’assimilazione.
L’assoggettamento militare e politico soltanto non è sufficiente a spiegare il corso degli eventi, come può mostrare il paragone con altre conquiste, lungo tutta la storia, di zone di elevata cultura, dove spesso il vincitore soccombe culturalmente al vinto. Si potrebbe persino porre la domanda se un senso più profondo, o almeno parzialmente, qualcosa del genere non sia avvenuto nel caso dell’ellenismo; ma ciò che è manifesto a prima vista è l’indiscusso ascendente della parte greca, il che determinò se non altro la forma di ogni futura espressione culturale.
Qual era dunque la condizione del mondo orientale alla vigilia della conquista di Alessandro, che possa spiegare il suo soccombere all’espansione della cultura greca? E in qual forma sopravvissero le originarie energie orientali e si espressero nelle nuove condizioni create dall’ellenismo? Perché naturalmente questo grande Oriente con le sue antiche e orgogliose civiltà non fu soltanto una materia grezza per la forma greca. Entrambe le questioni, quella riguardante le condizioni antecedenti e quella riguardante la maniera di sopravvivenza, sono estremamente più difficili da spiegare per la parte orientale di quanto non lo fossero le questioni analoghe per la parte greca. Eccone le ragioni.
In primo luogo, per il periodo precedente ad Alessandro ci troviamo in possesso di pochissimi documenti orientali, eccetto la letteratura ebraica, in contrasto con la ricchezza delle fonti greche. Questo fatto negativo tuttavia, se può essere un segno di sterilità letteraria, è pure una testimonianza storica che conferma quanto si può dedurre dalle fonti greche circa lo stato contemporaneo delle nazioni orientali.
Inoltre, questo vasto Oriente, unificato sotto l’Impero persiano, solo con la forza, era molto lontano dal costituire un’unità culturale come il mondo greco. La Grecia era la medesima dappertutto, mentre l’Oriente differiva da regione a regione. Perciò la risposta alla domanda sui presupposti culturali dovrebbe essere suddivisa in tante parti quante furono le entità culturali da considerare. Questo fatto complica inoltre il problema dell’ellenismo stesso per quanto riguarda la componente orientale. Infatti Gustav Droysen, il creatore del termine «ellenismo» per la sintesi greco-orientale postalessandrina, ha definito egli stesso il termine spiegando che in realtà fiorirono tanti generi diversi di ellenismo quante furono le individualità nazionali differenti. In molti casi tuttavia questi fattori locali ci sono poco conosciuti nella loro forma originale. Ciò nondimeno la generale omogeneità dello sviluppo ellenistico susseguente induce a pensare che vi fosse ovunque una certa somiglianza di condizioni. In realtà, a parte l’Egitto, è possibile distinguere nell’Oriente preellenico alcune tendenze universalistiche, inizi di sincretismo spirituale, che possono essere considerate come l’equivalente dell’atteggiamento cosmopolita della mente greca. Ne diremo di più in seguito.
Infine, nel periodo dopo Alessandro la supremazia della civiltà panellenica significò precisamente che l’Oriente stesso, se aspirava a un’espressione culturale, doveva esprimersi nella lingua e nella maniera greca. Di conseguenza, il riconoscere queste occorrenze di espressione come voci dell’Oriente nella totalità della letteratura ellenistica molto spesso per noi è questione di una distinzione sottile e non sempre inequivocabilmente dimostrabile: in altre parole, la condizione creata dall’ellenismo è essa stessa ambigua. Tratteremo più avanti l’interessante problema metodologico che ne deriva.
Sono, queste, alcune difficoltà che si incontrano nel tentativo di chiarire il quadro rappresentato dalla metà orientale di quel duplice fatto che abbiamo chiamato ellenismo. E’ possibile tuttavia ricavarne un’idea generale, anche se parzialmente congetturale, e ne diremo brevemente quanto necessario per il nostro scopo. Innanzi tutto un breve cenno sulle condizioni del mondo orientale alla vigilia della conquista greca che ne mette in evidenza, in primo luogo, l’inerzia letargica e in secondo luogo la lentezza del suo risveglio.
– L’Oriente alla vigilia delle conquiste di Alessandro.
“Apatia politica e stasi culturale”. Politicamente, questa condizione fu determinata dal susseguirsi di imperi dispotici che avevano pervaso l’Oriente nei secoli che precedettero. I loro metodi di conquista e di governo avevano spezzato la resistenza politica delle popolazioni locali e le avevano abituate ad accettare passivamente ogni nuovo padrone che saliva al potere nell’alternarsi degli imperi. I destini del potere centrale erano un fato ineluttabile per i popoli soggetti, i quali venivano trascinati nel gorgo insieme alle rovine di esso. In un tempo posteriore, la visione di Daniele dei quattro regni riflette ancora questo atteggiamento passivo dei popoli orientali di fronte al succedersi dei poteri politici. Così avvenne che tre battaglie che spezzarono la forza militare della monarchia persiana consegnarono nelle mani del vincitore un enorme impero formato di innumerevoli popoli divenuti tutti estranei all’idea di un’autodeterminazione e che non sentivano nemmeno il bisogno di avere un peso nelle decisioni. La sola seria resistenza di natura popolare che Alessandro incontrò fu quella di Tiro e Gaza, le quali dovettero essere sottomesse con un lungo e prolungato assedio. Tale eccezione non fu puro caso: la città fenicia – e il caso di Gaza fu probabilmente simile – nonostante la sua condizione di vassalla del Grande Re, era una città sovrana e i suoi cittadini lottarono per una loro causa durante il lungo periodo di rivalità greco-fenicia per la conquista del dominio marittimo.
L’apatia politica fu uguagliata da un ristagno culturale proveniente in parte da cause differenti. Nei vecchi centri della civiltà orientale sull’Eufrate e sul Nilo, che prima dell’epoca persiana erano anche centri del potere politico, ogni movimento intellettuale, dopo parecchi millenni di esistenza, si arrestò e rimase soltanto l’inerzia di formidabili tradizioni. Non possiamo qui addentrarci in spiegazioni che ci condurrebbero fuori dalla nostra strada; notiamo semplicemente il fatto, che particolarmente nel caso dell’Egitto è del tutto ovvio. Possiamo tuttavia far osservare che quell’immobilità che le nostre preferenze dinamiche ci portano a disprezzare come un segno di pietrificazione potrebbe anche essere considerata come un segno della perfezione raggiunta da un sistema di vita, considerazione che può bene applicarsi all’Egitto.
Inoltre, l’abitudine assira e babilonese di espatriare e trapiantare intere popolazioni conquistate, o per meglio dire gli strati più elevati socialmente e culturalmente, avevano distrutto le energie di crescita culturale in molte regioni intorno ai vecchi centri. Tale destino aveva colpito in molti casi popolazioni di giovane età culturale che dovevano ancora sviluppare la loro potenzialità. Per la facilità di manovra imperiale così guadagnata, il potere centrale ci rimetteva l’inaridirsi delle sorgenti potenziali della propria rigenerazione. Senza dubbio è questa una delle ragioni del torpore degli antichi centri che abbiamo sopra ricordato: avendo spezzato le forze vitali nazionali e regionali in tutto il regno, essi avevano, per così dire, fatto intorno a sé il deserto e in tali condizioni il potere centrale rimasto isolato non poteva più ricorrere a quelle influenze rigeneratrici che possono provenire dal basso. Ciò può spiegare in parte lo stato di paralisi nel quale l’Oriente si trovava prima di Alessandro e dal quale fu liberato per opera dello spirito vivificante dell’ellenismo.
“Inizi del sincretismo religioso”. Tale stato di cose tuttavia conteneva anche alcuni aspetti positivi per la funzione che l’Oriente doveva svolgere nell’età ellenistica. Non fu tanto la prevalente passività, la mancanza di forze operanti una resistenza cosciente, che facilitarono l’assimilazione. L’indebolimento stesso di aspetti strettamente locali di civiltà indigene rimosse molti ostacoli che avrebbero potuto opporsi alla formazione di una sintesi più ampia e rese così possibile l’introduzione di questi elementi culturali nel patrimonio comune. Lo sradicamento e il trapianto di intere popolazioni in particolare ebbe due effetti rilevanti. Da un lato, favorì il distacco dei contenuti culturali dal loro terreno nativo, la loro astrazione in forme trasmissibili di dottrina e la conseguente possibilità di essere usati come elementi in uno scambio di idee su scala mondiale, appunto come ne poteva far uso l’ellenismo. Dall’altro, favorì un sincretismo preellenistico, l’apparizione di divinità e culti di origini diverse e talvolta molto distanti, che fu l’anticipazione di un’importante caratteristica dello sviluppo ellenistico susseguente.
La storia biblica ci offre esempi di entrambi questi processi. La prima descrizione della genesi di un sincretismo religioso intenzionale si trova nel racconto del “II Re” [ = IV Re della Volgata], 17, 24-41, riguardo ai nuovi abitanti fatti stabilire dal re d’Assiria nella città evacuata di Samaria, quella storia ben nota dell’origine della setta samaritana che termina con le parole:
«Così quelle genti temevano il Signore e servivano i loro idoli; i loro figli e nipoti continuano a fare oggi come hanno fatto i loro padri» [17, 41].
Il sincretismo religioso su scala mondiale diventerà in seguito una caratteristica decisiva dell’ellenismo: qui ne vediamo gli inizi nell’Oriente stesso.
“Inizi dell’astrazione teologica nella religione ebraica, babilonese e persiana”. Ancora più importante è l’altro sviluppo che abbiamo ricordato, la trasformazione del contenuto sostanziale delle varie culture locali in ideologie. Per citare un altro classico esempio della Bibbia, l’esilio di Babilonia costrinse gli Ebrei a sviluppare quell’aspetto della loro religione la cui validità trascendeva le particolari condizioni della Palestina, e ad opporre la loro fede così purificata agli altri princìpi religiosi del mondo nel quale erano stati gettati. Ciò portò ad un confronto di idee con idee. Nella seconda parte del libro di Isaia si constata come tale situazione fosse già pienamente avvertita; Isaia enunzia il puro principio del monoteismo come causa del mondo, liberato dalle limitazioni specificamente palestinesi del culto di Jahvè. Così la deportazione stessa portò a compimento un processo che in realtà era iniziato al tempo degli antichi profeti.
Sebbene il caso ebraico sia stato unico nella storia, si possono notare sviluppi paralleli anche altrove nella disintegrazione politica dell’Oriente o possono essere dedotti dal seguito degli eventi. Così, dopo la conquista di Babilonia da parte dei Persiani, l’antica religione babilonese non fu più culto di stato unito al potere centrale e legato alle sue funzioni di governo. Come una delle istituzioni della monarchia, essa aveva goduto uno stato ufficiale ben definito e tale connessione con la struttura locale del potere secolare aveva sostenuto, ma al tempo stesso limitato, la sua funzione. Con la perdita di questa condizione, sia il sostegno che la limitazione svanirono. La liberazione della religione dalla funzione politica fu uno sradicamento paragonabile a quello territoriale subìto da Israele.
La condizione di soggezione e di impotenza politica nell’Impero persiano obbligò la religione babilonese a poggiare da allora in poi soltanto sui propri valori spirituali. Non più collegata alle istituzioni di un sistema di governo e non usufruendo del prestigio della sua autorità, essa dovette riporre fiducia soltanto sulle sue intrinseche qualità “teologiche” che avevano bisogno di una precisa formulazione per potersi mantenere di fronte ad altri sistemi religiosi, i quali pure erano stati portati a galla ed erano pronti a competere per la loro influenza sullo spirito degli uomini. La perdita di uno stabile regime politico portò alla liberazione del contenuto spirituale. Divenendo materia di speculazione, il principio generalizzato acquistò vita propria e sviluppò le sue implicazioni astratte. Possiamo discernere qui l’azione di una legge storica che ci aiuta a comprendere molti sviluppi di pensiero della tarda antichità. Nel caso della religione di Babilonia, è evidente il successo di questo movimento verso l’astrazione nella sua forma posteriore quando emerse nella piena luce dell’ellenismo. Nello svolgimento unilaterale delle sue originali caratteristiche astrali, l’antico culto si trasformò in una dottrina astratta, il sistema razionale dell'”astrologia”, che per il semplice richiamo del suo contenuto di pensiero, presentato nella forma greca, divenne una grande forza nel mondo di idee ellenistico.
In modo analogo, per citare un ultimo esempio, l’antica religione persiana del mazdeismo si distaccò dal nativo suolo iranico. Trasportata in tutte le regioni dalla Siria all’India dalla nazione dominante, numericamente esigua, si trovò in una posizione in certo modo cosmopolita nel mezzo della pluralità di religioni dell’Impero persiano. In seguito alla caduta dell’Impero perse insieme al favore anche l’odiosità di un governo straniero e da allora in poi condivise con le altre fedi i pesi e i vantaggi della diaspora nelle religioni fuori della Persia. Anche qui vediamo che dall’insieme di tradizioni nazionali non ben definite venne fuori un principio di indubbio fondamento metafisico, il quale poi si sviluppò in un sistema che aveva un significato intellettuale universale: il sistema del dualismo teologico. Il contenuto di questa dottrina dualistica, generalizzato, divenne una delle idee-forza più efficaci nel sincretismo ideologico dell’ellenismo. Nella Persia stessa la reazione nazionale che portò successivamente alla formazione del regno parto e di quello neopersiano fu preparata e accompagnata da una restaurazione religiosa, la quale a sua volta fu obbligata a sistematizzare e dogmatizzare il contenuto dell’antica religione popolare; processo in certo modo analogo alla creazione contemporanea del Talmud. Così, sia in patria che nella diaspora le condizioni mutate produssero un risultato simile: la trasformazione della religione tradizionale in un sistema teologico le cui caratteristiche possono essere avvicinate a quelle di una dottrina razionale.
Possiamo supporre che processi simili si siano avuto in tutto l’Oriente, processi attraverso i quali le credenze originariamente nazionali e locali venivano preparate a diventare elementi di uno scambio internazionale di idee. L’orientamento generale di tali processi era volto ad una dogmatizzazione, nel senso che un principio veniva astratto dall’insieme della tradizione e sistemato in una dottrina coerente. L’influenza greca fornì sia l’impulso che gli strumenti logici e portò a maturità tale processo dappertutto; ma, come abbiamo cercato di dimostrare, l’Oriente stesso alla vigilia dell’ellenismo aveva iniziato ciò in casi significativi. I tre esempi che abbiamo citato sono stati scelti con un intento particolare: il monoteismo ebraico, l’astrologia babilonese e il dualismo persiano furono con molta probabilità le tre principali forze spirituali che l’Oriente dette come contributo alla configurazione dell’ellenismo, ed esse ne influenzarono sempre più lo svolgimento successivo.
Questo può bastare a proposito di quelle che abbiamo chiamato «precondizioni». Vogliamo soltanto sottolineare il fatto che la prima civiltà cosmopolita nota alla storia, perché si può considerare così la civiltà ellenistica, fu resa possibile dalle catastrofi che si abbatterono sull’unità originaria delle civiltà regionali. Senza la rovina di stati e nazioni, il processo di astrazione e di scambio non sarebbe avvenuto su così vasta scala. Ciò è vero, per quanto meno evidente, anche per la Grecia dove la decadenza politica della polis, questo fattore più intensivo di informazioni particolaristiche, aveva fornito una precondizione relativamente negativa. Soltanto nel caso dell’Egitto che abbiamo tralasciato nella nostra rassegna, le condizioni furono completamente differenti. In generale, tuttavia, fu dall’Asia, sia semitica che iranica, che sorsero le forze attivamente operanti insieme con l’eredità greca nella sintesi ellenistica: perciò limitiamo la nostra analisi alle condizioni asiatiche.
– L’Oriente durante l’ellenismo.
Dopo esserci soffermati sulle precondizioni, ci resta ora da considerare brevemente il destino dell’Oriente durante la nuova economia dell’ellenismo. La prima cosa che dobbiamo notare è che l’Oriente divenne silenzioso per molti secoli e fu quasi invisibile nella luce predominante del giorno ellenico. Per quanto riguarda gli avvenimenti che si susseguirono dal primo secolo d.C. in poi, possiamo chiamare questo periodo iniziale il periodo latente della mente orientale e in base a tale osservazione possiamo stabilire una divisione dell’età ellenistica in due distinti periodi: il periodo di manifesta predominanza greca e di sommersione orientale, e il periodo di reazione di un Oriente rinascente che avanzò vittoriosamente contro l’Occidente in una specie di contrattacco spirituale e riformò la cultura universale. Stiamo evidentemente parlando di eventi di ordine intellettuale e non politico. In questo senso, l’ellenizzazione dell’Oriente prevalse nel primo periodo, l’orientalizzazione dell’Occidente nel secondo e quest’ultimo processo ebbe termine intorno al 300 d.C. Il risultato dei due processi insieme è una sintesi che si protrasse lungo tutto il Medio Evo.
“L’Oriente sommerso”. Possiamo considerare brevemente il primo periodo. E’ l’epoca dei regni dei Seleucidi e dei Tolomei, caratterizzata particolarmente dal fiorire di Alessandria. L’ellenismo trionfava ovunque in Oriente e costituiva la cultura generale, i cui canoni di pensiero e di espressione erano adottati da chiunque desiderasse partecipare alla vita intellettuale di quel periodo. Soltanto la voce greca si faceva udire: qualsiasi composizione letteraria era in quella lingua. In considerazione di ciò che abbiamo detto circa l’immissione degli orientali nella corrente di vita intellettuale greca, il silenzio dell’Oriente non può essere interpretato come una mancanza di vitalità intellettuale da parte degli individui, ma piuttosto come un non voler parlare per sé, in nome proprio. Chiunque avesse qualcosa da dire non aveva altra scelta che esprimerla in greco, non soltanto come lingua ma anche come concetti, idee, forme letterarie, cioè come parte ostensibile della tradizione greca.
Indubbiamente la civiltà ellenistica, aperta e ospitale, si offriva alle creazioni della mente orientale, una volta che queste avevano assunto la forma greca. Perciò l’unità formale di questa cultura abbracciava di fatto una pluralità, anche se, per così dire, sempre sotto l’etichetta ufficiale greca. Per quanto riguarda l’Oriente la situazione produsse una specie di mimetismo, che ebbe conseguenze di grande portata per tutto il suo futuro.
La mentalità greca da parte sua non poteva non rimanere influenzata: fu appunto la costatazione della differenza tra ciò che veniva chiamato «greco» prima e dopo Alessandro che spinse Droysen ad introdurre il termine «ellenistico» in contrapposizione al classico «ellenico». «Ellenistico» voleva significare non soltanto l’allargamento della civiltà della polis in una civiltà cosmopolita e le trasformazioni inerenti a questo processo, ma anche il cambiamento di carattere derivato dall’accoglienza delle influenze orientali di questa totalità ampliata.
Tuttavia l’anonimità dei contributi orientali rende difficile l’identificazione di codeste influenze nel primo periodo. Uomini come Zenone, che abbiamo ricordato precedentemente, non volevano essere altro che elleni, e la loro assimilazione fu tanto completa quanto poteva esserlo. La filosofia in genere seguì le orme tracciate dalle originarie scuole greche; ma verso la fine del periodo, circa due secoli dopo Zenone, cominciò a mostrare segni significativi di cambiamento nel suo sviluppo fino a quel momento autonomo. I segni all’inizio non sono punto chiari. La controversia tuttora esistente riguardo a Posidonio di Apamea (circa 135-50 a.C.) illustra bene la difficoltà di una facile attribuzione di influenze e in generale l’incertezza su ciò che in questo periodo è greco in modo genuino e ciò che è colorito di orientalismo. L’ardente pietà astrale che pervade la sua filosofia è un’espressione della mentalità orientale o no? Sia l’una che l’altra tesi possono essere sostenute e probabilmente continueranno ad esserlo, sebbene non sussistano dubbi che a suo giudizio il suo pensiero era realmente greco, che poi egli fosse o no greco di nascita.
Ciò che è stato detto per questo singolo caso, lo si può dire per il quadro generale: non è possibile chiedere una certezza maggiore di quella che comporta la natura complessa della situazione. Di fronte alla singolare anonimità, che potremmo persino chiamare pseudonimia, che riveste l’elemento orientale dobbiamo accontentarci dell’impressione generale che influenze orientali fossero all’opera, nel senso più ampio, nell’area del pensiero greco durante questo periodo.
Un caso più evidente è offerto dalla crescente letteratura sulla «sapienza dei barbari» che fece la sua apparizione nelle lettere greche: a lungo andare non rimase una materia di puro interesse di cose antiche, ma assunse gradualmente un carattere di propaganda. L’iniziativa di autori greci in questo campo fu accolta dagli antichi centri dell’Oriente, Babilonia ed Egitto, da sacerdoti indigeni che si dettero a comporre in lingua greca resoconti delle loro storie e culture nazionali. I più antichi potevano sempre contare su una rispettosa curiosità da parte del pubblico greco, ma poiché questa fu sempre più accompagnata da accoglienza verso gli stessi contenuti spirituali, i ricercatori di cose antiche furono incoraggiati a trasformarsi in maestri e predicatori.
Il più importante contributo, tuttavia, dato dall’Oriente alla cultura ellenistica in questo periodo non fu nel campo della letteratura, ma in quello del culto: il “sincretismo” religioso che divenne il fatto più decisivo nell’ultima fase cominciò a prendere forma in questo primo periodo dell’età ellenistica. Il significato del termine «sincretismo» può essere esteso, e generalmente lo è, ad indicare fenomeni mondani; in questo caso infatti tutta la civiltà ellenistica può essere chiamata sincretistica, in quanto gradualmente divenne una cultura eterogenea. In senso stretto però sincretismo denota un fenomeno religioso che l’antico termine «teocràsi», ossia mescolanza degli dèi, esprime in modo più adeguato. E’ questo un fenomeno dominante del periodo, per il quale noi non abbiamo un esatto parallelo nella nostra esperienza contemporanea, per quanto al corrente di mescolanze di idee e valori culturali.
Fu l’estensione sempre maggiore e la profondità di questo processo che causò il passaggio dal primo al secondo periodo dell’ellenismo, quello religioso-orientale. La teocràsi si espresse sia nel mito che nel culto ed uno dei suoi strumenti logici più importanti fu l’allegoria, della quale si era servita anche la filosofia nelle sue relazioni con religione e mito. Tra tutti i fenomeni che abbiamo notati in questa descrizione del primo periodo dell’ellenismo, è appunto in quello religioso che l’Oriente si è mostrato più attivo e più se stesso. Il prestigio crescente di dèi e culti orientali nel mondo occidentale annunziò la funzione che l’Oriente doveva svolgere nel secondo periodo, quando il comando passò nelle sue mani. Fu una funzione religiosa, mentre il contributo greco all’insieme ellenistico fu quello della cultura secolare. In sintesi, possiamo affermare che la prima metà dell’ellenismo, che durò fino al tempo di Cristo, è caratterizzata soprattutto da questa cultura greca secolare. Per l’Oriente è un periodo di preparazione per il suo risorgere, paragonabile ad un periodo di incubazione. Possiamo soltanto indovinare dalla sua seguente improvvisa rinascita quanto profonde dovettero essere le trasformazioni avvenute in questo periodo sotto la superficie ellenistica. A parte l’unica eccezione importante della rivolta dei Maccabei, non vi è quasi segno di affermazione orientale nell’orbita ellenistica durante il periodo che va da Alessandro a Cesare. Oltre i confini, la fondazione del regno dei Parti e la rinascita del mazdeismo rappresentano casi analoghi a quello ebraico. Tali eventi non alterano molto il quadro generale dell’Ellade come parte assimilatrice e dell’Oriente come parte assimilata durante tutto questo periodo.
“Concettualizzazione greca del pensiero orientale”. Tuttavia questo periodo di vita latente ebbe un profondo significato nella storia della vita dell’Oriente stesso. Il monopolio greco di ogni forma di espressione intellettuale ebbe per lo spirito orientale un doppio aspetto di soppressione e di liberazione: soppressione perché questo monopolio lo privò del suo mezzo originario e lo obbligò a dissimulare i propri contenuti sotto una diversa espressione; liberazione perché la forma concettuale greca offrì alla mente orientale una possibilità completamente nuova di portare alla luce la sua eredità propria.
Abbiamo visto che il sorgere di princìpi spirituali di comunicabilità generale fuori della massa delle tradizioni popolari s’era iniziato alla vigilia dell’ellenismo; ma fu con i mezzi logici forniti dallo spirito greco che tale processo giunse a compimento. Perché la Grecia aveva scoperto il “logos”, il concetto astratto, il metodo di espressione teorica, il sistema razionale, una delle maggiori scoperte nella storia del pensiero umano. Questo strumento formale applicabile a qualsiasi contenuto, l’ellenismo lo mise a disposizione dell’Oriente, la cui autoespressione poteva ora trarre beneficio da esso. L’effetto, ritardato nelle sue manifestazioni, fu incalcolabile. Il pensiero orientale era stato non concettuale, espresso in immagini e simboli, più incline a travestire i suoi oggetti ultimi in miti e riti anziché esprimerli logicamente. Rimaneva costretto nella rigidità dei suoi antichi simboli e da questo imprigionamento fu liberato dal soffio vivificante del pensiero greco, che dette un impeto nuovo e nello stesso tempo strumenti adatti ad esprimere quella tendenza all’astrazione che già precedentemente era all’opera.
In fondo il pensiero orientale rimase mitologico, come apparve chiaramente quando si presentò di nuovo al mondo; ma aveva imparato nel frattempo a manifestare le sue idee sotto forma di “teorie” e ad usare concetti razionali, anziché impiegare per esprimerle soltanto immagini sensibili. In tal modo con l’aiuto della concettualizzazione greca si ebbe la definitiva formulazione dei sistemi del dualismo, del fatalismo astrologico e del monoteismo trascendente. Avendo acquistato la condizione di dottrine metafisiche essi acquistarono corso generale e il loro messaggio poté essere rivolto a tutti. Perciò lo spirito greco liberò il pensiero orientale dalla schiavitù del suo stesso simbolismo e lo mise in grado di scoprire se stesso nella riflessione del “logos”. E fu precisamente con le armi tolte dall’arsenale greco che l’Oriente quando venne il suo momento lanciò la sua controffensiva.
“Il «sottofondo» orientale”. Naturalmente in uno sviluppo di questo tipo non si presentano solo circostanze favorevoli, ma vi sono anche connessi dei pericoli che minacciarono la sostanza genuina del pensiero orientale. Anzitutto ogni generalizzazione o razionalizzazione la si sconta con la perdita di specificità. In particolare, l’influenza greca indusse i pensatori orientali a trarre profitto dal prestigio di tutto quello che era greco e ad esprimere le loro idee non in maniera diretta, ma sotto il travestimento di altre analoghe prese dalla tradizione greca di pensiero. Così, per esempio, il fatalismo astrologico e la magia furono rivestiti degli ornamenti della cosmologia stoica con le sue dottrine di simpatia cosmica e di legge cosmica; il dualismo religioso assunse la veste del platonismo. Per la mentalità incline all’assimilazione ciò fu un progresso, ma lo scimmiottare così iniziato impedì un’ulteriore crescita della mente orientale e presenta inoltre specifiche difficoltà di interpretazione per lo storico. Il fenomeno che Oswald Spengler ha chiamato «pseudomorfismo», con un termine preso dalla mineralogia, richiamerà in seguito la nostra attenzione (confronta cap. 1, d).
Ci fu un altro effetto, forse ancora più profondo, che l’ascendente della Grecia ebbe sulla vita interiore dell’Oriente, effetto che divenne manifesto soltanto più tardi: la divisione dello spirito orientale che si mosse in un doppio piano, uno di superficie e l’altro di profondità, venendosi a formare una tradizione pubblica e una tradizione segreta. Perché la forza del modello greco non ebbe solo un effetto stimolante, ma anche un effetto repressivo. Le sue norme selettive agirono come un filtro: ciò che era suscettibile di ellenizzazione passava e guadagnava un posto in piena luce, cioè diveniva parte dello strato superiore articolato della cultura cosmopolita; il rimanente, ciò che era radicalmente diverso e inassimilabile, restava escluso e continuava una propria vita sotterranea. Questo «altro» non poteva sentirsi rappresentato dalle creazioni convenzionali del mondo letterario, non poteva riconoscersi nel messaggio generale.
Per opporre il suo messaggio a quella dominante dovette trovare un suo linguaggio e il trovarlo fu un processo che costò lunga fatica. Per la natura delle cose, furono le tendenze più genuine e originali dello spirito orientale, quelle del futuro piuttosto che del passato, che furono costrette a tale condizione di esistenza sotterranea.
Il monopolio spirituale della Grecia perciò causò la crescita di un Oriente invisibile la cui vita segreta formò una corrente nascosta antagonistica, al di sotto della superficie della pubblica civiltà ellenistica. Processi di profonda trasformazione, indirizzi nuovi di ampia portata, devono aver preso le mosse durante questo periodo di sommersione. Non possiamo naturalmente conoscerli, e tutta la nostra descrizione, fondata come è su semplici congetture, sarebbe priva di fondamento se non fosse per l’improvvisa ricomparsa di un nuovo Oriente di cui abbiamo testimonianza all’inizio della nuova èra e dalla cui forza e ampiezza possiamo trarre conseguenze riguardo alla sua incubazione.
– La ricomparsa dell’Oriente.
Ciò che in realtà noi costatiamo è un’esplosione dell’Oriente nel periodo che coincide grosso modo con gli inizi del cristianesimo. Come acque lungamente trattenute, le sue forze ruppero la crosta ellenistica e inondarono il mondo antico, scorrendo nelle forme greche già stabilite, riempiendole del loro contenuto, e creando inoltre letti loro propri.
S’iniziava la metamorfosi dell’ellenismo in una cultura religiosa orientale. Il momento dell’irrompere fu probabilmente determinato da due condizioni complementari, la maturazione dello sviluppo sotterraneo dell’Oriente che lo mise in grado di emergere alla piena luce del giorno, e la preparazione dell’Occidente ad un rinnovamento religioso, anzi, il bisogno di esso profondamente sentito, che aveva il suo fondamento nella condizione spirituale di quel mondo e lo dispose a rispondere con ardore al messaggio dell’Oriente. Questa relazione complementare di attività e ricettività non è dissimile da quella opposta che s’impose tre secoli prima quando la Grecia avanzò in Oriente.
“La novità del pensiero orientale risorto”. E’ importante riconoscere che negli eventi accennati non siamo in presenza di una reazione del “vecchio” Oriente, ma di un fenomeno nuovo che entrò in quel momento cruciale nel teatro della storia. Il «vecchio Oriente» era morto. Il nuovo risveglio non significò una resurrezione classicista della sua antica eredità. E nemmeno la più recente concettualizzazione del primitivo pensiero orientale fu la reale sostanza del movimento. Il dualismo tradizionale, il fatalismo astrologico tradizionale, il monoteismo tradizionale vi furono tutti conglobati, ma erano connessi insieme in modo così particolarmente nuovo che nella loro presente formulazione erano a servizio della rappresentazione di un nuovo principio spirituale; e la stessa cosa si può dire dell’uso dei termini filosofici greci. E’ necessario sottolineare questo fatto fin dal principio a causa della forte tendenza a negarlo creata dalle apparenze esteriori, che per lungo tempo hanno fuorviato gli storici portandoli a considerare la struttura di pensiero con la quale si trovavano a confronto come formata semplicemente dai residui delle vecchie tradizioni, tranne per la sua parte di contenuto cristiano.
Queste vecchie tradizioni di fatto appaiono tutte nella nuova corrente spirituale: simboli dell’antico pensiero orientale, anzi tutta intera la sua eredità mitologica; idee e figure prese dal patrimonio biblico; elementi dottrinali e termini presi dalla filosofia greca, particolarmente dal platonismo. Si deve alla situazione di sincretismo se questi elementi diversi si trovarono disponibili e poterono essere combinati a volontà. Ma il sincretismo stesso fornì soltanto l’aspetto esteriore e non l’essenza del fenomeno. L’aspetto esteriore risulta confuso a causa della sua natura composita e più ancora per l’associazione dei vecchi nomi. Tuttavia, sebbene tali associazioni non siano affatto irrilevanti, è possibile distinguere un nuovo centro spirituale intorno al quale ora si cristallizzano gli elementi della tradizione, l’unità al di là della loro molteplicità; e questa è la vera realtà, con la quale siamo messi a confronto, piuttosto che i mezzi sincretistici di espressione. Se consideriamo questo centro spirituale come una forza autonoma allora possiamo dire che esso usa quegli elementi piuttosto che essere costituito dalla loro mescolanza; e la totalità che in tal modo prende origine deve essere intesa, nonostante il suo carattere manifestamente sincretistico, non come prodotto di un qualunque eclettismo, ma come un sistema di idee originale e distinto.
Tuttavia questo sistema come tale deve essere tratto dalla massa di materiali disparati, i quali permetteranno la separazione soltanto se eseguita con una interrogazione appropriata, ossia con un’interpretazione già guidata dalla precedente conoscenza della sottostante unità. Non si può negare che la dimostrazione così ottenuta cada in una specie di circolo vizioso, e nemmeno si può negare l’elemento soggettivo incluso nell’anticipazione intuitiva del fine verso cui deve muovere l’interpretazione. Tale è tuttavia la natura e il rischio dell’interpretazione storica che riceve suggerimenti da un’impressione iniziale del materiale e trova la sua conferma solo nel risultato, la sua possibilità di convincimento o plausibilità, e soprattutto nella progressiva conferma delle cose che prendono il loro posto quando sono messe a contatto con il modello ipotetico.
“Principali manifestazioni dell’ondata orientale nel mondo ellenistico”. Dobbiamo ora enumerare brevemente i fenomeni nei quali l’ondata orientale si è manifestata nel mondo ellenistico dall’inizio circa dell’èra cristiana in poi. Ecco i principali: l’espansione del giudaismo ellenistico, e in modo particolare il sorgere della filosofia giudaico-alessandrina; la diffusione dell’astrologia babilonese e della magia, che coincise con un generale aumento del fatalismo nel mondo occidentale; la diffusione di differenti culti misterici orientali in tutto il mondo ellenistico-romano e la loro evoluzione in religioni misteriche spirituali; il sorgere del cristianesimo; la fioritura di movimenti gnostici, con i loro grandi sistemi, all’interno e all’esterno della struttura cristiana; e le filosofie trascendentali della tarda antichità, a cominciare dal neopitagorismo fino alla scuola neoplatonica.
Tutti questi fenomeni, per quanto distinti, si possono dire in senso lato collegati tra loro. I loro insegnamenti hanno importanti punti in comune e persino nelle loro divergenze partecipano di uno stesso clima di pensiero; la letteratura di ognuno può completare la nostra conoscenza degli altri. Più evidente dell’affinità della sostanza spirituale è la ricorrenza di modelli tipici di espressione, di immagini specifiche e formule, in tutta la letteratura dell’intero gruppo. In Filone di Alessandria oltre gli elementi platonici e stoici che rivestono il nucleo giudaico, troviamo anche il linguaggio dei culti misterici e la nascente terminologia di un nuovo misticismo.
Le religioni misteriche da parte loro hanno profonde relazioni col complesso astrale di idee. Il neoplatonismo è largamente aperto a ogni dottrina religiosa pagana, specialmente orientale, con una pretesa di antichità ed un alone di spiritualità. Il cristianesimo, persino nelle sue formulazioni «ortodosse», ha avuto fin dal principio (certamente dal tempo di san Paolo) aspetti sincretistici, sorpassato tuttavia di molto sotto questo aspetto dalle sue ramificazioni eretiche; i sistemi gnostici racchiudevano tutto: mitologie orientali, dottrine astrologiche, teologia iranica, elementi della tradizione giudaica, sia biblici, rabbinici o occulti, escatologia cristiana della salvezza, termini e concetti platonici. Il sincretismo raggiunse in questo periodo la sua maggiore efficienza; non era più confinato a culti specifici e non riguardava soltanto i loro sacerdoti, ma aveva pervaso tutto il pensiero dell’epoca e appariva in tutte le sfere di espressione letteraria. Perciò nessuno dei fenomeni che abbiamo enumerato, può essere considerato separatamente da tutto il resto.
Eppure il sincretismo, il frammischiarsi di date idee e immagini, ossia delle correnti formate dalle molteplici tradizioni, è naturalmente un fatto puramente formale che lascia aperta la questione circa il contenuto intellettuale la cui apparenza esteriore viene da tale fatto determinata. Vi è un’unità nella molteplicità, e qual è? ci si chiede di fronte a tale complesso fenomeno. Qual è la forza organizzatrice nella materia sincretistica? Abbiamo detto precedentemente, come affermazione preliminare, che nonostante il suo aspetto «sintetico» il nuovo spirito non era un eclettismo amorfo. Quale fu dunque il principio direttivo e quale la direzione?
“L’unità sottostante: capacità rappresentativa del pensiero gnostico”. Per avere una risposta a tale questione bisogna fissare la propria attenzione su alcuni atteggiamenti mentali caratteristici che si mostrano più o meno distintamente in tutto il gruppo, astraendo dalla grandissima diversità dei contenuti e livelli intellettuali. Se in questi lineamenti comuni riconosciamo un principio spirituale operante che non era presente nei singoli elementi del composto, possiamo identificare questo come il vero fattore della composizione. Ora è possibile scoprire di fatto un nuovo principio in tutta la letteratura che abbiamo ricordato, sebbene in gradi diversi di determinazione. Esso appare ovunque nei movimenti provenienti dall’Oriente e più particolarmente in quel gruppo di movimenti spirituali che sono compresi sotto il nome di «gnostici». Possiamo perciò assumerlo come il più radicale e totale rappresentante di un nuovo spirito e possiamo di conseguenza chiamare in modo analogico questo “principio generale”, che in alcune inequivocabili manifestazioni si estende al di là del campo della letteratura gnostica propriamente detta, il «principio gnostico». Qualunque possa essere l’utilità di tale estensione del significato del nome, certamente lo studio di questo particolare gruppo è di grande interesse non soltanto in se stesso, ma anche perché può fornire, se non la chiave di tutta l’epoca, almeno un contributo vitale alla sua comprensione.
Personalmente sono fortemente incline a considerare tutta la serie dei fenomeni nei quali si manifesta l’ondata orientale come differenti rifrazioni, ed anche reazioni, di questo ipotetico principio gnostico, e ho esposto in altra sede le mie ragioni a sostegno di tale tesi (3). Per quanto generosi si possa essere nell’accettarlo, questo modo di vedere racchiude nel suo significato la specificazione che il comune denominatore così identificato può assumere varie forme e ammettere molti gradi di diluizione e di compromesso con princìpi contrastanti. In parecchi casi potrà essere esso stesso soltanto uno degli elementi in un insieme complesso di motivi intellettuali, parzialmente operante e imperfettamente realizzato nella totalità risultante. Ma è un fattore nuovo, ovunque esso si faccia sentire, e la sua manifestazione più genuina si può trovare nella letteratura gnostica propriamente detta. A questa ci volgiamo ora, riservandoci nell’ultima parte (Parte terza) il tentativo di situare il suo messaggio nel vasto quadro della cultura contemporanea.
NOTE ALL’INTRODUZIONE.
1 (Basileus) «Re»: traduzione letterale di Malchus.
2. (Porfirio) «Vestito di rosso»: allusione al suo nome originale e insieme alla principale industria della sua città nativa, la tintura della porpora.
3. H. JONAS, “Gnosis und spätantiker Geist”, I e II, 1, passim; ved. in particolare l’introduzione al vol. 1 e il cap. 4 del vol. 2, 1.
Parte prima.
LETTERATURA GNOSTICA
PRINCIPI FONDAMENTALI
LINGUAGGIO SIMBOLICO.
Capitolo 1.
IL SIGNIFICATO DELLA GNOSI E LA PORTATA DEL MOVIMENTO GNOSTICO.
a) Clima spirituale dell’epoca.
All’inizio dell’èra cristiana e progressivamente durante i due secoli seguenti, il mondo mediterraneo orientale si trovava in un profondo fermento spirituale. La genesi del cristianesimo stesso e l’accoglienza al suo messaggio sono manifestazioni di tale fermento, ma non sono le sole. Per quanto riguarda l’ambiente nel quale il cristianesimo ebbe origine, i rotoli recentemente scoperti presso il Mar Morto hanno fortemente convalidato la tesi, già ragionevolmente certa prima, che la Palestina ribolliva di movimenti escatologici (ossia di salvezza) e che il sorgere della setta cristiana non fu un incidente isolato. La crisi spirituale dell’epoca trovò la sua espressione più ardita e, per così dire, la sua rappresentazione estremistica, nel pensiero delle molteplici sètte “gnostiche” che cominciarono improvvisamente a fiorire nella scia dell’espansione del cristianesimo. L’astrusità delle loro speculazioni, in parte intenzionalmente provocatorie, non diminuisce ma anzi accresce la loro capacità di rappresentazione simbolica nei confronti del pensiero di un periodo agitato. Prima di limitare la nostra ricerca al fenomeno particolare dello gnosticismo, dobbiamo brevemente accennare i lineamenti principali che caratterizzano tale pensiero contemporaneo nel suo insieme.
In primo luogo, tutti i fenomeni che abbiamo ricordato in connessione con l’«ondata orientale» sono indubbiamente di natura “religiosa”; e questa è la caratteristica principale, come abbiamo ripetutamente affermato, della seconda fase della cultura ellenistica in generale. In secondo luogo, tutte queste correnti hanno in qualche modo rapporto con la “salvezza”: la religione di questo periodo è in generale una religione di salvezza. In terzo luogo, tutte le religioni mostrano una concezione di Dio assolutamente “trascendente” (ossia oltremondana) e unitamente a ciò un’idea ugualmente trascendente e ultramondana del fine della salvezza. Infine, esse sostengono un “dualismo” radicale dei regni dell’essere – Dio e il mondo, spirito e materia, anima e corpo, luce e tenebre, bene e male, vita e morte – e di conseguenza un’estrema polarizzazione dell’esistenza che riguarda non soltanto l’uomo ma la realtà come un tutto: si può definire in generale la religione di questo periodo come “religione dualistica trascendente di salvezza”.
b) Il termine «gnosticismo».
Tornando allo gnosticismo in particolare, ci chiediamo quale sia il significato del termine, dove ebbe origine il movimento e quali documenti letterari abbia lasciato.
Il termine «gnosticismo», che è stato assunto come termine collettivo per designare una molteplicità di dottrine settarie che sorsero all’interno e intorno al cristianesimo durante i primi secoli della sua travagliata storia, deriva da “gnosis”, nome greco che significa «conoscenza». Il significato di “conoscenza” nel senso di mezzo per raggiungere la salvezza o persino come forma della salvezza stessa, e la pretesa di possedere tale conoscenza nella propria formulazione dottrinale, sono caratteristiche comuni alle numerose sètte nelle quali storicamente si espresse il movimento gnostico. Di fatto vi furono soltanto pochi gruppi i cui membri esplicitamente si chiamarono Gnostici, «coloro che conoscono»; ma già Ireneo nel titolo della sua opera usava il termine «gnosis» (con l’aggiunta: «erroneamente così detta») per indicare tutte quelle sètte che condividevano quel significato e alcune altre caratteristiche. In tal senso si può parlare di scuole gnostiche, sètte gnostiche e culti gnostici, di scritti e insegnamenti gnostici, di miti e speculazioni gnostiche e persino di religione gnostica in genere.
Pur seguendo l’esempio di antichi autori che per primi estesero il nome al di là dei pochi gruppi così definitisi, non siamo tuttavia obbligati a fermarci dove essi si fermarono per ragioni di conoscenza o interesse polemico; adopreremo piuttosto il termine come un concetto che raggruppa tutta una classe e può essere applicato ovunque sono presenti certe proprietà specifiche. Si spiega perciò che l’estensione dell’area gnostica può essere allargata o ristretta a seconda del criterio impiegato. I Padri della Chiesa considerarono lo gnosticismo essenzialmente come un’eresia cristiana e limitarono la loro indagine e confutazione a quei sistemi che o erano già sbocciati dal terreno del cristianesimo (per esempio il sistema valentiniano), oppure avevano in qualche modo aggiunto e adattato la figura di Cristo ai loro insegnamenti eterogenei (per esempio il sistema dei Naasseni della Frigia), o altrimenti a quelli che attraverso un comune fondamento giudaico erano abbastanza vicini da poter essere considerati come competitori o deformatori del messaggio cristiano (per esempio quello di Simon Mago).
Le ricerche moderne hanno progressivamente allargato questo elenco tradizionale, affermando l’esistenza di uno gnosticismo “giudaico-precristiano” e di uno gnosticismo “ellenistico-pagano” e portando alla luce le fonti “mandee”, l’esempio più straordinario di gnosticismo orientale al di fuori dell’orbita ellenistica, e altri nuovi documenti. Infine, se si assume come criterio non tanto il motivo specifico di «conoscenza», quanto lo spirito dualistico-anticosmico in generale, anche la religione di “Mani” deve essere classificata come gnostica.
c) L’origine dello gnosticismo.
Non è facile rispondere alla seconda domanda, dove o da quale tradizione storica abbia avuto origine lo gnosticismo, perché siamo in presenza di un vecchio dilemma della speculazione storica: lungo il corso del tempo sono state avanzate le più contrastanti teorie che ancora oggi sono in gioco. I Padri della Chiesa primitiva, e indipendentemente da loro Plotino, accentuarono l’influenza di “Platone” e di una mal interpretata filosofia greca in genere sopra un pensiero cristiano non ancora ben consolidato. Gli studiosi moderni hanno presentato di volta in volta l’ipotesi di un’origine greca, babilonese, egiziana e iranica, e di ogni possibile combinazione di queste tra di loro e con elementi giudaici e cristiani. Poiché per quanto riguarda la sua espressione lo gnosticismo è di fatto un prodotto del sincretismo, ciascuna di queste teorie può trovare conferma nelle fonti, ma nessuna di esse è di per sé sola soddisfacente; d’altra parte non lo è nemmeno la combinazione di tutte queste, che farebbe dello gnosticismo un semplice mosaico di questi elementi privandolo di un’essenza autonoma. Nell’insieme tuttavia la tesi orientale ha un lieve vantaggio su quella greca, una volta che il significato della parola «conoscenza» viene liberato da connessioni ingannevoli suggerite dalla tradizione della filosofia classica.
Si sostiene che le recenti scoperte copte nell’Alto Egitto (confronta par. e) mettano in rilievo l’apporto di un giudaismo occultistico eterodosso, ma occorre sospendere il giudizio finché è in corso la traduzione del vasto corpo di documenti (1). In ogni modo si deve accettare una certa connessione dello gnosticismo con gli inizi della “Cabbala”, comunque sia l’ordine di causa ed effetto. La tendenza fortemente antigiudaica dei più importanti sistemi gnostici non è di per sé incompatibile con una remota origine giudaico-eretica.
A parte tuttavia il fatto di chi fossero i primi Gnostici e quali le principali tradizioni introdotte nel movimento con arbitrarie reinterpretazioni, il movimento stesso trascende i confini etnici e denominazionali, perché ne fu nuovo il principio spirituale. La corrente ebraica nello gnosticismo non è certo quella ortodossa, come non lo è quella babilonese, quella iranica e così via. Per quanto riguarda l’ipotesi di una preminenza dell’influenza greca, molto dipende da come deve essere inteso in questo contesto il concetto cruciale di «conoscenza».
d) La natura della «conoscenza» gnostica.
«Conoscenza» è un termine puramente formale che non specifica il “che cosa” debba essere conosciuto; e nemmeno specifica la maniera psicologica e il significato soggettivo del possedere la conoscenza o il modo in cui può essere acquisita. Per quanto riguarda l’oggetto della conoscenza, l’associazione di idee suggerita dal termine ad un lettore di formazione classica indirizza verso oggetti “razionali”, e di conseguenza alla ragione naturale come all’organo adatto per acquistare e possedere la conoscenza. Nel contesto gnostico invece «conoscenza» ha un significato decisamente religioso e soprannaturale e si riferisce ad oggetti che noi oggi chiameremmo quelli di fede piuttosto che di ragione. Ora sebbene la relazione tra fede e “conoscenza” (“pistis” e “gnosis”) sia stato il problema più discusso nella Chiesa tra gli eretici gnostici e gli ortodossi, esso è diverso dalla moderna discussione intorno a fede e ragione alla quale siamo abituati; perché la «conoscenza» degli Gnostici con la quale la semplice fede cristiana si trovò in contrasto, non era di tipo razionale. “Gnosis” significò anzitutto conoscenza “di Dio”, e da quanto abbiamo detto circa la radicale trascendenza della divinità ne consegue che «conoscenza di Dio» è la conoscenza di qualche cosa di inconoscibile naturalmente e perciò di per sé non una condizione naturale. Oggetto di tale conoscenza è tutto quello che appartiene al regno divino dell’essere, e precisamente l’ordine e la storia dei mondi superiori e ciò che deve provenirne, ossia la salvezza dell’uomo.
Con simile contenuto la conoscenza atto mentale differisce profondamente dalla conoscenza razionale della filosofia. Da una parte è strettamente legata all’esperienza della rivelazione, di modo che la ricezione della verità, sia attraverso la dottrina sacra e segreta o per mezzo di una illuminazione interiore, sostituisce l’argomento razionale e teorico (sebbene questa base extrarazionale possa fornire una prospettiva per una speculazione separata); dall’altra parte, poiché riguarda i segreti della salvezza, la «conoscenza» non è soltanto un’informazione teoretica su alcune realtà, ma ha essa stessa, in quanto rappresenta una modificazione della condizione umana, la funzione di attuare la salvezza. Per tale motivo la «conoscenza» gnostica ha un aspetto eminentemente pratico. L’oggetto ultimo della gnosi è Dio: il suo avvento nell’anima trasforma lo gnostico facendolo partecipe della divina essenza (il che significa molto di più che l’assimilarlo all’essenza divina). Perciò nei sistemi gnostici più radicali come quello valentiniano la «conoscenza» non è soltanto strumento di salvezza, ma è la forma stessa in cui si possiede il fine della salvezza, cioè la perfezione ultima. Tali sistemi pretendono che la conoscenza e il possesso da parte dell’anima di Colui che è conosciuto coincidano, pretesa questa di ogni reale misticismo. Tale è anche la pretesa della “theoria” greca, ma in un senso diverso. In questo caso, l’oggetto della conoscenza è l’universale e la relazione conoscitiva è «ottica», ossia un analogo della relazione visuale con una forma oggettiva che rimane inalterata nonostante la relazione. La «conoscenza» gnostica riguarda il particolare (perché la divinità trascendente è pur sempre un particolare) e la relazione di conoscenza è mutua, cioè un conoscersi allo stesso tempo, e implica un’attiva effusione di sé da parte del «conosciuto». Là la mente è «informata» dalle forme che contempla e mentre le contempla (pensa); qui il soggetto è «trasformato» (da «anima» in «spirito») per l’unione con una realtà che in verità è essa stessa in queste condizioni il soggetto supremo, e strettamente parlando non è mai un oggetto.
Queste brevi osservazioni preliminari sono sufficienti a delimitare il tipo gnostico di «conoscenza» differenziandolo dall’idea di teoria razionale secondo cui il concetto era stato sviluppato nella filosofia greca. Tuttavia i richiami del termine «conoscenza» come tale, rafforzati dal fatto che lo gnosticismo produsse veri pensatori che dispiegarono i contenuti segreti della «conoscenza» in sistemi dottrinali elaborati usando termini astratti, spesso con antecedenti filosofici nella loro esposizione, hanno fatto sorgere tra teologi e storici un’accentuata tendenza a spiegare lo gnosticismo per mezzo dell’influenza dell’ideale greco sulle nuove forze religiose che venivano alla ribalta in quel tempo e più particolarmente sul pensiero cristiano nascente.
Le reali aspirazioni teoretiche che trasparivano nella forma più elevata di speculazione gnostica e che confermavano, a quel che sembrava, la testimonianza dei Padri della Chiesa primitiva, portarono Adolf von Harnack alla sua famosa definizione che lo gnosticismo in questa sua forma superiore era «l’acuta ellenizzazione del cristianesimo», mentre la minore e più misurata evoluzione della teologia ortodossa era considerata come la sua «ellenizzazione cronica». L’analogia presa dalla medicina non voleva definire come una malattia l’ellenizzazione in quanto tale; ma la fase «acuta» che aveva provocato la reazione delle forze sane nell’organismo della Chiesa venne intesa come l’anticipazione affrettata e perciò dirompente dello stesso processo che nella sua forma più prudente e meno spettacolare aveva condotto all’incorporazione di quegli aspetti dell’eredità greca che potevano essere di grande beneficio per il pensiero cristiano. Per quanto perspicace possa essere questa diagnosi, come definizione dello gnosticismo non è precisa in entrambi i termini che costituiscono la formula, «ellenizzazione» e «cristianesimo». Essa considera lo gnosticismo come un fenomeno esclusivamente cristiano, mentre le ricerche posteriori hanno stabilito una sua maggiore ampiezza; inoltre apre la via all’apparenza ellenica della concettualizzazione gnostica e del concetto di “gnosis” stessa, che in realtà maschera solo superficialmente una sostanza spirituale eterogenea.
E’ precisamente la natura genuina, ossia inderivata, di tale sostanza che sfida ogni tentativo di derivazione che voglia andare al di là della scorza esterna di espressione. Quanto all’idea di «conoscenza», questa grande parola d’ordine del movimento, bisogna sottolineare che la sua oggettivazione in sistemi articolati di pensiero riguardo a Dio e all’universo fu una produzione autonoma di quella sostanza, piuttosto che la sua subordinazione ad uno schema di “theoria” preso a prestito. La combinazione del concetto pratico, salvifico di conoscenza con la sua rappresentazione teoretica in sistemi di pensiero quasi razionali – la razionalizzazione del soprannaturale – fu tipica della forma più alta di gnosticismo e fece nascere un genere di speculazione precedentemente sconosciuto, ma che non sarebbe mai più scomparso dal pensiero religioso.
Tuttavia la mezza verità di Harnack riflette un fatto integrante del destino della nuova sapienza orientale quasi quanto lo fu la sostanza originale: il fatto chiamato da Spengler «pseudomorfismo» al quale abbiamo già fatto allusione prima. Se avviene che una sostanza cristallina diversa occupi la cavità lasciata in uno strato geologico da cristalli che si sono disintegrati, essa è costretta dallo stampo a prendere una forma cristallina che non le è propria e senza analisi chimica l’osservatore sarebbe portato a considerarla come un cristallo del tipo originale. Tale formazione è chiamata in mineralogia una «pseudomorfosi». Con l’intuizione ispirata che lo distinse e appassionato come fu in questo campo, Spengler vide una situazione analoga nel periodo che stiamo considerando e ne dedusse che il riconoscimento di essa doveva guidare nella comprensione di tutte le sue affermazioni. Secondo lui, il pensiero greco che si disintegrava è il vecchio cristallo dell’esempio, il pensiero orientale la nuova sostanza costretta nel suo stampo. Lasciando da parte la più ampia prospettiva storica nella quale Spengler situa la sua osservazione, egli ha dato un brillante contributo alla diagnosi di una situazione storica, che se adoperato con discernimento, può essere grandemente di aiuto per la nostra comprensione.
e) Rassegna delle fonti.
Quali sono le fonti, cioè la letteratura, per mezzo della quale dobbiamo ricostruire l’immagine di questo credo dimenticato? La seguente rassegna non ha la pretesa di essere completa ma soltanto rappresentativa. Dobbiamo dividere le fonti in originali e in secondarie, ma di queste ultime fino ad un’epoca recentissima quasi nessuna era conosciuta. Iniziamo da questo secondo gruppo.
– Fonti secondarie o indirette.
1. La lotta contro lo gnosticismo come pericolo per la vera fede occupò larga parte della primitiva letteratura cristiana e gli scritti dedicati a confutarlo rappresentano la più importante fonte secondaria di conoscenza sia per le loro discussioni, sia per i sommari che danno degli insegnamenti gnostici e frequentemente anche per le estese citazioni letterali da scritti gnostici. Possiamo aggiungere che fino al diciannovesimo secolo essi erano l’unica fonte (a parte il trattato di Plotino), perché la vittoria della Chiesa aveva naturalmente portato alla scomparsa degli originali gnostici. In questo gruppo sono comprese le grandi opere polemiche dei Padri: Ireneo, Ippolito, Origene ed Epifanio in greco, Tertulliano in latino. Un altro Padre, Clemente di Alessandria, lasciò tra i suoi scritti una collezione molto notevole di “Excerpta” greci dagli scritti di Teodoto, un membro della scuola valentiniana di gnosticismo, che ne rappresenta il ramo orientale («anatolico»). Del ramo italico, Epifanio ci ha conservato un completo documento letterario, la “Lettera a Flora” di Tolomeo. Nel caso di così complete, o quasi complete, descrizioni del soggetto contro cui è diretto l’attacco (tra le quali si possono annoverare anche i riferimenti di Ippolito sui Naasseni e sul “Libro di Baruch”), la distinzione da noi fatta tra fonti secondarie e primarie si offusca. E’ nella natura delle circostanze che tutti gli originali conservati in questo modo, sia interamente che in parte (di regola in parte), siano greci. Nell’insieme queste fonti patristiche danno notizia di un grande numero di sètte, tutte almeno nominalmente cristiane, sebbene in alcuni casi la vernice cristiana sia piuttosto tenue. Un contributo unico di questo gruppo proveniente dal campo pagano è il trattato di Plotino, il filosofo neoplatonico: “Contro gli Gnostici o contro coloro che affermano che il Creatore del mondo è cattivo e che il mondo è cattivo” (Enn. II, 9). Esso è diretto contro una particolare setta gnostica cristiana che non può essere identificata con nessuna di quelle nominate nei cataloghi patristici, ma che certamente doveva far parte di uno dei maggiori raggruppamenti gnostici.
2. Dopo il terzo secolo gli scrittori antieretici dovettero occuparsi di confutare il manicheismo. Essi non considerano questa nuova religione come facente parte dell’eresia gnostica che nel suo senso più ristretto in quel tempo era già scomparsa. Ma secondo il più ampio criterio della storia delle religioni appartiene allo stesso ordine di idee. Tra la letteratura cristiana molto estesa ricordiamo soltanto gli “Acta Archelai”, le opere di Tito di Bostra (greco), di sant’Agostino (latino) e di Teodoro bar Konai (siriaco). Inoltre un autore pagano, di buona educazione filosofica, Alessandro di Licopoli (in Egitto), che scrisse una generazione dopo Mani e si aggiunge al coro cristiano.
3. Alcune delle “religioni misteriche” della tarda antichità appartengono anch’esse in modo specifico al circolo gnostico, nel senso e fino al punto in cui esse allegorizzano i miti rituali e originali del loro culto in uno spirito somigliante a quello gnostico; possiamo menzionare i misteri di Iside, Mitra e Attis. Le fonti in questo caso consistono nei riferimenti di scrittori contemporanei, greci e latini, per la maggior parte pagani.
4. Un certo numero di velate informazioni si trovano sparse nella letteratura “rabbinica”, sebbene il silenzio fosse considerato l’unico modo efficace di comportarsi con l’eresia, a differenza della pratica cristiana.
5. Infine, quel ramo della letteratura “islamica”, per quanto tarda, che tratta della varietà delle religioni, contiene notizie importanti sulla religione manichea in particolare, ma anche su alcune oscure sètte gnostiche i cui scrittori sopravvivevano ancora nel periodo islamico.
Per quanto riguarda la lingua, queste fonti secondarie sono greche, latine, ebraiche, siriache e arabe.
– Fonti primarie o dirette.
Per la maggior parte le fonti dirette sono venute alla luce soltanto nel diciannovesimo secolo e sono in continuo aumento per le fortunate scoperte archeologiche. La seguente enumerazione è indipendente dall’ordine di origine e di scoperta.
1. Per la conoscenza dello gnosticismo sono di incalcolabile valore, al di fuori dell’orbita cristiana, i libri sacri dei “Mandei”, una setta che sopravvive in pochi gruppi residui nella regione del basso Eufrate (il moderno Iraq) e che è violentemente anticristiana e antigiudaica, ma annovera tra i suoi profeti Giovanni Battista in opposizione e a scapito del Cristo. E’ questo il solo esempio di religione gnostica che sia durato fino ai nostri giorni. Il nome deriva dall’aramaico “manda”, «conoscenza», perciò «Mandei» significa letteralmente «Gnostici».
Le loro scritture, in un dialetto aramaico molto vicino a quello del Talmud, costituiscono il più vasto corpo di scritti gnostici originali in nostro possesso, con la possibile eccezione del gruppo successivo. Esso comprende trattati mitologici e dottrinali, insegnamenti rituali e morali, liturgia e raccolte di inni e salmi, queste ultime comprendenti brani di profonda e toccante poesia religiosa.
2. Un gruppo di fonti in continuo aumento è costituito dagli scritti cristiani copto-gnostici, in massima parte della scuola valentiniana o della cui più ampia famiglia questa scuola è il membro preminente. Il Copto era il vernacolo egiziano dell’ultimo periodo ellenistico, derivante dall’antico egiziano, con una mescolanza di greco. L’assunzione di questo linguaggio popolare a mezzo di espressione letteraria riflette il sorgere di una religione di massa che si contrapponeva alla cultura greca secolare delle persone di formazione ellenistica. Fino a poco tempo fa, l’insieme di scritti copto-gnostici in nostro possesso, quali la “Pistis Sophia” e i “Libri di Jeû”, rappresentava un livello piuttosto basso e deteriore di pensiero gnostico, appartenente allo stadio decadente della speculazione sulla Sophia. Ma ultimamente (circa nel 1945) una scoperta sensazionale fatta a Nag-Hammadi (Chenoboskion) nell’Alto Egitto ha messo in luce un’intera biblioteca di una comunità gnostica, contenente scritti finora sconosciuti, tradotti dal greco in copto, di quella che può essere chiamata la fase «classica» della letteratura gnostica: tra essi uno dei più importanti libri dei Valentiniani, il “Vangelo della Verità” – da attribuirsi se non allo stesso Valentino, certamente a qualcuno della generazione fondatrice della scuola – di cui attraverso Ireneo erano noti semplicemente il titolo e l’esistenza dell’opera. Ad eccezione di quest’unica parte di un solo codice, che è stata pubblicata per intero nel 1956, ed alcuni estratti da altre parti, il restante del nuovo abbondante materiale (13 codici, alcuni frammenti, di cui alcuni quasi intatti, consistenti in totale di circa 1000 pagine di papiro e contenenti circa 48 scritti) non è stato ancora reso noto. D’altra parte, è stato recentemente pubblicato per la prima volta (1955), e quindi conosciuto nelle sue parti di contenuto gnostico, un codice proveniente dalle più antiche scoperte copte che era conservato da 60 anni nel Museo di Berlino; la parte più importante è l'”Apocrifo di Giovanni”, opera capitale degli Gnostici barbelioti, già citata da Ireneo nella sua esposizione di questo sistema che risale al secondo secolo. (Questo scritto e l’altro alquanto posteriore, “La Sapienza di Gesù Cristo”, sono pure stati trovati tra le opere inedite della biblioteca di Nag-Hammadi, l'”Apocrifo” in non meno di tre versioni, prova della stima di cui godeva.)
3. In lingua copta è anche la biblioteca di papiri “manichei” scoperta in Egitto nel 1930, la cui pubblicazione è in corso. I codici molto mal conservati, che risalgono al quarto secolo d.C. di circa 3500 pagine, hanno restituito fino ad ora uno dei libri di Mani, prima noto solo dal titolo che, come tutti i suoi scritti, era ritenuto irrimediabilmente perduto: i “Kephalaia”, ossia «I Capitoli»; un (il?) “Libro dei Salmi” della primitiva comunità manichea; ed anche parte di una collezione di “Omelie” che risale alla prima generazione dopo Mani. Ad esclusione dei rotoli del Mar Morto, tale scoperta si può considerare come il più grande avvenimento per la storia della religione che l’archeologia ci abbia fornito durante questa generazione. Come nel caso del corpo di scritti mandei, il corpo copto-manicheo contiene materiale dottrinale come pure composizioni poetiche. La traduzione è stata probabilmente fatta dal siriaco, per quanto non si possa del tutto escludere l’intermedio di una traduzione greca.
4. Un altro gruppo di fonti originali per la religione manichea, sebbene più tardive, questa volta in forma orientale, sono i cosiddetti frammenti di Turfan in lingua persiana e in lingua turca, trovati nelle ricerche compiute nell’oasi di Turfan nel Turkestan cinese al principio di questo secolo. Ad essi vanno aggiunti due testi cinesi trovati anche nel Turkestan, un rotolo di un inno e un trattato indicato dal nome del suo scopritore ed editore Pelliot. Tali documenti – non ancora interamente pubblicati – sono un segno evidente del fiorire di una religione gnostica in terre lontane come l’Asia centrale.
5. Da lungo tempo noto agli studiosi occidentali è il corpo di scritti greci attribuiti ad “Ermete Trismegisto” e spesso citato come “Poimandres”, che strettamente parlando è il nome del primo trattato solamente. Il corpo esistente, pubblicato per la prima volta nel sedicesimo secolo, è ciò che resta di una letteratura egiziana ellenistica di rivelazione, chiamata «ermetica» a causa dell’identificazione sincretistica del dio egiziano Thoth con il greco Hermes. Si aggiunge alle fonti per la conoscenza del pensiero ermetico un certo numero di riferimenti e citazioni in tardi scrittori classici, sia pagani che cristiani. Questa letteratura, non nel suo insieme ma in alcune parti, riflette lo spirito gnostico. Lo stesso si può dire per la letteratura “alchimistica” molto vicina alla precedente e per alcuni dei “papiri magici” greci e copti, che presentano una mescolanza di idee gnostiche. Lo stesso trattato ermetico “Poimandres”, nonostante certi segni di influenza giudaica, è da considerare come uno dei principali documenti di gnosticismo pagano indipendente.
6. C’è, infine, materiale gnostico in alcuni apocrifi del Nuovo Testamento, come gli “Atti di Tommaso” e le “Odi di Salomone”: in entrambi i casi nella forma di poesie, che sono tra le più belle espressioni del sentimento e della fede gnostica.
Per quanto riguarda il linguaggio, le fonti originali sono greche, copte, aramaiche, persiane, turche e cinesi. (Il termine «originali» non esclude qui antiche traduzioni, come è il caso dei documenti in lingua turca e cinese e la maggioranza di quelli in copto.)
Questa rassegna può dare una certa idea della vastità geografica e linguistica delle fonti gnostiche e della grande varietà di gruppi gnostici. Di conseguenza possiamo parlare della dottrina gnostica soltanto come un’astrazione. I più eminenti gnostici manifestarono un individualismo intellettuale molto pronunziato, e l’immaginativa mitologica di tutto il movimento fu incessantemente fertile. Il non-conformismo fu quasi un principio della mentalità gnostica e fu strettamente collegato alla dottrina di uno «spirito» sovrano come sorgente di conoscenza diretta e di illuminazione. Già Ireneo (“Adv. Haer.” I, 18, 1) osservava: «Ogni giorno ciascuno di essi inventa qualcosa di nuovo». I grandi artefici del sistema, come Tolomeo, Basilide, Mani, costruirono strutture speculative ingegnose ed elaborate che sono creazioni originali di menti singole, ma nello stesso tempo variazioni e sviluppi di alcuni temi principali condivisi da tutti: nel loro insieme questi formano ciò che può essere chiamato il più semplice «mito di base». Ad un livello meno intellettuale questo stesso contenuto basilare è espresso in favole, esortazioni, istruzioni pratiche (morali e magiche), inni e preghiere.
Nell’intento di aiutare il lettore a vedere l’unità di un così vasto campo, prima di entrare in una trattazione particolareggiata delineeremo questo «mito di base» che può essere estratto dalla varietà confusa del materiale a disposizione.
f) Sommario dei fondamentali princìpi gnostici.
– Teologia.
La caratteristica basilare del pensiero gnostico è il radicale dualismo che governa il rapporto di Dio col mondo e conseguentemente quello dell’uomo col mondo. La divinità è assolutamente transmondana, la sua natura del tutto estranea a quella dell’universo, il quale non è creato né governato, e in rapporto al quale il divino è in completa antitesi: al regno divino della luce, in sé perfetto e remoto, si contrappone il cosmo come regno delle tenebre. Il mondo è opera di potenze inferiori le quali, seppure possono provenire mediatamente da Lui, non conoscono il vero Dio e impediscono la conoscenza di Lui nel cosmo sul quale esse governano. La genesi di queste potenze inferiori, gli Arconti (governanti), e in generale quella di tutti gli ordini di esseri fuori di Dio, compreso il mondo stesso, è uno dei temi principali della speculazione gnostica, di cui daremo in seguito alcuni esempi. Il Dio stesso trascendente è nascosto a tutte le creature e non può essere conosciuto mediante concetti naturali. La conoscenza di Lui richiede rivelazione soprannaturale e illuminazione ed anche allora può difficilmente essere espressa altrimenti che in termini negativi.
– Cosmologia.
L’universo, il dominio degli Arconti, è come una vasta prigione la cui cavità più interna è la terra, lo scenario della vita dell’uomo. Intorno e al di sopra di esso le sfere cosmiche sono disposte in orbite concentriche che lo racchiudono. Più spesso vi sono le sette sfere dei pianeti circondati dall’ottava, quella delle stelle fisse. Ci fu tuttavia una tendenza a moltiplicare le strutture e costruire schemi sempre più estesi: Basilide contava non meno di 365 «cieli». Il significato religioso di questa architettura cosmica sta nell’idea che tutto quello che si frappone tra qui e l’aldilà serve a separare l’uomo da Dio, non soltanto per la distanza spaziale ma per le forze attive demoniache. Perciò la vastità e la molteplicità del sistema cosmico esprime il grado di separazione dell’uomo da Dio.
Le sfere sono i seggi degli Arconti, specialmente dei «Sette», ossia degli dèi planetari presi a prestito dal pantheon babilonese. E’ significativo che questi sono spesso chiamati, ora, mediante i nomi che l’Antico Testamento usa per Dio (Iao, Sabaoth, Adonai, Elohim, El Shaddai), i quali non sono più sinonimi dell’unico e supremo Dio, ma sono divenuti per tale trasposizione i nomi propri di esseri demoniaci inferiori: un esempio della rivalutazione peggiorativa alla quale lo gnosticismo ha sottoposto le antiche tradizioni in genere e la tradizione giudaica in specie.
Gli Arconti governano collettivamente sul mondo, e ciascuno individualmente nella sua sfera è un guardiano della prigione cosmica. Il loro tirannico governo del mondo è chiamato “heimarméne”, Fato universale, concetto preso dall’astrologia ma colorito ora di spirito gnostico anticosmico. Nel suo aspetto fisico questo governo è la legge di natura; nel suo aspetto psichico, che include per esempio l’istituzione e l’approvazione della Legge mosaica, mira all’asservimento dell’uomo. Come guardiano della propria sfera, ciascun Arconte sbarra il passaggio alle anime che cercano di ascendere dopo la morte, allo scopo di impedirne la fuga dal mondo e il ritorno a Dio. Gli Arconti sono anche i creatori del mondo, tranne quando questa funzione è riservata al loro capo, il quale allora prende il nome di “demiurgo” (l’artefice del mondo nel “Timeo” di Platone) ed è spesso dipinto coi lineamenti alterati del Dio dell’Antico Testamento.
– Antropologia.
L’uomo, l’oggetto principale di quest’ampia prospettiva, è composto di carne, anima e spirito. Ma ridotto ai princìpi ultimi, la sua origine è duplice: mondana ed extramondana. Non soltanto il corpo, ma anche l’«anima» è un prodotto delle potenze cosmiche che hanno formato il corpo ad immagine dell’Uomo Primigenio divino (o Archetipo) e lo hanno animato con le loro proprie forze psichiche: queste sono gli appetiti e le passioni dell’uomo naturale, ciascuna delle quali deriva e corrisponde ad una delle sfere cosmiche, e tutte insieme formano l’anima astrale dell’uomo, la sua «psiche». Per il suo corpo e la sua anima l’uomo è parte del mondo e soggetto all'”heimarméne”. Racchiuso nell’anima c’è lo spirito, o «pneuma» (chiamato anche «scintilla»), una porzione della divina sostanza dell’aldilà che è caduta nel mondo; e gli Arconti crearono l’uomo con l’espresso proposito di trattenerlo prigioniero quaggiù. Perciò, come nel macrocosmo l’uomo è racchiuso dalle sette sfere, così nel microcosmo umano lo spirito è racchiuso dai sette rivestimenti dell’anima, originati da esse. Nel suo stato irredento il pneuma, così immerso nell’anima e nella carne, non ha coscienza di se stesso, è intorpidito, addormentato, o intossicato dal veleno del mondo: in breve, è «ignorante». Il suo risveglio e la sua liberazione vengono effettuate mediante la «conoscenza».
– Escatologia.
La natura radicale del dualismo determina quella della dottrina della salvezza. Altrettanto straniero quanto è il Dio trascendente nei riguardi di «questo mondo», lo è pure il sé pneumatico nel mezzo di esso. Il fine dello sforzo gnostico è la liberazione dell’«uomo interiore» dai legami del mondo e il suo ritorno al regno nativo della luce. Condizione necessaria per questo è che egli «conosca» il Dio transmondano e se stesso, ossia la sua origine divina come pure la sua presente condizione e di conseguenza anche la natura del mondo che determina tale condizione. Come dice una famosa formula valentiniana:
«Ciò che libera è la conoscenza di quello che eravamo, di ciò che siamo diventati; di dove eravamo, dove siamo stati gettati; verso dove ci affrettiamo, da dove siamo redenti; che cosa è nascita, che cosa è rinascita» (Exc. Theod. 78, 2).
Tale conoscenza gli è impedita dalla sua stessa situazione, poiché l’«ignoranza» è l’essenza dell’esistenza mondana, proprio come è stata il principio del venire all’esistenza del mondo. In particolare, il Dio trascendente è sconosciuto al mondo e non può essere scoperto da esso; ragione per cui è necessaria la rivelazione. La necessità di essa è fondata sulla natura della condizione cosmica; la sua presenza altera tale situazione nel suo aspetto decisivo, quello dell’«ignoranza», ed è perciò essa stessa già parte della salvezza. Il suo portatore è un messaggio del mondo della luce che penetra le barriere delle sfere, giuoca gli Arconti, risveglia lo spirito dal suo torpore terreno e gli impartisce la conoscenza salvifica «da fuori». La missione di questo salvatore trascendente comincia persino prima della creazione del mondo (poiché la caduta dell’elemento divino ha preceduto la creazione) e corre parallela alla sua storia. La conoscenza così rivelata, anche se chiamata semplicemente «la conoscenza di Dio», comprende l’intero contenuto del mito gnostico con tutto quello che deve insegnare intorno a Dio, all’uomo e al mondo; ossia contiene gli elementi di un sistema teoretico. Dal punto di vista pratico tuttavia, è più particolarmente «conoscenza della vita», cioè della via dell’anima per uscire dal mondo, compresa la preparazione sacramentale e magica per la futura ascesa e i nomi segreti e le formule che forzano il passaggio attraverso ciascuna sfera. Fornita di tale “gnosis”, l’anima dopo la morte comincia il viaggio verso l’alto, lasciando dietro ad ogni sfera il «vestimento» psichico da essa provveduto: in tal modo lo spirito spogliato di ogni accrescimento estraneo raggiunge il Dio al di là del mondo e si riunisce alla divina sostanza. Sulla scala del totale dramma divino, questo processo fa parte della restaurazione dell’integrità divina che è stata guastata nei tempi precosmici dalla perdita di porzioni della sostanza divina. E’ soltanto in ragione di queste scintille perdute che la divinità è stata coinvolta nel destino del mondo, ed è per ricuperarle che un suo messaggero interviene nella storia cosmica. Compiuto questo processo di raccolta, secondo alcuni sistemi, il cosmos privato dei suoi elementi di luce, giungerà ad una fine.
– Morale.
In questa vita i “pneumatici”, come i possessori di gnosi chiamano se stessi, stanno appartati dalla gran massa dell’umanità. L’illuminazione diretta non soltanto rende l’individuo sovrano nella sfera di conoscenza (di qui la varietà illimitata di dottrine gnostiche), ma determina anche la sfera di azione. In termini generali, la moralità pneumatica è stabilita dall’ostilità verso il mondo e dal disprezzo di tutti i legami mondani. Da questo principio tuttavia si possono trarre due conclusioni contrarie ed entrambe trovano i loro rappresentanti estremisti: l’ascetica e la libertina. La prima deduce dal possesso della gnosi l’obbligo di evitare ogni ulteriore contaminazione da parte del mondo e di ridurre al minimo possibile il contatto con esso; la seconda fa derivare dallo stesso possesso il privilegio di assoluta libertà. Ci fermeremo in seguito sulla complessa teoria del libertinismo gnostico. In questa considerazione preliminare ci contenteremo di poche osservazioni. La legge del «Tu devi» e «Tu non devi» promulgata dal Creatore è soltanto una forma in più di tirannia «cosmica». Le sanzioni legate alla trasgressione di tale legge possono colpire soltanto il corpo e la psiche. Poiché il pneumatico è libero dall'”heimarméne”, ugualmente è libero dal giogo della legge morale. A lui tutte le cose sono permesse, poiché il pneuma è «salvato nella sua natura» e non può essere macchiato dalle azioni né spaventato dalla minaccia della retribuzione arcontica. La libertà pneumatica tuttavia è più che una questione di permissione indifferente: mediante la violazione intenzionale delle norme demiurgiche il pneumatico contrasta il disegno degli Arconti e paradossalmente contribuisce all’opera di salvezza. Questo libertinismo antinomico rivela più potentemente della versione ascetica l’elemento “nihilistico” contenuto nell’acosmismo gnostico.
Persino il lettore che non ha familiarità con la materia potrà comprendere dalla sintesi precedente che, qualsiasi elevatezza di concettualizzazione abbia raggiunto la teoria gnostica nei singoli pensatori, esiste un indissolubile nucleo mitologico del pensiero gnostico come tale. Molto lontano dall’atmosfera rarefatta del ragionamento filosofico, esso si muove nello spesso mezzo dell’immaginazione e della personificazione. Nei capitoli seguenti ci rimane da completare il quadro generale della nostra esposizione con la sostanza della metafora e del mito gnostico, e inoltre presentare alcune elaborazioni di questo contenuto basilare nei sistemi speculativi di pensiero.
NOTA AL CAPITOLO 1.
1. Ved. cap. 11 [n. d. cur.: la traduzione del corpo dei documenti è oggi completa].
Capitolo 2.
IMMAGINAZIONE GNOSTICA E LINGUAGGIO SIMBOLICO.
Al primo contatto con la letteratura gnostica, il lettore sarà colpito da certe espressioni ricorrenti che per la loro intrinseca qualità, anche al di fuori del più ampio contesto, rivelano qualche cosa della fondamentale esperienza, del modo di sentire e della visione della realtà caratteristicamente distintivi della mentalità gnostica. Tali espressioni vanno dalle singole parole con richiamo simbolico alle metafore sviluppate; e più che per la frequenza con cui ricorrono, sono significative per la loro eloquenza intrinseca, spesso accresciuta da novità strabilianti. In questo capitolo ne considereremo alcune. Il vantaggio di una simile linea di approccio è quello di metterci a confronto con un livello di espressione più fondamentale della differenziazione dottrinale nella quale il pensiero gnostico si è ramificato nei sistemi completi.
Particolarmente ricca in questa specie di costruzione originale, che mostra l’impronta della mentalità gnostica con forza espressiva, è la letteratura mandea. Tale ricchezza di espressività è almeno in parte il rovescio della povertà che mostra dal lato teoretico; ed è anche collegata al fatto che per la loro situazione geografica e sociale, lontana dall’influenza ellenistica, i Mandei erano meno esposti della maggioranza degli Gnostici alla tentazione di rendere l’espressione delle loro idee con le convenzioni intellettuali e letterarie dell’Occidente. Nei loro scritti abbonda la fantasia mitologica, la compattezza delle immagini non è attenuata da alcuna pretesa di concettualizzazione, la varietà non è frenata dalla preoccupazione di coerenza e sistemazione. Sebbene tale mancanza di disciplina intellettuale renda spesso tediosa la lettura delle loro ampie composizioni, che presentano frequenti ripetizioni, la vividezza senza sofisticazione della visione mitica che le permea offre un largo compenso; e nella poesia mandea l’anima gnostica effonde la sua angoscia, la sua nostalgia e il suo conforto in una vena inesauribile di potente simbolismo.
Per lo scopo del presente capitolo attingeremo abbondantemente da questa fonte, senza tuttavia esagerare l’importanza dei Mandei nel quadro generale dello gnosticismo.
a) Lo «straniero».
«Nel nome della grande, originaria Vita straniera dei mondi della luce, il sublime che sta al di sopra di tutte le opere»: questo è l’inizio tipico delle composizioni mandee, e «straniero» è un attributo costante della «Vita» che per sua natura è straniera rispetto a questo mondo e secondo certe considerazioni straniera all’interno di esso. La formula citata parla di «originaria» Vita «che sta al di sopra di tutte le opere» [da supplirvi: «di creazione»] ossia «al di sopra del mondo». Il concetto di Vita straniera è una delle parole-simbolo maggiormente espressive che si incontrano nel linguaggio gnostico, ed è nuova nella storia del linguaggio umano in generale. Ha equivalenti in tutta la letteratura gnostica, per esempio nel concetto di Marcione del «Dio straniero» o soltanto dello «Straniero», «l’Altro», «lo Sconosciuto», «l’Innominabile», «il Nascosto»; o il «Padre sconosciuto» di parecchi scritti gnostico-cristiani. Il suo corrispondente filosofico è «l’assoluta trascendenza» del pensiero neoplatonico. Ma anche al di fuori di questi usi teologici in cui è uno dei predicati di Dio o dell’Essere supremo, la parola «straniero» (e i suoi equivalenti) ha il suo proprio significato simbolico come espressione di una elementare esperienza umana, e questo è il fondamento dei differenti significati della parola in parecchi contesti teoretici. Rispetto a questa fondamentale esperienza, la combinazione «vita straniera» è particolarmente istruttiva.
Straniero è ciò che proviene da altro luogo e non appartiene a questo qui. A coloro che sono di qui appare strano, non familiare e incomprensibile; ma il loro mondo dal canto suo è altrettanto incomprensibile allo straniero che viene ad abitarvi e simile ad una terra straniera dove si trova lontano da casa. Soffre perciò il destino dello straniero che è solitario, senza protezione, incompreso e incapace a comprendere, in una situazione piena di pericoli. Angoscia e nostalgia della patria sono parte del destino dello straniero. Egli che non conosce le strade del nuovo paese girovaga sperduto; se impara a conoscerle troppo bene, dimentica di essere uno straniero e si perde in un senso diverso, soccombendo all’attrattiva del mondo straniero e diventando estraneo alla sua propria origine. Diviene così un «figlio della casa», ed anche ciò fa parte del fato del forestiero. Nell’alienazione da se stesso l’angoscia è sparita, ma questo stesso fatto è il culmine della tragedia dello straniero. La reminiscenza della sua origine, il riconoscimento del suo posto di esilio per quello che è, è il primo passo indietro; il risveglio del desiderio della patria è l’inizio del ritorno. Tutto ciò appartiene al lato di «sofferenza» dell’estraneità; tuttavia in relazione alla sua origine è allo stesso tempo un segno di eccellenza, una fonte di potere e di vita segreta, sconosciuta all’ambiente circostante, e in ultima analisi impermeabile per esso, perché è incomprensibile alle creature di questo mondo. In questa superiorità dello straniero, che lo distingue anche quaggiù, sebbene segretamente, sta la sua gloria manifesta nel regno nativo, che è al di fuori di questo mondo. In tale situazione lo straniero è il remoto, l’inaccessibile, e la sua singolarità significa maestà. Perciò lo straniero preso assolutamente è il totalmente trascendente, l’«al di là», e un attributo eminente di Dio.
Entrambi gli aspetti dell’idea dello «straniero», il positivo e il negativo, l’estraneità come superiorità e sofferenza, come prerogativa di distanza e fato di essere coinvolto nel mondo, si alternano come le caratteristiche di un unico e medesimo soggetto: la «Vita». In quanto è la «grande Vita originaria», partecipa soltanto dell’aspetto positivo: è «al di là», «al di sopra del mondo», «nei mondi di luce», «nei frutti di splendore, nelle corti di luce, nella casa di perfezione», e così via. Nella sua suddivisa esistenza in questo mondo essa partecipa in modo tragico all’interpenetrazione di entrambi gli aspetti; e l’attualizzazione di tutte le caratteristiche delineate sopra, in una drammatica successione che è governata dal tema della salvezza, compone la storia metafisica della luce esiliata dalla Luce, della vita esiliata dalla Vita e coinvolta nel mondo: la storia della sua alienazione e del suo ritrovamento, la sua «via» giù e attraverso il basso mondo e su di nuovo. Secondo i vari stadi di questa storia, il termine «straniero» o i suoi equivalenti possono entrare in molteplici combinazioni: «la mia anima straniera», «il mio cuore oppresso dal mondo», «la vigna solitaria», si applicano alla condizione umana, mentre «l’uomo straniero» e «l’estraneo» si applicano al messaggero del mondo della Luce, sebbene questi possa applicare a se stesso anche i termini precedenti, come vedremo meglio quando considereremo «il redentore redento».
Quindi per la sua implicanza il concetto stesso di «straniero» racchiude nel suo significato tutti gli aspetti che la «via» esplica in forma di fasi temporali ben distinte. Nello stesso tempo esso più direttamente esprime l’esperienza fondamentale che per prima condusse a questa concezione della «via» di esistenza: l’esperienza elementare di estraneità e trascendenza. Possiamo perciò considerare la figura della «Vita straniera» come un simbolo primario dello gnosticismo.
b) «Al di là», «fuori», «questo mondo» e «l’altro mondo».
A questo concetto centrale altri termini e immagini sono organicamente collegati. Se la «Vita» è per sua origine straniera, allora la sua patria è «al di fuori» o «al di là» di questo mondo. «Al di là» significa al di là di tutto quello che è del cosmo, cielo e stelle comprese. E «comprese» letteralmente: l’idea di un assoluto «al di fuori» limita il mondo ad un sistema chiuso e limitato, terrificante nella sua ampiezza e inclusività per coloro che sono persi in esso, eppure finito dentro il campo totale dell’essere. E’ un sistema di potenza, un’entità demoniaca carica di tendenze personali e di forze coercitive. La limitazione derivante dall’idea dell’«al di là» priva il «mondo» della sua pretesa di totalità. In quanto il «mondo» significa «il Tutto», la somma totale di realtà, c’è soltanto «il» mondo e ogni ulteriore specificazione sarebbe senza senso: se il cosmo cessa di essere il Tutto, se è limitato da qualche cosa radicalmente «altro», eppure eminentemente reale, allora deve essere designato come «questo» mondo. Tutte le relazioni dell’esistenza terrestre dell’uomo sono «in questo mondo», «di questo mondo», che è in contrasto con «l’altro mondo», l’abitazione della «Vita». Visto dall’al di là, tuttavia, e agli occhi degli abitanti del mondo della Luce e della Vita, è il nostro mondo che appare come «quel mondo». L’aggettivo dimostrativo è diventato perciò un’aggiunta rilevante al termine «mondo»; e la combinazione è di nuovo un simbolo linguistico fondamentale dello gnosticismo, strettamente collegato al concetto primario dello «straniero».
c) Mondi di eoni.
E’ nella linea di tale visione delle realtà che «mondo» viene ad essere usato al plurale. L’espressione «i mondi» denota la lunga catena di questi domini chiusi di potere, divisioni del vasto sistema cosmico, attraverso cui la Vita deve passare nel suo cammino, tutti ugualmente estranei ad essa. Soltanto perdendo il suo stato di totalità, divenendo particolarizzato e nello stesso tempo demonizzato, il concetto «mondo» poté ammettere una pluralità. Si potrebbe anche dire che «mondo» denota un collettivo piuttosto che un’unità, una famiglia demoniaca piuttosto che una sola entità. La pluralità indica anche l’aspetto labirintico del mondo: nei mondi l’anima perde la sua via e vagabonda, e ovunque cerca una fuga non fa che passare da un mondo all’altro, che è pur sempre mondo. Questa moltiplicazione di sistemi demoniaci attraverso i quali è bandita la vita non redenta è un tema di molte dottrine gnostiche. Ai «mondi» dei Mandei corrispondono gli «eoni» dello gnosticismo ellenistico. Di solito ve ne sono sette o dodici (corrispondenti al numero dei pianeti o ai segni dello zodiaco), ma in qualche sistema la pluralità aumenta fino a proporzioni vertiginose e terrificanti, fino ai 365 «cieli» o agli innumerevoli «spazi», «misteri» (qui usati topologicamente) ed «eoni» della “Pistis Sophia”. Attraverso tutti questi, che rappresentano altrettanti gradi di separazione dalla luce, la «Vita» deve passare per sfuggirne.
«Vedi, o figlio, attraverso quanti corpi [elementi?], quanti ordini di demoni, quante concatenazioni e rivoluzioni di stelle, dobbiamo aprirci il cammino per affrettarci verso l’unico e solo Dio» (C.H. IV, 8).
Anche se non espressamente affermato è da intendersi che la funzione di queste forze che si frappongono è ostile e ostruttiva: con la distesa spaziale esse simbolizzano nello stesso tempo il potere antidivino e imprigionante di questo mondo. «La via che dobbiamo percorrere è lunga e senza termine» (G 433) (1); «Quanto vasti sono i confini di questi mondi di tenebre!» (G 155);
«Avendo una volta vagabondato nei labirinti delle malvagità,
la misera [Anima] non trova la via di uscita…
Essa cerca di sfuggire all’amaro caos,
e non sa come potrà liberarsene».
(Salmo naasseno, Hippol. V, 10, 2).
A parte ogni personificazione, la totalità dello spazio in cui la vita si trova ha un carattere spirituale malevolo, e i «demoni» stessi sono sia regni spaziali che persone. Vincerli è lo stesso che attraversarli, e aprirsi un passaggio attraverso i loro confini ne spezza al tempo stesso il potere e compie la liberazione dalla magia della loro sfera. Perciò negli scritti mandei la Vita anche nella sua funzione di redentore dice di se stessa che «ha errato attraverso i mondi», o, come è detto di Gesù nel Salmo naasseno: «Viaggerò attraverso tutti i mondi, dischiuderò tutti i misteri».
Questo è l’aspetto spaziale della concezione. Non meno demonizzata è la dimensione temporale dell’esistenza cosmica della vita, rappresentata anch’essa come un ordine di potenze quasi-personali (per esempio gli «eoni»). Le loro qualità, similmente a quelle dello spazio del mondo, riflettono l’esperienza basilare di estraneità ed esilio. Anche qui osserviamo la pluralità notata là: intere serie delle età si stendono tra l’anima e il suo fine, e il loro semplice numero esprime l’influenza che il cosmo, come principio, esercita sui suoi prigionieri. Anche qui la liberazione è raggiunta soltanto passando attraverso tutte queste. Perciò la via di salvezza conduce attraverso l’ordine temporale delle «generazioni»: attraverso catene di innumerevoli generazioni la Vita trascendente entra nel mondo, soggiorna in esso, ne sopporta la durata apparentemente senza fine, e soltanto attraverso questa lunga e faticosa via, perdendo e riacquistando la memoria, può compiere il suo destino. Ciò spiega la formula espressiva «mondi e generazioni» che ricorre costantemente negli scritti mandei: «Ho girovagato attraverso mondi e generazioni», dice il redentore. Per l’anima non ancora redenta (che può anche essere quella del redentore stesso) questa prospettiva temporale è fonte di angoscia. Il terrore della vastità degli spazi cosmici è uguagliato dal terrore dei tempi che devono essere sopportati: «Quanto a lungo ho già sopportato e ho dimorato nel mondo!» (G 458).
Questo duplice aspetto del terrore cosmico, lo spaziale e il temporale, è espresso bene nel significato complesso del concetto ellenistico di «eone», adattato a loro uso dagli Gnostici. Originariamente un concetto puramente temporale (durata della vita, lunghezza del tempo cosmico, quindi eternità) subì una personificazione nella religione ellenistica pregnostica – probabilmente un adattamento del dio persiano Zervan – e divenne oggetto di adorazione, anche allora associato ad un certo timore. Nello gnosticismo ha assunto un senso mitologico più accentuato ed è diventato un nome di classe per tutte le categorie di esseri, sia divini che semidivini, che demoniaci. In quest’ultimo senso «gli eoni» rappresentano il potere demoniaco dell’universo con implicazioni sia temporali che spaziali, oppure (come nella “Pistis Sophia”) il potere demoniaco del regno delle tenebre nella sua immensità. La loro estrema personificazione può talvolta far dimenticare l’originale aspetto temporale, ma la frequente uguaglianza di «eoni» e «mondi» mantiene vivo quell’aspetto come parte di un significato divenuto piuttosto mutevole per la quantità di immagini mitiche (2).
Il sentimento ispirato dall’aspetto tempo dell’esilio cosmico trova commovente espressione in parole come le seguenti:
«In quel mondo [di tenebre] ho dimorato migliaia di miriadi di anni e nessuno sapeva che io ero quaggiù… Per anni ed anni, per generazioni e generazioni io ero là ed essi non sapevano che io dimoravo nel loro mondo» (G 153 s.) (3).
oppure (da un testo manicheo turco):
«Ora, o nostro Padre benigno, sono passati innumerevoli miriadi di anni da quando siamo separati da te. Siamo desiderosi di vedere il tuo aspetto amato, risplendente e vivente…» (Abb. d. Pr. Akad. 1912, p. 10).
L’incommensurabile durata cosmica significa separazione da Dio, come pure la scala immensa di spazi cosmici e la qualità demoniaca di entrambe consiste nel mantenere tale separazione.
d) L’abitazione cosmica e il soggiorno dello straniero.
Per il mondo come un tutto, vasto come sembra ai suoi abitanti, abbiamo perciò l’immagine visiva di una cella circoscritta – ciò che Marcione chiamava sdegnosamente “haec cellula creatoris” – nella quale o fuori della quale la Vita può muoversi. «Venire dal di fuori» o «andare fuori» sono frasi tipiche nella letteratura gnostica. Perciò la Vita o la Luce «è venuta in questo mondo», «ha viaggiato quaggiù»; essa «parte per il mondo», può fermarsi «al margine esterno dei mondi» e di lì, «dal di fuori», «far visite nel» mondo. Ci soffermeremo più avanti sul significato religioso di queste espressioni: per il momento ci occuperemo della topologia simbolica e della diretta eloquenza delle immagini.
Il soggiorno «nel mondo» è chiamato «dimora», il mondo stesso una «dimora» o «casa», e, in contrasto con le dimore risplendenti, l’«oscura» o la «bassa» dimora, «la casa mortale». L’idea di «dimora» ha due aspetti: da una parte implica uno stato temporaneo, qualche cosa di contingente e perciò revocabile – una dimora può essere scambiata con un’altra, può essere abbandonata ed anche lasciata andare in rovina -; dall’altra implica la dipendenza della vita dagli ambienti circostanti – il luogo dove si dimora non è indifferente per l’abitatore e ne determina tutta la condizione. Egli può perciò soltanto cambiare una dimora con un’altra, e l’esistenza extramondana è anche chiamata «dimora», questa volta nelle sedi della Luce e della Vita, che per quanto infinite hanno il loro proprio ordine di regioni limitate. Quando la Vita si stabilisce nel mondo, la temporanea appartenenza così fissata può condurre al suo divenire «un figlio della casa» e rende necessario il ricordare: «Tu non eri di qui, e la tua radice non era di questo mondo» (G 379). Se l’accento è posto sulla natura temporanea e transeunte del soggiorno terreno e sulla condizione di essere straniero, il mondo è anche chiamato «l’albergo» nel quale «si alloggia»; e «stare in albergo» è una formula per «essere nel mondo» o «nel corpo». Le creature di questo mondo sono «abitanti dell’albergo», sebbene la loro relazione con esso non sia quella di ospiti: «Poiché ero uno e mi tenevo in disparte, ero straniero ai miei compagni d’albergo» («Inno della Perla» in “Acta Thomae”).
La stessa espressione può riferirsi al corpo, che è eminentemente la «casa» di vita e lo strumento del potere del mondo sulla Vita, che è racchiusa in esso. Più particolarmente «tenda» e «vestito» denotano il corpo come forma terrena transeunte includente l’anima; anche questi termini tuttavia possono essere applicati al mondo. Un vestito è indossato, smesso e cambiato, il vestito terreno per quello di luce.
Separata dalla sua origine, la Vita langue nella veste corporale:
«Io sono un Mana (4) della grande Vita. Chi mi ha fatto vivere nel Tibil (5), chi mi ha gettato nel ceppo del corpo?» (G 454).
«Sono un Mana della grande Vita. Chi mi ha gettato nella sofferenza dei mondi, chi mi ha trasportato nella malvagia oscurità? Così a lungo ho sopportato e ho dimorato nel mondo, così a lungo ho dimorato tra le opere delle mie mani» (G 457 s.).
«Afflizione e dolore io soffro nel vestito corporale nel quale essi mi hanno trasportato e gettato. Quante volte devo smetterlo, quante volte devo indossarlo, sempre di nuovo devo definire la mia lotta (6) e non guardare la Vita nella sua “sh’kina” (7)» (G 461).
Da tutto ciò sorge la domanda rivolta alla grande Vita: «Perché hai creato questo mondo, perché hai costretto le tribù [di Vita] a chiudersi in esso, fuori dal tuo centro?» (G 437). La risposta a tali quesiti varia da sistema a sistema: le questioni stesse sono più fondamentali di ogni particolare dottrina e riflettono immediatamente la sottostante condizione umana.
e) «Luce», «tenebre», «vita» e «morte».
Dobbiamo aggiungere qualche parola circa l’antitesi di luce e tenebre che è una caratteristica così costante in questo contesto. Ritroviamo il suo simbolismo un po’ dappertutto nella letteratura gnostica, ma, per ragioni che discuteremo in seguito, il suo uso più enfatico e dottrinalmente più importante va ricercato in quella che chiameremo la corrente “iranica” dello gnosticismo, la quale è anche una componente del pensiero mandeo. La maggior parte degli esempi seguenti sono presi da esso e implicano perciò la versione iranica del dualismo gnostico. Il simbolismo, pur astraendo dal contesto teoretico, riflette tuttavia un universale atteggiamento gnostico. L’originaria Vita forestiera è il «Re di Luce», il cui mondo è «un mondo di splendore e di luce senza tenebre», «un mondo di indulgenza senza ribellione, un mondo di giustizia senza turbolenza, un mondo di vita eterna senza decadenza e morte, un mondo di bontà senza peccato… Un mondo puro non mescolato al male» (G 10). In opposizione ad esso è il «mondo delle tenebre, interamente pieno di male… pieno di fuoco divorante… pieno di falsità e inganno… Un mondo di turbolenza senza fermezza, un mondo di tenebre senza luce… un mondo di morte senza vita eterna, un mondo nel quale le cose buone e i progetti finiscono in niente» (G 14).
Mani, che adottò più completamente la versione iranica del dualismo, inizia la sua dottrina delle origini come è riportata nel “Fihrist”, una fonte araba, nel modo seguente: «Due esseri erano al principio del mondo, uno Luce, l’altro Tenebre». Secondo tale concezione il mondo esistente, «questo» mondo, è una mescolanza di luce e tenebre, con una preponderanza tuttavia di tenebre: la sua sostanza principale è tenebre, l’immissione estranea, luce. Nello stato attuale delle cose, la dualità di tenebre e luce coincide con quella di «questo mondo» e «l’altro mondo», poiché le tenebre hanno incorporato tutta la loro essenza e potere in questo mondo che è ora perciò “il” mondo delle tenebre (8). L’equazione «mondo (cosmos) = tenebre» è di fatto indipendente e più fondamentale di quella particolare teoria delle origini della quale abbiamo or ora dato un esempio, e come espressione di una data condizione ammette tipi grandemente divergenti di derivazione, come vedremo in seguito. L’equazione come tale è simbolicamente valida per lo gnosticismo in generale. Nel “Corpus Hermeticum” troviamo l’esortazione: «Allontanati dalla luce tenebrosa» (C.H. I, 28), dove la combinazione paradossale manifesta chiaramente che persino la cosiddetta luce in questo mondo, in realtà è tenebre. «Perché il cosmo è la pienezza del male, Dio la pienezza del bene» (C.H. VI, 4); e come «tenebre» e «male», così anche «morte» è un simbolo del mondo come tale. «Colui che è nato da madre è portato nella morte e nel cosmo; colui che è rinato da Cristo e trasportato nella vita e negli Otto [ossia, sottratto al potere dei Sette]» (Exc. Theod. 80,1). Così comprendiamo l’affermazione ermetica citata in Macrobio (In somn. Scip. I, 11) che l’anima «per altrettante morti quante sfere essa attraversa, discende a ciò che nel mondo è chiamata vita».
f) «Mescolanza», «dispersione», «l’uno» e i «molti».
Per tornare ancora una volta alla concezione iranica, l’ideale di due entità primarie ed opposte conduce alla metafora di «mescolanza» per l’origine e la composizione di questo mondo. La mescolanza tuttavia è ineguale e il termine denota essenzialmente la tragedia delle particelle di Luce separate dal loro corpo originario e immerse in un elemento estraneo.
«Io sono io, il figlio dei pacifici [ossia degli esseri di Luce]. Sono stato mescolato e vedo pianto. Conducimi fuori dall’abbraccio di morte» (Frammento di Turfan, M 7).
«Essi portarono acque vive (9) e le versarono nelle acque torbide (9); essi portarono luce splendente e la gettarono nelle spesse tenebre. Essi portarono il vento rinfrescante e lo gettarono nel vento ardente. Essi portarono il fuoco vivente e lo gettarono nel fuoco divoratore. Essi portarono l’anima, il puro Mana, e la gettarono nel corpo senza valore» J 56).
Il mescolamento è espresso qui nei termini dei cinque elementi fondamentali dello schema manicheo, che ovviamente sta alla base di questo testo mandeo.
«Tu hai preso il tesoro di Vita e lo hai gettato nella terra senza valore. Tu hai preso il mondo di Vita e lo hai gettato nel mondo della mortalità» (G 362).
«Non appena è entrata nell’acqua torbida, l’acqua vivente si è lamentata e ha pianto… Non appena egli ha mescolato l’acqua viva con quella torbida, le tenebre sono penetrate nella luce» (J 216).
Persino il messaggero è soggetto al destino della mescolanza:
«Allora il fuoco vivente subì un cambiamento in lui… Il suo splendore fu diminuito e offuscato… Guarda come lo splendore dell’Uomo forestiero è diminuito!» (G 98 s.).
Nel manicheismo la dottrina di mescolamento, con la sua parte opposta di non mescolamento, forma la base di tutto il sistema cosmologico e soteriologico, come mostreremo in un capitolo seguente.
Strettamente connessa all’idea di «mescolanza» è quella di «dispersione». Se particelle della Luce o della Vita originaria sono state separate da essa e mescolate con le tenebre, allora si è perduta un’unità originaria per dar luogo alla pluralità: le schegge sono le scintille disperse nella creazione. «Chi ha preso il canto di lode, l’ha diviso in due parti e l’ha gettato di qua e di là?» (J 13). La stessa creazione di Eva e lo schema di riproduzione iniziato da essa asseconda l’indefinita ulteriore dispersione delle particelle di luce, che il potere delle tenebre è riuscito ad assorbire e con tal mezzo cerca di trattenere più sicuramente. Di conseguenza la salvezza implica un processo di raccolta, di ri-collezione di ciò che era andato disperso, e la salvezza mira al ristabilimento dell’unità primitiva.
«Io sono tu e tu sei io, e dove tu sei io sono, e in tutte le cose sono disperso. E da ovunque tu vuoi, tu mi raccogli; ma raccogliendomi, tu raccogli te stesso» (10).
Questa raccolta di sé viene considerata come procedente “pari passu” con il progresso della «conoscenza», e il suo adempimento come una condizione per la definitiva liberazione dal mondo:
«Colui che raggiunge tale gnosi e raccoglie se stesso dal cosmo… non è più trattenuto quaggiù, ma sale al di sopra degli Arconti» (11);
e proclamando questo stesso fatto l’anima che ascende risponde alla sfida dei guardiani celesti:
«Sono giunto a conoscere me stesso ed ho raccolto me stesso da ogni parte…» (12).
E’ facile vedere da queste citazioni che il concetto di unità e unificazione, come quello di pluralità, diversità e dispersione, ha un aspetto interiore e un aspetto metafisico, cioè si applica al sé individuale come pure all’essere universale. E’ segno di una più alta, o più filosofica, forma di gnosi il fatto che questi due aspetti, complementari fin dall’inizio, siano arrivati a coincidere sempre più completamente; e che la crescente comprensione dell’aspetto interiore purifichi quello metafisico dalle significazioni mitologiche più imperfette che aveva al principio. Per i Valentiniani, il cui simbolismo spiritualizzato segna un passo importante sulla via della demitizzazione, «unificazione» è la definizione stessa di ciò che «la conoscenza del Padre» compirà per «ciascuno»:
«E’ per mezzo dell’Unità che ognuno riceverà se stesso di nuovo. Tramite la conoscenza purificherà se stesso dalla diversità con la visione dell’Unità, assorbendo (divorando) la Materia in se stesso come una fiamma, le Tenebre per mezzo della Luce e la Morte per mezzo della Vita» (E. V. 25, 10-19).
Va osservato che nel sistema valentiniano la medesima realizzazione è attribuita alla “gnosis” sul piano dell’essere universale, dove la «restaurazione dell’Unità» e «l’assorbimento della Materia» significano niente di meno che l’attuale dissoluzione di tutto il basso mondo, ossia della natura sensibile come tale, non per mezzo di un atto di forza esterna ma solamente per mezzo di un avvenimento interno alla mente: la «conoscenza» su scala trascendentale. Vedremo in seguito (cap. 7) mediante quale principio speculativo i Valentiniani stabilirono questa efficacia oggettiva e ontologica di ciò che a prima vista sembra essere un atto puramente privato e soggettivo; e in qual modo la loro dottrina giustificasse la coincidenza dell’unificazione individuale con la riunione dell’universo in Dio.
Sia l’aspetto universale (metafisico) che quello individuale (mistico) dell’idea di unità e i loro opposti divennero temi accolti dalla successiva speculazione man mano che s’allontanavano di più dalla mitologia. Origene, la cui vicinanza al pensiero gnostico è evidente nel suo sistema (giustamente condannato dalla Chiesa), considerava il movimento totale della realtà secondo le categorie di perdita e riacquisto dell’Unità metafisica (13). Ma fu Plotino che nella sua speculazione trasse le conclusioni mistiche più complete dalla metafisica di «Unità contro Pluralità». Dispersione e raccolta, categorie ontologiche della realtà totale, sono ad un tempo schemi d’azione dell’esperienza potenziale di ciascun’anima, e unificazione che internamente è unione con l’Uno. Emerge così lo schema neoplatonico dell’ascesa interiore dai Molti all’Uno che nei primi gradini della scala è etica, quindi teoretica, e nello stadio culminante è mistica.
«Sforzati di ascendere in te stesso, raccogliendo dal corpo tutte le tue membra, che sono state disperse e sparpagliate nella molteplicità dall’unità che una volta sovrabbondava nella grandezza del suo potere. Metti d’accordo e unifica le idee innate e cerca di articolare quelle che sono confuse e di portare nella luce quelle che sono oscure» (Porphyr. “Ad Marcell.” X).
Fu probabilmente attraverso gli scritti di Porfirio che questa concezione neoplatonica dell’unificazione come principio di vita personale giunse fino ad Agostino, che nella sua maniera estremamente soggettiva spostò alla fine l’accento dall’aspetto metafisico a quello morale.
«Da quando mediante l’iniquità dell’empietà ci siamo separati e abbiamo dissentito e siamo caduti dalla fedeltà all’Unico Vero e Altissimo Dio, e ci siamo dissipati nei molti, separati dai molti e rimanendo fedeli ai molti: fu necessario che… i molti fossero riuniti acclamando per la venuta dell’Uno (Cristo)… e che noi, liberati dall’ingombro dei molti, venissimo all’Uno… e, giustificati nella giustizia di Uno, diventassimo Uno» (Trin. IV 11).
«Mediante la continenza siamo riuniti nell’Uno dal quale ci siamo allontanati per i molti» (Confess. X, 14; confronta Ord. I, 3).
La «dispersione» ha infine ricevuto ciò che ai nostri giorni potremmo chiamare un significato esistenzialista: quello della «distrazione» dell’anima, provocata dai molteplici interessi e attrattive del mondo che agiscono attraverso i sensi del corpo; ossia, è stata trasformata in un concetto psicologico ed etico all’interno dello schema della salvezza individuale.
g) «Caduta», «affondamento», «cattura».
Ci sono una quantità di espressioni per indicare la maniera in cui la vita è giunta alla sua attuale condizione: alcune di esse descrivono il processo come puramente passivo, altre gli attribuiscono un andamento più attivo. «La tribù di anime (14) fu trasportata quaggiù dalla casa di Vita» (G 24); «il tesoro di Vita che fu strappato di là» (G 96), o «che fu portato qui». Ancora più drastica è l’immagine della caduta: l’anima o spirito, parte della Vita originaria o della Luce, cadde nel mondo o nel corpo. E’ questo uno dei simboli fondamentali dello gnosticismo: una caduta precosmica di una parte del principio divino soggiace alla genesi del mondo e dell’esistenza umana nella maggioranza dei sistemi gnostici. «La Luce cadde nelle tenebre» significa una fase precedente del medesimo dramma divino, in cui «la Luce brillò nelle tenebre» può dirsi significhi una fase posteriore.
In che modo tale caduta ebbe origine e attraverso quali stadi procedette è materia di speculazione grandemente divergenti. Tranne nel manicheismo e nei tipi iraniani affini, dove l’intero processo viene iniziato dai poteri delle tenebre, c’è un elemento volontario nel movimento discendente del divino: una colpevole «inclinazione» dell’Anima (come entità mitica) verso i regni più bassi, con motivazioni varie quali la curiosità, la vanità, il desiderio sensuale, che sono l’equivalente gnostico del peccato originale. La caduta è precosmica e una delle sue conseguenze è il mondo stesso, un’altra la condizione e il destino delle anime individuali nel mondo.
«L’Anima si volse una volta verso la materia, se ne innamorò, e ardendo dal desiderio di sperimentare i piaceri del corpo, non volle più liberarsi da essa. Così nacque il mondo. Da quel momento l’Anima dimenticò se stessa. Dimenticò la sua abitazione originaria, il suo vero centro, il suo essere eterno» (15).
Una volta separata dal regno divino e immersa in un mezzo estraneo, il movimento dell’Anima continua nella direzione discendente in cui ebbe inizio e tale movimento è descritto come «affondamento»: «Fino a quando affonderò in tutti i mondi?» (J 196). Spesso tuttavia viene aggiunto un elemento di violenza a questa descrizione della caduta, come nelle metafore relative alla cattività delle quali parleremo più a lungo studiando il sistema manicheo. Qui ci limiteremo ad alcuni esempi mandei. «Chi mi ha trascinato in cattività lontano dal mio posto e dalla mia abitazione, dalla casa dei miei genitori che mi hanno allevato?» (G 323). «Perché mi hai portato via dalla mia abitazione nella cattività e gettato nel vile corpo?» (G 388) (16).
Il termine «gettare» che ricorre nell’ultima citazione, richiede un commento. Il suo uso, come abbiamo visto precedentemente, non è limitato alla metafora di cattività: è un’immagine a sé e di vastissima applicazione: la vita è stata gettata nel mondo e nel corpo. Abbiamo incontrato l’espressione collegata al simbolismo di «mescolanza», dove è usata per l’origine del cosmo come pure per quella dell’uomo: «Ptahil (17) gettò la forma che la Seconda [Vita] aveva formato nel mondo delle tenebre. Egli fece delle creazioni e formò delle tribù al di fuori della Vita» (G 242). Questo passo si riferisce all’attività cosmogonica del demiurgo: nell’antropogonia l’immagine è ripetuta ed è lì che ha il suo significato principale. «Ptahil prese un Mana nascosto che gli era stato dato dalla casa di Vita, lo portò di qua e lo gettò in Adamo ed Eva» (ibid.). Questa è l’espressione che ricorre costantemente per indicare l’animazione dell’uomo da parte del suo creatore non autorizzato. Che questo non fosse un evento contemplato nello schema della Vita, ma una violenza fatta ad essa e all’ordine divino è evidente dal rimorso che il demiurgo prova in seguito. «Chi mi ha reso stolto, tanto da essere un pazzo e gettare l’anima nel corpo?» (G 393) (18). Persino nella formula valentiniana citata prima (par. f, «Escatologia»), sebbene essa appartenga ad un ramo dello gnosticismo più incline a categorie di motivi interni piuttosto che di forza esterna nell’esposizione della preistoria dell’Anima, incontriamo l’espressione «dove siamo stati gettati». Certamente è intenzionale la nota stridente che questo termine concreto introduce nella serie di verbi astratti e neutri che lo precedono nella formula (forme di «essere» e «divenire»). L’urto dell’immagine ha esso stesso un valore simbolico nella considerazione gnostica dell’esistenza umana. Sarebbe di grande interesse paragonarne l’uso nello gnosticismo con l’uso fattone in una recente analisi filosofica dell’esistenza, quella di Martin Heidegger (19). Tutto quello che possiamo dire qui è che in entrambi i casi «essere stati gettati» non è semplicemente una descrizione del passato, ma un attributo che qualifica la situazione esistenziale attuale quale è stata determinata da quel passato. Dall’esperienza gnostica della presente situazione di vita questa drammatica immagine della sua genesi è stata proiettata nel passato, ed è parte dell’espressione mitologica di tale esperienza. «Chi mi ha gettato nell’afflizione dei mondi, chi mi ha trasportato nelle tenebre perverse?» (G 457), domanda la Vita; e implora: «Salvaci dalle tenebre di questo mondo nel quale siamo gettati» (G 254). Alla domanda la Grande Vita replica: «Non è secondo la volontà della Grande Vita che tu sei andato là» (G 329); «Quella casa nella quale dimori non l’ha costruita la Vita» (G 379); «Questo mondo non è stato creato per la volontà della Vita» (G 247). Apprenderemo in seguito quale sia il significato di queste risposte negative in termini di una mitologia positiva. Il mito gnostico ha appunto cercato di tradurre la realtà bruta, sperimentata nella visione gnostica dell’esistenza e direttamente espressa in queste domande con le relative risposte negative, secondo uno schema esplicativo che, pur derivando lo stato attuale dalle sue origini, ne offrisse la promessa del superamento.
La Vita così «gettata» nel mondo esprime la sua condizione e il suo modo di essere quaggiù in un gruppo di metafore che ora considereremo. Per la maggior parte queste si riferiscono, nelle fonti gnostiche, non all’«uomo» nel senso ordinario, ma ad un essere simbolico-mitologico, ad un personaggio divino, abitante nel mondo, investito di una funzione particolare e tragica, quale vittima e salvatore insieme. Poiché tuttavia questa figura, secondo il significato del sistema, è il prototipo dell’uomo, il cui destino egli soffre nella sua persona in tutta la sua pienezza (spesso il suo nome è Uomo, benché la figura possa anche essere femminile), ci sembra di essere giustificati nel considerare le affermazioni della sua sofferenza fatte in prima persona, come proiezioni dell’esperienza di coloro che lo fanno parlare in tal modo, anche se tali asserzioni si riferiscono ad eventi precosmici. Di conseguenza nel commento seguente non faremo distinzione e ci atterremo all’esistenza dell’uomo nel mondo, qualunque sia la fase o il personaggio del dramma mitico a cui si riferisce l’affermazione.
h) Abbandono, paura, nostalgia.
Tutte le implicazioni emotive che la nostra analisi iniziale aveva rivelato nel concetto di «straniero» come tale trovano formulazione esplicita nel mito e nella poesia gnostica. Le narrazioni e gli inni mandei, le fantasie valentiniane circa le avventure della Sophia errante, le lamentazioni lungamente estese della “Pistis Sophia”, abbondano di espressioni sullo stato pauroso e nostalgico dell’anima abbandonata nel mondo. Ne scegliamo pochi esempi.
«Manda d’Hayye (20) parlò ad Anosh (20): “Non temere e non essere spaventato e non dire: ‘Essi mi hanno lasciato solo in questo mondo di malvagi’. Perché presto verrò da te”… [Anosh, lasciato solo nel mondo, medita sul mondo creato, specialmente sui pianeti e sui loro vari doni e influenze: egli è sopraffatto dal timore e dalla desolazione della solitudine:] “I malvagi cospirano contro di me… Essi dicono gli uni con gli altri: ‘Nel nostro mondo la chiamata della Vita non sarà udita, esso [il mondo] sarà nostro’… Ogni giorno cerco di sfuggire loro, poiché sono solo in questo mondo. Alzo gli occhi a Manda d’Hayye che mi ha detto: ‘Presto vengo da te’… Ogni giorno alzo gli occhi alla via nella quale camminano i miei fratelli, al sentiero per il quale verrà Manda d’Hayye… Manda d’Hayye venne, mi chiamò e mi disse: Piccolo Enosh, perché sei spaventato, perché hai tremato?… Da quando il terrore ti ha sopraffatto in questo mondo, io sono venuto ad illuminarti. Non temere i poteri malvagi di questo mondo”» (G 261 s.s.).
Pregustando la sua liberazione, l’Anima abbandonata dice:
«O quanto mi rallegrerò allora, io che sono ora afflitta e paurosa nell’abitazione dei malvagi! O quanto si rallegrerà il mio cuore fuori delle opere che ho fatto in questo mondo! Per quanto tempo sarò vagabonda e per quanto tempo affonderò in tutti i mondi?» (J 196).
L’abbandono della Vita che dall’aldilà è venuta a soggiornare nel mondo è espresso in maniera toccante:
«Sono una vite, una vite solitaria che sta nel mondo. Non ho un sublime piantatore, non ho un coltivatore, non un mite aiuto che venga ad istruirmi su tutte le cose» (G 346).
Il sentimento di essere stata dimenticata in terra straniera da quelli dell’altro mondo ritorna continuamente:
«I Sette mi hanno oppressa e i Dodici sono diventati la mia persecuzione. La Prima [Vita] mi ha dimenticato e la Seconda non si dà pensiero di me» (J 62).
La forma interrogativa che così abbonda in misura cospicua nella letteratura mandea riflette con particolare vividezza il brancolare e l’incapacità della Vita perduta nel mondo forestiero. Alcuni passi delle seguenti citazioni sono stati riportati precedentemente:
«Rifletto in che modo questo è avvenuto. Chi mi ha trasportato in prigionia lontano dal mio luogo e dalla mia dimora, dalla casa dei miei genitori che mi hanno allevato? Chi mi ha portato tra i malvagi, i figli della vana dimora? Chi mi ha portato tra i ribelli che ogni giorno fanno guerra?» (G 328).
«Sono un Mana della grande Vita. Sono un Mana della potente Vita. Chi mi ha costretto a vivere nel Tibil, chi mi ha gettato in questo ceppo del corpo?… I miei occhi, che erano aperti dalla dimora di luce, appartengono ora al ceppo. Il mio cuore, che aspira alla Vita, venne qui e divenne parte del ceppo. E’ il cammino del ceppo, i Sette non mi lasceranno andare per la mia strada. Come devo obbedire, come sopportare, come posso calmare la mia mente! Come devo temere i sette e i dodici misteri, come devo gemere! Come può la Parola del mio mite Padre dimorare tra le creature delle tenebre!» (G 454 s.).
Come esempi di letteratura mandea questi saranno sufficienti. Facciamo notare il tono di lamento che è caratteristico delle fonti orientali.
Abbiamo citato più su alcuni versetti dal «Salmo dell’Anima» naasseno. Tra tutte le fonti greche è quella che descrive in modo più drammatico lo stato dell’Anima nel labirinto del mondo ostile. Il testo è irrimediabilmente corrotto, e qualsiasi traduzione di esso può essere soltanto un tentativo: il contenuto generale tuttavia è sufficientemente chiaro. L’anima, un terzo principio posto in certo modo tra i primi due, Spirito e Caos, è stata immersa in quest’ultimo. Nella forma indegna della quale è stata rivestita, essa si agita e si affanna. Preda della Morte, di quando in quando ha potere regale e contempla la luce oppure è immersa nella miseria e nel pianto. Compianta (21) essa si rallegra, lamentandosi è condannata, condannata muore, per rinascere incessantemente. Così essa si aggira in un labirinto di mali e non trova via di uscita. E’ per lei che Gesù domanda al Padre di essere inviato con i sigilli che lo mettono in grado di passare attraverso gli eoni e dischiudere i loro misteri (Hippol. V, 10, 2).
Infine aggiungiamo una breve citazione delle lamentazioni della “Pistis Sophia”, cap. 32:
«O Luce delle Luci, nella quale ho avuto fede fin dal principio, ascolta ora il mio pentimento (22). Liberami, o Luce, perché pensieri malvagi sono entrati in me… Sono venuta e mi sono trovata nelle tenebre che sono nel caos di sotto, ed ero impotente ad allontanarmene in fretta e ritornare al mio posto, perché ero afflitta da tutte le Emanazioni dell’Authades [l’Arrogante]… Ed invocavo aiuto, ma la mia voce non uscì fuori dalle tenebre, e guardavo in alto perché la Luce nella quale ho avuto fede venisse in mio aiuto… Ed ero in quel luogo, piangendo e cercando la Luce che avevo visto in alto. E i guardiani delle porte degli Eoni mi cercarono e tutti coloro che stanno nei loro misteri mi deridevano… Ora, o Luce delle Luci, sono afflitta nelle tenebre del caos… Liberami dalla materia di queste tenebre, che io non sia sommersa in essa… La mia forza ha guardato in alto dal centro del caos e dal centro delle tenebre, e attendevo il mio sposo, che venisse e combattesse per me, ma egli non venne».
i) Torpore, sonno, ebbrezza.
Si può dire che le categorie emotive espresse nell’ultima parte riflettano una generale esperienza umana che può sorgere e trovare espressione ovunque, sebbene raramente in forma così enfatica. Un’altra serie di metafore che si riferiscono alla condizione umana nel mondo è più esclusivamente gnostica e ricorre con grande regolarità attraverso tutto l’ordine di formulazioni gnostiche, senza considerazione per i confini linguistici. L’esistenza terrena, come abbiamo visto, è caratterizzata, da una parte, dai sentimenti di abbandono, paura, nostalgia, dall’altra è descritta anche come «torpore», «sonno», «ubriachezza» e «oblio»: cioè ha assunto (ad eccezione dell’ubriachezza) tutte le caratteristiche che un periodo precedente attribuiva allo stato di morte nel mondo sotterraneo. In realtà, troveremo che nel pensiero gnostico il mondo prende il posto del tradizionale mondo sotterraneo ed è esso stesso già il regno della morte, cioè di coloro che devono essere chiamati di nuovo alla vita. Sotto certi aspetti questa serie di metafore contraddice la precedente: l’incoscienza esclude il timore. Il che non è trascurato nella narrativa particolareggiata dei miti: è soltanto il risveglio dallo stato di incoscienza («ignoranza»), effettuato dal di fuori, che rivela all’uomo la sua condizione, precedentemente a lui nascosta, e provoca uno scoppio di paura e disperazione; tuttavia queste in certo modo dovevano essere all’opera già nello stato precedente di ignoranza, al quale la vita mostra una tendenza ad aggrapparsi e a resistere al risveglio.
In che modo sopraggiunse lo stato di incoscienza e in quali termini concreti lo si descrive? Il «gettare» come tale potrebbe spiegare il torpore dell’anima caduta: ma il mezzo estraneo stesso, il mondo come entità demoniaca, vi ha una parte attiva. Nella cosmogonia manichea riferita da Teodoro bar Konai leggiamo:
«Come i Figli delle Tenebre li ebbero divorati, i cinque Dei Luminosi [i figli dell’Uomo Primordiale, e la sostanza di tutte le anime disperse in seguito nel mondo] vennero privati di intelletto e per mezzo del veleno dei Figli delle Tenebre divennero simili ad un uomo che è stato morso da un cane arrabbiato o da un serpente» (23).
L’incoscienza è perciò una vera infezione portata dal veleno delle tenebre. Si tratta qui, come in tutto il gruppo delle metafore del sonno, non di un particolare mitologico, semplice episodio nella narrativa, ma di una caratteristica fondamentale dell’esistenza nel mondo alla quale si collega tutta l’attività redentiva della divinità extramondana. Il mondo da parte sua fa ogni sforzo per creare e mantenere tale stato nelle sue vittime e contrastare l’operazione di risveglio: il suo potere e persino la sua esistenza è in gioco.
«Nella loro astuzia mi versarono una bevanda e mi diedero da gustare della loro carne. Dimenticai che ero figlio di re e servii il loro re. Dimenticai la Perla per la quale i miei genitori mi avevano inviato. Per la pesantezza del loro nutrimento caddi in un sonno profondo» («Inno della Perla» in “Acta Thomae”).
L’immagine di «sonno» è probabilmente quella di uso più costante e più ampio. L’Anima è assopita nella Materia. Adamo, il «capo» della razza e nello stesso tempo simbolo dell’umanità, giace in sonno profondo, di un genere molto diverso da quello dell’Adamo biblico: gli uomini in genere sono «addormentati» nel mondo. La metafora esprime il totale abbandono dell’uomo al mondo. Talune figure del linguaggio sottolineano questo aspetto spirituale e morale. Gli uomini non sono soltanto addormentati, ma «amano» il sonno («Perché amate il sonno e peccate con coloro che peccano?», G 181); essi si abbandonano al sonno come pure all’ubriachezza (C.H. I, 27). Pur comprendendo che il sonno è il più grande pericolo dell’esistenza nel mondo, ciò non basta a tener sveglio, ma suggerisce la preghiera:
«Secondo quello che tu, Grande Vita, mi hai detto, mi giunge ogni giorno una voce per tenermi desto, perché io non inciampi. Se tu mi chiami, i mondi malvagi non mi inganneranno e non cadrò preda degli Eoni» (G 485).
La metafora del sonno può servire ugualmente a far deprezzare le sensazioni di «vita qui» come pure illusioni e sogni, sebbene pieni di incubi, che noi siamo impotenti a controllare; e le similitudini di «sonno» si uniscono a quelle di «traviamento» e «paura»:
«Che cosa, allora, Egli desidera che l’uomo pensi? Questo: ‘Sono come le ombre e i fantasmi della Notte’. Quando appare la luce dell’alba, allora l’uomo comprende che il Terrore che lo ha investito, non era niente… Finché l’Ignoranza ispirava in loro terrore e confusione, e li lasciava incerti, tormentati e divisi, vi erano molte illusioni dalle quali essi erano molestati, e vuote finzioni, come se fossero sprofondati nel sonno e si ritrovassero preda di sogni affannosi. O essi fuggono da qualche parte, oppure sono trascinati inutilmente ad inseguire altri; o si trovano coinvolti in risse, dando o ricevendo colpi; oppure cadono da grandi altezze… [eccetera, eccetera]: fino al momento in cui coloro che stanno attraversando tutte queste cose, si svegliano. Allora quelli che avevano sperimentato tutte queste confusioni, improvvisamente non vedono niente. Perché esse non sono niente, cioè una fantasmagoria» (E. V. 28, 24 – 29, 32).
Siccome il messaggio gnostico si considera un movimento in direzione opposta al disegno del mondo, in quanto chiamata intesa a romperne l’incanto, la metafora del sonno, o i suoi equivalenti, sono una componente costante dei caratteristici appelli gnostici all’uomo, che di conseguenza si presentano come chiamate di «risveglio». Ritroveremo perciò di continuo queste metafore quando tratteremo della «chiamata».
La metafora dell’ubriachezza richiede un particolare commento. L’«ubriachezza» del mondo è un fenomeno caratteristico dell’aspetto spirituale di ciò che gli Gnostici intendevano col termine «mondo». Essa è portata dal «vino dell’ignoranza» (C H. VII, 1), che il mondo offre all’uomo ovunque. La metafora mette in evidenza che l’ignoranza non è uno stato neutro, la semplice assenza di conoscenza, ma è una positiva condizione contrastante con quella di conoscenza, attivamente provocata e mantenuta per impedire quest’ultima. L’ignoranza da ubriachezza è l’ignoranza dell’anima, dimentica di se stessa, della sua origine e della sua condizione nel mondo forestiero: è precisamente la consapevolezza di estraneità che l’intossicazione tende a sopprimere; l’uomo attirato nel vortice e fatto dimentico del suo vero essere può diventare uno dei figli del mondo. Tale è lo scopo confessato dei poteri del mondo nell’offrire il loro vino e nel tenere il loro «banchetto». All’ubriachezza di ignoranza si oppone la «sobrietà» di conoscenza, formula religiosa spinta talvolta fino al paradosso di «sobria ebbrezza» (24). Così nelle “Odi di Salomone” leggiamo:
«Dalla sorgente del Signore venne in abbondanza alle mie labbra un’acqua parlante. Io bevvi e fui ebbro con l’acqua di vita eterna, tuttavia la mia ebbrezza non era quella di ignoranza, ma abbandonai ogni vanità» (Ode XI, 6-8).
«Colui che così possiede conoscenza… [è come] una persona che, essendo stata inebriata, diventa sobria e tornata in se stessa riafferma quello che è essenzialmente suo proprio» (E. V. 22, 13-20).
Negli scritti mandei ci sono scene molto estese nelle quali viene descritto con frequenza il banchetto orgiastico preparato dal mondo per la seduzione dell’uomo, o più generalmente della Vita straniera dell’al di là. L’esempio seguente occupa molte pagine nell’originale ed è stato qui notevolmente abbreviato. Per il lettore che non sia familiare con la mitologia mandea è necessario spiegare che Ruha è la madre demoniaca dei Pianeti e, come spirito malvagio, è il principale avversario dei figli della luce (25).
«Ruha e i Pianeti incominciarono a formare piani e dissero: ‘Inganneremo Adamo e lo prenderemo e lo tratterremo con noi nel Tibil. Mentre egli mangia e beve, noi inganneremo il mondo. Ci daremo agli abbracci nel mondo e fonderemo una comunità nel mondo. Lo inganneremo con corni e flauti, in modo che non possa allontanarsi da noi… Sedurremo la tribù della Vita e la intercetteremo con noi nel mondo… (G 13 s.). Sorgi, facciamo una celebrazione: sorgi, facciamo un banchetto. Pratichiamo i misteri di amore e seduciamo il mondo intero!… Faremo tacere il richiamo della Vita, porteremo contese nella casa, che non si calmeranno per tutta l’eternità. Uccideremo lo Straniero. Renderemo Adamo nostro complice e vedremo chi sarà allora il suo liberatore… Distruggeremo la sua fazione, la fazione che lo Straniero ha fondato, cosicché non abbia più alcuna parte nel mondo. Tuttavia la casa sarà soltanto nostra… Che cosa ha fatto lo Straniero nella casa, da potervi fondare una fazione?’. Essi presero l’acqua viva e vi versarono [acque] torbide. Presero il capo della tribù e consumarono su di lui il mistero di amore e di concupiscenza, per il quale tutti i mondi sono infiammati. Esercitarono su di lui la seduzione, dalla quale tutti i mondi sono sedotti. Esercitarono su di lui il mistero dell’ebbrezza, del quale tutti i mondi sono fatti ebbri… I mondi sono fatti ebbri da esso e voltarono le loro facce al Mar Rosso (26)» (G 120 s.s.).
Non abbiamo che poche osservazioni da aggiungere a questa scena così efficace. La principale arma del mondo nella sua grande seduzione è «amore». Troviamo qui un tema generale del pensiero gnostico: la diffidenza nei riguardi dell’amore sessuale e del piacere sensuale in genere. E’ considerato come la forma principale per prendere l’uomo al laccio per mezzo del mondo: «L’uomo spirituale si riconoscerà come immortale, e l’amore come causa di morte» (C.H. I, 17); «Colui che ha accarezzato il suo corpo, sorto dall’errore di amore, rimane nelle tenebre errando e soffrendo nei suoi sensi i servizi di morte» (ibid. 19). Più che di amore sessuale si tratta qui di “eros” come principio di mortalità (per Platone esso era invece il principio della ricerca dell’immortalità). La concupiscenza per le cose di questo mondo può assumere in genere molte forme e da tutte queste l’anima è distolta dal suo vero fine e trattenuta sotto l’incanto della sua dimora forestiera.
«Non amate il mondo, né le cose che sono nel mondo. Se qualcuno ama il mondo, la carità del Padre non è in lui, perché tutto quello che è nel mondo è concupiscenza della carne, concupiscenza degli occhi e superbia della vita, le quali cose non sono dal Padre, ma dal mondo» (1 Io. 2, 15-16).
Le tre inclinazioni qui ricordate, «la concupiscenza della carne», «la concupiscenza degli occhi» e «la superbia della vita» sono riprese più tardi da Agostino come categorie principali della tentazione esercitata dal mondo (confronta Confess. X, 41 s.s.). Il «mistero di amore» nel testo mandeo è la versione mitologica della stessa idea.
j) Il rumore del mondo.
La scena mandea della cospirazione del mondo suggerisce un’ulteriore osservazione. Il banchetto orgiastico, che ha lo scopo di trascinare l’uomo nel suo turbine ubriacatore, ha un altro aspetto oltre quello di ubriachezza: il suo rumore impedisce di udire il «richiamo della Vita» e rende l’uomo sordo alla voce dell’Uomo forestiero.
«Essi non udiranno le parole dell’Uomo forestiero che è venuto qui… Dal momento che abbiamo creato Adamo, egli verrà e obbedirà a noi e a nostro Padre Ptahil» (G 244).
«Orsù, facciamo in modo che egli oda un grande frastuono, perché possa dimenticare le voci celesti» (J 62).
Tuttavia, come ci si può aspettare in ragione della follia essenziale delle potenze del mondo, lo strepito ha anche un effetto molto diverso e in ultima analisi controproducente:
«Come il loro rumore venne alle orecchie di Adamo, egli si svegliò dal suo sonno e alzò gli occhi al luogo della luce. Egli chiamò i suoi aiutanti, chiamò il benefico fedele Uthras. Parlò a Hibil-Uthra [qui invece di Manda d’Hayye] l’uomo che gli aveva fatto ascoltare la sua voce: ‘Che cosa è avvenuto nella casa perché il suono dello strepito è salito al cielo?’. Come Adamo ebbe così parlato, una lagrima si raccolse nei suoi occhi… Venni vicino a lui, gli presi la mano destra, e feci di nuovo riposare il suo cuore sul suo sostegno» (G 126).
Così l’arma stessa del mondo si volge contro di esso: intesa a rendere sordi e confondere, essa atterrisce Adamo e lo fa guardare verso lo straniero, gli fa porgere orecchio all’altra voce.
k) La «chiamata dal di fuori».
«Un Uthra chiama dal di fuori e istruisce Adamo, l’uomo» (G 387, J 225); «Al cancello dei mondi sta Kushta (Verità) e fa una chiamata al mondo» (J 4); «E’ la chiamata di Manda d’Hayye… Egli sta al margine eterno dei mondi e chiama il suo eletto» (G 397). L’oltremondano penetra la cerchia del mondo e si fa udire qui come un richiamo. E’ la stessa e identica chiamata dell’altro mondo: «Una chiamata viene e istruisce su tutte le chiamate» (G 90); è la «chiamata della Vita» o «della grande Vita», che è equivalente all’irrompere della luce nelle tenebre: «Essi (gli Uthras) faranno sentire il richiamo della Vita e illumineranno la casa mortale» (G 91). Tale richiamo è diretto al mondo: «Ho mandato una chiamata nel mondo» (G 58); nel suo strepito si può percepire qualche cosa di profondamente diverso: «Egli chiamò nel tumulto dei mondi con voce celeste» (J 58).
Il simbolo della chiamata come forma in cui l’oltremondano fa la sua apparizione nel mondo, è così fondamentale per lo gnosticismo orientale che possiamo persino designare le religioni mandea e manichea come le «religioni della chiamata» (27). Il lettore ricorderà la stretta connessione che si trova nel Nuovo Testamento tra udito e fede. Troviamo molti esempi di ciò negli scritti mandei: la fede è la risposta alla chiamata dell’aldilà che non può essere vista ma deve essere udita. Il simbolismo manicheo è giunto al punto di ipostatizzare «Chiamata» e «Risposta» in due diverse figure divine (confronta par. m). Nell’«Inno della Perla» la «lettera» che i celesti inviano ai loro simili esiliati nel mondo si trasforma al suo arrivo in «voce»:
«Come un messaggero era la lettera che il Re aveva sigillato con la mano destra… Egli volò come un’aquila e atterrò vicino a me e divenne tutto discorso. Al suono della sua voce mi svegliai e sorsi dal sonno… e indirizzai i miei passi in modo da poter giungere alla luce della nostra casa. La lettera che mi aveva svegliato, la trovai dinanzi a me sulla via, la lettera che con la sua voce mi aveva svegliato dal sonno…».
Nell’elaborazione valentiniana la chiamata è in modo specifico la chiamata per «nome», ossia il nome mistico spirituale della persona, «scritto» dall’eternità presso Dio «nel libro dei viventi» (28).
«Coloro i cui nomi Egli conobbe in precedenza, furono chiamati alla fine cosicché colui che conosce è colui il cui nome è stato pronunziato dal Padre. Perché colui il cui nome non è stato pronunziato, è ignorante. In verità, come potrebbe una persona udire, se il suo nome non è stato chiamato? Perché colui che rimane ignorante sino alla fine, è una creatura dell”Oblio’ e sarà distrutto con essa. Se non è così, perché questi miserabili non hanno ricevuto nome, perché non odono la chiamata?» (E. V. 21, 25 – 22, 2).
Infine la chiamata può anche essere la chiamata apocalittica che annunzia la fine del mondo:
«Una chiamata risuonò intorno a tutto il mondo, lo splendore sparì da ogni città. Manda d’Hayye si è rivelato a tutti i figli degli uomini e li ha redenti dalle tenebre nella luce» (G 182).
l) L’«Uomo Straniero».
La chiamata è stata proferita da colui che è stato mandato nel mondo a tale scopo e nella cui persona la Vita trascendente ha preso ancora una volta su di sé il destino dello straniero: egli è il Messaggero o l’Inviato – in relazione al mondo, egli è l’Uomo Straniero. Ruha dice ai Pianeti:
«L’uomo non appartiene a noi, e il suo parlare non è il vostro parlare. Egli non ha nessun rapporto con voi… Il suo parlare viene dal di fuori» (G 258).
Il nome «lo Straniero» indica i vari generi di accoglienza che egli trova quaggiù: l’esultante «benvenuto» di coloro che si sentono forestieri ed esiliati quaggiù («Adamo provò amore per l’Uomo Straniero la cui parola è straniera, estraniata dal mondo», G 244); la malevola sorpresa delle potenze cosmiche che non comprendono ciò che succede in mezzo a loro («Che cosa ha fatto lo Straniero nella casa, perché possa trovare adesione là dentro?», G 122); infine la banda ostile dei figli della casa contro l’intruso («Uccideremo lo Straniero… Distruggeremo i suoi aderenti, cosicché non possa avere alcuna parte nel mondo. Tutta la casa sarà soltanto nostra», G 121 s.). L’effetto immediato della sua apparizione quaggiù è potentemente descritto nell'”Evangelium Veritatis”:
«Quando la Parola apparve, la Parola che è nei cuori di coloro che La pronunziano – ed Essa non era soltanto un suono, ma aveva anche assunto un corpo – una grande confusione regnò tra i vasi perché alcuni erano stati svuotati, altri riempiti; alcuni furono riforniti, altri rovesciati; alcuni furono santificati altri ridotti in pezzi. Tutti gli spazi (?) furono scossi e confusi, perché non avevano fissità né stabilità. ‘Errore’ si agitò, non sapendo che cosa fare. Era afflitto e si lamentava e si tormentava perché non sapeva nulla. Dal momento che la Gnosi, che è la rovina di ‘Errore’ e di tutte le sue Emanazioni, gli si avvicinò, Errore divenne vuoto, perché non vi era più niente in lui» (E. V. 26, 4-27).
Così la Vita, per ricuperare ciò che è suo, intraprende ancora una volta nella persona di un suo membro non decaduto la discesa nella prigione del mondo, «per rivestirsi delle afflizioni del mondo» e per assumersi il destino dell’esilio lontano dal regno della luce. Questa può essere chiamata la seconda discesa del divino, distinta da quella precedente, tragica, che ha portato alla condizione che deve appunto essere redenta. Mentre in passato la Vita, ora impigliata nel mondo, vi giunse per via di «caduta», di «affondamento», «gettata», «presa prigioniera», questa volta il suo ingresso è di natura diversa: mandato dalla Grande Vita e investito di autorità, l’Uomo Straniero non è caduto, ma si è portato nel mondo.
«Una chiamata viene per istruire su tutte le chiamate. Una parola viene per istruire su tutte le parole. Un Figlio viene, che era stato formato dalla matrice dello splendore… La sua immagine è conservata intatta al suo posto. Egli viene con l’illuminazione della vita, con il comando che suo Padre impartisce. Egli viene rivestito di fuoco vivo e si porta nel tuo [di Ruha] mondo» (G 90).
«Sono Yokabar-Kushta, uscita dalla casa di mio Padre e venuto qua. Sono venuto qua con splendore nascosto e con luce senza fine» (G 318).
L’uscir fuori e il venire qua devono essere presi letteralmente nel loro significato spaziale: essi conducono realmente, nel senso di una «via» vera, dal di fuori nella cerchia del mondo, e nel passaggio bisogna penetrare attraverso tutte le orbite concentriche, ossia le molteplici sfere e eoni o mondi, per giungere allo spazio più interno dove l’uomo è imprigionato.
«Per la sua salvezza mandami, Padre.
In possesso dei sigilli io scenderò,
attraverso gli Eoni mi aprirò la via,
aprirò tutti i misteri,
renderò manifeste le forme degli dèi,
i segreti della Via sacra,
conosciuti come Conoscenza, io trasmetterò»
(“Salmo dell’Anima”, naasseno).
Questo passaggio attraverso il sistema cosmico ha il carattere di un irrompere ed è perciò già una vittoria sulle potenze cosmiche stesse.
«Nel nome di colui che è venuto, nel nome di colui che viene, nel nome di colui che sta per nascere. Nel nome di quell’Uomo Straniero che si è aperto un passaggio attraverso i mondi, è venuto, ha scisso il firmamento ed ha rivelato se stesso» (G 197).
Abbiamo qui la ragione del perché una semplice chiamata di risveglio dall’esterno non è sufficiente: gli uomini non soltanto devono essere risvegliati e chiamati a ritornare, ma se le loro anime debbono sfuggire al mondo, una vera breccia deve essere aperta nel «muro di ferro» del firmamento, il quale sbarra il passaggio sia verso l’esterno che verso l’interno. Solamente un atto della divinità stessa, penetrante il sistema, può operare tale breccia: «Egli ruppe le loro torri di guardia e fece una breccia nella loro compattezza» (J 69). «Essendo penetrato negli spazi vuoti del terrore, Egli mise Se stesso alla testa di coloro che furono spogliati dall’Oblio» (E.V, p. 20, 34-38). Così già col semplice fatto della sua discesa il Messaggero prepara la via per le anime che ascendono.
Tuttavia, a seconda del grado di spiritualizzazione nei differenti sistemi, l’accento può spostarsi sempre di più da questa funzione mitologica a quella puramente religiosa, racchiusa nella chiamata come tale e nell’insegnamento che essa deve trasmettere, e quindi anche alla risposta individuale alla chiamata come contributo umano alla salvezza. Tale è la funzione di Gesù nell'”Evangelium Veritatis” valentiniano:
«Per mezzo di Lui Egli illuminò coloro che erano nelle tenebre a causa dell”Oblio’. Egli li illuminò e indicò loro un cammino; e quel cammino è la Verità che Egli insegno loro. Fu a causa di ciò che ‘Errore’ si adirò con Lui, Lo perseguitò, Lo oppresse e Lo annientò» (E.V. 18, 16-21).
Troviamo qui, incidentalmente, l’interpretazione che gli Gnostici cristiani possono dare alla Passione di Cristo e della ragione di essa: essa è dovuta all’inimicizia delle potenze della creazione inferiore (il principio cosmico «Errore», generalmente personificato negli Arconti), minacciate nel loro dominio e nella stessa esistenza dalla sua missione; e molto spesso la sofferenza e la morte che esse gli infliggono non sono affatto reali (29).
Ora in ultima analisi colui che viene è identico a colui dal quale egli va: la Vita Salvatrice è identica alla vita che deve essere salvata. Lo Straniero viene dal di fuori a colui che è straniero nel mondo, e gli stessi termini descrittivi possono essere attribuiti alternativamente, in una maniera che colpisce, sia all’uno che all’altro. Nella sofferenza come nel trionfo è spesso impossibile distinguere quale dei due stia parlando o a quale dei due un’affermazione si riferisca. Il prigioniero è qui chiamato anche lui «l’uomo straniero» (confronta J 67 s.s., dove il nome è riferito all’uomo che deve essere salvato), ed egli riacquista, per così dire, tale qualità per mezzo dell’incontro con lo Straniero mandato dal di fuori:
«Io sono un uomo straniero… Guardai la Vita e la Vita guardò me. Le mie provviste per il viaggio vengono dall’Uomo Straniero che la Vita ha voluto e piantato. Verrò in mezzo al bene che l’Uomo Straniero ha amato» (G 273).
C’è un inconfondibile accenno ad una doppia funzione, attiva e passiva, dell’unica e medesima entità. In ultima analisi, lo Straniero che discende redime se stesso, cioè quella parte di sé (l’Anima) persa un tempo nel mondo e per lei egli stesso diviene straniero nella terra delle tenebre ed è infine un «salvatore salvato». «La Vita ha sostenuto la Vita, la Vita ha trovato ciò che era suo» (“Mandäische Liturgien”, p. 111).
Tale ricerca, ritrovamento e raccolta di ciò che era proprio è un processo a lunga scadenza, in quanto è legato alla forma spazio-temporale dell’esistenza cosmica. «Ho girovagato attraverso mondi e generazioni finché sono giunto alla porta di Gerusalemme» (J 243). Ciò conduce all’idea che il salvatore non viene una sola volta nel mondo, ma che dall’inizio del tempo egli si aggira in forme differenti attraverso la storia, egli stesso esiliato nel mondo, che sempre di nuovo rivela se stesso finché, quando la raccolta sarà completata, egli potrà essere liberato dalla sua missione cosmica (la dottrina è presentata in modo più completo nelle “Omelie” pseudo-clementine: confronta citazione dell’Omelia terza, 20, p. 246).
Prescindendo dalle incarnazioni umane mutevoli, la forma costante della sua presenza è precisamente la chiamata dell’altro mondo, che risuona nel mondo e rappresenta ciò che è forestiero in mezzo ad esso; e tra una manifestazione e l’altra egli cammina invisibile attraverso il tempo.
«Dal luogo della luce sono uscito,
da te, abitazione luminosa.
Vengo a esaminare i cuori,
a misurare e provare tutte le menti,
a vedere in quale cuore dimoro,
in quale mente riposo.
Chi pensa a me, io penso a lui;
chi invoca il mio nome, io lo chiamo.
Chi prega la mia preghiera da laggiù,
io prego la sua preghiera dal luogo della luce…
Sono venuto e ho trovato
i cuori sinceri e credenti.
Quando non dimoravo in mezzo ad essi,
pure il mio nome era sulle loro labbra.
Li ho presi e li ho guidati su nel mondo della luce»
(G 389 s.).
m) Il contenuto della chiamata.
Che cosa è venuta a comunicare agli uomini la chiamata? Il suo contenuto è determinato dallo scopo che essa ha di «risvegliare», e talvolta l’intero messaggio può essere semplicemente l’avvertimento del risveglio; quasi sempre ne è l’apertura. «Sono la chiamata del risveglio dal sonno nell’Eone della notte», comincia un estratto dalla scrittura dei Perati in Ippolito (Refut. V, 14,1). Qui la chiamata come tale è il contenuto proprio, poiché afferma semplicemente che quello che il suo essere ha detto, effettuerà: il risveglio dal sonno. Tale risveglio è costantemente designato come l’essenza della sua missione, sia da parte del messaggero che da parte di coloro che lo mandano.
«Sono una parola, un figlio di parole, che è venuto nel nome di Jawar. La grande Vita mi ha chiamato, incaricato e preparato, me, Anosh [Uomo], il grande Uthra figlio dei potenti… Mi ha mandato a sorvegliare questa èra, a scuotere dal loro sonno e far alzare coloro che dormono. Essa mi ha detto: “Va’, raccogliti dei seguaci dal Tibil… Scegli, e trascina l’eletto fuori del mondo… Istruisci le anime, che non muoiano e periscano, e non siano trattenute dalla tenebra densa… Quando tu vieni nella terra Tibil, i malvagi non sapranno niente di te… Non temere e non spaventarti, e non dire ‘Sono qui solo’. Quando il timore ti sopraffà, noi tutti saremo al tuo fianco…”» (G 295 s.).
«Essi profusero sui guardiani una chiamata sublime, per scuotere e far alzare coloro che dormono. Essi dovevano risvegliare le anime che avevano errato fuori del luogo della luce. Essi dovevano svegliarle e scuoterle, perché potessero alzare la faccia al luogo della luce» (G 308).
Pertanto, il primo effetto della chiamata è sempre descritto come «risveglio», come nelle versioni gnostiche della storia di Adamo (confronta par. n). Spesso l’esortazione semplicemente formale: «Svegliati dal sonno» (o «dall’ebbrezza», o meno frequentemente «dalla morte»), con elaborazione metaforica e con frasario differente, costituisce il solo contenuto del richiamo gnostico alla salvezza. Tuttavia questo imperativo formale racchiude implicitamente tutto lo schema speculativo nell’ambito del quale le idee di sonno, ebbrezza, risveglio, assumono il loro significato specifico; e di regola la chiamata rende esplicito tale schema come parte del suo contenuto, cioè collega il comando del risveglio con i seguenti elementi dottrinali: il “ricordo” dell’origine celeste e della storia trascendente dell’uomo; la “promessa” della redenzione, in cui è compresa anche la ragione della missione del redentore e della sua discesa nel mondo; e infine l'”istruzione” pratica sul come vivere d’ora in avanti nel mondo, in conformità della «conoscenza» recentemente acquisita e in preparazione dell’eventuale ascesa.
Ora, questi tre elementi contengono “in nuce” il completo mito gnostico, perciò la chiamata gnostica di risveglio è una specie di sunto della dottrina gnostica in generale. La gnosi trasmessa dal messaggio e compressa in esso in pochi termini simbolici costituisce tutto il mito cosmogonico-soteriologico, la cui narrazione presenta l’evento di tale messaggio come una fase, di fatto la svolta che imprime al movimento totale una direzione opposta. Questa «conoscenza» compendiosa dell’insieme teoretico ha il complemento pratico nella conoscenza della retta «via» verso la liberazione dalla schiavitù del mondo. Nelle numerose versioni letterarie della chiamata, l’uno o l’altro di tali aspetti può predominare o essere espresso in maniera esclusiva: il ricordo dell’origine, la promessa della salvezza, l’istruzione morale.
Citeremo dalla letteratura gnostica alcune di queste chiamate di risveglio, iniziando con esempi manichei. La prima di tali chiamate nel dramma del mondo, narrato dal sistema manicheo con rigida rappresentazione, avviene prima dell’inizio del nostro mondo ed è rivolta all’Uomo Primordiale, che giace incosciente nelle profondità dopo essere stato vinto e assorbito nell’iniziale lotta precosmica di luce e tenebre. La scena seguente è tratta dal racconto siriaco di Teodoro bar Konai.
«Allora lo Spirito Vivente chiamò ad alta voce; e la voce dello Spirito Vivente divenne come una spada acuminata e mise a nudo la forma dell’Uomo Primordiale. E gli disse:
‘Sia pace a te, buono tra i cattivi,
essere luminoso tra le tenebre,
Dio che dimori tra i bruti di collera
i quali non conoscono il suo (30) onore’.
Perciò l’Uomo Primordiale gli rispose e disse:
‘Vieni per la pace di colui che è morto,
vieni, o tesoro di serenità e di pace!’
e disse inoltre a lui:
‘Come stanno i nostri Padri,
i Figli di Luce nella loro città?’.
E la Chiamata gli disse: ‘Stanno bene’. E Chiamata e Risposta si unirono uno all’altro e salirono alla Madre di Vita e allo Spirito Vivente. Lo Spirito Vivente assunse la Chiamata e la Madre di Vita assunse la Risposta, il suo amato figlio» (31).
Qui in apparenza la chiamata ha la forma di un semplice saluto. Come tale, tuttavia, include il “ricordo” dell’origine divina di colui che è salutato, ossia il risveglio della conoscenza di se stesso, persa nel veleno delle tenebre, e nello stesso tempo la “promessa” della sua salvezza: l’apostrofe «essere buono tra i cattivi», eccetera, rappresenta il ricordo; il saluto «sia pace a te» rappresenta la promessa. La commovente richiesta dell’Uomo Primordiale circa i Figli di Luce nella loro città può essere intesa in rapporto al fatto che egli è andato incontro al suo destino per la loro protezione. Svegliato dal suo stupore, egli desidera sapere se il sacrificio ha raggiunto il suo scopo.
Un’altra versione di tale scena è venuta alla luce nel frammento di Turfan M 7:
«’Scuoti di dosso l’ebbrezza nella quale ti sei addormentato,
svegliati e guardami!
Buone nuove a te dal mondo della gioia
dal quale sono mandato per causa tua’.
Ed egli rispose a colui che è senza sofferenza:
‘Sono io, il figlio di coloro che sono benevoli.
Sono confuso e vedo lamentazione.
Guidami fuori dall’abbraccio della morte’.
[Il messaggero dice:]
‘Potenza e prosperità del Vivente
su di te dalla tua casa!
Seguimi, figlio della benevolenza,
metti sul tuo capo la corona di luce’» (32).
In un altro testo di Turfan, la cosiddetta «Messa breve dei morti», troviamo la chiamata indirizzata all’anima in modo generico, distaccata dal contesto mitologico.
«Anima mia, o splendidissima, dove te ne sei andata? Ritorna di nuovo. Svegliati, anima di splendore dal sonno dell’ebbrezza nel quale sei caduta…, seguimi al luogo della terra sublime dove tu da principio dimori…» (33).
Passiamo ora alla letteratura mandea, dove abbondano le versioni della chiamata di risveglio, indirizzata sia ad Adamo (non identico all’Uomo Primordiale), sia all’infinito numero di credenti del mondo. Il simbolismo collegato ad Adamo verrà preso in considerazione più sotto; qui diremo soltanto che il motivo biblico del suo sonno nel Giardino è trasformato in un simbolo della condizione umana nel mondo. Il seguente passo presenta uno stretto parallelismo con le versioni manichee.
«Essi crearono il messaggero e lo mandarono al capo delle generazioni. Egli chiamò con voce celeste nel tumulto dei mondi. Alla chiamata del messaggero, Adamo, che giaceva là, si svegliò… e venne incontro al messaggero: ‘Vieni in pace, tu messaggero, inviato della Vita, che sei venuto dalla casa del Padre. Come sta salda nei suoi luoghi la cara splendida Vita! E come sta qui in lamento la mia forma tenebrosa!’. Allora il messaggero replicò: ‘Tutti ti ricordano con amore e… mi hanno mandato da te. Sono venuto e ti istruirò, Adamo, e ti libererò da questo mondo. Porgi orecchio e ascolta e sii istruito, e sali vittorioso al luogo della luce’» (J 57).
L’istruzione menzionata qui è spesso inclusa nella chiamata come spiegazione del comando «Non dormire», e talvolta si prolunga in lunghe omelie morali che assorbono l’intero contenuto della chiamata e per la loro lunghezza fanno della situazione di base una semplice finzione letteraria.
«Un Uthra chiama dal di fuori e istruisce Adamo, l’uomo. Egli parla ad Adamo: ‘Non riposare e non dormire e non dimenticare quello di cui il Signore ti ha incaricato. Non essere un figlio della casa e non essere chiamato un peccatore nel Tibil. Non amare ghirlande dal piacevole profumo e non prendere piacere in una donna avvenente… Non amare la concupiscenza né le ombre ingannatrici… Nel tuo andare e venire, guarda di non dimenticare il tuo Signore [eccetera eccetera]… Adamo, osserva il mondo, che è cosa del tutto senza sostanza,… nel quale non devi riporre alcuna fiducia. Le bilance sono preparate, e tra migliaia essi scelgono una [sola anima]… Le ghirlande profumate appassiscono, e la bellezza della donna diventa come se non fosse mai stata… Tutte le opere passano, hanno la loro fine e sono come se non fossero mai state’» (34).
Talvolta la chiamata di risveglio è immediatamente connessa con l’ingiunzione di lasciare il mondo: è al tempo stesso il messaggio di morte ed è quindi seguito dall’ascesa dell’anima, come nell’esempio seguente.
«Il salvatore si avvicinò, stette al capezzale di Adamo, e lo svegliò dal suo sonno. ‘Sorgi, sorgi, Adamo, metti via il tuo corpo vile, il tuo vestito di creta, i ceppi, la catena…, perché è giunto il tuo tempo, la tua misura è piena, per partire da questo mondo…’» (G 430).
Talvolta l’intero contenuto della chiamata è concentrato nella sola ammonizione di essere vigilante su se stesso:
«Ho mandato una chiamata nel mondo: ogni uomo sia vigilante su se stesso. Chiunque è vigilante su di sé sarà salvato dal fuoco divoratore» (G 58).
La formula tipica di risveglio è passata anche nel Nuovo Testamento, dove si ritrova in Eph. 5, 14 come citazione anonima:
«Perciò dice: ‘Sorgi tu che dormi, e risorgi dai morti, e Cristo ti illuminerà’».
Per concludere citiamo dal “Poimandres” a versione ellenistica della chiamata di risveglio, che è stata distaccata dal mito ed è usata come mezzo stilistico di esortazione etico-religiosa.
«O popoli, uomini terrestri, che vi siete abbandonati all’ebbrezza e al sonno e all’ignoranza di Dio, diventate sobri, mettete fine alla vostra ubriachezza, all’incanto del sonno irrazionale!… Perché, o uomini terrestri, vi siete dati alla morte, voi che eravate investiti del potere di condividere l’immortalità? Cambiate le vostre vie, voi compagni di viaggio dell’errore e compagni dell’ignoranza; abbandonate la luce tenebrosa [cioè il cosmo], prendete parte all’immortalità e lasciate la corruzione» (C.H. I, 27 s.) (35).
n) La risposta alla chiamata.
Come risponde alla chiamata e al suo contenuto colui che è chiamato? Il primo effetto della chiamata è naturalmente il risveglio dal sonno profondo del mondo. In seguito, tuttavia, la reazione di colui che è risvegliato alla sua condizione come è rivelata nella chiamata e la reazione alle richieste presentategli può essere di vario genere, e ne possono scaturire dialoghi significativi tra colui che è chiamato e colui che chiama. Nella cosmogonia manichea secondo Teodoro bar Konai, per esempio, la prima reazione di Adamo al suo risveglio e all’informazione che egli riceve intorno a se stesso è uno scoppio di acuto terrore per la sua condizione:
«Gesù Luminoso si avvicinò all’innocente Adamo. Lo svegliò dal sonno della morte, perché potesse venir liberato dai molti demoni. E come un uomo che è giusto e trova un uomo posseduto da un demonio potente e lo calma col suo potere, così era Adamo perché quell’Amico lo trovò sprofondato in un sonno profondissimo, lo svegliò, fece che si scuotesse, lo rese vigilante, condusse via da lui il Demonio seducente e allontanò da lui l’Arconte potente [qui al femminile] che mise in ceppi. E Adamo si esaminò e scoprì chi egli era. Gesù gli mostrò nell’alto i Padri e il suo proprio Io (36) gettato in tutte le cose, ai denti di pantere ed elefanti, divorato da coloro che divorano, consumato da coloro che consumano, mangiato dai cani, mescolato e legato in tutto quello che è, imprigionato nel fetore delle tenebre. Egli lo fece alzare e gli fece mangiare dall’albero della vita. Allora Adamo pianse e si lamentò: alzò la voce in modo terribile come un leone ruggente, strappò [il suo vestito], si percosse il petto e disse: ‘Guai, guai a colui che ha formato il mio corpo, a coloro che hanno incatenato la mia anima, e ai ribelli che mi hanno reso schiavo!’».
Un tono di lamento somigliante a questo, sebbene più smorzato, abbiamo potuto riscontrarlo nel paragrafo precedente, come prima risposta alla chiamata (nel frammento di Turfan M 7 e nel passo mandeo J 57).
Umana, ma in maniera più primitiva, è la reazione di Adamo nel testo mandeo G 430 s., di cui abbiamo citato l’inizio a p. precedente. Qui, come abbiamo visto, la chiamata di risveglio coincide col messaggio di morte, e il seguito mostra l’anima legata alla terra, atterrita alla prospettiva di dover partire e aggrappata disperatamente alle cose di questo mondo:
«Quando Adamo udì questo, si lamentò del suo fato e pianse. [Cerca di dimostrare di essere indispensabile nel mondo:] ‘Padre! Se vengo con te, chi sarà il guardiano in questo vasto Tibil?… Chi aggiogherà i buoi all’aratro e chi getterà il seme nella terra?… Chi vestirà l’ignudo… Chi comporrà la contesa nel villaggio?’. [Il messaggero della Vita:] ‘Non aver rimpianti, Adamo, per questo posto nel quale dimori, perché questo posto è desolato… I lavori saranno totalmente abbandonati, e non saranno più ripresi…’ [Allora Adamo implora che sua moglie Eva, i suoi figli e le sue figlie possano accompagnarlo nella via. Il messaggero lo informa che nella casa della Vita non vi è corpo né parentela. Quindi lo istruisce sul cammino:] ‘La via che dobbiamo percorrere è lunga e senza fine… Sovrintendenti vi sono installati, e guardiani e collettori del pedaggio siedono lungo essa… Le bilance sono preparate, e tra migliaia essi scelgono una sola anima che è buona e illuminata’. Con che Adamo partì dal suo corpo [egli si volta indietro ancora una volta e rimpiange il corpo], quindi cominciò il suo viaggio attraverso l’etere. [Anche qui il dialogo continua; di nuovo Adamo rimpiange il corpo, ancora una volta chiede di Eva, sebbene abbia saputo che egli ‘deve partire da solo, deve comporre da solo la sua lotta’. Infine gli viene detto:] ‘Calmati e taci, Adamo, e la pace dei buoni ti avvolge. Tu vai e sali al tuo luogo, e tua moglie Eva salirà dopo di te. Poi tutte le generazioni giungeranno al termine e tutte le creature periranno’».
Così la chiamata al singolo è legata all’escatologia generale del ritorno di tutte le anime.
Ai differenti significati del lamento col quale l’anima risvegliata risponde inizialmente alla chiamata dobbiamo aggiungere il suo rammarico, persino la sua accusa alla Grande Vita stessa, che è chiamata a rendere conto della condizione innaturale appena rivelata all’anima. Leggiamo perciò nella versione della chiamata in G 387 s. (p. 101):
«Appena Adamo udì ciò, si lamentò e pianse su se stesso. Disse all’Uthra della Vita: ‘Se voi sapete che le cose stanno così, perché mi avete portato via dalla mia casa in prigionia e gettato nel vile corpo…?’. Allora egli rispose a lui: ‘Taci, Adamo, tu capo di tutta la tribù. Il mondo che sarà non possiamo sopprimerlo. Sorgi, sorgi, adora la Grande [Vita] e sottomettiti, perché la Vita possa essere il tuo salvatore. La Vita sia il tuo salvatore, e tu ascendi e guarda il luogo della Vita’».
Alla fine l’anima domanda alla Grande Vita di rendere ragione dell’esistenza del mondo come tale e del suo proprio esilio quaggiù: ossia chiede il grande «Perché», il quale non è affatto quietato dal risveglio e dal ricordo della propria origine, ma ne è anzi fortemente eccitato e diviene il principale interesse della gnosi appena iniziata. Codesto interrogativo è anche chiamato «il processo riguardo al mondo», che Adamo presenta direttamente alla Vita Primordiale stessa.
«Tu ascendi, Adamo, e presenti la tua causa alla Grande Vita Primordiale la tua causa concernente il mondo nel quale tu dimori. Di’ alla Grande Vita: ‘Perché ha creato questo mondo, perché hai fatto andare le tribù là, fuori dal tuo centro, perché hai gettato la contesa nel Tibil? Perché domandi ora di me e di tutta la mia tribù?’» (G 437).
La risposta a questo tipo di domanda è l’oggetto principale delle varie speculazioni gnostiche sugli inizi: considereremo alcune di tali forme quando giungeremo a trattare dei differenti sistemi.
Nella maggioranza dei casi, tuttavia, la risposta alla chiamata non è di genere problematico, ma di accettazione gioiosa e riconoscente. «Il Vangelo di Verità è gioia per coloro che hanno ricevuto dal Padre di Verità la grazia di conoscerlo» (parole con cui si apre il Vangelo di Verità).
«Se una persona ha la gnosi, è un essere dall’alto. Se egli è chiamato, ode, replica, e si volge a Colui che lo chiama, per riascendere a Lui. Ed egli sa perché è chiamato. In possesso della gnosi, egli compie la volontà di Colui che lo ha chiamato. Desidera fare ciò che piace a Lui, e riceve riposo. Il nome di ciascuno giunge a lui. Chi in tal modo possiede la gnosi, sa da dove viene e dove va» (E. V. 22, 3-15) (37).
«Gioia all’uomo che ha riscoperto se stesso e si è svegliato!» (E. V. 30, 13 s.).
Si incontra spesso in tale contesto la relazione di «udire» e «credere», così familiare nel Nuovo Testamento:
«Adamo udì e “credette”… Adamo ricevette la “Verità”… Adamo guardò in alto pieno di “speranza” e ascese…» (J 57).
Abbiamo qui la triade fede, conoscenza e speranza come risposta all’ascolto della chiamata. Altrove amore è menzionato nello stesso contesto: «Adamo sentì “amore” per l’Uomo Straniero il cui parlare è forestiero ed estraniato dal mondo» (G 244). «Ognuno ama la Verità, perché la Verità è la Bocca del Padre; la Sua Lingua è lo Spirito Santo…» (E.V., p. 26, 33-36). Il lettore cristiano ha ben presente la triade paolina di fede, speranza e carità (1 Cor. 13, 13), dove san Paolo, non senza ragione e con intenzione (confronta 1 Cor. 1, 22 s.s.; 8, 1), omette la conoscenza ed esalta l’amore come il più grande di tutti.
La poesia mandea esprime in modo splendido l’accettazione in fede e riconoscenza del messaggio, la conseguente conversione del cuore e il rinnovamento della vita. Alcuni esempi possono concludere questa esposizione.
«Dal giorno in cui ti abbiamo contemplato,
i nostri cuori furono colmi di pace.
Noi abbiamo creduto in Te, Unico Buono,
abbiamo contemplato la tua luce e non ti dimenticheremo.
In tutti i nostri giorni non ti dimenticheremo,
nemmeno per un’ora ti lasceremo fuori dai nostri cuori.
Perché i nostri cuori non si accecheranno,
le nostre anime non saranno trattenute lontano»
(G 60).
«Dal luogo della luce è la mia provenienza,
da te, abitazione luminosa…
Un Uthra mi ha accompagnato dalla casa della Vita.
L’Uthra che mi ha accompagnato dalla casa della Grande Vita
aveva in mano una verga fluente acqua viva.
La verga che aveva in mano era fronzuta e
le foglie erano di un genere eccellente.
Egli mi offrì delle sue foglie,
e da ciò scaturirono preghiere e rituali perfetti.
Un’altra volta mi offrì di esse
e il mio cuore ammalato trovò guarigione
e la mia anima forestiera trovò conforto.
Una terza volta mi offrì di esse,
e volse gli occhi su al mio capo
cosicché io contemplai mio Padre e lo conobbi.
Contemplai mio Padre e lo conobbi
e gli rivolsi tre richieste.
Gli chiesi bontà senza ribellione,
gli chiesi un cuore forte
per sopportare grandi e piccole cose.
Gli chiesi cammini agevoli
per ascendere e contemplare il luogo della luce».
(G 377 s.)
«Dal giorno in cui cominciai ad amare la Vita,
dal giorno in cui il mio cuore cominciò ad amare la Verità,
non ho più fiducia in alcuna cosa nel mondo.
Nel padre e nella madre
non ho più fiducia in questo mondo.
Nei fratelli e nelle sorelle
non ho fiducia in questo mondo.
In ciò che è fatto e creato
non ho fiducia in questo mondo.
Nell’intero mondo e nelle sue opere
non ho fiducia in questo mondo.
Vado alla ricerca soltanto della mia anima,
che per me vale generazioni e mondi.
Sono andato e ho trovato la mia anima:
che cosa contano per me tutti i mondi?
Sono andato e ho trovato la Verità
perché essa sta al margine esterno dei mondi…»
(G 390 s.).
o) Allegoria gnostica.
La nostra descrizione dell’immaginativa gnostica e del linguaggio simbolico sarebbe incompleta se omettessimo alcune osservazioni sull’uso peculiare dell’allegoria negli scritti gnostici. L’allegoria, che probabilmente è stata inventata dai filosofi, era largamente usata nella letteratura greca come un mezzo per rendere conformi ad un pensiero «illuminato» racconti e figure del materiale mitico. Considerando le entità concrete e gli episodi del mito classico come espressioni simboliche di idee astratte, tali antichi elementi della tradizione e della fede popolare furono così concettualizzati che un generico concorso di verità sembrò unire l’intuizione intellettuale più avanzata con la sapienza del passato. Così Zeus fu equiparato alla «ragione» cosmica degli Stoici, e altri dèi dell’Olimpo a manifestazioni particolari del principio universale. Per quanto tale metodo fosse arbitrario, aveva il vantaggio di mettere in luce il reale significato dell’antico patrimonio e nella traduzione concettuale di presentarlo spogliato dalla veste simbolica. Nello stesso tempo forniva alle idee contemporanee il prestigio di una veneranda antichità. La tendenza fu perciò quella di mettere tutto in armonia e, nonostante l’arditezza dell’interpretazione, essa rimase nei casi individuali conservatrice ed essenzialmente rispettosa della tradizione: un’eredità omogenea di conoscenza circa le realtà più alte veniva a comprendere il vecchio e il nuovo e a dare gli stessi insegnamenti sotto forme diverse. Di conseguenza il mito, per quanto liberamente elaborato, non veniva contraddetto, né i suoi giudizi erano messi in discussione. Nel primo secolo d.C., ossia al tempo in cui il movimento gnostico si diffondeva, Filone di Alessandria mise l’allegoria, che fino ad allora era soprattutto strumento di adattamento del mito alla filosofia, al servizio della religione nello sforzo di mettere d’accordo la sua fede giudaica con la filosofia platonizzante. Il sistema di allegoria scritturistica sviluppatosi nella sua scuola rimane in eredità ai primi Padri della Chiesa come un modello. Anche in questo caso lo scopo fu quello di integrazione e di sintesi.
L’allegoria gnostica, sebbene spesso di questo tipo convenzionale, negli esempi più espressivi è di natura del tutto diversa. Invece di adottare il sistema di valori del mito tradizionale, cerca di sperimentare una «conoscenza» più profonda rovesciando le parti trovate nell’originale di buono e cattivo, sublime e vile, benedetto e maledetto. Non tenta di dimostrare consenso, ma, sovvertendo in modo clamoroso, tenta di scuotere il significato degli elementi della tradizione più saldamente stabiliti e di preferenza maggiormente venerati. Non può passare inosservato il tono ribelle di questo tipo di allegoria, ed essa perciò esprime la posizione rivoluzionaria che lo gnosticismo occupa nella tarda cultura classica.
Dei tre esempi che prenderemo in esame, due riguardano argomenti presi dall’Antico Testamento, il quale fornisce il materiale preferito per i travisamenti gnostici di significato, e il terzo si serve di un motivo tratto dalla mitologia greca.
– Eva e il serpente.
Abbiamo già incontrato sopra (par. i, n) l’interpretazione gnostica del sonno di Adamo nell’Eden, la quale implica una concezione molto poco ortodossa dell’autore circa questo sonno e il giardino nel quale ha luogo la scena. L'”Apocrifo di Giovanni”, pubblicato di recente, dà forma esplicita a questa revisione comprensiva del racconto della Genesi, in cui si afferma che esso è una rivelazione del Signore al discepolo Giovanni. A proposito del giardino:
«Il primo Arconte (Ialdabaoth) portò Adamo (creato dagli Arconti) nel paradiso che gli disse essere una ‘delizia’ (38) per lui; cioè, aveva intenzione di ingannarlo. Perché la loro (degli Arconti) delizia è amara e la loro bellezza è illecita. Lo loro delizia è inganno e il loro albero era inimicizia. Il loro frutto è veleno contro il quale non vi è rimedio, e la loro promessa è morte per lui. Tuttavia il loro albero fu piantato come ‘albero della vita’, ti svelerò il mistero della loro ‘vita’: è il loro Spirito contraffatto (39) che ha origine da essi per tenere Adamo lontano (40), cosicché egli non conosca la sua perfezione» (55, 18-56, 17, Till).
A proposito del sonno:
«Non come disse Mosè ‘Lo fece dormire’, ma egli coprì la sua percezione con un velo e lo rese pesante per l’incapacità di percezione, perché egli disse a se stesso per bocca del profeta (Is. 6,10): ‘Renderò sorde le orecchie dei loro cuori, affinché non possano comprendere e non possano vedere’» (58,16 – 59, 5).
Nella stessa vena di opposizione è la concezione gnostica del serpente e la sua funzione nell’indurre Eva a mangiare il frutto. Per più di una ragione, tra le quali una non di poco conto è la menzione della «conoscenza», il racconto biblico esercitò grande attrazione sugli Gnostici. Essendo il serpente a persuadere Adamo ed Eva a mangiare del frutto della conoscenza e quindi a disubbidire al loro Creatore, esso venne a rappresentare in tutto un gruppo di sistemi il principio «pneumatico» che contrasta dall’aldilà i disegni del Demiurgo, e così tanto più in grado di diventare un simbolo dei poteri di redenzione, quanto il Dio biblico era stato degradato a simbolo di oppressione cosmica.
In realtà, più di una setta gnostica ha derivato il nome dal culto del “serpente” («Ofiti» dal greco “ophis”; «Naasseni» dall’ebraico “nahas” – il gruppo nel suo insieme è chiamato «ofitico»); e tale posizione del serpente è basata su un’audace interpretazione allegorica del testo biblico. Ecco la versione data da Ireneo nella sua esposizione riassuntiva della concezione ofitica (I, 30, 7): la Madre oltremondana, Sophia-Prunikos, che cerca di contrastare l’attività demiurgica del figlio apostata Ialdabaoth, manda il serpente a «sedurre Adamo ed Eva e indurli a disobbedire al comando di Ialdabaoth». Il piano riesce, entrambi mangiano dell’albero «del quale Dio [cioè il Demiurgo] aveva proibito loro di mangiare. Ma dopo che essi ebbero mangiato, conobbero il potere dell’al di là e si allontanarono dai loro creatori». E’ il primo successo del principio trascendente contro il principio del mondo, il quale è vitalmente interessato ad impedire la conoscenza nell’uomo, come ostaggio della Luce all’interno del mondo: l’azione del serpente segna l’inizio della gnosi sulla terra, che perciò per la sua stessa origine è segnata come opposizione al mondo e al suo Dio, e invero come una forma di ribellione.
I Perati, di un’estrema coerenza, non hanno esitato a considerare il Gesù storico come una particolare incarnazione del «serpente universale», ossia il serpente del Paradiso inteso come principio (confronta più avanti). Nell'”Apocrifo di Giovanni”, gnostico-barbeliota (non-ofitico), tale identificazione, che diviene inevitabile nello svolgimento dell’argomentazione, è evitata di stretta misura giocando sulla differenza tra «albero della vita» e «albero della conoscenza del bene e del male»: Cristo infatti invita l’uomo a mangiare di quest’ultimo contro il comando degli Arconti, mentre il serpente, identificato con Ialdabaoth, spingendo l’uomo verso l’altro albero, è lasciato al suo compito tradizionale di corruttore (questo, in maniera non troppo convincente, in risposta alla domanda allarmata dei discepoli: «Cristo, non è stato il serpente che l’ammaestrò?»). Perciò, evitando così l’identificazione delle due figure simboliche, solo una parte della funzione del serpente è stata attribuita a Cristo. I Valentiniani d’altra parte, sebbene non abbiano coinvolto Gesù nell’azione svoltasi in Paradiso, tracciarono un parallelo allegorico tra lui e il “frutto” dell’albero: essendo stato appeso ad un «legno» (41), egli «divenne un Frutto della Conoscenza del Padre, che tuttavia “non” portò rovina a coloro che ne mangiarono» (E. V. 18, 25 s.). Non si può decidere con certezza dall’esempio citato se la negazione mette semplicemente in contrasto il nuovo avvenimento e il vecchio (secondo la maniera di san Paolo), oppure se intende rettificare il racconto stesso della Genesi. Ma questa seconda ipotesi si verifica chiaramente in altri passi ed è certamente secondo la maniera gnostica (confronta il ripetuto, brusco «non come Mosè disse» nell'”Apocrifo di Giovanni”).
Al tempo di Mani (terzo secolo) l’interpretazione gnostica della storia del Paradiso e la connessione di Gesù con essa era così fermamente stabilita, che egli poté mettere semplicemente Gesù al posto del serpente senza neanche menzionare quest’ultimo: «Egli fece alzare (Adamo) e gli fece mangiare dell’albero della vita» (confronta sopra, par. n). Ciò che una volta era stato una cosciente arditezza di allegoria era diventato un mito indipendente che poteva essere sfruttato senza alcun riferimento al modello originale (e forse nemmeno un ricordo di esso). La genesi rivoluzionaria di codesto motivo a quest’epoca era probabilmente del tutto dimenticata. Il che mostra che l’allegoria gnostica, a differenza di quella degli Stoici o della letteratura sincretistica in genere, era essa stessa la fonte di una nuova mitologia: questa è il veicolo rivoluzionario del suo emergere nei confronti di una tradizione inveterata; e poiché cerca di sopraffare quest’ultima, il principio di tale allegoria deve essere il paradosso e non la coerenza.
– Caino e il Creatore.
Appartiene ugualmente al circolo ofitico l’esempio seguente, tratto dalla relazione di Ippolito sui Perati (Refut. V, 16, 9 s.):
«Questo serpente universale è anche la Parola sapiente di Eva. Questo è il mistero dell’Eden: questo è il fiume che scorre dall’Eden. Questo è anche il segno con cui è stato marcato Caino, il cui sacrificio non fu accettato dal dio del mondo, mentre egli accettò il sacrificio sanguinoso di Abele perché il signore di questo mondo si diletta del sangue. Questo serpente è quello che apparve in forma umana negli ultimi giorni al tempo di Erode…».
L’elevazione di Caino a simbolo pneumatico e ad una posizione onorata nella linea che porta a Cristo, Caino che è il prototipo del reietto, condannato da Dio ad essere «fuggitivo e vagabondo» sulla terra, è senza dubbio una sfida intenzionale a valutazioni inveterate. Questo optare per l’«altra» parte, per ciò che è tradizionalmente infame, è un metodo eretico, molto più serio di una presa di posizione puramente sentimentale per la parte più debole, senza considerare il puro indulgere alla libertà speculativa. E’ evidente che l’allegoria, mezzo di per sé rispettabile per armonizzare, è diventata in questo caso una bravata di non-conformismo. Forse si dovrebbe parlare qui non di allegoria, ma di una forma di polemica, cioè non di esegesi del testo originale, ma di una tendenziosa rielaborazione del testo. In realtà, gli Gnostici in tali casi non avevano la “pretesa” di chiarire il vero significato dell’originale, se con «vero» si vuol significare il senso “inteso” dall’autore, visto che questo autore, direttamente o indirettamente, era il loro grande avversario, l’ignorante dio-creatore. La loro inconfessata pretesa era piuttosto quella di ritenere che l’autore di scarsa vista avesse involontariamente immesso qualche cosa della verità nella sua visione partigiana della realtà, e che questa verità potesse essere portata in luce sovvertendo completamente il senso inteso dall’autore .
La figura di Caino, da cui una setta gnostica ha preso il nome (a proposito dei Cainiti, confronta Iren. I, 31, 2), è soltanto l’esempio più evidente della messa in opera del metodo. Nella costruzione di una serie completa di tali controfigure, che si prolunga per secoli, una visione da ribelli della storia come un tutto viene deliberatamente opposta a quella ufficiale.
Codesto parteggiare per Caino viene esteso in modo coerente a tutte le figure scritturistiche di «reietti»: il passo citato prima continua con un’analoga elevazione di Esaù, il quale «non ricevette una benedizione cieca, ma divenne ricco di fuori senza accettare nulla dal cieco» (loc. cit. 9); e Marcione, che l’odio per il dio-creatore dell’Antico Testamento aveva portato alle conclusioni più radicali sotto tutti gli aspetti, insegnò che Cristo era disceso all’inferno al solo scopo di redimere Caino e Korah, Dathan e Abiram, Esaù e tutte le nazioni che non avevano riconosciuto il Dio degli Ebrei, mentre Abele, Enoch, Noè, Abramo, eccetera, i quali avevano servito il creatore e la sua legge e avevano ignorato il vero Dio, erano stati lasciati giù (confronta cap. 5, nota 11).
– Prometeo e Zeus.
Il terzo esempio viene aggiunto soprattutto per mostrare che si tratta qui di un principio generale dell’allegoria gnostica e non soltanto di un atteggiamento particolare verso l’Antico Testamento. E’ pur vero che la degradazione blasfema dell’Altissimo, della religione anteriore, fino al punto di farne un principio demoniaco con la conseguente revisione della posizione dei suoi amici e nemici, trova il suo materiale preferito nella tradizione giudaica: solamente là il prestigio dell’originale sacro, l’importanza delle sue pretese, la devozione dei suoi fedeli, diedero al rovesciamento gnostico il sapore di provocazione e scandalo, che era proprio l’effetto desiderato dal nuovo messaggio. Con gli dèi dell’Olimpo l’immaginativa letteraria poteva sbizzarrirsi più liberamente senza recare oltraggio ai sentimenti di pietà. Essi non erano presi troppo sul serio, anche dai loro seguaci più formalisti, e nell’insieme furono ignorati dagli Gnostici: tuttavia la posizione di Zeus come il più eccelso degli dèi del pantheon era abbastanza degna di riverenza da rendere la sua degradazione una faccenda grave, perciò anch’egli fu sottoposto occasionalmente allo stesso trattamento riservato al Signore biblico della Creazione.
L’alchimista Zosimo nel suo trattato “Omega” (par. 3 s., p. 229, linea 16 s.s., Berthelot) divide il genere umano tra coloro che sono «sotto» e coloro che sono «sopra» l'”heimarméne”, e chiama gli ultimi la «tribù dei filosofi» (42); costoro, egli dice, sono «sopra l'”heimarméne” in quanto né sono rallegrati dalle sue fortune, perché dominano i loro piaceri, né sono depressi dalle sue disgrazie… e nemmeno accettano gli splendidi doni che essa offre». Degli altri egli dice che «seguono nel corteo dell'”heimarméne”» e sono «sotto tutti gli aspetti i suoi accoliti». Quindi continua con un’allegoria: per questo motivo Prometeo consiglia Epimeteo, in Esiodo (“Erga”, I, 86 s.), «’di non accettare un dono da Zeus Olimpico, ma di restituirlo’, così egli insegna a suo fratello per mezzo della filosofia a rifiutare i doni di Zeus, ossia dell'”heimarméne”». E’ l’identificazione di Zeus con l'”heimarméne” che fa della citazione di Esiodo un’allegoria gnostica. L’identificazione implica quella parallela di Prometeo, suo sfidante e vittima, con il tipo dell’uomo «spirituale» la cui lealtà non è per il dio di questo mondo, ma per il dio trascendente.
Così in modo paradossale la condizione di Zeus come principio più alto del cosmo è presa dalla tradizione, ma con valori rovesciati: poiché l’oppositore di Prometeo è il governatore cosmico, il commentatore prende le parti del ribelle e fa di quest’ultimo l’incarnazione di un principio superiore a tutto l’universo. La vittima dell’antica mitologia diventa il portatore del messaggio della nuova. Qui di nuovo l’allegoria urta deliberatamente la pietà di un’intera cultura religiosa radicata nell’ambiente ellenistico. E opportuno notare che identificare lo “Iupiter summus exsuperantissimus” della religione imperiale con l'”heimarméne” non significa in realtà sottovalutarlo, perché la necessità del destino cosmico è un aspetto legittimo del suo potere divino. Il punto è che la nuova valutazione gnostica del cosmo come tale (per cui “heimarméne” ha preso il significato di un simbolo repulsivo) ha portato con sé lo scadimento della sua eccelsa divinità, ed è appunto per il suo potere cosmico che Zeus è divenuto oggetto di disprezzo. Se volessimo parlare anche noi in termini di mitologia, potremmo dire che Zeus subisce ora il destino a cui ha condannato i suoi predecessori e che la rivolta dei Titani contro la sua legge consegue una vittoria ritardata.
Appendice al capitolo 2.
GLOSSARIO DI TERMINI MANDEI.
“Acqua torbida”. Acqua intorbidata, letteralmente «acqua dell’Abisso [o Caos]»: la materia originaria del mondo delle tenebre con la quale l’acqua viva si è mescolata.
“Acqua viva”. Acqua fluente, che è di origine sublime e scorre in ruscelli, i quali erano chiamati tutti «Giordano» dai Mandei (probabilmente per indicare l’origine geografica della comunità mandea). Soltanto questa poteva essere usata nei riti, ossia nei battesimi frequenti che sono una caratteristica principale del culto mandeo. Per questo motivo i Mandei potevano risiedere soltanto vicino ai fiumi. L’espressione «acqua viva» è forse presa dall’Antico Testamento (confronta Gen. 26, 19; Lev. 14, 5.50). L’opposto è acqua stagnante e acqua torbida del mare (v. “Acqua torbida”).
“Anosh” (o “Enosh”). «Uomo», uno degli Uthra, eterno ma temporaneamente esiliato nel mondo delle tenebre.
“Kushta”. Verità, veracità, la vera fede: anche fedeltà e sincerità nel comportamento dei credenti nei riguardi dell’Essere supremo e gli uni con gli altri. «Passare Kushta» significa scambiarsi strette di mano in segno di fraternità. Talvolta personificato.
“Mana”. Essere spirituale di pura divinità, o anche lo spirito divino nell’uomo: il Grande Mana (anche Mana di Gloria) è la divinità suprema. Il significato originale è forse «vaso», «giara».
“Manda”. Conoscenza: equivalente del greco “gnosis”.
“Manda d’Hayye”. «Conoscenza della Vita»: la gnosi personificata nella figura divina centrale del salvatore nella religione mandea, chiamato dalla Vita nel mondo della luce e mandato giù nel basso mondo. Il composto è usato solamente come nome proprio.
“Mar Rosso” (“Mare Suphi”). Il Mar Rosso attraverso il quale i figli d’Israele dovettero passare nel loro esodo dall’Egitto: nella speculazione gnostica, come pure in quella alessandrina-giudaica, questo era riferito allegoricamente all’esodo dell’anima dal corpo, o dal mondo, cosicché il Mar Rosso divenne un simbolo delle acque che dividono questo mondo dall’altro. Per un facile cambiamento di vocale da “suf” (canne) in “sof” (fine), il Mar Rosso (“Mare Suph”) poteva essere interpretato come «mare della fine», ossia della morte.
“Mondi”. “Almaya”: può anche significare «esseri», talvolta anche, nonostante il plurale, semplicemente il singolare «mondo»; il più delle volte è dubbio quale sia il significato inteso in un dato caso.
“Ptahil”. Uno degli Uthra; come esecutore dei piani cosmogonici di un gruppo di Uthra, più direttamente collegato con la formazione di questo mondo: egli è perciò il Demiurgo mandeo. Il nome Ptah-il è quello del dio-artigiano egiziano “Ptah” con l’aggiunta del semitico “il” («dio»). Il fatto che il nome per il Demiurgo è preso dal pantheon egiziano è senza dubbio legato alla funzione simbolica dell’Egitto come rappresentante del mondo materiale (v. Mar Rosso; confronta cap. 3 [p. 128 s. ed. in nero]).
“Ruha”. «Spirito», più completamente anche Ruha d’Qudsha, «Spirito Santo» (!), il demone femminile principale dei Mandei, madre dei sette Pianeti e interamente malvagio (per la spiegazione confronta cap. 2, nota 25).
“Saldamente fondato”, “raffermato”. Quasi identico a «benedetto», predicato soprattutto degli Uthra più eccelsi e perfetti.
“Sh’kina”. «Abitazione» degli esseri della luce (cioè della Vita, degli Uthra individuali): usato dai Mandei soprattutto nel senso letterale, con la connotazione di gloria come l’aura-di-luce che circonda questi esseri come un’abitazione; qualche volta, tuttavia, anche nel senso personificato che il termine ha acquistato nella speculazione giudaica (confronta “sh’kina” di Mani, equivalente ad «eoni», le potenze personificate che circondano la divinità suprema).
“Tibil”. Il “tevel” dell’Antico Testamento, «terra», “terra firma”, usato dai Mandei come un nome del mondo terrestre, sempre con una connotazione di degradazione in opposizione alla purezza del mondo divino.
“Tribù di anime”. Nome per la totalità dei credenti, ossia i Mandei.
“Uthra”. Nome degli esseri divini al di sotto del Grande Mana e della Prima Vita paragonabili agli angeli e agli arcangeli della dottrina giudaica e cristiana. Nome che ha bandito il termine abituale semitico “mal’ach” per angelo usato lungo tutto l’Antico Testamento: quando il vecchio termine ricorre negli scritti mandei denota sempre geni di stregoneria o spiriti malvagi. Il significato letterale di Uthra è «ricchezza», «abbondanza», che indica questi esseri come emanazioni della perfezione divina. Essi furono generati (in parte in ordini di discesa mediata) nel fondo della luce, e nella totalità, con i loro rispettivi “sh’kina”, formano quel mondo. Alcuni di essi tuttavia sono fallibili (v. “Saldamente fondato”).
NOTE AL CAPITOLO 2.
1. Le citazioni dei testi mandei sono basate sulla traduzione tedesca di M. Lidzbarski, «G» è l’abbreviazione di “Ginza: Des Schatz oder das Grosse Buch der Mandäer”, Göttingen, 1925, «J» di “Das Johannesbuch der Mandäer”, Giessen, 1915. I numeri che seguono la lettera indicano la pagina delle opere.
2. Al singolare, «eone» può significare semplicemente «il mondo», e nel pensiero ebraico e cristiano «questo eone» è in opposizione a «l’eone che verrà»: il modello qui è probabilmente la parola ebraica “olam” (aramaico “alma”), il cui significato originario di «eternità» può includere quello di «mondo». Il plurale mandeo “almaya” può significare «mondi» e «esseri», questi ultimi in senso personale (superumano). Al concetto del Nuovo Testamento di «questo eone» si aggiunge la personificazione per mezzo di espressioni come «il dio [o «i governanti»] di questo eone».
3. Sono parole dette dal salvatore; ma lo stretto rapporto tra la sua condizione e quella della Vita in generale esiliata nel mondo, cioè di quelli che devono essere salvati, è mostrato dalle parole con cui è inviato per la sua missione: «Vai, vai, figlio nostro e nostra immagine… Il luogo dove vai – gravi sofferenze ti aspettano in quei mondi di tenebra. Generazione dopo generazione rimarrai là, finché ti dimenticheremo. La tua forma rimarrà, lì, finché celebreremo per te la messa dei morti» (G 152 s.).
4. Ved. il Glossario alla fine del capitolo.
5. Ved. il Glossario alla fine del capitolo.
6. «Definire la mia lotta», formula per «morire».
7. Ved. il Glossario alla fine del capitolo.
8. Il re della tenebra primordiale è chiamato anche nello stadio precosmico «il re di questo mondo» e «di questi eoni», sebbene secondo il sistema il «mondo» provenga da una mescolanza dei due princìpi. Un parallelo mandeo all’insegnamento di Mani sulle origini, di cui abbiamo citato prima la frase iniziale, dice: «C’erano due re, due nature furono create: un re di questo mondo e un re al di fuori dei mondi. Il re di questi eoni cinse una spada e una corona di tenebra [eccetera]» (J 55). In termini di logica ciò è incoerente; ma in senso simbolico è più gnostico dell’astrazione di Mani, perché il principio della «tenebra» è fin dall’inizio “definito” qui come quello del «mondo», secondo la concezione dell’esperienza gnostica. Il «mondo» è determinato dalla tenebra, e la «tenebra» solamente dal mondo.
9. Ved. il Glossario alla fine del capitolo.
10. Da un frammento gnostico del “Vangelo di Eva” conservato da Epifanio (Haer. 26, 3).
11. Ibid. 26, 10.
12. Ibid. 26, 13; per la citazione completa del passo ved. più avanti, cap. 6, b) «L’ascesa dell’anima».
13. Confronta JONAS, “Gnosis und spätantiker Geist”, II, 1, p.p. 175-223.
14. Ved. il Glossario alla fine del capitolo.
15. El Chatibi a proposito dei Harraniti; per il seguito ved. il cap. 6, b) «L’unione dell’Uomo con la natura», nota 15, p. 178.
16. Prigione, palla e catena, ceppi e nodi sono simboli usati di frequente per indicare il corpo.
17. Ved. il Glossario alla fine del capitolo.
18. Il rimorso del creatore si trova anche nello gnosticismo cristiano. Nel “Libro di Baruch” lo vediamo supplicare – senza risultato – il Dio supremo: «Signore, lasciami distruggere il mondo che ho creato, perché il mio spirito [pneuma] è incatenato negli esseri umani e voglio liberarlo di là» (Hippol. V, 26, 17).
19. Per il significato di “Geworfenheit” ved. “Sein und Zeit”, Halle, 1927, p. 175 s.s. Ho cercato di tracciare un parallelo tra gnosticismo ed esistenzialismo nell’Epilogo.
20. Ved. il Glossario alla fine del capitolo.
21. Cioè, per la morte corporale? Le tre frasi che iniziano qui formano il passo più difficile da interpretare di tutto il testo.
22. Una caduta colpevole ha avuto luogo.
23. Ved. anche la descrizione corrispondente in un frammento di Turfan: «E dall’impurità dei demoni maschili e dalla sozzura dei demoni femminili essa [Az, ‘la madre malvagia di tutti i demoni’] formò questo corpo, ed essa stessa vi entrò. Poi, dai cinque elementi di Luce, l’armatura di Ormuzd, essa formò [?] l’anima buona e la incatenò nel corpo. La fece come cieca e sorda, inconscia e confusa, cosicché al principio non conoscesse la sua vera origine e parentela». (W. HENNING, “Geburt und Entstehtung des manichäischen Urmenschen”, Nachrichten der Gött. Ges. Wiss., Phil.-hist. Kl. 1932, Göttingen, 1933, p. 217 s.s.).
24. Forse una frase coniata da Filone Giudeo che ha avuto larga diffusione nella letteratura mistica: confronta HANS LEWY, “Sobria ebrietas” (Beihefte zur ZNW 9, Giessen, 1929).
25. “Ruha”, lett. «spirito». La perversione del termine nel denotare la più alta personificazione del male è un episodio interessante nella storia della religione, tanto più paradossale in quanto il nome completo di questa figura antidivina è “Ruha d’Qudsha”, cioè «lo Spirito Santo». Ma lo stesso paradosso rivela la causa: la violenta ostilità verso la dottrina cristiana, il cui Fondatore secondo la tradizione mandea aveva rubato e falsificato il messaggio del suo maestro Giovanni Battista. Ma l’ambivalenza della figura dello «Spirito Santo», inteso come femminile, si può trovare anche nello gnosticismo cristiano, come vedremo quando tratteremo la speculazione sulla Sophia.
26. Ved. il Glossario alla fine del capitolo.
27. «Richiamatore della chiamata» è il nome dato al missionario manicheo; ed anche nell’Islam la parola usata per la missione è «chiamata», per il missionario «richiamatore».
28. Questa idea, come pure tutto il misticismo del «nome» – e del «libro» -, così rilevante nel Vangelo di Verità, indica certe speculazioni ebraiche come probabile fonte; ma il tema poteva essere largamente diffuso nel pensiero orientale: ved. nel salmo mandeo citato a fine par., il versetto «chi invoca il mio nome, io lo chiamo».
29. Non così, bisogna aggiungere, nel “Vangelo di Verità”: lì in realtà una volta tanto le formulazioni sulle sofferenze di Cristo tradiscono un fervore emotivo e un senso del mistero («Oh! grande, sublime Insegnamento») che suggeriscono un significato religioso molto al di là di quanto è abituale nel cosiddetto gnosticismo cristiano, compresa gran parte della stessa letteratura valentiniana conosciuta.
30. Testo: loro.
31. Per spiegare l’ultima frase: la Madre della Vita ha creato l’Uomo Primordiale che la «Risposta» presenta ora come espressione del suo io risvegliato. Lo Spirito Vivente da parte sua ha mandato la «Chiamata» come un messaggero. L’una e l’altra sono indossate come vestiti da coloro che le hanno originate, ossia sono riunite alla loro sorgente. Come detto sopra, la personificazione di «Chiamata» e «Risposta» è una caratteristica della speculazione manichea (Jackson traduce «Appellante» e «Rispondente»). Perciò, come nel passo citato di Teodoro bar Konai, il frammento di inno in M 33 di Turfan riferisce come il Padre primordiale abbandoni lo «Spirito» (equivalente qui a Uomo Primordiale) ai nemici, la Madre della Vita intercede presso di lui per il Figlio prigioniero, il dio Chroshtag («Chiamata») è mandato a lui, il dio liberato come «Chiamata» ascende e la Madre saluta il Figlio di ritorno a casa (REITZENSTEIN, “Das iranische Erlösungsmysterium”, p. 8).
32. Secondo la traduzione di Andreas in REITZEINSTEIN, “Hellenistiche Mysterien-religionen”, 3a ed., 1927, p. 58; anche in “Das iranische Erlösungsmysterium”, p. 3. Confronta JACKSON, p. 257: «Provengo dalla Luce e dagli Dei e sono diventato straniero per loro; i nemici si sono riuniti insieme contro di me e da loro sono trascinato giù nella morte» (M 7). Confronta ibid., p. 256: «Sono diventato un forestiero per la Grande Maestà».
33. “Das Iranische Erlösungsmysterium”, p. 11 s.s.
34. Identico in G 387 S. e in J 225 s. Ciò è abbastanza vicino alla situazione fittizia della chiamata. In G 16-27 ci sono pagine di esortazioni introdotte da una specie di formula: «Il Signore ha chiamato e incaricato me, il puro messaggero, dicendo: ‘Vai e manda una chiamata ad Adamo e a tutte le sue tribù e istruiscile su tutte le cose sul Re supremo della Luce… e sui mondi della luce, quelli eterni. Parla con lui perché il suo cuore sia illuminato… Insegna la gnosi ad Adamo, ad Eva sua moglie e a tutte le loro tribù. Di’ loro…’». Segue una serie di esortazioni le più svariate, raccomandazioni e comandi, che sono collegati dallo stesso atteggiamento anticosmico. Ecco alcuni esempi: «[95] Non amate l’oro e l’argento e il possesso di questo mondo. Perché questo mondo perisce e passa… [103] Con sincerità e fede e retto discorso riscattate l’anima dalla tenebra per portarla nella luce, dall’errore alla verità, dall’incredulità alla fede nel vostro Signore. Colui che riscatta un’anima vale per me generazioni e mondi. [134] Quando qualcuno abbandona il corpo, non piangete e non lamentatevi per lui… [135] Andate, voi poveri miserabili e perseguitati, piangete per voi stessi; perché fintantoché sarete nel mondo aumenterete i vostri peccati. [155] Il mio eletto non ha fiducia nel mondo in cui vivete perché non è vostro. Abbiate fiducia nelle opere che compite. [163] Non esaltate i Sette e i Dodici, i governanti del mondo… perché portano fuori strada la tribù di anime che è stata trasportata qui dalla casa della vita». La serie si chiude con le parole: «Questo è il primo insegnamento che Adamo il capo della tribù vivente ha ricevuto». (I numeri tra parentesi indicano i paragrafi nell’edizione di Lidzbarski).
35. Confronta C.H. VII, 1 s.: «Dove siete trasportati, uomini ubriachi che avete bevuto fino in fondo il vino puro [lett. ‘parola’] dell’ignoranza… fermatevi e diventate sobri e guardate con gli occhi del cuore… Cercate la guida che vi condurrà per mano alle porte della conoscenza dove è la luce splendente che è priva di tenebra, dove nessuno è ubriaco ma tutti sono sobri e rivolgono i loro cuori a vedere Colui la cui volontà è di essere visto».
36. Di Gesù o di Adamo, ma più probabilmente del primo: ved. cap. 8, b) p. 244 s.s. sulla dottrina del Gesù patibile (“Jesus patibilis”).
37. Confronta la versione completa di questa formula valentiniana in Exc. Theod. 78, 2 (ved. sopra cap. 1, f, «Escatologia»).
38. Traduzione di “Eden”.
39. Una imitazione pervertita del vero Spirito divino.
40. Dalla Luce.
41. “xylon” come traduzione dell’ebraico “ets” = «albero», e la sua materia «legno»: perciò la frase può significare anche «appeso ad un albero»; confronta “Atti”, 10, 40; Deut. 21, 22.
42. «Filosofo» significa qui quello che nella terminologia gnostica è generalmente chiamato «pneumatico»; attraverso questo uso è giunto a significare il vero alchimista che ha il potere mistico di trasformare gli elementi inferiori in quelli nobili: di qui «la pietra filosofale».
Parte seconda.
SISTEMI GNOSTICI DI SPECULAZIONE.
Dopo la rassegna degli “elementi” semantici, che mettono l’accento sul terreno comune del pensiero gnostico piuttosto che sulle differenziazioni dottrinali, passiamo ora ad esaminare le unità teoriche più importanti in cui è stata espressa la visione gnostica della realtà, ossia ai “sistemi” di speculazione gnostica coscientemente elaborati. Ne esiste un gran numero, ma possiamo qui offrire soltanto una selezione rappresentativa dei tipi maggiori, e, anche così, considerazioni di spazio ci obbligano a sacrificare qualche cosa della loro ricchezza di particolari mitologici.
La speculazione gnostica ha il suo compito prestabilito dai princìpi fondamentali della visione gnostica della realtà. Questa comprendeva, come abbiamo già visto, una certa concezione del mondo, dell’estraneità dell’uomo all’interno di esso e della natura transmondana della divinità. Questi princìpi costituivano per così dire la visione della realtà come è data qui e ora. Ma ciò che è, specialmente se è di un genere così sconvolgente, deve avere avuto una “storia” per la quale è giunto ad essere come è e che spiega la sua condizione «innaturale». Il compito della speculazione quindi è di rendere ragione del presente stato delle cose in una esposizione storica, di farlo derivare dai primi inizi e così di spiegarne l’enigma: in altre parole, di trasportare la visione della realtà nella luce della gnosi. La maniera in cui tale compito è portato a termine è invariabilmente “mitologica”, ma il mito che ne risulta, a parte il piano generale, è in molti casi opera di libera invenzione dei singoli autori, e nonostante ciò che prende in prestito dalla tradizione popolare non è un prodotto del folclore (1). Il suo simbolismo è decisamente voluto, e nelle mani dei maggiori costruttori di sistemi diviene uno strumento, maneggiato con grande virtuosismo, per la comunicazione di idee artificiose. Il carattere mitologico di queste speculazioni non deve tuttavia essere sottovalutato. La natura drammatica e il significato psicologico delle verità da trasmettere richiedevano questo mezzo, in cui la personificazione è la forma legittima di espressione.
Nello studio che facciamo seguire, inizieremo con esempi relativamente semplici di dottrina gnostica e proseguiremo con quelli maggiormente elaborati.
NOTA.
1. Per lo studioso della religione, in ragione di questo prestito, è un deposito di materiale vecchio e in parte pietrificato; ma il nuovo contesto permea cotesto materiale con significati spesso molto lontani da quelli originali.
Capitolo 3.
SIMON MAGO.
I Padri della Chiesa consideravano Simon Mago come il padre di ogni eresia. Egli fu contemporaneo degli apostoli e samaritano, e la Samaria era notoriamente indisciplinata in fatto di religione e guardata con sospetto dagli ortodossi. Quando l’apostolo Filippo giunse là a predicare il Vangelo, trovò il movimento di Simone in pieno rigoglio, con Simone che diceva di se stesso, e il popolo con lui, che egli era «la Potenza di Dio, quella che era chiamata la Grande» (Act. 8,10). Ciò significa che egli non predicava come apostolo, ma riteneva se stesso un messia. La storia della sua posteriore conversione, sebbene non necessariamente quella del battesimo, deve essere falsa (se in realtà il Simone degli Atti e l’eresiarca dei Padri sono una sola e medesima persona, ciò che è stato messo seriamente in dubbio), perché in nessun resoconto eresiologico dell’insegnamento simoniaco dal secondo al terzo secolo si trova alcun indizio che la posizione di Gesù fosse riconosciuta dalla setta, tranne il ritenere che Gesù era stato una precedente incarnazione di Simone stesso. In ogni modo – anche se facciamo astrazione del racconto degli Atti in quanto possa riferirsi ad una persona diversa e assegniamo il profeta gnostico dello stesso nome ad una o due generazioni più tardi – il simonianismo fu fin dal suo sorgere, e rimase, un messaggio rivale di origine evidentemente indipendente; in altre parole, Simone non fu un cristiano dissidente, e se i Padri della Chiesa ne fecero una figura di arcieretico, essi implicitamente ammettevano che lo gnosticismo non era un fenomeno interno al cristianesimo. D’altra parte lo scrittore pagano Celso dà testimonianza che i termini che Simone pare impiegasse parlando di se stesso, erano correnti con gli pseudo-messia che ancora formicolavano in Fenicia e Palestina al suo tempo, verso la metà del secondo secolo. Egli stesso ne aveva udito un certo numero e ne riferisce un sermone tipico (1):
«Io sono Dio (o un figlio di Dio, o uno Spirito divino). E sono venuto. Ormai il mondo sta per essere distrutto. E voi, o uomini, dovete morire a causa delle vostre iniquità. Ma voglio salvarvi. E voi mi vedete che ritorno di nuovo con potere celeste. Beato colui che ora mi ha adorato! Ma io rovescerò fuoco eterno su tutti gli altri, sulle città e sulle campagne. E gli uomini che non si rendono conto dei castighi in serbo per loro, invano si pentiranno e gemeranno. Ma io preserverò per sempre quelli che si sono lasciati convincere da me» (2).
Un tratto caratteristico del viaggio terrestre di Simone fu quello di prendere con sé una donna chiamata Elena che, diceva, egli aveva trovato in un bordello a Tiro e che secondo lui era l’ultima e infima incarnazione del «Pensiero» caduto di Dio, redenta da lui e mezzo di redenzione per tutti quelli che credevano in entrambi. Quanto spiegheremo in seguito potrà far comprendere il significato dottrinale di tale esibizionismo; il modo pittoresco e la sfrontatezza dell’esibizione parlano già da sé (3).
La dottrina simoniana sviluppata, che sia opera sua propria o elaborazione della sua scuola, è stata conservata da un certo numero di scrittori posteriori, a cominciare da Giustino Martire (egli stesso cresciuto nel distretto di Samaria) fino a Ireneo, Ippolito, Tertulliano ed Epifanio. Una fonte di grande valore sono gli scritti intitolati “Ricognizioni” o “Omelie”, che passarono per essere di Clemente Romano e perciò dette «Clementine» o «Pseudo-Clementine». Daremo qui una sintesi di tutte queste notizie e soltanto occasionalmente indicheremo la fonte particolare.
«Vi è una sola Potenza, divisa in superiore e inferiore, che genera se stessa, accresce se stessa, cerca se stessa, trova se stessa, e che è sua madre, suo padre…, sua figlia, suo figlio…, Unica, radice del Tutto». Questo Unico, dispiegato, «è colui che sta, stette e starà: egli sta in alto nella Potenza increata, egli stette in basso nella corrente delle acque [cioè il mondo della materia], generato nell’immagine; egli starà in alto nella benedetta, infinita Potenza quando la sua immagine sarà perfetta» (Hippol., “Refut.” VI, 17, 1-3).
Come avviene questa divisione di sé dell’Unico in superiore e inferiore? In altri termini, come mai l’Essere originario ha stabilito per se stesso la necessità della sua restaurazione posteriore? E’ caratteristico della speculazione seguente che non sia affermato un mondo di tenebre e di materia esistente dall’origine in opposizione all’essere primordiale, ma che il dualismo della realtà esistente sia derivato da un processo interno all’unica divinità. E’ questo un carattere distintivo della gnosi siriaca ed alessandrina ed un elemento di differenziazione dal tipo iranico di speculazione gnostica, che parte da un dualismo di princìpi preesistenti. La sottilissima descrizione attribuita a Simone dell’autodivisione dell’unità divina si trova relativamente tardi, in Ippolito, che la copiò da un significativo trattato simoniano intitolato «La Grande Esposizione». Alquanto semplificato dice così:
L’unica radice è Silenzio impenetrabile, potenza preesistente senza limiti, esistente in singolarità. Essa si agita e assume un aspetto determinato diventando Mente (“Nous”), da cui ha origine il Pensiero (“Epinoia”), concepito nella singolarità. Mente e Pensiero non sono più uno, ma due: nel suo Pensiero il Primo «apparve a se stesso da se stesso e perciò divenne un Secondo». In tal modo per l’atto di riflessione l’indeterminata potenza della Radice, che si può descrivere solo negativamente, diventa un principio positivo legato all’oggetto del suo pensare, anche che se tale oggetto è lei stessa. E’ ancora Una in quanto contiene in se stessa il Pensiero, ma già divisa e non più nella sua primitiva integrità. Ora, tutto lo sviluppo susseguente, sia qui che in altre speculazioni dello stesso tipo, dipende dal fatto che le parole greche “epinoia” ed “ennoia”, come pure la parola “sophia” (sapienza) di altri sistemi, ancora più frequentemente usato, sono femminili e lo sono anche le parole equivalenti ebraiche e aramaiche. Il Pensiero creato dall’Uno originario è rispetto ad esso femminile; la Mente (“Nous”) in corrispondenza alla sua capacità di concezione assume una funzione maschile. Il suo nome diviene «Padre» quando il Pensiero lo chiama così, cioè quando si rivolge a lui e lo invoca nella sua funzione generativa. Quindi la separazione originaria proviene dal Nous che «genera se stesso da se stesso rendendo manifesto a se stesso il suo proprio pensiero» (4). L’Epinoia manifestata osserva il Padre e lo nasconde in se stessa come potenza creativa, e in questa misura la Potenza primitiva è attirata nel Pensiero formando una combinazione androgina: la Potenza (o Mente) è l’elemento superiore e l’Epinoia l’inferiore. Sebbene congiunti in unità, essi sono al tempo stesso posti l’uno di fronte all’altra, e nella loro dualità fanno apparire la distanza tra di essi. Il principio superiore, la grande Potenza, è in questa combinazione la Mente del Tutto, che governa ogni cosa ed è maschile; il principio inferiore, il grande Pensiero, è colui che genera tutto ed è femminile (5).
Di qui in poi – volgendoci ora a fonti più autentiche – la figura femminile dell’Epinoia (o, alternativamente, Ennoia), ipostatizzata e personificata, che ha assorbito in se stessa la potenza generatrice del Padre, è il soggetto della ulteriore storia divina iniziata col primo atto di riflessione. Tale storia è quella della creazione o di una serie di creazioni; e la caratteristica gnostica specifica del processo creativo è di rappresentarlo come progressiva deteriorazione (alienazione) durante la quale l’Epinoia, portatrice delle potenze creatrici separate dalla loro sorgente, perde controllo sulle sue proprie creazioni e diviene sempre di più vittima delle loro forze che tendono ad affermare se stesse. Le più antiche relazioni su Simone riguardavano esclusivamente la caduta, la sofferenza, la degradazione e l’eventuale redenzione di questa ipostasi femminile del divino. Questi resoconti della dottrina simoniana non riferiscono niente di simile alla deduzione concettuale della Grande Esposizione, ma introducono l’entità femminile con la semplice affermazione che essa è «il primo Pensiero della Sua (divina) mente, la madre universale per la quale fin dal principio Egli ebbe in mente di creare angeli e arcangeli». Il racconto prosegue: «Questa Epinoia, generata da Lui (6) e comprendente l’intenzione del Padre, discese nelle regioni inferiori e, anticipando Lui, generò gli angeli e le potenze dalle quali è stato fatto questo mondo. Dopo che li ebbe generati, essa fu trattenuta da loro per invidia, perché non volevano venir considerati progenie di qualcun altro. Il Padre era loro completamente sconosciuto: il suo Pensiero, tuttavia, era trattenuto da quegli angeli e potenze emanate da lei ed era trascinato giù dai cieli eccelsi fino nel cosmo. Essa pativa ogni sorta di maltrattamenti da parte loro, affinché non potesse tornare in alto dal Padre, fino al punto che fu rinchiusa in carne umana e migrò per secoli di vaso in vaso in differenti corpi femminili. E poiché tutte le Potenze se ne contendevano il possesso, lotta e guerra si scatenarono tra le nazioni ovunque essa appariva. Così essa fu anche quell’Elena per la quale si combatté la guerra troiana, e in tal modo Greci e barbari contemplarono un fantasma della verità. Migrando di corpo in corpo, soffrendo ingiuria in ciascuno, essa alla fine divenne una donna di malaffare in un bordello, e questa è la ‘pecora perduta’» (7). Per lei Dio discese nella persona di Simone; e un punto essenziale nel vangelo di quest’ultimo consiste precisamente nel dichiarare che la donna di malaffare proveniente da Tiro, che viaggiava con lui, era l’Ennoia caduta del Dio supremo, ossia di se stesso, e che la salvezza del mondo era legata alla redenzione di lei per opera sua. Dobbiamo aggiungere qui al racconto citato da Ireneo (et al.) che ogni «Egli» o «Suo» riferito al Padre divino era «Io», eccetera, nelle parole di Simone; cioè egli dichiarava se stesso il Dio del principio assoluto, «Colui che sta», e raccontava la generazione dell’Ennoia, la creazione degli angeli per mezzo di lei, e indirettamente persino la creazione non autorizzata del mondo attraverso loro, come suoi propri atti.
«Perciò [egli dice] egli venne, per prima cosa per risvegliare lei e liberarla dai suoi legami, e poi per portare la salvezza a tutti gli uomini per mezzo della conoscenza di lui. Poiché, siccome gli angeli governavano malamente il mondo, perché ciascuno di essi bramava la superiorità sugli altri, egli era venuto per raddrizzare le cose, ed era disceso trasformando e assimilando se stesso alle virtù, alle potenze e agli angeli, cosicché (eventualmente) egli apparve come uomo tra gli uomini, sebbene non fosse uno di essi, e si pensò che avesse patito in Giudea, sebbene non abbia patito». (Il riferimento a Gesù è più chiaramente specificato quando Simone asserisce che egli, la potenza suprema, è apparso in Giudea come Figlio, in Samaria come Padre e in altre nazioni come Spirito Santo.) La trasformazione del salvatore nella discesa attraverso le sfere è un motivo diffuso dell’escatologia gnostica, e Simone stesso ne dà la seguente descrizione secondo Epifanio:
«In ogni cielo ho assunto una forma differente, secondo la forma degli esseri in ogni cielo, per poter rimanere nascosto agli angeli che governavano e discendere fino all’Ennoia, che è chiamata anche Prunikos (8) e Spirito Santo, per mezzo della quale ho creato gli angeli, i quali a loro volta hanno creato il mondo e gli uomini» (Haer. XXI, 2, 4).
Per continuare il racconto di Ireneo:
«I profeti hanno pronunziato le loro profezie ispirati dagli angeli che hanno fatto il mondo; perciò coloro che hanno posto la loro speranza in lui stesso e nella sua Elena non hanno bisogno di farvi attenzione e possono fare liberamente quello che a loro piace. Perché gli uomini sono salvati dalla sua grazia, non dagli atti virtuosi. Perché le opere non sono buone (o cattive) per loro natura, ma per disposizione esterna: gli angeli che hanno fatto il mondo le decretano tali per mezzo di precetti di tal fatta allo scopo di asservire gli uomini. Perciò egli ha promesso che questo mondo sarebbe dissolto e che il suo mondo sarebbe liberato dal dominio di coloro che hanno fatto il mondo» (Iren., “Adv. Haer.” I, 23, 2-3).
L’Elena di Simone era anche chiamata “Selene” (Luna), appellativo che suggerisce la derivazione mitologica della figura dall’antica dea Luna (9). Ugualmente il numero di trenta discepoli ricordato nelle “Ricognizioni” indica un’origine lunare. Questo tratto, come vedremo in seguito, è rimasto nella speculazione dei Valentiniani intorno al pleroma, dove Sofia e il suo consorte sono gli ultimi due di trenta Eoni. Il fondamento per trasferire il tema lunare al simbolismo della salvezza sta nel decrescere e crescere della luna, che nell’antica mitologia della natura era a volte rappresentata come un ratto e un ritrovamento. Nella spiritualizzazione gnostica, «Luna» è semplicemente il nome esoterico della figura: il suo vero nome è Epinoia, Ennoia, Sofia e Spirito Santo. La sua rappresentazione come cortigiana è intesa a mostrare fino a quale profondità il principio divino è caduto dopo essere stato invischiato nella creazione.
Le controversie delle Pseudo-Clementine mettono in evidenza l’aspetto antigiudaico dell’insegnamento di Simone. Secondo tale fonte egli professa «una Potenza di incommensurabile e ineffabile luce, la cui grandezza sta nel fatto di essere mantenuta incomprensibile, la quale Potenza è sconosciuta persino al creatore del mondo, al legislatore Mosè e al vostro Maestro Gesù» (Recogn. II, 49) In questo contesto polemico egli scelse il più eccelso degli angeli, quello che creò il mondo e lo divise tra loro, e identificò questo capo con il Dio dei Giudei: delle settantadue nazioni della terra il popolo ebreo toccò in sorte a lui (loc. cit. 39) (10). Talvolta, tralasciando la figura dell’Ennoia, egli afferma semplicemente che questo demiurgo è stato mandato in origine dal Dio buono per creare il mondo, ma che in seguito ha stabilito se stesso come una divinità indipendente, ossia ha dato ad intendere di essere l’Altissimo ed ha trattenuto prigioniere nella creazione le anime che appartengono al Dio supremo (loc. cit. 57). Il fatto che quello che è detto altrove del rapimento dell’Ennoia sia riferito qui alla pluralità delle anime, mostra che l’Ennoia è l’anima in generale, come abbiamo già riscontrato, per esempio, nel Salmo dei Naasseni: la sua incarnazione nell’Elena di Tiro è un tratto aggiunto, caratteristico di Simone.
Per quanto riguarda il carattere del dio del mondo, Simone – come fece in seguito Marcione con particolare veemenza – dimostra la sua inferiorità in base alla creazione e ne determina la natura, in contrasto con la «bontà» del Dio trascendente, come qualità della «giustizia» intesa in senso deteriore, com’era la moda del tempo. (Ci soffermeremo più a lungo su tale contrasto quando tratteremo di Marcione.) Abbiamo già visto che l’antinomismo proveniente da tale interpretazione del dio del mondo e della sua legge porta direttamente al libertinismo, che troveremo in altri sistemi gnostici come una dottrina pienamente sviluppata.
Per concludere, riportiamo quello che Simone ha detto a Pietro circa la novità del suo insegnamento: «Tu in verità, come uno che sia continuamente stupefatto, per così dire chiudi le orecchie perché non possano essere contaminate dalla bestemmia e corri via, non trovando niente da replicare; e il popolo incapace di pensare acconsente e ti approva come uno che insegna ciò che è noto a loro: invece essi esecreranno me come uno che professa una novità mai udita» (loc. cit. 37).
Questo discorso suona troppo vero perché possa essere stato inventato da un oppositore come l’autore delle Clementine: dispute di tal genere devono in realtà aver avuto luogo, se non tra Simone e Pietro stesso, almeno tra qualcuno dei loro seguaci della prima o seconda generazione, e in seguito attribuite ai protagonisti principali. Qual era dunque la «novità mai udita»? In ultima analisi, niente altro che la professione di una potenza trascendente oltre il creatore del mondo, la quale può nello stesso tempo apparire nel mondo, anche nelle forme più vili, e, conosciutolo, può disprezzarlo. In breve, la novità mai udita è una rivolta contro il mondo e il suo dio nel nome di un’assoluta libertà di spirito.
Simone viaggiò dappertutto come un profeta, operatore di miracoli e mago, si direbbe, con molto ciarlatanismo. Le fonti esistenti naturalmente, essendo cristiane, non tracciano un ritratto molto simpatico del personaggio e delle sue gesta. Secondo esse, egli diede spettacolo anche alla corte imperiale di Roma e fece una brutta fine là mentre compiva il tentativo di volare (11). E’ interessante notare, sebbene ciò si ricavi da un contesto molto lontano dai nostri, come negli ambienti latini Simone usasse il cognome di “Faustus” («il fortunato»): questo dimostra chiaramente, insieme al fatto che il suo cognome abituale era «il Mago» ed era sempre accompagnato da un’Elena, da lui proclamata rinata Elena di Troia, che qui abbiamo una delle fonti della leggenda di Faust del principio del Rinascimento. Sicuramente pochi degli ammiratori delle opere di Marlowe e di Goethe hanno avuto sentore che il loro eroe è il discendente di una setta gnostica e che la bella Elena richiamata dalle sue arti è stata una volta il Pensiero di Dio, caduto e risorto, per mezzo del quale l’umanità doveva essere salvata (12).
NOTE AL CAPITOLO 3.
1. Egli presenta ciò che chiama «il più perfetto tipo di uomo in quella regione» con queste parole: «Ci sono molti che profetizzano alla leggera per qualunque causa fuori e dentro i templi; e ci sono di quelli che vanno in giro mendicando nelle città e nei campi militari; e pretendono di essere mossi come se dessero oracoli. E’ un’abitudine normale e comune che ognuno dica…», e qui segue il discorso citato.
2. Celso continua: «Dopo queste minacce essi aggiungono frasi incomprensibili, incoerenti e oscure il cui significato nessuna persona intelligente potrebbe scoprire, perché sono senza senso e danno la possibilità a qualsiasi pazzo o stregone di interpretarle nel modo che preferisce» (ORIGENE, “Contra Celsum”, VII, 9, trad. Chadwick, p.p. 402-403).
3. Simone è ingiustamente privato di una caratteristica originale e provocante, se si cerca, come ha fatto un autore contemporaneo, di considerare la prostituta come una calunnia o un malinteso dei primi scrittori cristiani (G. QUISPEL, “Gnosis als Weltreligion”, p. 69).
4. Prossimi a questa descrizione del primo stadio della divina moltiplicazione di sé sono alcuni testi mandei e nell’area greca la descrizione dell'”Apocrifo di Giovanni” (conservato nella traduzione copta). «Egli ‘pensò’ la propria immagine quando la vide riflessa nella pura acqua di Luce che Lo circondava. E il Suo Pensiero [“ennoia”] diventò efficace e si rese manifesto. Dallo splendore della Luce essa sorse e stette dinanzi a Lui: questa è la Potenza prima di tutte le cose che divenne manifesta; questa è la perfetta Premeditazione del Tutto, la Luce che è immagine della Luce, la sembianza dell’Invisibile… Essa è la prima Ennoia, la Sua immagine» (“Apocrifo di Giovanni”, 27, 1 s.s., Till).
5. Riassunto da Ippolito VI, 18. Nell’originale il racconto è molto più lungo è molto più involuto, e passa a una teoria fisica dell’universo molto elaborata. La Grande Esposizione non è certamente di Simone, e forse Ippolito fu tratto in inganno nell’attribuirla alla setta simoniana. Di fatto il solo legame con la dottrina simoniana quale è esposta in tutte le altre trattazioni è il «Pensiero» femminile di Dio, che tuttavia non è soggetto alla degradazione della storia di Elena. Se nonostante ciò ho incluso la speculazione iniziale della Grande Esposizione trattando di Simone, è perché questo esempio tipico della maniera gnostica di trattare concetti astratti in veste semimitologica doveva pur essere presentato, e l’attribuzione di Ippolito, giusta o errata, è stata la scusa per farlo qui.
6. Un richiamo del mito che descrive la nascita di Pallade Atena dalla testa di Zeus.
7. Iren. I, 23, 2, con l’inserzione di alcuni punti dai racconti paralleli delle “Omelie” (II, 25), di Ippolito (VI, 19) e di Tertulliano (“De anima”, cap. 34).
8. «La pruriente»: abitualmente nei testi gnostici nella connessione «Sophia-Prunikos», della quale parleremo più a lungo quando tratteremo la speculazione valentiniana.
9. Una certa speculazione mitologica greca pare abbia collegato l’Elena omerica con la luna, sia che tale associazione fosse suggerita dalla somiglianza di Helene e Selene, o dal suo fato (ratto e recupero) interpretato come mito della natura, o dal paragone omerico della sua figura con quella di Artemide. Un racconto afferma che l’uovo trovato da Leda era caduto dalla luna; e un tardo commentatore di Omero, Eustazio (sec. dodicesimo d.C.), ricorda che c’erano taluni che dicevano che Elena era caduta sulla terra dalla luna e che essa era stata ricondotta lassù quando la volontà di Zeus era stata compiuta. Quando e da chi ciò sia stato detto Eustazio non dice; né egli dice (o sottintende) che in tale forma del mito Elena servisse come simbolo dell'”anima”. Non è quindi permesso dedurre da questa testimonianza la conclusione che «già nell’antichità Elena era considerata come immagine dell’Anima caduta», come fa G. Quispel nella spiegazione della dottrina simoniana» (“Gnosis als Weltreligion”, p. 64 s.s.). Anche se ammesso, il punto proverebbe altrettanto poco contro la storicità della compagna terrena di Simone quanto il mito primitivo della morte e resurrezione di un dio contro la storicità di Cristo.
10. Questa idea si trova un po dappertutto nella letteratura gnostica, per esempio in Basilide.
11. Secondo almeno una fonte, tuttavia, questa fu un’ascensione tentata con l’intendimento di porre termine e compimento alla sua missione terrestre e annunziata con le parole: «Domani vi abbandonerò, empii e cattivi, e mi rifugerò presso Dio di cui sono il potere, anche se divento debole. Mentre voi siete caduti, ecco, io sono colui-che-sta. E ascendo al Padre e gli dirò: essi volevano far cadere anche me, Tuo Figlio l’Eretto, ma non ho avuto a che fare con loro, ma sono ritornato a me stesso» (“Actus Vercellensis”, 31). Pietro allora con una preghiera realmente «lo fece cadere» da mezz’aria, portando così a termine la sua carriera.
12. Confronta E. M. BUTLER, “The Myth of the Magus”, Cambridge University Press, 1948; “The Fortunes of Faust”, Cambridge University Press, 1952.
Capitolo 4.
«L’INNO DELLA PERLA».
Con la dottrina simoniana abbiamo dato un esempio di quella che può essere chiamata la gnosi siriaco-egiziana. Facciamo seguire un esempio introduttivo dell’altro tipo principale di speculazione gnostica, che per ragioni che spiegheremo in seguito chiameremo iranica. In senso stretto il testo scelto per una prima presentazione di questo tipo non è una composizione sistematica, ma poetica, la quale riveste di una favola, che apparentemente mette in azione attori umani, la parte centrale della dottrina iranica, e concentrandosi sulla parte escatologica del dramma divino ne trascura la prima parte, la cosmogonica. Si tratta tuttavia di un documento del sentimento e del pensiero gnostico così affascinante nella sua vivezza e nella sua sottile semplicità, che non si sarebbe potuta trovare un’introduzione migliore a questo genere di gnosi. La parte più teorica, cosmogonica, della dottrina iranica sarà presentata in seguito nel capitolo sull’insegnamento di Mani. Dopo la sfrontatezza calcolata di Simon Mago, la commovente tenerezza della poesia seguente porterà una nota di forte contrasto.
Il cosiddetto «Inno della Perla» si trova negli Atti apocrifi dell’apostolo Tommaso, una composizione gnostica conservata con rielaborazioni ortodosse di poco rilievo: il testo stesso dell’Inno ne è completamente privo. «Inno della Perla» è il titolo dato dai traduttori moderni: negli Atti invece è chiamato «Canto dell’apostolo Giuda Tommaso nella terra degli Indiani» (1). In considerazione dell’intenzione didattica e della forma narrativa della composizione poetica, «inno» non è forse del tutto esatto. Esiste col rimanente degli Atti in una versione siriaca ed una greca; quella siriaca è quella originale (o una immediata discendente dell’originale, che era senza dubbio siriaco).
Nella nostra traduzione, basata specialmente sul testo siriaco, trascureremo le divisioni metriche e renderemo il testo come se fosse una prosa narrativa.
a) Il testo.
«Quando ero bambino e abitavo nel regno della casa di mio Padre e mi dilettavo della ricchezza e dello splendore di coloro che mi avevano allevato, i miei genitori mi mandarono dall’oriente, nostra patria, con le provviste per il viaggio (2). Delle ricchezze della nostra casa fecero un carico per me: esso era grande, eppure leggero, in modo che potessi portarlo da solo… (3). Mi tolsero il vestito di gloria che nel loro amore avevano fatto per me, e il manto di porpora che era stato tessuto in modo che si adattasse perfettamente alla mia persona (4), e fecero un patto con me e lo scrissero nel mio cuore perché non lo potessi scordare: ‘Quando andrai in Egitto e ne riporterai l’Unica Perla che giace in mezzo al mare, accerchiata dal serpente sibilante, indosserai di nuovo il tuo vestito di gloria e il manto sopra di esso, e con tuo fratello, prossimo a noi in dignità, sii erede nel nostro regno’.
Lasciai l’Oriente e m’avviai alla discesa, accompagnato da due messi reali, poiché il cammino era pericoloso e difficile ed io ero troppo giovane per un tale viaggio; oltrepassai i confini di Maishan, punto d’incontro dei mercanti dell’Oriente, giunsi nella terra di Babel ed entrai nelle mura di Sarburg. Scesi in Egitto e i miei compagni mi lasciarono. Mi diressi deciso al serpente e mi stabilii vicino alla sua dimora in attesa che si riposasse e dormisse per potergli prendere la Perla. Poiché ero solo e me ne stavo in disparte, ero forestiero per gli abitanti dell’albergo. Pure vidi là uno della mia razza, un giovane leggiadro e bello, figlio di re [lett.: ‘di coloro che sono unti’]. Egli venne e si unì a me; io lo accolsi familiarmente e con fiducia e gli raccontai della mia missione. Io [egli?] lo [me?] avvertii di guardarsi dagli Egiziani e di evitare il contatto con gli impuri. Tuttavia mi vestii con i loro abiti, perché non sospettassero di me, che ero venuto da fuori per prendere la Perla, e non risvegliassero il serpente contro di me. Ma in qualche modo si accorsero che non ero uno di loro e cercarono di rendersi graditi a me; mi mescerono nella loro astuzia [una bevanda], e mi dettero da mangiare della loro carne; e io dimenticai che ero figlio di re e servii il loro re. Io dimenticai la Perla per la quale i miei genitori mi avevano mandato. Per la pesantezza del loro cibo caddi in un sonno profondo.
I miei genitori avevano notato tutto quello che mi accadeva ed erano afflitti per me. Fu proclamato nel nostro regno che tutti dovevano presentarsi alle nostre porte. E i re e i grandi della Partia e tutti i nobili dell’Oriente formarono un piano perché io non fossi lasciato in Egitto. E mi scrissero una lettera firmata col nome di ciascuno dei grandi.
‘Da tuo padre, il re dei re, e da tua madre, signora dell’Oriente, e da tuo fratello, nostro prossimo di rango, a te nostro figlio in Egitto, salute. Svegliati e sorgi dal tuo sonno, e intendi le parole della nostra lettera. Ricordati che sei figlio di re: guarda chi hai servito in schiavitù. Poni mente alla Perla per la quale sei partito per l’Egitto. Ricordati del vestito di gloria, richiama il manto splendido, per indossarli e adornarti con essi, e il tuo nome possa essere letto nel libro degli eroi e tu divenga con tuo fratello, nostro delegato, erede nel nostro regno’.
Come un messaggero era la lettera che il Re aveva sigillato con la mano destra contro i malvagi, i figli di Babel e i demoni ribelli di Sarburg. Si levò in forma di aquila, il re di tutti gli alati, e volò finché discese vicino a me e divenne interamente parola. Al suono della sua voce mi svegliai e mi destai dal sonno; la presi, la baciai, ruppi il sigillo e lessi. Conformi a quanto era stato scritto nel mio cuore si potevano leggere le parole della mia lettera. Mi ricordai che ero figlio di re e che la mia anima, nata libera, aspirava ai suoi simili. Mi ricordai della Perla per la quale ero stato mandato in Egitto e cominciai ad incantare il terribile serpente sibilante. Lo indussi al sonno invocando su di lui il nome di mio Padre, il nome del nostro prossimo in rango e quello di mia madre, la regina dell’Oriente. Presi la Perla e mi volsi per tornare a casa da mio Padre. Mi spogliai del loro vestito sordido e impuro e lo abbandonai nella loro terra; diressi il mio cammino onde giungere alla luce della nostra patria, l’Oriente.
Trovai la lettera che mi aveva ridestato davanti a me sul mio cammino; e come mi aveva svegliato con la sua voce, ora mi guidava con la sua luce che brillava dinanzi a me; e con la voce incoraggiava il mio timore e col suo amore mi traeva. E andai avanti… (5) I miei genitori… mandarono incontro a me a mezzo dei loro tesorieri, a cui erano stati affidati, il vestito di gloria che avevo tolto e il manto che doveva coprirlo. Avevo dimenticato il suo splendore, avendolo lasciato da bambino in casa di mio Padre. Mentre ora osservavo il vestito, mi sembrò che diventasse improvvisamente uno specchio-immagine di me stesso: mi vidi tutto intero in esso ed esso tutto vidi in me, cosicché eravamo due separati, eppure ancora uno per l’uguaglianza della forma… (6) E l’immagine del Re dei Re era raffigurata dappertutto su di esso… E vidi anche vibrare dappertutto su di esso i movimenti della gnosi. Vidi che stava per parlare e percepii il suono delle canzoni che mormorava lungo la discesa: ‘Sono io che ho agito nelle azioni di colui per il quale sono stato allevato nella casa di mio Padre, ed ho sentito in me stesso che la mia statura cresceva in corrispondenza delle sue fatiche’. E con i suoi movimenti regali si offerse tutto a me e dalle mani di quelli che lo portavano si affrettò perché potessi prenderlo; e anch’io ero mosso dall’amore a correre verso di esso per riceverlo. E mi protesi verso di lui, lo presi, e mi avvolsi nella bellezza dei suoi colori. E gettai il manto regale intorno a tutta la mia persona. Così rivestito, salii alla porta della salvezza e dell’adorazione. Inchinai la testa e adorai lo splendore di mio Padre che me lo aveva mandato, i cui comandi avevo adempiuto perché anch’egli aveva mantenuto ciò che aveva promesso… Mi accolse gioiosamente ed ero con lui nel suo regno, e tutti i suoi servitori lo lodarono con voce di organo, cantando che egli aveva promesso che avrei raggiunto la corte del Re dei Re e avendo portato la mia Perla sarei apparso insieme a lui».
b) Commento.
L’incanto immediato di questo racconto è tale che commuove il lettore ancor prima di qualsiasi analisi di significato. Il mistero del messaggio trasmesso parla di per sé, in modo tale che ci si potrebbe quasi astenere da un’interpretazione particolareggiata. Forse in nessun altro testo l’esperienza gnostica fondamentale è espressa in termini così commoventi e così semplici. Tuttavia il racconto è simbolico nell’insieme ed impiega simboli nelle varie parti, perciò sia il simbolismo globale sia gli elementi che lo compongono richiedono di essere spiegati. Inizieremo da questi ultimi.
– Serpente, mare, Egitto.
Se diamo per scontato che la casa del Padre nell’Oriente è la dimora celeste e spostiamo la questione al significato della Perla, sono da spiegare i simboli dell’Egitto, del serpente e del mare. Incontriamo qui il serpente per la seconda volta nel mondo gnostico di immagini (v. sopra, cap. 2, o, p. 109 in nero); ma a differenza del significato che aveva nelle sètte degli Ofiti, per le quali esso era un simbolo pneumatico, assume qui il significato di reggitore e principio malvagio di questo mondo, nella forma del dragone del caos originario, circondante la terra. La “Pistis Sophia” (cap. 126, p. 207, Schmidt) dice: «La tenebra esterna è un immenso dragone la cui coda è nella sua bocca». Gli Atti stessi, in un passo non compreso nell’inno, offrono una descrizione più particolareggiata di questa figura per bocca di uno dei suoi figli-dragoni:
«Sono progenie del serpente-natura e figlio di un corruttore. Sono figlio di colui che… siede sul trono e ha il dominio su tutta la creazione al di sotto dei cieli,… che circonda le sfere,… che è all’esterno (intorno) dell’oceano, la cui coda sta nella sua bocca» (par. 32).
Si trovano molti parallelismi, nella letteratura gnostica, che si riferiscono a questo secondo significato del serpente. Origene nella sua opera “Contra Celsum” (VI, 25, 35) descrive il cosiddetto «diagramma degli Ofiti», dove i sette cerchi di Arconti sono posti in un cerchio più ampio che è chiamato il Leviatan, il grande dragone (non identico, naturalmente, al «serpente» del sistema), e chiamato anche “psyche” (qui «anima del mondo»). Nel sistema mandeo questo Leviatan è chiamato Ur ed è il padre dei Sette. L’archetipo mitologico di tale figura è la babilonese Ti’amat, il mostro del caos ucciso da Marduk nella storia della creazione. Il parallelo gnostico più vicino al nostro racconto va ricercato nel testo ebraico apocrifo, gli Atti di Ciriaco e Giulitta (confronta REITZENSTEIN, “Das iranische Erlösungsmysterium”, p. 77), dove la preghiera di Ciriaco riferisce, anche in prima persona, come l’eroe mandato da sua Madre nella terra straniera, la «città delle tenebre», dopo lungo vagabondare e dopo esser passato attraverso le acque dell’abisso, incontra il dragone, il «re dei vermi della terra, la cui coda è nella sua bocca. Questo è il serpente che ha fuorviato gli angeli per mezzo delle passioni, allontanandoli dall’alto; questo è il serpente che ha condotto fuori strada il primo Adamo e lo ha scacciato dal Paradiso…» (7). Anche qui una mistica lettera lo salva dal serpente e gli fa adempiere la sua missione.
Il “mare” o le “acque” sono un simbolo gnostico fisso per il mondo della materia o delle tenebre nel quale è immerso il divino. Così i Naasseni interpretavano nel modo seguente il Salmo 29, 3 e 10, sul Dio che abita gli abissi e la cui voce echeggia sopra le acque: «Le molte acque rappresentano il mondo multiforme della generazione mortale nel quale è affondato il dio uomo e dalla cui profondità egli invoca il Dio supremo, l’Uomo Primordiale, il suo modello originale non caduto» (Ippol. V, 8, 15). Abbiamo citato (cap. 3, p. 122 in nero) la divisione data da Simone dell’Unico in colui che «sta sopra, nella Potenza increata» e in colui che «stette sotto nella corrente delle acque, generato nell’immagine». I Perati interpretavano il Mar Rosso, che doveva essere attraversato andando o tornando dall’Egitto, come «l’acqua della corruzione» e lo identificavano con Kronos, cioè il «tempo» e il ««divenire» (ibid. 16, 5). Nel testo mandeo “Ginza di Sinistra” III leggiamo: «Io sono un grande Mana… che abitava nel mare… finché ali mi furono allestite ed io mi innalzai al luogo della luce». Il quarto libro apocrifo di Esdra, un’apocalisse, riporta nel cap. 13 una visione impressionante dell’Uomo che vola in alto «dalle profondità del mare». In questo contesto va pure ricordato il simbolismo del pesce nel cristianesimo primitivo.
L’Egitto come simbolo del mondo materiale è molto comune nello gnosticismo (e fuori di esso). La storia biblica della schiavitù e della liberazione d’Israele si prestava magnificamente a quel tipo d’interpretazione spirituale che piaceva agli Gnostici. Ma la storia biblica non è l’unico riferimento che vedeva l’Egitto nella sua funzione allegorica. Fin dai tempi antichi l’Egitto era stato considerato come la sede del culto dei morti e perciò il regno della Morte; questo ed altri aspetti della religione egiziana, quali i suoi dèi con la testa di bestia e la grande parte che vi aveva la magia, ispirarono agli Ebrei e più tardi ai Persiani un particolare orrore e li portarono a considerare l’«Egitto» come la personificazione di un principio demoniaco. Gli Gnostici allora si valsero di questa concezione per fare dell’Egitto un simbolo di «questo mondo», cioè il mondo della materia, dell’ignoranza e di una religione perversa: «Tutti gli ignoranti [ossia coloro che sono privi di gnosi] sono ‘Egiziani’», afferma un detto peratico citato da Ippolito (V, 16, 5).
Abbiamo notato precedentemente che in generale i simboli del mondo possono servire come simboli del corpo e viceversa; ciò è vero anche per i tre che abbiamo appena esaminato: «mare» e «dragone» talvolta indicano negli scritti mandei il corpo, e circa «l’Egitto» i Perati, per i quali ugualmente esso significa il «mondo», dicevano anche che «il corpo è un piccolo Egitto» (Ippol. V, 16,5; parimente i Naasseni, ibid. 7, 41).
– Il vestito impuro.
Che lo straniero indossi le vesti degli Egiziani appartiene al simbolismo generale della «veste» che abbiamo esaminato nel cap. 2, d (p. 76 in nero). La ragione addotta qui, di rimanere sconosciuto agli Egiziani, collega quel simbolismo con un tema che si ritrova dappertutto nello gnosticismo in numerose varianti: il salvatore viene nel mondo sconosciuto ai suoi governanti, assumendo di volta in volta le loro stesse forme. Abbiamo trovato tale dottrina in Simon Mago, collegata al passaggio attraverso le sfere. In un testo mandeo leggiamo: «Mi sono nascosto ai Sette, mi sono imposto di assumere una forma corporea» (G 112). Di fatto questo tema unisce due idee differenti, quella dell’inganno per il quale gli Arconti sono superati, e quella della necessità sacrificale imposta al salvatore di «rivestirsi dell’afflizione dei mondi» per esautorare i poteri del mondo, cioè come parte del meccanismo stesso della salvezza. E se analizziamo da vicino il nostro testo, vediamo che il Figlio del Re in realtà non ha altra scelta che indossare le vesti terrestri, avendo lasciato le sue proprie nel regno superiore. E’ anche evidente, e nonostante la sua paradossalità fa parte della logica del processo stesso, che la familiarità con gli «Egiziani» resa possibile da questo scambio di vesti elude in certa misura il proposito di sorveglianza sul messaggero facendolo partecipe del loro mangiare e bere. Gli Egiziani, sebbene non riconoscano la sua origine o la sua missione (nel qual caso avrebbero eccitato contro di lui il dragone), intuiscono la differenza che esiste tra lui e loro stessi e sono ansiosi di renderlo uno di loro. Essi riescono proprio perché il suo nascondimento è riuscito: ossia il suo aver assunto un corpo. Perciò lo stratagemma di nascondersi ai poteri cosmici diventa per necessità causa di alienazione di sé e mette a repentaglio l’intera missione. Ciò fa parte della situazione divina: la condizione necessaria per il successo del salvatore comporta al tempo stesso il più grande pericolo di fallimento.
– La lettera.
Le tribolazioni del messaggero e il suo temporaneo soccombere sono descritti nelle metafore di sonno e ubriachezza delle quali abbiamo parlato al cap. 2 (v. «Torpore, sonno, ebbrezza»). Il suo ritorno alla coscienza per opera della voce della lettera fa parte del linguaggio figurato collegato alla «chiamata» (v. «La ‘chiamata dal di fuori’», cap. 2, k). La «lettera» in particolare è il tema dell’intera Ode ventitreesima, una delle Odi apocrife di Salomone, della quale riportiamo qui una stanza.
«Il suo piano di salvezza è divenuto simile ad una lettera,
la sua volontà è discesa dall’alto
e fu mandata come una freccia
che è scoccata con forza dall’arco.
Molte mani si tesero verso la lettera
per afferrarla, per prenderla e leggerla;
ma essa sfuggì dalle loro dita.
Essi ne ebbero timore e del sigillo su di essa,
non avendo il potere di rompere il sigillo,
perché la forza del sigillo era più forte di loro» (5-9).
E’ da osservare che i Mandei, invertendo la direzione, hanno chiamato l'”anima” che parte dal corpo «una lettera ben sigillata inviata fuori del mondo il cui segreto nessuno conosceva… l’anima vola e procede per la sua strada…» (“Mandäische Liturgien”, p. 111). Ma più frequentemente la lettera è la personificazione della chiamata che viene “nel” mondo e raggiunge l’anima addormentata quaggiù, e ciò è causa di un curioso gioco di contrappunto semantico nel contesto del nostro racconto. Nel simbolismo gnostico colui che chiama è il messaggero, e colei che è chiamata è l’anima addormentata. Qui tuttavia il dormiente chiamato è egli stesso il messaggero e la lettera perciò ha una doppia funzione, come il messaggero del resto fa anche la parte del tesoro divino che egli è venuto a ricuperare in questo mondo. Se a ciò aggiungiamo lo sdoppiamento della figura del messaggero nel suo vestito celestiale, il suo specchio-immagine col quale è riunito al compimento della sua missione, comprendiamo qualche cosa della logica di quella corrente di simbolismo escatologico che abbiamo racchiuso nell’espressione «il salvatore salvato».
– La vittoria sul serpente e l’ascesa.
La maniera in cui il messaggero vince il serpente e gli porta via il tesoro è appena narrata nel nostro testo. Esso afferma semplicemente che il serpente viene addormentato, ossia prova quello che il messaggero aveva provato prima. Ciò che qui è attribuito per accenni ad un incantesimo, in altre fonti è spiegato col fatto che la Luce è un veleno per le Tenebre quanto le Tenebre sono veleno per la Luce. Così nella cosmogonia manichea l’Uomo Primordiale, vedendo la sua imminente sconfitta nell’incontro con le forze delle Tenebre, «dà se stesso e i suoi cinque figli come nutrimento ai cinque figli delle Tenebre, come un uomo che ha un nemico mescola un veleno mortale in una focaccia e gliela dà» (secondo Teodoro bar Konai). Con questo mezzo sacrificale il furore delle Tenebre è di fatto «placato». E’ evidente la connessione del motivo gnostico del salvatore con l’antico mito naturistico del sole: il tema dell’eroe che si lascia divorare dal mostro e lo vince dall’interno è largamente diffuso nella mitologia ovunque. Se ne può notare la trasposizione dalla religione della natura al simbolismo della salvezza nel mito della vittoria di Cristo sull’inferno, che in realtà appartiene ad una dottrina dualistica e difficilmente si può dire di origine cristiana. Nelle “Odi di Salomone” leggiamo:
«L’inferno mi guardò e s’avvalì: la Morte mi vomitò e molti con me: fiele e veleno io fui per lui, e discesi con lui fino alle sue estreme profondità: i suoi piedi e la sua testa divennero senza forza…» (Ode XLII, 11-13).
I Mandei hanno conservato più alla lettera la forma originaria, non spiritualizzata, del mito. Nel loro trattato principale sulla discesa del salvatore nei mondi inferi, Hibil, il dio-salvatore, così descrive la sua avventura:
«Karkûm, la grande montagna di carne, mi disse: ‘Vattene, o ti divorerò’. Quando mi disse questo, ero in una custodia di spade, sciabole, lance, coltelli e lame, e gli dissi: ‘Divorami’. Allora… mi ingoiò per metà: quindi mi vomitò… Egli vomitò veleno dalla sua bocca, perché i suoi visceri, il fegato e i reni erano stati fatti a pezzi» (G 157).
L’autore dell’Inno evidentemente non aveva interesse per simili crudezze.
L’ascesa inizia con l’abbandono delle vesti impure (8) ed è guidata e incitata dalla lettera, che è insieme luce e voce. Essa ha perciò la funzione attribuita alla Verità in un passo parallelo tratto dalle “Odi di Salomone”:
«Sono salito alla luce come portato sul carro della Verità,
la verità mi ha guidato e condotto.
Essa mi ha portato al di sopra di crepacci e abissi
e mi ha trasportato in alto al di là di gole e vallate.
E’ divenuta per me un porto di salvezza
e mi ha messo nelle braccia della vita eterna»
(Ode XXXVIII, 1-3).
Nel nostro racconto tuttavia la guida della lettera finisce a quello che possiamo chiamare il culmine dell’ascesa, l’incontro del figlio che ritorna con la sua veste. Simbolo affascinante, che richiede uno speciale commento.
– La veste celeste; l’immagine.
Nella liturgia mandea dei Morti leggiamo questa formula tipica: «Vado incontro alla mia immagine e la mia immagine viene ad incontrarmi: mi accarezza e mi abbraccia come se io ritornassi dalla prigionia» (per esempio, in G 559). La concezione deriva da una dottrina dell’Avesta (9) secondo la quale dopo la morte di un credente «la sua coscienza religiosa appare alla sua anima sotto forma di una bella fanciulla» e risponde alla domanda chi essa sia:
«O giovane di buoni pensieri, buone parole, buone azioni, buona coscienza, io non sono altro che la tua propria coscienza personale… Tu mi hai amato… in questa sublimità, bontà, bellezza… nella quale ora ti apparisco» (“Hadokht Nask” 2, 9 s.s.).
La dottrina fu ripresa dai Manichei: confronta il F 100 dei frammenti di Turfan, dove è detto che dopo la morte viene incontro all’anima la veste, la corona (e altri emblemi) e «la vergine simile all’anima del fedele». Nella genealogia copto-manichea degli dèi troviamo tra le divine emanazioni la «figura di luce che viene incontro al morente» chiamata anche «l’angelo con la veste di luce». Nel racconto che abbiamo riportato la veste diventa questa figura stessa e agisce come una persona. Essa simbolizza l’io celeste o eterno della persona, l’idea originaria, una specie di doppio o “alter ego” preservato nel mondo superiore, mentre essa si affatica quaggiù: come dice un testo mandeo, «la sua immagine è mantenuta sana e salva al suo posto» (G 90). Cresce con le sue azioni e la sua forma è perfezionata dalle fatiche (10). La sua pienezza segna l’adempimento del suo compito e quindi la sua liberazione dall’esilio del mondo. Perciò l’incontro con questo aspetto sdoppiato dell’io, il riconoscimento di esso come propria immagine e la riunione con esso significano il vero momento della salvezza. Tale concezione, applicata come in questo caso e in altri ancora al messaggero o salvatore, conduce all’interessante idea teologica di un fratello gemello o originale eterno del salvatore che rimane nel mondo superiore durante la sua missione terrena. Duplicati di questo genere abbondano nella speculazione gnostica in rapporto alle figure divine in genere, ovunque la loro funzione richieda un distacco dal regno divino e un mescolarsi agli eventi del basso mondo.
Per quel che riguarda l’interpretazione del nostro testo, le precedenti considerazioni suggeriscono con evidenza che il Secondo («prossimo in dignità»), del quale è detto ripetutamente che sta con i suoi genitori e col quale il Figlio del Re sarà erede nella casa del Padre, è un altro di tali duplicati e, di fatto, una sola cosa con la veste: egli non è più menzionato proprio quando ci si aspetterebbe di vederlo menzionato, ossia dopo il ritorno trionfante dello straniero. Nella riunione di quest’ultimo con la sua veste, la figura del fratello sembra essere stata riassorbita nell’unità.
– L’io trascendentale.
Come abbiamo visto, il «doppio» del salvatore non è che una rappresentazione teologica particolare di un’idea riguardante la dottrina dell’uomo in genere e contrassegnata dal concetto dell’io. In tale concetto possiamo discernere ciò che forse è il contributo più profondo della religione persiana allo gnosticismo e alla storia delle religioni in genere. La Parola Avesta è “daena”, per la quale l’orientalista Bartholomae annota i seguenti significati: «1. religione, 2. essenza interna, io spirituale, individualità; spesso quasi intraducibile» (11).
Nei frammenti manichei del Turfan è usata un’altra parola, “grev”, che può tradursi sia con «sé» che con «ego». Indica la persona metafisica, il vero soggetto trascendente della salvezza, che non è identico all’anima empirica. Nel trattato manicheo cinese tradotto da Pelliot, è anche chiamata «la natura luminosa», «la nostra originaria natura luminosa», o «natura interiore» che richiama «l’uomo interiore» di san Paolo; gli inni manichei la chiamano il «sé vivente» o il «sé luminoso». Il «Mana» mandeo esprime la stessa idea e rende particolarmente chiara l’identità tra questo principio interiore e la divinità suprema; infatti «Mana» è il nome della Potenza transmondana di Luce, la prima divinità, e nello stesso tempo è quello del centro non-mondano, trascendente dell’ego individuale (12). La stessa identità è espressa dall’uso naasseno del nome «Uomo» o «Adamo» per indicare il Dio supremo e il suo corrispondente caduto nel mondo.
Nel Nuovo Testamento, specialmente in san Paolo, questo principio trascendente dell’anima umana è chiamato «spirito» (“pneuma”), «lo spirito in noi», «l’uomo interiore», e in senso escatologico anche «l’uomo nuovo». E’ significativo che Paolo, il quale scriveva in greco e non ignorava certamente la terminologia greca, non usi mai in questo senso il termine “psyche”, che pure fin dal tempo degli Orfici e di Platone aveva significato il principio divino in noi. Al contrario egli “oppone”, come fecero gli scrittori gnostici greci dopo di lui, «anima» e «spirito», «uomo psichico» (13) e «uomo pneumatico». Evidentemente il significato greco di “psyche”, nonostante tutta la sua dignità, non era sufficiente ad esprimere la nuova concezione di un principio che trascende ogni associazione umana e cosmica, inerente al concetto greco. Il termine “pneuma” è usato in genere nello gnosticismo greco come equivalente dell’espressione «sé» spirituale, per il quale il greco, a differenza di alcune lingue orientali, manca di un termine proprio. In tale funzione lo troviamo impiegato nella cosiddetta Liturgia di Mitra con aggettivi quali «santo» e «immortale», in contrasto a “psyche” o «potere umano psichico». L’alchimista Zosimo usa «il nostro “pneuma” luminoso», «l’uomo interiore pneumatico», eccetera. In alcuni gnostici cristiani è anche chiamato «scintilla» e «seme di luce».
E’ tra questo principio nascosto della persona terrestre e il suo originale celeste che ha luogo il riconoscimento e la definitiva riunione. Perciò nel nostro racconto la funzione della veste come forma celestiale dell’io invisibile, perché temporaneamente oscurato, è una delle rappresentazioni simboliche di una dottrina largamente diffusa ed essenziale allo gnosticismo. Non è esagerato affermare che la scoperta nell’uomo di questo principio interiore trascendente e del supremo interesse riguardo del suo destino è il vero centro della religione gnostica.
– La Perla.
Il che ci riporta alla nostra ultima domanda: Qual è il significato della Perla? La risposta a tale questione determina anche il significato della storia nel suo insieme. E’ facile rispondere alla questione, come particolare mitografico. Nel glossario del simbolismo gnostico «perla» è una delle metafore fisse per «anima» nel senso soprannaturale. Il termine perciò lo si poteva includere nella lista dei termini equivalenti, di cui abbiamo trattato nell’elenco precedente. Tuttavia è più un nome segreto che un termine chiaro di quell’enumerazione; e inoltre sta in una categoria a sé perché sottolinea un aspetto particolare, o condizione metafisica, di quel principio trascendente. Mentre quasi tutte le altre espressioni possono ugualmente applicarsi alla divinità integra e alla sua parte caduta, la «perla» indica in modo speciale quest’ultima nel destino che l’ha colpita. La «perla» è essenzialmente la perla «perduta» e che deve essere ricuperata. Il fatto che la perla è racchiusa in un guscio animale ed è nascosta nel profondo può essere stato tra le associazioni di idee che in origine suggerirono l’immagine.
I Naasseni, interpretando a loro modo “Matteo” 7, 6, chiamarono «discernimenti, intelligenze e uomini» (ossia gli elementi «viventi» del cosmo fisico) «le perle di quell’Uno senza Forma costretto nella forma [cioè il corpo]» (Hippol., “Refut.” V, 8, 32). Quando ci si rivolge all’anima come «perla» (come avviene in un testo del Turfan), è per ricordarle la sua origine, ma anche per accentuare il suo pregio agli esseri celestiali che la ricercano, e per mettere in contrasto il suo valore con l’indegnità di quello che ora la circonda, il suo splendore con le tenebre nelle quali è immersa. L’appellativo è usato dallo «Spirito» come apertura del suo messaggio di salvezza. Nel testo a cui abbiamo accennato, lo Spirito continua chiamando l’anima un «re», a causa del quale è stata mossa guerra in cielo e in terra e per il quale sono stati mandati dei messaggeri.
«E per causa tua gli dèi sono usciti, sono apparsi e hanno distrutto la Morte e ucciso le Tenebre… E sono venuto io che libererò dal male… E aprirò dinanzi a te le parole in ciascun cielo… e ti mostrerò il Padre, il Re in eterno, e ti guiderò dinanzi a lui in una veste pura» (14).
Ora, se questo è il messaggio rivolto alla Perla, il lettore, ricordando la narrazione degli “Atti di Tommaso”, sarà colpito dal fatto che questo è anche il messaggio indirizzato a colui che partì per ricuperare la Perla: anche lui lo si rassicura che gli «dèi», i grandi nel regno di suo Padre, si preoccupano della sua liberazione, anche a lui viene ricordata la sua origine regale, e anche lui è guidato in alto dalla «lettera», cioè lo Spirito o la Verità; infine anche lui è condotto dinanzi al Padre con vesti pure. In altre parole, il destino del messaggero ha tirato a sé tutte le caratteristiche che potrebbero adeguatamente descrivere il destino della Perla, mentre nell’inno la Perla stessa rimane un puro oggetto e come tale non è punto descritta. Qui essa è talmente solo simbolo di un compito dalla cui esecuzione dipende il destino stesso del messaggero, che essa è quasi del tutto dimenticata nella storia del suo ritorno, e della sua consegna al Re si fa appena cenno. Perciò, se il nostro inno è talvolta chiamato «L’Inno dell’Anima», sembra che il contenuto giustifichi tale designazione solo nella figura del Principe: qualunque cosa abbia da dire circa la condizione e il destino dell’anima, lo dice per mezzo della “sua” esperienza. Il che ha portato alcuni interpreti a ritenere che la Perla stia qui semplicemente per il «sé» o la «vita buona» che l’inviato deve trovare nel suo viaggio terreno, essendo tale viaggio una prova alla quale egli è sottoposto per far prova di sé: il che significa che egli stesso, e non la Perla, rappresenta «l’anima» in genere, e che il viaggio non è stato intrapreso a causa della Perla, ma per se stesso. In questo caso, la Perla, oggetto della ricerca, non avrebbe una posizione propria, indipendentemente dalla ricerca: sarebbe piuttosto un’espressione di quest’ultima, che può pertanto essere designata come «autointegrazione».
Per quanto tale interpretazione sembri essere convalidata dal simbolismo del vestito celeste che cresce con le azioni del viaggiatore, eccetera, il significato allegorico della Perla è troppo saldamente stabilito nel mito gnostico (15) per poter essere dissolto in una funzione puramente morale; e come indubbiamente le esperienze del messaggero possono essere sostituite da quelle della Perla, se essa sta a rappresentare l’anima, altrettanto indubbiamente il recupero della Perla è la principale preoccupazione degli Esseri celesti, che suggeriscono la missione del Figlio con i pericoli personali, altrimenti non necessari. La Perla è un’entità nel suo pieno diritto; essa cadde in potere delle Tenebre prima dell’invio del Principe e per essa egli è pronto ad assumersi il peso della discesa e dell’esilio, e con ciò a riprodurre inevitabilmente alcune caratteristiche del destino della «perla».
In realtà, il problema degli interpreti, ossia l’intercambiabilità del soggetto e dell’oggetto della missione, del salvatore e dell’anima, del Principe e della Perla, è la chiave del vero significato della composizione e dell’escatologia gnostica in generale. Possiamo ritenere con certezza che il Figlio del Re è il Salvatore, una figura divina ben precisa, e non soltanto la personificazione dell’anima umana in generale. Tuttavia questa posizione specifica non gli impedisce di soffrire nella propria persona il destino umano in tutta la sua pienezza, fino al punto che egli stesso, il salvatore in persona, deve essere salvato. E invero questa è la condizione imprescindibile dalla sua funzione salvifica. Poiché le particelle della divinità disperse nelle tenebre possono essere recuperate soltanto nell’abisso in cui sono state inghiottite; e il potere che le trattiene, quello del mondo, può essere vinto soltanto dall’interno. Ciò significa che il dio-salvatore deve rendersi simile alle forme dell’esistenza cosmica e quindi assoggettarsi alle sue condizioni. Il lettore cristiano non deve confondere questa necessità con l’interpretazione ortodossa della passione di Cristo. Poiché la concezione gnostica della salvezza non ha nulla a che fare con la remissione del peccato («il peccato» stesso non ha senso nella dottrina gnostica, la quale mette al suo posto «l’ignoranza»), non vi è nella discesa del salvatore niente della sofferenza vicaria, dell’espiazione come condizione del perdono divino e, con la sola eccezione di Marcione, nulla neppure di un riscatto mediante il quale le anime prigioniere possano essere liberate. Piuttosto l’idea è quella o di una necessità tecnica imposta dalle condizioni della missione, cioè la natura del sistema lontano dal regno divino nel quale il messaggero deve penetrare e le cui leggi egli non può infrangere per se stesso, o quella di un’astuzia mediante la quale gli Arconti debbano essere ingannati. In quest’ultima interpretazione, la sofferenza o la temporanea sconfitta del salvatore può non essere affatto reale, ma solo apparente e parte dell’inganno (16). Non è questo naturalmente il caso del nostro inno, in cui la condizione dello straniero è del tutto reale. Tuttavia anche qui le sofferenze del salvatore sono una conseguenza degli inevitabili pericoli della sua missione e non parte del suo significato reale. In altre parole, esse mettono a repentaglio il successo della sua missione e sono superate in modo trionfale, mentre nel contesto cristiano le sofferenze sono il vero e proprio “mezzo” e “maniera” dell’adempimento della missione. Tenendo ben presente questa fondamentale differenza, possiamo pur dire che secondo il nostro inno nella discesa del salvatore vi è un elemento sacrificale, in quanto egli accetta, per amore della Perla, di sobbarcarsi a un destino di esilio e di ripetere nella sua persona la storia di quella che egli è venuto a redimere: l’Anima.
Se inoltre abbiamo ragione di vedere nel Figlio del Re certi aspetti dell’Uomo Primordiale della dottrina manichea, egli ripete pure il destino di quella divinità pre-cosmica nella quale ha avuto origine l’attuale condizione dell’Anima, cioè della Perla. Invero, come vedremo quando giungeremo ad esaminare la cosmogonia manichea, tutte queste fasi successive e analoghe del dramma del mondo, nonostante il loro significato cosmico, simbolizzano pure i patimenti e i trionfi dell’anima umana. In particolare il riferimento all’Uomo Primordiale ci fornisce un anello di congiunzione definitiva nella soluzione del nostro enigma. Non per nulla una divinità eterna pre-cosmica (e mediatamente cosmogonica) porta il nome «Uomo»: le anime disperse nel mondo sono la sua «Armatura di Luce», parte della sua sostanza originaria che ha ceduto alle Tenebre nel combattimento primordiale (la «conseguente corruzione» dell’allegoria citata, nota 15), cosicché egli è in realtà presente in ogni anima umana, esiliata, prigioniera, stordita; e se il Principe come sua ultima raffigurazione viene a recuperare questi elementi perduti, egli in un certo senso realmente cerca ciò che è suo, e la sua opera è proprio quella di reintegrazione del sé divino, anzi del suo proprio sé, ma non nel senso spettante ad una persona individuale. Se quindi c’è un’identità metafisica, sebbene non numerica, tra il messaggero e la Perla, ognuno che ascolti il racconto può legittimamente, senza confusione di identità personali, riconoscere nelle avventure del messaggero la storia della propria anima diretta alla terra, vedere il proprio destino come parte e analogo a quello della divinità, eppure nello stesso tempo anche come oggetto di quest’ultimo. Perciò, viste nella giusta prospettiva, le interpretazioni contrastanti si risolvono non in maniera alternativa, ma complementare.
NOTE AL CAPITOLO 4.
1. Si suppone che sia stato composto durante la prigionia.
2. Abbiamo già trovato questo simbolo nella letteratura mandea (v. cap. 2, l, p. 96 ed. in nero) dove a differenza di qui le provviste sono fatte per il ritorno delle anime, ma sempre per questo scopo portate anche dall’uomo forestiero per il proprio viaggio: è l’istruzione spirituale oltremondana, la gnosi, che egli comunica al fedele. Un analogo significato simbolico si deve probabilmente attribuire al «fardello» preso dal tesoro celeste, menzionato nella frase seguente.
3. Il fardello, come è descritto nelle linee omesse, consiste di cinque sostanze preziose, che chiaramente collegano il «Principe» di questo racconto con l’Uomo Primordiale della speculazione manichea: v. sotto, cap. 8, b, p. 226 s.s. in nero.
4. Per il simbolismo della veste, v. sopra, cap. 2, d, p. 75 s. in nero.
5. Le tappe del viaggio di ritorno corrispondono a quelle della discesa.
6. Tralasciamo la descrizione estesa della veste.
7. Negli “Acta Thomae” (par. 32) questi e molti altri atti di seduzione sono attribuiti al “figlio” del serpente originale, dal cui discorso abbiamo citato la descrizione del progenitore.
8. Su ciò ritroveremo una più ampia descrizione nella dottrina dell’ascesa del “Poimandres”.
9. Avesta è il canone degli scritti zoroastriani come vennero redatti nel periodo sassanide.
10. Confronta il rovescio di tale idea in “The picture of Dorian Gray”.
11. Confronta REITZENSTEIN, “Hellenistische Mysterienreligionen”, 3a ed., 1927, p. 409.
12. I Mandei talvolta collegano la frase «l’Adamo nascosto» col termine «Mana» usato in rapporto all’uomo.
13. La versione autorizzata traduce “psychikos” con «naturale».
14. REITZENSTEIN, “Das iranische Erlösungsmysterium”, p. 22 s.s.
15. Confronta per esempio l’allegoria della «Santa Chiesa» nel testo manicheo “Kephalaia” (p. 204) che può essere riassunta così: La goccia di pioggia cade dall’alto nel mare e forma una perla nel guscio di ostrica; i tuffatori scendono nelle profondità del mare per prendere questa perla; i tuffatori la danno ai mercanti e i mercanti la danno ai re. Perciò l’allegoria stabilisce un’eguaglianza tra la goccia di pioggia e la preda trascinata giù dall’alto agli inizi, ossia l’Anima vivente; tra il guscio di ostrica e la carne dell’umanità in cui l’Anima è raccolta e conservata come perla; tra i tuffatori e gli apostoli; tra i mercanti e gli illuminatori dei cieli (sole e luna come agenti di salvezza nel mito manicheo); tra i re e nobili e gli Eoni della Grandezza. Confronta “Matteo” 14, 15 s. Si può aggiungere un esempio mandeo: «I tesorieri di questo mondo si riunirono e dissero: ‘Chi ha portato via la perla che illuminava la dimora peritura? Nella casa che ha abbandonato le pareti crollano e rovinano’» (G 517): la «casa» può essere il corpo, ma più probabilmente è il mondo, nel quale caso la «perla» è l’anima in generale o la totalità delle anime (perciò la sua sottrazione secondo Mani è la distruzione del mondo), e questo dovrebbe essere anche il significato della Perla nel nostro componimento.
16. Questa è l’interpretazione data da parecchi Gnostici cristiani alla passione di Cristo, il cosiddetto Docetismo.
Capitolo 5.
GLI ANGELI CHE HANNO FATTO IL MONDO.
IL VANGELO DI MARCIONE.
«L’Inno della Perla» non riferiva in che modo la Perla era caduta in potere delle Tenebre. Simon Mago lo ha fatto, seppure brevemente nelle trattazioni esistenti, facendo riferimento alla divina Ennoia o Sophia, che nel suo sistema corrisponde alla Perla dell’inno. Come abbiamo visto, essa è stata trascinata nella creazione dalla sua stessa progenie, gli angeli creatori del mondo, a causa del loro orgoglio ignorante e della brama di un potere simile a quello divino. L’origine divina, sebbene non immediata, di questi agenti cosmici, e perciò la concezione di tutta la storia come una divina degradazione, è un punto integrante di questo tipo di speculazione, addirittura il principio esplicativo. La stessa derivazione non può essere applicata al dragone che trattiene la Perla in prigionia. Se, come suggerisce l’originale babilonese, esso incarna il potere del caos primordiale, allora il suo principio era antidivino dall’origine e il suo carattere era malvagio o «tenebroso» in un senso diverso dall’errore e dalla follia degli angeli traviati di Simone.
Abbiamo fatto notare (p. 123 in nero) che su questo punto i due principali sistemi di speculazione gnostica divergono. Mentre la speculazione iranica vuole spiegare in che modo le Tenebre originarie abbiano potuto assorbire elementi di Luce, la speculazione siro-egiziana ha considerato suo compito principale la derivazione della frattura dualistica e la conseguente condizione del divino nel sistema di creazione dall’unica e indivisa sorgente dell’essere; e l’ha fatto per mezzo di un’estesa genealogia di stati divini che si evolvono l’uno dall’altro, la quale descrive il progressivo ottenebramento della Luce divina in categorie mentali. La differenza veramente importante sta, non tanto nella preesistenza o meno di un regno delle Tenebre indipendentemente da Dio, quando nell’alternativa che la tragedia divina sia fatta derivare dall’esterno o sia considerata risultante da una condizione interna. Quest’ultima ipotesi può essere mantenuta anche nel caso della preesistenza della Tenebra o Materia, se la sua funzione è quella passiva di tentare i membri del regno superiore verso la creatività materiale piuttosto che quella attiva di invadere il regno della Luce. In tale forma, adottata da alcuni sistemi, lo schema iranico dei due opposti princìpi originari potrebbe essere ricondotto alla visione dello schema siro-egiziano dell’inganno e dell’errore divini (1).
Si potrebbe sostenere che per lo stato di cose esistente e per la preoccupazione di salvezza fondata su di esso, che in fin dei conti è la preoccupazione principale della religione gnostica, non aveva grande importanza che si adottasse l’uno o l’altro tipo di preistoria, perché entrambi portavano in sostanza allo stesso risultato: che, siano gli angeli demiurgici i «reggitori malvagi del mondo», o i demoni della Tenebra primordiale che trattengono le anime in schiavitù, «salvezza» significa salvezza dal loro potere e il salvatore deve vincerli come suoi nemici. Ciò è vero, perché se fosse altrimenti i due sistemi teoretici non potrebbero essere entrambi espressioni dello spirito gnostico, per il quale la valutazione negativa del cosmo è fondamentale. Tuttavia non ha poca importanza, dal punto di vista religioso, che il mondo sia considerato espressione di un principio inferiore o che la sua sostanza sia vista come interamente diabolica. Ed è il tipo siro-egiziano che, con il suo impegno deduttivo più sottile e più complesso, non soltanto è più ambizioso speculativamente e più differenziato psicologicamente del rigido dualismo iranico, ma è anche quello dei due che in modo sistematico meglio interpreta la pretesa di redenzione della gnosi così dominante nella religione gnostica: questo perché si accorda al suo opposto, «ignoranza» come evento “divino”, una funzione metafisica nella creazione stessa del cosmo e nel mantenere la condizione dualistica come tale. Ci soffermeremo di più su questo aspetto quando tratteremo il sistema valentiniano. E’ ovvio che anche a questo stadio lo schema siro-egiziano permette una maggiore varietà di speculazione e che, una volta stabilito il carattere di questo mondo e dei suoi diretti signori e creatori, come risultato quasi logico nel quadro gnostico generale, il centro teoretico di gravità si sposti all’elaborazione di stadi intermedi tra queste divinità cosmiche e la divinità primordiale da cui esse sono state originate: la tendenza è allora quella di moltiplicare le figure e di prolungare la genealogia, sia per accentuare la differenziazione spirituale sia per aumentare la distanza tra il mondo inferiore e l’intatto regno della Luce. Per spiegare questa tendenza molto importante possiamo anche attribuirla ad un crescente interesse speculativo circa i mondi superiori come tali che trova soddisfazione in una crescente molteplicità. In ogni modo, alla luce di ciò che è emerso in definitiva, la genealogia di Simone con i suoi due gradi di Ennoia e angeli creatori del mondo deve sembrare un modestissimo inizio.
a) Gli angeli che hanno creato il mondo.
La maggioranza dei sistemi gnostici cristiani, catalogati dagli eresiologi, appartiene al tipo siriaco, anche quando la Tenebra originaria viene incorporata nella forma platonizzante di materia passiva. Ciò non vuol dire che tutti si siano compiaciuti nel genere di genealogia trascendentale che abbiamo indicato. Di fatto, ovunque gli «angeli» o il «demiurgo» sono detti creatori e reggitori del mondo, anche quando la loro linea di provenienza non è dal Dio supremo, siamo in presenza di un principio non completamente malvagio, ma piuttosto inferiore o degenerato come causa ed essenza di creazione.
Così “Carpocrate”, senza alcun tentativo di deduzione (stando a Ireneo), afferma semplicemente che il mondo è stato fatto dagli angeli «che sono di gran lunga inferiori al Padre ingenerato»: Gesù e tutte le anime che come la sua si mantennero pure e forti nel ricordo del Padre ingenerato possono disprezzare i creatori e passare in mezzo a loro (Iren. I, 25, 1-2). “Menandro” insegna in modo simile a Simone che la Prima Potenza è sconosciuta a tutti e che il mondo è stato fatto dagli angeli, i quali egli, «come Simone, dice che sono emanati dall’Ennoia»: pretende di essere in grado con la magia di sottomettere questi reggitori del mondo (loc. cit. 23, 5). “Saturnino”, tralasciando l’Ennoia, o altro simile principio femminile, insegna semplicemente secondo Ireneo che «l’unico Padre inconoscibile ha fatto gli angeli, gli arcangeli, le potenze e le dominazioni. Il mondo tuttavia, e quanto esso contiene, è stato fatto da sette angeli particolari, e anche l’uomo è opera degli angeli», uno dei quali è il dio ebraico. Egli descrive questi angeli di volta in volta come artigiani inefficaci e come ribelli. Cristo è venuto per distruggere il dio degli Ebrei. Una caratteristica (2) di Saturnino è quella di annoverare tra questi angeli anche il demonio, che «è un angelo nemico di quegli angeli e dio degli Ebrei»: una specie di inimicizia privata nell’ambito delle potenze inferiori (loc. cit. 24, 1-2).
I sistemi più vasti, d’altra parte, fanno provenire, come è stato detto, la discendenza dell’ordine inferiore dal principio superiore elaborando genealogie estese e sempre più complicate: una specie di «devoluzione» metafisica che termina nella decadenza che è questo mondo. Così, per esempio, “Basilide” prolunga la linea di discendenza in una enorme catena che, attraverso un certo numero di figure spirituali come Nous, Logos, eccetera, conduce a 365 cieli successivamente generati con le loro popolazioni angeliche, l’ultimo dei quali è quello che vediamo, abitato dagli angeli che creano il mondo. Il loro capo è il dio dei Giudei. Anche qui il Padre innominabile manda Cristo, il Nous eterno, a liberare coloro che credono in lui dalla dominazione dei costruttori del mondo. La sua passione è stata un inganno, perché Simone di Cirene è morto sulla croce nella sua figura (loc. cit. 24, 3-4; ci soffermeremo in seguito sugli altri due principali esempi di questo tipo, i Barbelognostici e i Valentiniani).
In tutti questi casi, le potenze che sono responsabili del mondo e contro le quali è diretta l’opera della salvezza sono più spregevoli che sinistre. La loro malvagità non è quella dell’arcinemico, l’odiatore eterno della Luce, ma quella di usurpatori ignoranti che, non considerando il loro rango subalterno nella gerarchia dell’essere, si arrogano la direzione del mondo e, scarsi di mezzi, con l’invidia e la bramosia di potere, possono solamente rappresentare una caricatura della vera divinità. Il mondo, creato da loro in imitazione illegittima della creatività divina e come prova della loro propria divinità, è di fatto una dimostrazione della loro inferiorità sia nella sua costituzione che nel suo governo.
Una caratteristica che ricorre di frequente è l’asserzione che le profezie e la Legge mosaica sono promanate dagli angeli governanti il mondo, tra i quali spicca il dio dei Giudei (3). Ciò indica un particolare antagonismo verso la religione dell’Antico Testamento e il suo Dio, la cui realtà non è però in nessun modo negata. Al contrario, dopo che questo Dio in astrologia aveva dato i suoi “nomi” a quattro dei sette arconti planetari (4), che gli Gnostici poi promossero a creatori del mondo, la sua immagine tracciata con animo polemico emerse con maggior evidenza dal loro numero come una inconfondibile caricatura del Dio biblico, non venerando, ma nondimeno terribile. Dei Sette è soprattutto Ialdabaoth che si appropria questa eminenza e questa somiglianza. Nel sistema degli Ofiti, come riferito da Ireneo, egli è il primogenito della Sophia minore o Prunikos e genera dalle acque un figlio chiamato Iao, che a sua volta genera allo stesso modo un figlio, Sabaoth, e così di seguito per i Sette. Perciò Ialdabaoth è mediatamente il padre di tutti questi e quindi della creazione. «Egli si vantò di quanto accadeva ai suoi piedi e disse: ‘Io sono Padre e Dio e non vi è nessuno al di sopra di me’» (secondo il modello di certe formule dell’Antico Testamento, come Is. 45, 5: «Io sono il Signore e non c’è nessun altro, non c’è altro Dio all’infuori di me»); al che sua madre replica: «Non mentire, Ialdabaoth: c’è sopra di te il Padre di tutti, il “Primo Uomo”, e “Uomo”, Figlio dell’Uomo» (loc. cit. 30, 4-6).
Il tema dell’orgoglio demiurgico è frequente nella letteratura gnostica, comprese le allusioni all’Antico Testamento. «Perché là governa il grande Arconte, il cui dominio si estende al firmamento, il quale crede di essere il solo Dio e che non vi sia niente al di sopra di lui» (Basilide, in Hippol. VII, 25, 3; confronta 23, 4 s.s.). L'”Apocrifo di Giovanni” va un passo più avanti nella diffamazione del carattere demiurgico, laddove Ialdabaoth, per desiderio di dominio, inganna i suoi angeli su ciò che concede e ciò che trattiene nella loro creazione, e la sua gelosia viene intesa come segno di conoscenza anziché di ignoranza del Dio supremo:
«Egli ha assegnato loro parte del suo fuoco, che è il suo attributo, e parte del suo potere; ma non ha dato ad essi niente della pura Luce del potere che ha ereditato da sua Madre. Per tal motivo ha dominio sopra di loro, a causa della gloria che era in lui dal potere della Luce della Madre. Perciò ha permesso che fosse chiamato ‘il dio’, ripudiando la sostanza dalla quale era provenuto… E contemplò la creazione sotto di lui e la moltitudine degli angeli al di sotto di lui che erano scaturiti da lui, e disse loro: ‘Sono un dio geloso, non vi è nessuno all’infuori di me’, con ciò indicando già agli angeli al di sotto di lui che vi è un altro Dio; perché se non vi fosse nessuno, di chi sarebbe geloso?» (42, 13 s.s.; 44, 9 s.s., Till).
Lo stesso tema è abbondantemente sfruttato nelle speculazioni mandee sugli inizi, pur senza riferimento evidente all’Antico Testamento: «B’haq-Ziva si stimò strapotente, e abbandonò il nome che suo Padre aveva creato [per lui]. Egli disse: ‘Sono il padre degli Uthra, che hanno creato delle “sh’kina” per sé’. Meditò sulle acque torbide e disse: ‘Creerò un mondo’» (G 97 s.).
Tipica è anche la replica dall’alto che mette il creatore al suo posto (5). Ma ancora più umiliante è il rimprovero proveniente dall’anima dello pneumatico in ascesa, il quale vanta la sua origine in faccia al signore, o signori, del mondo:
«Sono un vaso più prezioso della donna che ti ha fatto. Tua madre non conosce la sua origine, ma io conosco me stesso e so di dove provengo. Invoco l’incorruttibile Sophia che abita nel Padre ed è la madre di tua madre… Ma una donna nata da donna ti ha generato, senza conoscere sua madre e credendo di essere da se stessa: ma io invoco sua madre» (Iren. I, 21, 5).
Formule simili, che si trovano in gran numero, esprimono efficacemente la confidenza dell’eletto gnostico e il suo disprezzo sovrano per quelle potenze inferiori, anche se sono le reggitrici di questo mondo. Ciò non esclude un sentimento di paura, che si trova curiosamente mescolato all’audacia della provocazione. La preoccupazione principale dell’anima è di “sfuggire” ai terribili arconti, e piuttosto che trovarsi a faccia a faccia con loro essa preferisce, se le riesce, di svignarsela inosservata. Di conseguenza, si dice talvolta che la funzione dei sacramenti è quella di rendere le anime nella loro futura ascesa invisibili agli arconti che ne impedirebbero il cammino, e specialmente al loro principe, che in veste di giudice le farebbe responsabili delle loro azioni sotto la sua legge. Poiché l’essenza di questa legge è «giustizia», sfuggire alla sua sanzione fa parte per gli Gnostici di un generale atteggiamento contrario alla legge ed esprime il ripudio del Dio dell’Antico Testamento nel suo aspetto morale. Ritorneremo in seguito su questo punto in rapporto al libertinismo gnostico; il riferimento all’antitesi paolina di legge e grazia ci occuperà subito.
In alcuni gnostici cristiani, la figura di un unico dio del mondo assorbe completamente la pluralità di angeli e arconti e diventa, com’era rappresentato nella Bibbia, il solo simbolo della creazione e della sua legge, in modo che tutto il problema della salvezza viene ristretto ad una questione tra lui e il Dio sconosciuto dell’aldilà. Si hanno parecchi esempi di questo sviluppo quasi-monoteistico, per quel che riguarda il regno cosmico (6). “Cerinto” insegnava che «il mondo era stato fatto, non dal primo Dio, ma da un potere molto distante e separato dalla sorgente dell’essere, il quale non aveva nemmeno conoscenza del Dio che è esaltato al di sopra di tutte le cose»: Cristo fu il primo a predicare nel mondo il Padre sconosciuto (Iren. I, 26,1) (7). Nella stessa linea, “Cerdone” affermava che «il Dio predicato da Mosè e dai profeti non è il Padre di Gesù Cristo: l’uno è conoscibile, l’altro no; l’uno soltanto giusto, l’altro buono» (loc. cit. 27, 1). La dottrina di Cerdone, della quale possediamo soltanto questo breve sommario, conduce nelle strette vicinanze di “Marcione”, il più grande maestro di questo gruppo.
b) Il Vangelo di Marcione.
Marcione di Sinope nel Ponto occupa una posizione singolare sia tra i pensatori gnostici sia nella storia della Chiesa cristiana. Sotto quest’ultimo aspetto, egli è stato il più decisamente e integralmente «cristiano» tra gli Gnostici, e per tal motivo ha rappresentato la più grande sfida all’ortodossia cristiana; anzi, per essere più precisi, la sua sfida più di qualsiasi altra «eresia» ha condotto alla formulazione della stessa dottrina ortodossa. Nell’ambito del pensiero gnostico, la singolarità della sua posizione è tale che la sua appartenenza al movimento gnostico è stata respinta nientemeno che da uno studioso di Marcione quale Harnack.
– La posizione singolare di Marcione nel pensiero gnostico.
In verità egli rappresenta un’eccezione a molte regole gnostiche. Egli solo fra tutti ha preso sul serio la passione di Cristo, sebbene l’interpretazione che ne ha dato sia stata inaccettabile per la Chiesa; la sua dottrina è interamente libera dalla fantasia mitologica nella quale si è sbizzarrito il pensiero gnostico; egli non specula sulle prime origini; non moltiplica le figure divine e semidivine; rifiuta l’allegoria per l’interpretazione dell’Antico e del Nuovo Testamento; non afferma la conquista di una conoscenza superiore «pneumatica» o la presenza in genere nell’uomo di quell’elemento divino che potrebbe essere la sua origine o il suo ricevente; egli fonda interamente la sua dottrina su ciò che pretende essere il significato letterale del Vangelo; in questa rigorosa restrizione è libero da ogni sincretismo così caratteristico dello gnosticismo in genere; infine, come Paolo, che era per lui «l’apostolo», assume la fede e non la conoscenza come mezzo della redenzione. Tale considerazione potrebbe far mettere Marcione decisamente al di fuori dell’area gnostica, se questa è definita dal concetto di gnosi. Tuttavia il dualismo anticosmico come tale, di cui Marcione è l’esponente più aperto, l’idea di un Dio sconosciuto opposto a quello del cosmo, la concezione stessa di un creatore inferiore ed oppressore e la conseguente visione di salvezza come liberazione dal suo potere mediante un principio forestiero, sono così manifestamente gnostici che chiunque li affermi in tale contesto storico deve essere annoverato tra gli Gnostici, non solo per semplice classificazione, ma nel senso che le idee gnostiche che circolavano avevano di fatto plasmato il suo pensiero. La stessa concezione, tuttavia, che collega così strettamente Marcione con la corrente gnostica generale, quella dello «Straniero», assunse nel suo insegnamento una direzione completamente nuova. In sintesi, il vangelo di Marcione (8) era quello «del Dio straniero e buono, il Padre di Gesù Cristo, che conduce alla vita eterna la miserabile umanità liberandola da pesanti catene, umanità ancora “del tutto estranea a lui”». Marcione condivide con lo gnosticismo in genere il concetto dell'”estraneità” del vero Dio: che egli è straniero perfino per l’oggetto della sua salvezza, che gli uomini persino nell’anima e nello spirito sono a lui estranei, tali concezioni sono sue proprie. Di fatto questo annulla uno dei princìpi basilari della religione gnostica, secondo la quale gli uomini sono stranieri in questo mondo, e perciò la loro assunzione nel regno divino è un ritorno alla loro vera casa, o nel salvare l’umanità il Dio supremo salva ciò che è suo. Secondo Marcione, l’uomo nella sua integrale costituzione, come tutta la natura, è creatura del dio del mondo e, prima della venuta di Cristo, è sua legittima e assoluta proprietà, corpo e anima insieme (9). «In senso naturale», perciò, nulla dell’uomo è straniero nel mondo, mentre il Dio buono è straniero in senso assoluto a lui, come ad ogni cosa creata. Per nessun verso la divinità che salva dal mondo ha alcun rapporto con l’esistenza del mondo, nemmeno quello secondo cui lungo il corso della speculazione gnostica una parte della divinità sia stata trascinata nella creazione per decadimento o per violenza.
Di conseguenza, non viene elaborata una genealogia, o storia di qualsiasi specie, che colleghi il demiurgo col Dio buono. Il primo è una divinità per proprio conto, che manifesta la sua natura nell’universo visibile, sua creazione, ed è l’antitesi del Dio buono, non in quanto malvagio, ma in quanto «giusto». Perciò, sebbene descritto senza simpatie, egli non è il Principe delle Tenebre. Nella elaborazione dell’antitesi tra queste due divinità da una parte e il significato della redenzione per mezzo di Cristo dall’altra, consiste l’originalità dell’insegnamento di Marcione.
-La redenzione secondo Marcione.
Per cominciare col secondo aspetto, Harnack afferma: «Alla questione circa ciò da cui Cristo ci ha salvato – dai demoni, dalla morte, dal peccato, dalla carne (tutte queste risposte furono date fin dai primissimi tempi) – Marcione risponde in modo radicale: Egli ci ha salvato dal mondo e dal suo dio per farci figli di un Dio nuovo e straniero» (10). Codesta risposta sollecita la domanda: «Quale motivo aveva il Dio buono di interessarsi al destino dell’uomo?». E la risposta è: Nessuno, tranne la sua bontà. Egli non richiama dall’esilio i figli perduti per riportarli alla loro casa, ma liberamente adotta degli stranieri per condurli dalla loro terra di oppressione e di miseria nella nuova casa del Padre. Di conseguenza, poiché essi non sono sua proprietà, ma fin dall’origine proprietà del dio del mondo, la loro salvezza è un «libero acquisto» da parte di Cristo. Marcione fa qui appello a Gal. 3,13: «Cristo ci ha riscattato» (e incidentalmente, con un cambiamento di due lettere, legge anche Gal. 2, 20: «mi ha riscattato [“egorese”], perché mi ha amato [“egapese”]» – uno dei caratteristici emendamenti del testo fatti da Marcione), e argomenta: «evidentemente in quanto stranieri, perché nessuno mai compera quelli che gli appartengono». Il prezzo del riscatto era il sangue di Cristo, che non è stato dato per la remissione dei peccati o per la purificazione del genere umano dalla colpa, oppure come espiazione vicaria in adempimento della Legge – in una parola, non per la riconciliazione dell’umanità con Dio – ma per cancellare il diritto del creatore alla sua proprietà. La legittimità di tale diritto è riconosciuta, come pure la validità della Legge, alla quale come sudditi del padrone del mondo, e fintantoché rimangono tali, gli uomini devono obbedienza. Marcione intende in tal senso la dottrina paolina circa la Legge e così interpreta tutte quelle espressioni dell’apostolo che insistono sulla validità della rivelazione dell’Antico Testamento, le quali altrimenti sarebbero contrastanti con la sua posizione. In verità Marcione riconosce la rivelazione “quale” autentico documento del dio del mondo e nella sua interpretazione concorda con l’esegesi giudaica contro i suoi contemporanei cristiani, insistendo sul significato letterale e respingendo il metodo allegorico che la Chiesa applicava all’Antico Testamento per stabilirne la concordanza col Nuovo. Non solo egli non aveva interesse per tale concordanza, ma non la ammette nemmeno, visto che l’Antico Testamento affermava di essere la rivelazione di quel dio che ha creato e governa il mondo. Accettando questa asserzione, Marcione poteva anche ammettere in senso letterale quelle affermazioni che la Chiesa poteva riconciliare con la rivelazione cristiana soltanto per mezzo di un’interpretazione allegorica. Così Marcione concordava con gli Ebrei che il loro Messia promesso, il messia terreno, figlio del dio del mondo, doveva ancora venire e stabilire il suo regno terreno proprio come i profeti l’avevano dichiarato.
Ciò tuttavia non ha niente a che fare con la salvezza portata da Cristo che è acosmica per natura e non muta il corso degli eventi terrestri, neppure nel senso di un miglioramento: infatti cambia soltanto la prospettiva dell’anima redenta rispetto alla vita futura e, a mezzo della fede in tale futuro, la sua presente condizione “spirituale”, ma lascia il mondo a se stesso, cioè alla sua finale distruzione. Per il restante del loro soggiorno terreno, la condotta dei credenti è determinata perciò non tanto da una preoccupazione positiva di santificazione, quanto piuttosto da un atteggiamento negativo di ridurre al massimo il contatto col regno del creatore (v. in seguito).
La beatitudine futura può essere anticipata quaggiù soltanto per mezzo della fede, e la fede invero è l’unica forma in cui deve essere accettata l’adozione divina offerta da Cristo, poiché nella negazione di quella questa può essere respinta: coloro i quali rimangono sotto il potere del creatore lo fanno di loro propria scelta (11). Perciò in questo contratto strettamente legale tra il Dio buono, il creatore e le anime “adottate” nella primitiva paternità, non interviene alcuna «esperienza pneumatica» né illuminazione dell’eletto per mezzo di una «gnosi» che trasforma la sua natura o mette in luce l’elemento divino nascosto in lui. Solamente i credenti sono salvati, non gli «gnostici», sebbene la fede con la certezza che infonde comporti una propria esperienza di beatitudine.
Ciò basti per quanto riguarda la soteriologia.
– I due dèi.
Marcione ha elaborato la sua teologia in forma di «antitesi»: questo era il titolo di uno dei suoi libri perduti. La maggior parte di tali antitesi consistevano in attributi dei due dèi. L’uno è l’«artigiano» (“demiurgo”), il «Dio della creazione» (o «generazione»), il «reggitore di questo eone», «conosciuto» e «predicabile»; l’altro è il Dio «nascosto», «sconosciuto», «incomprensibile», «impredicabile», «estraneo», «lo straniero», «l’altro», «il diverso» ed anche «il nuovo». Il dio-creatore è “conosciuto” dalla sua creazione, nella quale si manifesta la sua natura. Il mondo lascia trapelare non soltanto la sua esistenza ma anche il suo carattere, che è quello di un animo gretto.
Basta uno sguardo alla miseria della sua opera: «I Marcioniti con estrema impudenza arricciano il naso alla creazione e distruggono l’opera del Creatore: ‘Davvero – essi dicono – un’opera magnifica, degna del suo Dio, è questo mondo!’» (Tertull., “Contra Marc.” I, 13). Altrove Tertulliano riporta le espressioni: «questi miserevoli elementi» e «questa celletta del creatore» (12). Le stesse «piccinerie, debolezze e incoerenze» della sua creazione si manifestano pure nel comportamento col genere umano e persino col suo popolo eletto. A prova di ciò, Marcione porta la conferma dell’Antico Testamento, che per lui è «vero» nel senso indicato. La più significativa rivelazione di sé è la Legge, e ciò ci conduce all’ultima e più importante antitesi di Marcione: quella tra il Dio “giusto” e il Dio “buono”. Dal punto di vista cristiano codesto aspetto del dualismo di Marcione è molto pericoloso: esso separa e distribuisce tra due dèi che si escludono a vicenda quella polarità tra giustizia e misericordia la cui unione in un unico Dio è il motivo, per la sua tensione, di tutta la dialettica della teologia paolina. Per Marcione, mente meno profonda e perciò più incline alla chiarezza della coerenza formale, giustizia e bontà sono contraddittorie e quindi non possono trovarsi riunite in un medesimo dio: il concetto di ognuno dei due dèi, soprattutto quello del vero Dio, non dev’essere equivoco – errore di tutti i dualismi teologici. Il dio giusto è quello «della Legge», il dio buono è quello «del Vangelo». Marcione, qui come altrove semplificando troppo san Paolo, intende la «giustizia» della Legge come puramente formale, ristretta, retributiva e vendicativa («occhio per occhio, dente per dente»): una tale giustizia, non proprio cattiveria, è proprietà fondamentale del dio-creatore. Perciò il dio che Cristo ha indicato come falso non è il persiano Ahriman, non l’assoluta tenebra – Marcione lasciò sussistere il demonio come figura separata entro il regno del creatore – né la materia, ma semplicemente il dio del mondo come presentato dalla Legge e dai profeti. La virtù morale sotto la Legge, sebbene preferibile secondo norme terrene alla licenziosità, non ha grande importanza dal punto di vista della salvezza trascendente.
Come il dio-creatore è conosciuto, evidente e «giusto», così il vero Dio è sconosciuto, straniero e buono. Egli è sconosciuto perché il mondo non dice niente di lui. Non avendo parte nella creazione, non esiste in tutta la natura traccia alcuna che possa anche soltanto far sospettare la sua esistenza. Come riassume Tertulliano: «Il Dio di Marcione è sconosciuto “per via naturale” e mai rivelato tranne che nel Vangelo» (op. cit. V, 16). Non essendo l’autore del mondo e neppure dell’uomo, egli è anche lo straniero. In altre parole, nessun legame naturale, nessuna relazione preesistente lo collega con le creature di questo mondo e non vi è nessun obbligo da parte sua di preoccuparsi del destino dell’uomo. Per Marcione è evidente che egli non entra in alcun modo nel governo fisico del mondo: volle eliminare dal Vangelo come interpolazioni giudaiche quei detti del Signore laddove si dice ad esempio che il Padre si prende cura dei passeri e tiene conto del numero di capelli che ognuno ha in testa. Il Padre proclamato da Gesù Cristo non avrebbe potuto occuparsi di ciò che riguarda la natura o il suo dio. E ciò toglie di mezzo qualsiasi idea di una provvidenza che opera nel mondo. La sola attività con la quale il Dio buono interviene nel mondo e il suo unico rapporto con esso è quello di aver mandato suo Figlio per redimere l’uomo dal mondo e dal suo dio: «Quest'”unica” opera è sufficiente per il “nostro” Dio, che abbia liberato l’uomo per sua suprema e superlativa bontà, che è da preferirsi a tutte le cavallette (13)» (Tertull., op. cit. I, 17). E’ chiaro che la bontà del Dio buono è collegata alla sua estraneità, in quanto quest’ultima toglie ogni altro fondamento al suo interesse verso l’uomo. La bontà della sua azione salvifica è maggiore appunto per il fatto che egli è straniero e si occupa di estranei: «L’uomo, quest'”opera del dio-creatore”, che il Dio più buono ha scelto di amare, e per amor suo si è assunto l’onere di discendere dal terzo cielo in questi elementi miserabili, e in favore di lui è stato persino crocifisso in questa piccola cella del creatore» (ibid. 14).
– «La grazia data liberamente».
Perciò l’unica relazione del Dio buono col mondo è soteriologica, ossia diretta contro di esso e contro il suo dio. Per quanto riguarda l’uomo, questa relazione è iniziativa del tutto gratuita da parte del Dio straniero ed è perciò un atto di pura grazia. Anche qui Marcione interpreta a modo suo l’antitesi paolina di «grazia gratis data» e «giustificazione per mezzo delle opere». Che la grazia sia data gratuitamente rappresenta per entrambi gli autori tutto il contenuto della religione cristiana; ma mentre in Paolo «gratuitamente» significa «rispetto alla colpa e all’insufficienza umana», cioè in assenza di ogni merito da parte dell’uomo, in Marcione significa «rispetto alla reciproca estraneità», cioè in assenza di ogni legame obbligante. Né la responsabilità, né l’attaccamento paterno di un creatore verso le sue creature è in gioco in questo caso, e nemmeno nella maniera gnostica abituale il Dio buono è mediatamente interessato al destino delle anime (e del mondo) per le connessioni genealogiche descritte: di modo che non c’è niente che egli debba riscattare o restaurare. Infine, in mancanza di ogni precedente azione, le idee di perdono e riconciliazione non sono applicabili: se gli uomini sono stati in precedenza peccatori, non possono certamente aver peccato contro di Lui. Il fatto è che la prima relazione tra questo Dio e quelle creature non sue è stata stabilita per mezzo del suo atto di una grazia senza un passato, e la relazione continua a sussistere in questo modo. Il lettore cristiano può chiedersi a questo proposito che ne è del concetto cristiano di amore divino e di misericordia. Il richiamo al pentimento, l’imminenza del giudizio, timore e tremore, espiazione, tutto è stato eliminato dal messaggio cristiano. Ma bisogna notare che mentre Marcione abolisce il paradosso paolino di un Dio che è giusto e buono, di fronte al quale l’uomo è colpevole e tuttavia amato, egli accentua ancora di più il paradosso di una grazia incomprensibile, non sollecitata, senza precedenti che possano richiederla o prepararla, un profondo mistero della divina bontà come tale. Per codesto motivo Marcione deve essere annoverato tra i grandi protagonisti di una religione paradossale.
– La moralità ascetica di Marcione.
Marcione è stato altrettanto rigido nella formulazione della dottrina teologica quanto nei precetti di condotta che ne dedusse. Non vi poteva naturalmente essere alcuna preparazione, o aumento, della grazia divina per mezzo delle opere, ancor meno un perfezionamento della natura umana mediante la pratica delle virtù nel senso classico pagano. In linea di principio, la moralità positiva, come mezzo per regolare e quindi confermare l’appartenenza degli uomini al sistema della creazione, non era che una versione di quella Legge per mezzo della quale il creatore esercitava il suo dominio sull’anima dell’uomo e alla cui osservanza coloro che venivano salvati non erano più tenuti: continuare a praticarla significherebbe consolidare un’appartenenza al cosmo che al contrario dovrebbe essere ridotta al minimo indispensabile, fino alla definitiva rimozione dal suo ordine. Quest’ultima considerazione definisce il tipo di moralità che Marcione sosteneva. Il suo principio era: non completare, ma ridurre il mondo del creatore e farne il minor uso possibile. «Per via di opposizione al Demiurgo, Marcione respinge l’uso delle cose di questo mondo» (Clem. Alex., “Strom.” III, 4, 25).
L'”ascetismo” così raccomandato, strettamente parlando, non è una questione di etica, ma di allineamento metafisico. Evitare la contaminazione del mondo ne è un aspetto importante, ma l’aspetto principale è quello di opporsi anziché di promuovere la causa del creatore, o anche, proprio per fargli dispetto: «[Marcione] crede di molestare il Demiurgo astenendosi da ciò che quello ha fatto o istituito» (Hippol., “Refut.” X, 19, 4). La «perpetua astinenza» in materia di cibo è «per distruggere e disprezzare e abominare le opere del creatore» (Hieron., “Adv. Jovinian.” II, 167). Particolarmente evidente è il proposito di opposizione nella proibizione del rapporto sessuale e del matrimonio: «Non volendo aiutare a popolare il mondo fatto dal Demiurgo, i Marcioniti stabiliscono l’astensione dal matrimonio, sfidando il loro creatore e affrettandosi verso l’Unico Buono che li ha chiamati e il quale, essi dicono, è Dio in un senso differente: perciò, non volendo lasciare niente di proprio quaggiù, diventano continenti non per un principio morale, ma per ostilità al loro fattore, e per non voler servirsi della sua creazione» (Clem. Alex., loc. cit.). Qui la contaminazione della carne e la concupiscenza, temi così diffusi in questo periodo, non sono nemmeno menzionati; invece (sebbene non esclusivamente: confronta Tertull., op. cit. I, 19, dove il matrimonio è chiamato «bruttura» o «sozzura» [“spurcitiae”]) è l’aspetto di “riproduzione” che squalifica la sessualità – quello stesso aspetto che per la Chiesa ne è la sola giustificazione come suo fine secondo la disposizione della natura. Marcione qui riecheggia un genuino e tipico argomento “gnostico”, di cui si avrà la completa elaborazione in Mani: cioè che la riproduzione è un inganno ingegnoso dell’arconte per trattenere indefinitamente le anime nel mondo (14). Perciò l’ascetismo di Marcione, a differenza di quello degli Esseni o più tardi del monachesimo cristiano, non era inteso a promuovere la santificazione dell’esistenza umana, ma era essenzialmente negativo nella sua concezione e faceva parte della rivolta gnostica contro il cosmo.
– Marcione e la Scrittura.
Assumendo come misura di ciò che è genuinamente cristiano e di ciò che non lo è la propria interpretazione di san Paolo, Marcione ha sottoposto gli scritti del Nuovo Testamento ad un rigoroso processo di vagliatura per separare il vero da quello che egli riteneva fossero falsificazioni posteriori. E fu per questa via che per la prima volta un lavoro di critica testuale, sebbene in modo piuttosto arbitrario, fu applicato ai primitivi documenti cristiani e che nella Chiesa cristiana nacque e fu realizzata l’idea stessa di un “canone”. Il canone dell’Antico Testamento era stato stabilito già da gran tempo dai teologi ebraici, ma non era stato definitivamente fissato un corpo di libri autorevoli o autentici tra la massa fluttuante di scritti cristiani, tranne la definizione globale di Sacra Scrittura. Il canone che Marcione compose per la Chiesa era comprensibilmente scarno. Non c’è bisogno di dire che l’Antico Testamento nella sua totalità fu buttato a mare. Quanto al Nuovo Testamento soltanto il Vangelo secondo Luca e dieci Lettere paoline furono accettate, sebbene anche queste ultime con emendamenti ed eliminazione di ciò che Marcione considerava come interpolazioni giudaiche. Queste ultime, secondo lui, avevano anche invaso il Vangelo di Luca, che nell’insieme Marcione considerava come il solo autentico, ossia quello dato da Dio (e perciò non da Luca), di modo che ne era necessaria un’accurata purgazione: la storia della nascita, per esempio, con la sua discendenza davidica doveva essere tolta e molto altro ancora (tra cui abbiamo ricordato l’eliminazione di 12, 6). Queste caratteristiche principali sono sufficienti a dare un’idea del lavoro di critica testuale fatto da Marcione. Fu in risposta al tentativo di Marcione di far accettare dalla Chiesa il suo canone e con esso la sua interpretazione del messaggio cristiano che la Chiesa procedette a stabilire il canone ortodosso e il dogma ortodosso. Fissando il primo, lo scontro maggiore verteva sul ritenere o abbandonare l’Antico Testamento; e se «Sacra Scrittura» fino ad oggi significa entrambi i Testamenti, ciò è dovuto al fatto che il marcionismo non riuscì ad imporsi. Per quanto riguarda il dogma, l’accentuazione antimarcionita è chiaramente percepibile nelle primitive formulazioni. La “regula fidei”, che Origene ha messo all’inizio della sua opera principale, “De principiis”, contiene questa affermazione enfatica (15): «Questo Dio, giusto e buono, Padre di nostro Signore Gesù Cristo, ha dato “egli stesso” la legge e i profeti e i vangeli, egli che è il Dio degli apostoli e dell’Antico e del Nuovo Testamento».
Tuttavia in un modo o nell’altro il marcionismo è rimasto fino ad oggi materia di discussione nel cristianesimo. E prescindendo da qualsiasi controversia dottrinale, il messaggio di Marcione circa il Dio nuovo e straniero non mancherà di trovare un’eco nel cuore umano.
NOTE AL CAPITOLO 5.
1. Un’interpretazione di questo tipo è persino riportata come variante della dottrina manichea, che per la sovrabbondanza della documentazione è la rappresentazione classica del tipo iranico, il quale descrive il regno delle Tenebre come primo aggressore e la storia del mondo come il prolungamento della lotta tra i due opposti princìpi (confronta JONAS, “Gnosis”, I, p. 301).
2. In comune con Marcione e i Valentiniani.
3. Saturnino si è spinto così lontano da affermare che le profezie furono date in parte dai creatori del mondo, in parte da Satana.
4. Iao, Sabaoth, Adonaios, Elohim; più raramente anche Esaldaios = El-shaddai.
5. Per esempio, in Epifanio il Ialdabaoth-Sabaoth degli «Gnostici» è trattato da sua madre Barbelo (come è chiamata la Sophia in quel sistema) con lo stesso rimprovero che era stato rivolto al Ialdabaoth degli Ofiti in Ireneo (Epiph., “Haer.” XXVI, 2, 3 s.). Basilide fa uscire la correzione dal «Vangelo della Figliolanza», nella forma meno aspra di illuminazione, e qui si trova anche una risposta più soddisfacente attribuita al demiurgo che non in altri testi: «e l’Arconte imparò che egli non era il Dio universale ma era generato ed aveva sopra di lui il tesoro dell’ineffabile e innominabile ‘Non-Esistente’ [nome paradossale dato da Basilide alla Causa Prima] e della Figliolanza; e si volse e fu spaventato, comprendendo in quale ignoranza era stato… e confessò il peccato che aveva commesso nel magnificare se stesso» (Hippol. VII, 26, 1-3). Confronta sopra, cap. 2, nota 18, il «rimorso nel creatore».
6. Già nel «Baruch» di Giustino viene messo in opposizione l’Elohim demiurgico col “Bene” supremo, ma c’è nell'”Edem” femminile un terzo principio inferiore che è causa del male, sebbene non completamente malvagio in se stesso.
7. Il principale sostegno scritturistico della loro dottrina del Padre Inconoscibile e rivelato soltanto da Cristo è in “Matteo” 11, 25-27 = “Luca” 10, 21-22. Nel suo resoconto generale dei Valentiniani, Ireneo riferisce: «Come appoggio alla loro tesi essi adducono il seguente passo: ‘Ti ringrazio, Padre, Signore del cielo e della terra, che hai nascosto queste cose ai sapienti e ai prudenti e le hai rivelate ai piccoli… nessuno conosce il Padre se non il Figlio, né il Figlio se non il Padre e colui al quale il Figlio rivelerà [ciò]’ [citato così con leggera deviazione dal nostro N. T.]. Con tali parole, essi dicono, egli ha esplicitamente insegnato che il ‘Padre di Verità’ inventato da loro non era mai stato conosciuto da alcuno prima della sua apparizione [di Cristo]; e vogliono stabilire che il creatore e facitore del mondo è sempre stato conosciuto da tutti: quelle parole perciò – essi dicono – il Signore le ha pronunziate riguardo al Padre Sconosciuto a tutti che essi proclamano» (Adv. haer. I, 20, 3).
8. La fonte più estesa è l’opera di Tertulliano in cinque parti, “Adversus Marcionem”. Della compendiosa polemica di Origene, l’altro grande critico di Marcione nel terzo secolo, sono rimasti solo pochi frammenti. Per il resto, tutti gli eresiologi, a cominciare dal primo di essi, Giustino Martire (secondo secolo) trattano di Marcione o dei suoi seguaci e la polemica continuò nel quinto secolo quando le comunità marcionite, residui della chiesa che Marcione aveva fondato, erano ancora esistenti nell’Oriente. Nel nostro riassunto dell’insegnamento di Marcione indicheremo le fonti particolari solo occasionalmente.
9. Marcione accetta il racconto della Genesi sulla creazione dell’uomo, con la conseguenza per lui che il Dio Buono non ha avuto niente a che fare con essa.
10. ADOLF VON HARNACK, “Marcion: Das Evangelium vom fremden Gott”, Leipzig, 1921, p. 31, n. 1. Il libro di Harnack è un classico, certamente la migliore monografia su ogni singolo capitolo dello gnosticismo.
11. A tal riguardo Marcione ha una spiegazione originale, alquanto faceta, a riguardo di quanto afferma che (a differenza di Caino, dei Sodomiti e loro simili) Abele, i patriarchi e tutti i giusti e i profeti della tradizione biblica non furono salvati quando Cristo discese all’inferno: sapendo per lunga esperienza che il loro Dio amava tentarli, essi sospettarono che anche questa volta si trattasse di una tentazione e perciò non vollero credere al Vangelo di Cristo (Iren. I, 27, 3).
12. In genere Marcione determina il carattere del dio del mondo secondo quello del mondo, «perché ciò che è fatto deve essere simile a colui che lo ha fatto» (Hippol., “Refut.” X, 19, 2); la sua sapienza è identica alla «sapienza di questo mondo» nel senso peggiorativo attribuito dalla religione trascendentale. Nell’esegesi di alcuni passi di san Paolo, Marcione identifica semplicemente il creatore col mondo, prendendo quello che è detto di quest’ultimo come se si applicasse al primo; e secondo lui il creatore perisce alla fine col mondo per una specie di autodistruzione, che dimostra che in ultima analisi egli non è veramente un dio ma nient’altro che lo spirito di questo mondo.
13. Usato come simbolo dispregiativo della creazione (o un’allusione ad una delle piaghe d’Egitto?).
14. Ciò fornisce incidentalmente una prova conclusiva, contro il parere di Harnack, di una dipendenza di Marcione da una primitiva speculazione gnostica: perché l’argomento ha un senso soltanto nel caso in cui le anime sono particelle perdute della divinità da ricuperare, nel qual caso la riproduzione prolunga la prigionia del divino e mediante un’ulteriore dispersione rende più difficile l’opera di salvezza come di raccolta.
15. Non meno antivalentiniana che antimarcionita, naturalmente.
Capitolo 6.
IL «POIMANDRES» DI ERMETE TRISMEGISTO.
Nel corso del precedente capitolo ci siamo mossi in un ambito interamente giudaico-cristiano, per quanto con andamento assai irregolare e, riguardo all’aspetto giudaico, per via di rimbalzo. Le dottrine riguardanti i creatori del mondo che abbiamo or ora esaminato, furono formulate in antagonismo all’Antico Testamento. Sarebbe forse spingersi troppo oltre affermare che tale antagonismo sia stato di per sé la fonte dei princìpi gnostici, ma di certo li ha permeati e coloriti in misura più marcata in tutto codesto gruppo di sistemi. L’argomento del presente capitolo mostrerà che nel mondo ellenistico ebbe corso un pensiero ed una speculazione gnostica interamente liberi da connessioni col cristianesimo. Gli scritti ermetici, composti originariamente in greco, non soltanto sono del tutto pagani ma mancano anche di riferimenti polemici sia verso il giudaismo che il cristianesimo. Solo il “Poimandres”, per conto suo, mostra che l’autore aveva conoscenza della storia biblica della creazione, che aveva avuto larga diffusione nel mondo greco attraverso la traduzione dei Settanta.
La religione del «Tre volte grandissimo Ermete» ha avuto origine nell’Egitto ellenistico, dove Ermete era identificato con Thoth. Non tutto il “corpus” può essere considerato come una fonte gnostica: in molte parti di esso trapela lo spirito di un panteismo cosmico molto lontano dalla violenta condanna dell’universo fisico così caratteristica degli Gnostici. Altre parti sono prevalentemente morali, e il loro accentuato dualismo di sensuale e spirituale, di corpo e mente, sebbene in pieno accordo con l’atteggiamento gnostico, si adatta egualmente, per esempio, ad un contesto cristiano o platonico, perché esprime il generale andamento trascendentale dell’epoca. Ci sono tuttavia alcune parti indubbiamente gnostiche in questo assieme sincretistico, e particolarmente il primo trattato del “corpus”, chiamato “Poimandres”, è un evidente documento di cosmogonia e antropologia gnostica indipendente dalle speculazioni degli Gnostici cristiani. Il sistema del “Poimandres” s’accentra nella figura divina dell’Uomo Primordiale, il suo sprofondare nella natura è il culmine drammatico della rivelazione, uguagliato dall’ascesa dell’anima la cui descrizione conclude la rivelazione. E’ assente l’antitesi del creatore e del Dio supremo: il Demiurgo è stato incaricato dal Padre e la sua creazione sembra essere il modo migliore di trovare un senso all’esistenza di una tenebra caotica (come è stato fatto più tardi nel manicheismo). Tuttavia il fatto che l’Uomo divino sia stato racchiuso nel sistema cosmico non volutamente, è senz’altro tragico; e persino il carattere del prodotto più genuino del Demiurgo, le sette sfere e i loro governanti, risulta molto più problematico di quanto ci si potrebbe aspettare dal racconto della loro origine. Difficoltà considerevoli ostano alla composizione delle differenti parti in una dottrina coerente, e forse una certa ambiguità, dovuta alla combinazione di materiale contraddittorio, fa parte della sua stessa natura. Ci soffermeremo su tali questioni dopo aver riportato la parte principale del testo.
a) Il testo.
«1. Una volta, mentre ero in meditazione sulle cose che sono e la mia mente veniva sollevata in alto e i sensi corporei erano intorpiditi… pensai di vedere una presenza di smisurata grandezza che mi chiamava per nome e mi diceva: ‘Che cosa desideri udire e vedere e nel pensiero imparare a capire?’. 2. Risposi: ‘Chi sei tu?’. ‘Io sono Poimandres – egli disse – la Mente (Nous) del Potere Assoluto. Io so quello che tu desideri e sono con te ovunque’. 3. Dissi: ‘Desidero che mi si insegni la natura delle cose che sono e comprenderla, e conoscere Dio…’. Ed egli replicò ‘Tieni fermo nella tua mente ciò che desideri imparare ed io te lo insegnerò’.
4. A queste parole, egli cambiò forma e improvvisamente tutte le cose si spiegarono dinanzi a me in un lampo ed ebbi una visione illimitata essendo tutto divenuto Luce, serenità e gioia… E fui affascinato da quella vista. E dopo un poco ecco una Tenebra che scendeva in basso… (1), spaventevole e odiosa, aggrovigliata e tortuosa, simile ad un serpente. Poi vidi questa Tenebra mutarsi in una materia umida, agitarsi in modo indescrivibile e lanciare fumo come da un fuoco e pronunziare una specie di suono indicibile, lamentoso. Quindi ne uscì un ruggito [o un grido] inarticolato, paragonabile alla voce di un fuoco. 5. Dalla Luce venne una Parola (“logos”) santa sopra la materia, e un fuoco puro balzò dalla materia umida verso la sommità; era leggero e penetrante, e attivo nello stesso tempo; e l’aria essendo leggera seguì il soffio infuocato sollevandosi quanto il fuoco della terra e dall’acqua, cosicché sembrava sospesa ad esso; ma la terra e l’acqua rimasero al loro posto, mescolate insieme, di modo che la terra non si poteva discernere separata dall’acqua; ed esse erano mantenute in un movimento percepibile per mezzo del soffio della Parola che era portata sopra di loro.
6. Allora Poimandres mi disse: ‘Quella Luce sono Io, Nous, il tuo Dio, che ero prima della sostanza umida che è emersa dalla Tenebra. E la Parola luminosa che è uscita dal Nous è il Figlio di Dio… Da questo comprendi: ciò che in te vede e ode è la Parola del Signore, ma il Nous [il tuo nous?] è Dio Padre: essi non sono separati l’uno dall’altro perché la Vita è l’unione di questi… Ora dunque, concentra la tua mente nella Luce e impara a conoscerla’.
7. Ciò detto, mi fissò intensamente cosicché io tremavo alla sua vista; poi quando guardò in alto, vidi nel mio nous (2) la Luce consistente di Potenze innumerevoli e divenuta un Cosmo sconfinato, e il fuoco contenuto da un grande potere che restava al suo posto sotto il suo fermo controllo…
8. Di nuovo mi parla: ‘Tu hai visto nel Nous la forma archetipa, il principio che precede l’infinita origine ‘ (3)… ‘Da dove allora – chiesi sono sorti gli elementi della natura?’. Al che egli replicò: ‘Dalla Volontà (4) di Dio, che dopo aver ricevuto in se stessa la Parola e aver mirato la bellezza [archetipa] del Cosmo, lo ha imitato ed ha formato se stessa come un cosmo [o ordinato se stessa] in conformità dei suoi propri elementi e della sua progenie, ossia le anime.
‘9. Ma il Nous divino, essendo androgino, poiché esiste come Vita e Luce, produsse per mezzo di una parola un altro Nous, il Demiurgo, che come dio al di sopra del fuoco e del soffio formò sette Governanti, che racchiudono i loro cerchi in modo sensibile, e il loro governo si chiama Heimarmène [Destino]. 10. Immediatamente la Parola di Dio si slanciò in alto al di sopra degli elementi tendenti al basso nella pura [parte della] creazione fisica [la sfera demiurgica] e si unì con il Nous-Demiurgo, perché era della stessa sostanza. E così gli elementi inferiori della Natura rimasero senza ragione (5), cosicché essi non erano ormai che semplice Materia. 11. E insieme con la Parola il Nous-Demiurgo, abbracciando i cerchi e aggirandoli con velocità di tuono, impose un moto circolare alla sua creazione in una rivoluzione senza fine, perché ricomincia ove finisce. E codesta rotazione delle sfere in conformità della volontà del Nous[-Demiurgo] produsse dagli elementi inferiori animali irrazionali, perché quegli elementi non avevano trattenuto la Parola… [aria, acqua, terra – gli ultimi due ora separati – ciascuno producente i propri animali: androgini, come appare in seguito].
’12. Ora il Nous, Padre di tutto, essendo Vita e Luce, generò l’Uomo simile a se stesso, del quale si innamorò come del proprio figlio, perché era bellissimo avendo in sé l’immagine del Padre; anzi, in verità anche Dio si innamorò della propria forma e gli consegnò tutte le sue opere. 13. E l’Uomo, guardando la creazione che il Demiurgo aveva formato nel fuoco [le sfere celesti], volle creare anche lui ed ebbe il permesso dal Padre. Quando penetrò nella sfera demiurgica dove avrebbe avuto piena autorità, vide le opere di suo fratello, ed essi [i sette Governanti] si innamorarono di lui e ciascuno gli diede parte del proprio regno (6). Avendo conosciuto la loro essenza e avendo ricevuto la partecipazione alla loro natura, egli volle allora attraversare la circonferenza dei cerchi e sopraffare [?] (7) il potere di colui che governa sul fuoco. 14. Ed egli [Uomo] che aveva pieno potere sul mondo delle cose mortali e sugli animali irrazionali piegò in giù attraverso l’Armonia (8) ed essendo penetrato di là della volta mostrò alla Natura inferiore la bella forma di Dio. Quando essa mirò colui che aveva in sé la bellezza inesauribile e tutte le forze dei Governanti insieme alla forma di Dio, sorrise amorosa; perché essa aveva visto il riflesso di questa bellissima forma di Uomo nell’acqua e la sua ombra sulla terra. Anch’egli, vedendo la propria immagine presente in lei, riflessa nell’acqua, la amò e desiderò abitare in lei. Subito il desiderio divenne realtà ed egli venne ad abitare la forma priva di ragione. E la Natura, avendo ricevuto in se stessa l’amato, lo abbracciò completamente e si unirono: poiché essi erano accesi d’amore. 15. E questa è la ragione per cui soltanto l’uomo tra tutti gli animali della terra ha una duplice natura, mortale per il corpo, immortale per l’Uomo sostanziale. Perché, sebbene egli sia immortale ed abbia potere su tutte le cose, tuttavia subisce la sorte della mortalità, essendo sottoposto all’Heimarméne; sebbene fosse al di sopra dell’Armonia, egli è diventato schiavo nell’Armonia; sebbene fosse androgino, poiché proveniva dal Padre androgino, e incapace di sonno da colui che è incapace di sonno, egli è dominato dall’amore e dal sonno’.
[Segue una descrizione particolareggiata dell’origine della razza attuale degli uomini [16-19], e un’istruzione morale [20-23], che riassumiamo come segue. Poiché l’Uomo, ora mescolato con la Natura, ‘aveva in se stesso la natura dell’Armonia dei Sette’, la Natura generò sette uomini androgini, corrispondenti alle nature dei sette Governanti. Tralasciamo i particolari circa il contributo rispettivo dato dagli elementi – terra, acqua, fuoco ed etere – alla costituzione di queste creature. Quanto al contributo dell’Uomo come parte della mescolanza generante, egli si trasformò ‘da Vita e Luce in anima e mente (“nous”), in anima dalla Vita e in mente dalla Luce’ [17]. Tale condizione della creazione durò sino alla fine di un’èra del mondo. La nuova èra del mondo iniziò con la separazione di tutte le creature androgine, animali e uomini, in maschi e femmine. E’, questo, l’unico esempio in cui l’autore mostri la sua familiarità con la versione greca dell’Antico Testamento in una citazione diretta. Sul modello di Gen. 1, 22.28, Dio ammonisce la nuova creazione bisessuale: ‘Crescete e moltiplicatevi’; quindi continua con tutt’altra intonazione: ‘E (l’uomo) dotato di mente riconoscerà che è immortale e che causa della morte è l’amore’ (ossia, in definitiva, l’amore che ha trascinato l’Uomo Primordiale nella natura) [18]. Colui che è giunto a conoscere se stesso ha raggiunto il bene supremo; chi però ha amato il corpo venuto dall’errore dell’amore rimane nelle tenebre, errando, soffrendo nei propri sensi le opere della morte. Qual è dunque il peccato di coloro che sono ignoranti, perché debbano essere privati dell’immortalità? La causa prima del corpo individuale è l’odiosa tenebra dalla quale è venuta la materia umida, da cui è stato costituito il corpo del mondo sensibile, dal quale la morte ricava il nutrimento. Perciò coloro che amano il corpo sono di fatto “nella” morte e meritano la morte. D’altra parte, chi conosce se stesso sa che il Padre di tutte le cose consiste di Luce e di Vita, a somiglianza dunque dell’Uomo Primordiale che procede da lui, e per mezzo di ciò conosce di essere Luce e Vita, e per mezzo di questa conoscenza ritornerà alla Vita. Coloro che hanno conoscenza, ripieni di amore per il Padre, prima di abbandonare il corpo alla morte aborriscono i sensi, il cui effetto essi conoscono; e il Poimandres-Nous li assiste in ciò, agendo come una sentinella alle porte e sbarrando l’entrata alle influenze malvage del corpo. Gli ignoranti sono lasciati in preda alle cattive passioni che, insaziabili, costituiscono il loro tormento e aumentano sempre la fiamma che li consuma.]
[L’ultima parte dell’istruzione [24-26] è dedicata all’ascesa dell’anima dopo la morte. Anzitutto, dopo la dissoluzione del corpo materiale si abbandona al demonio la natura sensitiva (?) (9), ormai inefficace, e i sensi corporei ritornano ciascuno alla propria origine tra gli elementi.] ’25. E in seguito l’uomo si slancia in alto penetrando attraverso l’Armonia e nella prima zona abbandona il potere di crescere e decrescere, e nella seconda le macchinazioni dell’astuzia demoniaca, ormai impotenti, e nella terza l’inganno della concupiscenza, ormai resa impotente, e nella quarta la superbia del dominio, svuotata della sua ambizione [o impotente ora a realizzarla], e nella quinta l’audacia empia e la temerarietà del desiderio impulsivo, e nella sesta gli appetiti cattivi di ricchezza, ormai resi impotenti, e nella settima zona la menzogna che insidia. 26. E allora, spoglio degli effetti dell’Armonia, l’uomo entra nella natura dell’Ogdoade [ossia nell’ottava sfera che è quella delle stelle fisse], ormai in possesso del proprio potere, ed esalta il Padre insieme a coloro che già vi sono; e i presenti si rallegrano con lui per la sua venuta, ed egli essendo divenuto simile ai suoi compagni ascolta alcune potenze sopra l’ottava sfera che esaltano Dio con dolce voce. Ed allora in processione essi salgono verso il Padre e si consegnano alle Potenze, e divenuti essi stessi Potenze entrano nella Divinità. Questa è la fine buona di coloro che sono in possesso della gnosi: diventare Dio’».
b) Commento.
La composizione del trattato è chiara. La sua parte principale (1-26) è il resoconto, in prima persona, di un’esperienza visiva e dell’insegnamento impartito nel corso di essa. I paragrafi conclusivi (27-32), che abbiamo omesso di riportare, descrivono la successiva attività missionaria di colui che riceve il messaggio, in mezzo ai suoi simili. Nel racconto della rivelazione, la sola parte sulla quale ci soffermeremo qui, si possono distinguere le seguenti suddivisioni principali. Dal paragrafo 1 a 3, la descrizione della “situazione della visione” con l’apparizione di Poimandres («Pastore di Uomini»), che identifica se stesso col Nous (Mente), ossia con la divinità suprema. Dal paragrafo 4 a 11, la “cosmogonia” fino alla creazione di animali irrazionali; dal paragrafo 12 a 19, l'”antropogonia”, la dottrina centrale di tutta la rivelazione. Dal paragrafo 20 a 23, in cui si tirano le conclusioni morali ricavate dalle parti teoretiche precedenti della rivelazione, la descrizione dei due tipi opposti di “condotta umana”. I paragrafi da 24 a 26 completano la rivelazione descrivendo l’ascesa dell’anima gnostica dopo la morte. Commenteremo dapprima la dottrina centrale riguardo all’origine e all’assenza dell'”uomo”, alla quale la parte cosmogonica fornisce una base di conoscenza non necessaria in modo assoluto per la sua comprensione. Tratteremo in seguito l'”ascesa dell’anima”, che corrisponde alla discesa originaria dell’Uomo Primordiale, e i cui particolari completano il racconto di quest’ultima. Allora ritorneremo alla “cosmogonia” e cercheremo di rintracciare il bandolo della narrazione alquanto elusiva e non completamente omogenea di queste fasi iniziali del dramma.
– L’origine dell’Uomo divino.
L’uomo è terzo nella triade di creazioni divine successive o emanazioni: la Parola (Logos), la Mente-Artefice (Nous-Demiurgos), l’Uomo (Anthropos). Egli può considerare il Demiurgo come suo fratello, ma ha questa particolare analogia con il Logos, che entrambi sono in stretto rapporto con la Natura inferiore, la quale a suo tempo si dissolve di nuovo. La Parola e il Demiurgo devono adempiere ciascuno un compito cosmogonico, sul quale ci soffermeremo in seguito; mentre l’Uomo è stato generato dal primo Dio “dopo” la fondazione del sistema cosmico, ma fuori di esso, e senza alcuno scopo apparente, oltre il fatto che Dio possa rallegrarsi della propria perfezione in un’immagine perfetta di se stesso non corrotta dalla mescolanza col mondo inferiore.
Questa versione dell’origine del dio Uomo, per le sue caratteristiche di essere creato «ad immagine di Dio» e creato soltanto dopo il termine della creazione cosmica, mostra una più stretta relazione col racconto biblico che non la versione più diffusa nello gnosticismo secondo la quale l’Uomo “precede” la creazione ed ha egli stesso una funzione cosmogonica. Le speculazioni rabbiniche su Adamo fondate sul duplice racconto della sua creazione in Gen. 1 e 2, che venivano riferite rispettivamente ad un Adamo celeste e ad un Adamo terrestre, forniscono un legame tra la dottrina biblica e quella gnostica riguardo al Primo Uomo. Certe dottrine di Zoroastro, sia attraverso quelle speculazioni giudaiche o direttamente, possono anche aver contribuito alla concezione di questa figura così straordinaria della teologia gnostica. La deviazione dal modello biblico (se questo è stato realmente il punto di partenza dello svolgimento, ciò che è molto discusso tra gli studiosi moderni) è notevole nelle caratteristiche seguenti: Dio non ha «fatto» l’Uomo, ma come principio generativo androgino lo genera e lo produce, cosicché egli è realmente un’emanazione della sua sostanza; egli non è formato di argilla, ma è pura Vita e Luce; la «somiglianza» non è una similitudine simbolica, ma è piena identità di forma, per cui Dio contempla ed ama in lui la Sua rappresentazione adeguata; egli è extramondano, mentre anche il Demiurgo ha il suo seggio all’interno del sistema cosmico, sebbene nella sfera più elevata e più esterna, l’ottava; le sue dimensioni sono proporzionate a quella della creazione fisica, come dimostra la sua seguente unione con l’insieme della Natura; il dominio che gli è dato non è soltanto, come nella Genesi, semplicemente sulla fauna terrestre, ma anche sul macrocosmo astrale.
L’esercizio di tale potere, tuttavia, non era lo scopo originario per cui il Padre lo produsse: potere che gli venne quando fu assecondato il suo desiderio di «potere anch’egli creare». La ragione della discesa del divino e del suo essere coinvolto nel basso mondo è più spesso, e in modo più logico, collegata col principio demiurgico stesso e mira a render conto della stessa esistenza del mondo (10). Ma in questo testo il mondo è già creato, ed è difficile scorgere che cosa possa ancora fare l’Uomo sia in collaborazione sia in competizione col Demiurgo. E nemmeno il seguito dell’esposizione fornisce una risposta a tale domanda: più che un impulso creativo, il motivo principale che lo spinge a penetrare il sistema demiurgico sembra essere la curiosità. Codeste incoerenze fanno pensare che si tratta di una forma accomodata del mito di Anthropos, nella quale sono conservate soltanto alcune tracce dell’originaria funzione cosmogonica del personaggio.
– La discesa dell’uomo; l’anima planetaria.
Il suo ingresso nella sfera demiurgica segna l’inizio della sua storia che si svolge all’interno del mondo. Il tributo resogli da parte di ciascuno dei sette Governanti che lo fanno partecipe ognuno del proprio regno, pare consistere in un accrescimento positivo del suo stesso essere: egli assorbe e quindi possiede in se stesso la natura dell’Armonia, cioè i poteri dei sette Governanti nelle loro sfere rispettive; il che, almeno agli occhi della Natura inferiore, sembra aumentare l’attrazione della forma divina quando egli le si mostra. Pure non va dimenticato che i Governanti e le loro sfere sono state plasmate dal Demiurgo col fuoco, che, sebbene fosse il più puro, è tuttavia uno degli elementi fisici originati dalla Tenebra primordiale. Così possiamo già a questo punto sospettare che i doni dei poteri planetari possano essere non del tutto desiderabili per un essere di pura divinità e possano anche avere i loro aspetti fatali. Il contesto diretto non ha nulla che possa dar adito a tale sospetto, anzi tenderebbe a dissiparlo, se non fosse per la descrizione che segue dall'”ascesa” dell’anima, e per altre spiegazioni all’interno e all’esterno della letteratura ermetica circa la sua discesa originaria attraverso le sfere fino alla sua dimora terrena. E’ questo un aspetto caratteristico della complessità della religione ermetica, oscillante tra il significato pregnostico e gnostico dello stesso tema mitologico. E il tema dell’acquisto di un’attrezzatura planetaria da parte dell’anima. Concezione che fa parte di dottrine astrologiche: ciascuno dei poteri planetari dà il suo contributo all’attrezzatura dell’anima prima della sua incarnazione. In una cosmologia affermativa, questi sono doni utili che fanno l’uomo adatto per la sua esistenza terrena. Ed è a causa di queste componenti psichiche che ha in se stesso che l’uomo è unito per connaturalità con le loro sorgenti astrali, cioè col cosmo, del quale partecipa l’«armonia». Per tale connaturalità egli è anche soggetto alle “influenze” delle stelle e quindi all'”heirmarméne” – il presupposto fondamentale dell’astrologia – ma finché il cosmo è considerato buono non vi è niente di deleterio in questa concezione; infatti è espressione di pietà cosmica (11). A questo insieme di idee lo gnosticismo ha dato una nuova interpretazione considerando i costituenti planetari dell’anima, acquisiti durante la sua discesa attraverso le sfere cosmiche, come corruzioni della sua natura originaria. Il cristiano Arnobio riferisce questo insegnamento attribuendolo al pensiero ermetico:
«Mentre noi scivoliamo e precipitiamo nei corpi umani, si avvincono a noi dalle sfere cosmiche le cause per le quali diventiamo sempre peggiori» (Adv. nat. II, 16).
Uno stretto parallelo (in direzione opposta) alla versione del “Poimandres” sull’ascesa dell’anima si trova nella seguente descrizione della sua discesa:
«Nella loro discesa le anime trascinano con sé il torpore di Saturno, la collera di Marte, la concupiscenza di Venere, l’avidità di guadagno di Mercurio, la bramosia di potere di Giove; le quali cose provocano una confusione nelle anime, di modo che esse non possono più servirsi del loro potere e delle facoltà loro proprie» (Serv., “In Aen.” VI, 714).
Le espressioni dimostrano chiaramente che ciò che aderisce all’anima nel suo viaggio verso il basso ha il carattere di entità sostanziali, sebbene immateriali, le quali vengono spesso descritte come «avvolgimenti» o «vesti». Di conseguenza l’«anima» terrestre che ne risulta si può paragonare ad una cipolla con tanti strati, sul modello del cosmo stesso, solamente in ordine inverso: ciò che è più esterno là, qui è più interno, e una volta compiuto il processo di incarnazione ciò che è più interiore nelle sfere cosmiche, la terra, è, in quanto corpo, la veste più esteriore dell’uomo. Che questo “corpo” sia una fatalità per l’anima era stato ripreso nell’epoca dello gnosticismo. Ma ora anche questi avvolgimenti “psichici” sono considerati impedimenti e danni dello spirito ultramondano.
«Guardando giù dalla sommità eccelsa e dalla vita eterna e avendo contemplato con segreto desiderio l’appetibilità del corpo e della sua ‘vita’, così chiamata sulla terra, l’anima per la pesantezza di questo suo pensiero terreno precipita nel basso mondo… In ciascuna sfera [che essa attraversa] è rivestita di una veste eterea, cosicché essa gradualmente si riconcilia con la compagnia del rivestimento terreno. E perciò subisce tante morti quante sono le sfere che attraversa per giungere a ciò che qui sulla terra è chiamata ‘vita’» (Macrob., “In somn. Scip.” II, 11).
Ora, che cosa sono questi accrescimenti estranei? Nel loro insieme rappresentano il carattere empirico dell’uomo con tutte le facoltà e inclinazioni per le quali l’uomo si mette in rapporto col mondo della natura e con la società; costituiscono cioè quello che normalmente si chiamerebbe la sua «psiche». E qual è l’entità originaria ricoperta da codeste incrostazioni? E’ il principio acosmico trascendente nell’uomo, in genere nascosto e non svelato nelle sue preoccupazioni terrene, o che si rivela negativamente in un sentimento di estraneità, di non completa appartenenza, e che diviene positivo quaggiù soltanto per mezzo della gnosi, la quale nella contemplazione della luce divina gli fornisce un contenuto acosmico di ciò che le è proprio e lo restituisce così nella sua primitiva condizione, ora oscurata.
Molto spesso, come abbiamo visto precedentemente, questo principio segreto è chiamato «pneuma», mentre il termine «psiche» è riservato al rivestimento «cosmico» manifesto. Gli scritti ermetici evitano il termine «pneuma» nel significato spirituale (12), e lo sostituiscono con «nous»; ma altrove il nome «psiche» è usato, con appropriate specificazioni, per “entrambe” le parti, e spesso, come nelle precedenti citazioni, leggiamo semplicemente che l’«anima» discende e subisce le deteriorazioni descritte. Nel caso in cui la dignità tradizionale del termine «anima» è mantenuta, quelle deteriorazioni sono chiamate o spiriti aggiunti all’anima originaria o addirittura una seconda anima che contiene la prima. Per la prima versione citiamo Clemente Alessandrino:
«Quelli intorno a Basilide hanno l’abitudine di chiamare le passioni ‘appendici’, che, essi dicono, sono nella loro essenza certi spiriti aggiunti all’anima razionale in seguito a un primitivo rivolgimento e confusione» (Strom. II, 20,112).
Nella scuola di Basilide si riteneva che queste appendici nella loro totalità costituissero esse stesse un’anima, come mostra il titolo di un’opera perduta del figlio Isidoro, “Sull’accrescimento dell’anima”, che tratta della «forza delle appendici» (ibid.) (13). Queste idee sfociarono nella teoria della doppia anima riguardo all’uomo terreno, che troviamo esplicitamente affermata come dottrina ermetica in una tarda opera neoplatonica.
«L’uomo ha due anime: una è dalla Prima Mente e partecipa anche del potere del Demiurgo, l’altra è stata immessa dalla rivoluzione dei cieli ed in questa penetra l’anima che vede Dio. Stando così le cose, l’anima che è discesa dentro di noi dalle sfere (lett.: «mondi») segue il corso delle rivoluzioni delle sfere, ma quella presente in noi come mente dalla Mente è superiore alla mozione che opera il divenire, ed è da essa che proviene la liberazione dell’heimarméne e l’ascesa agli Dei Intelligibili» (Iamblic., “De myst.” VIII, 6).
Per riferire ancora una citazione, lo scrittore gnostico siriaco, Bardesane, dice:
«Ci sono poteri ostili, stelle e segni, un corpo dal Malvagio senza resurrezione, un’anima dai Sette» (Ephraem, “Hymn.” 53).
Si potrebbero moltiplicare le testimonianze sulla dottrina dell’anima planetaria (per esempio, dalla letteratura mandea e dalla “Pistis Sophia”), ma la nostra scelta ha reso abbastanza chiaramente l’essenziale della concezione.
La citazione ermetica tratta da Giamblico mostra con singolare chiarezza ciò che sta dietro a questa fantasia mitologica: non un rifiuto dell’universo fisico in una luce di pessimismo, ma l’affermazione di un’idea interamente nuova circa la libertà umana, molto diversa dalla concezione morale di essa che avevano elaborato i filosofi greci. Per quanto profondamente l’uomo sia determinato dalla natura nella quale egli è totalmente inserito – e sondando nel proprio interno si può scoprire di strato in strato tale dipendenza – c’è pur sempre un nucleo interiore che non appartiene al regno della natura e per il quale egli è al di sopra di tutti i suoi stimoli e necessità. L’astrologia è vera per l’uomo naturale, ossia per ogni uomo in quanto membro del sistema cosmico, ma non per l’uomo spirituale all’interno del naturale (14). Per la prima volta nella storia è stata scoperta la differenza radicale tra uomo e natura e l’esperienza di tale realtà così fortemente emozionante è stata espressa in dottrine strane e suggestive. Questa frattura tra uomo e natura non doveva essere mai più colmata e l’affermazione della nascosta, ma essenziale “diversità” dell’uomo, divenne un tema frequente, in molte varianti, nella ricerca della verità circa l’uomo.
– L’unione dell’uomo con la natura; il tema di Narciso.
Consideriamo ora l’altra parte del dramma di Anthropos, la caduta dell’Uomo nella Natura inferiore. Su questo punto la narrazione è meravigliosamente chiara ed impressionante: la rivelazione dall’alto della sua forma divina alla Natura terrestre è nello stesso tempo il suo rispecchiarsi negli elementi inferiori, ed egli è trascinato sempre più in giù dalla propria bellezza il cui riflesso gli appare dal basso. Il tema di Narciso come viene qui sfruttato è una caratteristica originale del “Poimandres”, e, così esplicito, ricorre altrove nella letteratura dell’epoca soltanto in confusi accenni. Il tema di Narciso, tuttavia, dà solo una particolare impronta ad un’idea mitologica molto frequente nel pensiero gnostico, il cui significato originario non ha niente a che fare con la leggenda greca: l’idea che il processo cosmogonico o la caduta dell’anima, o più generalmente il movimento verso il basso di un principio divino, sia stato iniziato da un riflesso della Luce superiore nella Tenebra sottostante. Se analizziamo attentamente la versione del Poimandres, osserviamo in esso la combinazione ingegnosa di tre idee differenti: quella della Tenebra che si innamora della Luce e si impossessa di una parte di essa; quella della Luce che si innamora della Tenebra e si sprofonda volontariamente in essa; quella di una radiazione, riflesso o immagine della Luce proiettata giù nella Tenebra e qui trattenuta fermamente. Tutte e tre queste idee si trovano rappresentate nel pensiero gnostico. La prima attribuisce l’iniziativa d’una possibile mescolanza alle forze inferiori, e questa versione si trova espressa in forma più completa nel sistema manicheo, del quale tratteremo separatamente. Della seconda versione è stato dato un esempio nella citazione ermetica tratta da Macrobio (p. 173 in nero). Risulta chiaro dalla tradizione araba degli Harraniti, di cui abbiamo dato una citazione precedentemente (15), che tale versione non si riferisce soltanto alla discesa dell’anima individuale, ma principalmente alla discesa cosmogonica dell’Anima primordiale.
La terza versione ci appare la più bizzarra, perché implica l’idea mitica della sostanzialità di un’immagine, riflesso o ombra, come rappresentante una parte reale dell’entità originaria dalla quale si è distaccata. Bisogna ritenere che questo simbolismo fosse convincente per coloro che lo adoperavano per la fase cruciale del dramma divino. In questo senso lo troviamo usato nella speculazione dei Setiani (Hippol. V, 19), nei Perati (ibid. 12 ss.), negli Gnostici contro i quali scrisse Plotino, e in un sistema ricordato da Basilide non come suo proprio ma di alcuni «barbari», termine che molto probabilmente stava ad indicare dei pensatori persiani (Act. Arch. 67, 5). L’idea generale comune a queste dottrine è la seguente. Per sua natura la Luce brilla nella Tenebra sottostante. Codesta illuminazione parziale della Tenebra è paragonabile all’azione di un semplice raggio, ossia ad una lucentezza che si diffonde come tale, oppure se proviene da una figura divina individuale come la Sophia o l’Uomo, è del tipo di una “forma” proiettata nel mezzo tenebroso e che appare là come immagine o riflesso del divino. In entrambi i casi, sebbene non vi sia stata una reale discesa o caduta dell’originale divino, qualche cosa di esso è rimasto immerso nel basso mondo, e appunto perché la Tenebra lo considera una spoglia preziosa, per questo motivo la divinità non caduta è rimasta implicata nell’ulteriore destino di questa emanazione. La Tenebra è presa da cupidigia per lo splendore apparso nel suo mezzo o sulla superficie delle acque primordiali e cercando di mescolarsi ad esso e trattenerlo strettamente e in permanenza, lo trascina in basso, lo assorbe e lo spezzetta in innumerevoli particelle. Da allora in poi le potenze superiori sono coinvolte nel ricupero di queste particelle rapite di Luce. D’altra parte, è con l’aiuto di tali elementi che le potenze inferiori sono in grado di creare questo mondo. In ogni parte della creazione è dispersa la loro preda originaria sotto forma di «scintille», cioè di anime individuali. In una versione un po’ più sofisticata del concetto, è con l’aiuto dell'”immagine” proiettata della “forma” divina che le potenze inferiori producono il mondo o l’uomo, cioè come “imitazione” dell’originale divino; ma poiché in tal modo la forma divina viene incorporata nella materia di Tenebra e l’«immagine» è considerata come parte sostanziale della divinità stessa, il risultato è poi lo stesso che nel caso più rozzo dell’inghiottimento e della suddivisione. In ogni caso tutto questo insieme di simbolismo sviluppa la tragedia divina senza una colpa dall’alto o un’invasione dal basso del regno divino. Che la semplice e inevitabile radiazione della Luce e il suo riflesso in forma di immagini crei nuove ipostasi del suo stesso essere è ancora in Plotino un principio metafisico di prim’ordine, che influenza il suo schema ontologico generale. Per quanto riguarda in particolare la relazione dell’anima superiore con quella inferiore, egli spiega, nello stesso contesto in cui riferisce la similitudine di Platone del dio del mare (confronta nota 13), che il volgersi dell’anima verso il basso non è altro che l’illuminazione da parte sua di ciò che sta sotto di lei; attraverso questa illuminazione si origina un “eidolon”, un riflesso, che è l’anima inferiore soggetta alle passioni; ma l’Anima originaria in realtà non discendeva mai (Enn. I, 1,12). Una dottrina sorprendentemente analoga è affermata da quegli stessi Gnostici che erano stati bersaglio delle aspre critiche di Plotino:
«L’Anima, essi dicono, e una certa Sapienza [“sophia”: Plotino non è sicuro se essa sia diversa o identica all’«Anima»] si è volta verso il basso… e con essa sono discese le altre anime: queste, come fossero ‘membri’ della Sapienza, assunsero corpi… Ma poi di nuovo essi dicono che colei per la quale le anime sono discese non è, in un altro senso, discesa essa stessa e in qualche modo non si è realmente volta al basso, ma ha soltanto illuminato la Tenebra, dal che ha avuto origine una ‘immagine’ (“eidolon”) nella Materia. Poi essi fingono un’ulteriore ‘immagine dell’immagine’ che si forma in qualche parte quaggiù per mezzo della Materia o Materialità… e fanno così generare colui che chiamano Demiurgo e lo fanno separare dalla Madre, continuando a far procedere da lui il mondo fino all’ultima delle ‘immagini’» (16) (Enn. II, 9,10).
La differenza principale, e in verità cruciale, su questo punto tra gli Gnostici e Plotino è che i primi deplorano la «discesa» per immagine-riflessione come causa della tragedia divina e della passione, mentre Plotino l’afferma come autoespressione necessaria e positiva dell’efficacia della prima sorgente. Ma la struttura verticale di questa scala di sviluppo, cioè la direzione verso il basso di tutta la generazione metafisica che perciò non può essere che deteriorazione, è comune ad entrambi.
Ora, questa apparizione della Luce dall’alto in un riflesso dal basso può anche servire come spiegazione dell’errore divino. Tutta la tragedia della Pistis Sophia, il suo vagabondare, la sua miseria, il suo pentimento nel mondo della tenebra, è conseguenza del fatto iniziale che essa ha scambiato la luce che ha visto in basso per la «Luce delle Luci» per la quale si struggeva dal desiderio, e l’ha seguita fino nelle profondità. Troviamo inoltre, particolarmente nella speculazione di Mani, l’uso frequente di una similitudine divina come esca per allettare e trattenere la sostanza divina da parte degli arconti, oppure al contrario adoperata da parte dei messaggeri della divinità per sottrarre la luce-sostanza catturata dalla prigionia degli arconti.
Possiamo ora renderci conto che il tema di Narciso nell’errore – amore di Anthropos nel “Poimandres” – è una sottile variante e combinazione di parecchi dei temi cui abbiamo accennato. Egli non è così colpevole come quell’Anima primordiale che soccombe al desiderio dei piaceri del corpo, perché è la bellezza della sua propria forma divina, essa stessa somiglianza perfetta del Dio supremo, che lo trascina in basso. Egli è più colpevole della Pistis Sophia che è semplicemente ingannata, perché egli vuole agire indipendentemente e non avrebbe potuto confondere il riflesso quaggiù con la luce del Padre dal quale egli si era separato di proposito. Tuttavia egli è per metà scusato del suo errore per il fatto che ignorava la vera natura degli elementi inferiori, avvolti com’erano nel suo proprio riflesso. Perciò la proiezione della sua forma sulla terra e sull’acqua ha perso il carattere di un evento in sé sostanziale, e nella manipolazione di questo autore ellenistico è diventato il mezzo per motivare piuttosto che costituire l’immersione di un’emanazione divina nel basso mondo.
– L’ascesa dell’anima.
Veniamo ora all’ascesa dopo la morte dell’anima che ha acquistato conoscenza, principale prospettiva offerta al vero gnostico o pneumatico, nella cui anticipazione egli indirizza la sua vita. Dopo ciò che abbiamo visto circa le dottrine prevalenti collegate con la discesa astrale dell’anima, la descrizione dell’ascesa nel “Poimandres” non richiede ulteriori spiegazioni; essa è il rovescio della prima. Ma alcuni paralleli e variazioni presi da altre scuole di speculazione gnostica possono sottolineare la vasta diffusione e la grande importanza di questo tema in tutto l’ordine della religione gnostica. Il viaggio celeste dell’anima che ritorna è invero una delle caratteristiche più comuni e costanti in sistemi che per altri aspetti divergono grandemente, e il suo significato per la mente gnostica è valorizzato dal fatto che esso rappresenta una fede non soltanto essenziale nella teoria e aspettativa gnostica, e inoltre espressiva della concezione della relazione dell’uomo con il mondo, ma anche di importanza “pratica” immediata per il credente gnostico, poiché il senso della gnosi è quello di preparare per l’evento finale e tutta la sua istruzione etica, rituale, tecnica, è intesa ad assicurare il suo adempimento completo. Storicamente c’è un aspetto di portata ancora maggiore del significato letterale per le dottrine dell’ascesa. In uno stadio posteriore di sviluppo «gnostico» (sebbene non più denominato gnosticismo), la topologia esterna dell’ascesa attraverso le sfere, col progressivo spogliamento dell’anima dai suoi viluppi mondani e il ricupero della sua originale natura acosmica, poté essere «interiorizzato» e trovare il suo analogo, in una tecnica psicologica di trasformazione interiore per la quale l’io, “mentre è ancora nel corpo”, può raggiungere l’Assoluto come condizione immanente, seppure temporanea: una scala ascendente di stati mentali sostituisce le stazioni dell’itinerario mitico: la dinamica della progressiva trasformazione spirituale di sé sostituisce la spinta spaziale attraverso le sfere.
Per tal modo la stessa trascendenza è volta in immanenza, tutto il processo viene spiritualizzato e posto entro il potere e l’ambito del soggetto. Con questa trasposizione di uno schema mitologico nell’interiorità della persona, con la trasposizione dei suoi stadi oggettivi in fasi soggettive di un’esperienza attuabile il cui punto culminante ha la forma di estasi, il mito gnostico si è trasformato in misticismo (neoplatonico e monastico), e in questo nuovo mezzo continua la sua vita molto dopo la sparizione delle originali credenze mitologiche.
Nel “Poimandres” l’ascesa è descritta come una serie di successive sottrazioni che lasciano il vero sé «nudo», esempio dell’Uomo Primordiale qual era prima della sua caduta cosmica, libero di entrare nel regno divino e diventare di nuovo una sola cosa con Dio. Abbiamo visto precedentemente una versione diversa dell’ascesa in cui la caratteristica principale del viaggio non è lo spogliamento dell’anima, ma il suo passaggio come tale. Codesta versione sottintende che ciò che inizia l’ascesa è già il puro pneuma sciolto dai suoi ingombri terreni, e inoltre, che i governanti delle sfere sono poteri ostili che cercano di impedirne il passaggio allo scopo di trattenerlo nel mondo. Entrambe queste versioni sono ampiamente documentate negli scritti gnostici. Ovunque si legge di svestire, di rivestire, di scioglimento di nodi, di apertura di ceppi lungo il viaggio verso l’alto, si hanno analogie con passi del “Poimandres”. L’insieme di tali nodi, ecc., è chiamato «psiche»: che è l’anima di cui lo pneuma si libera (confronta Iren. I, 7, 1; 21, 5). In questo senso l’ascesa non è soltanto un processo topologico, ma anche qualitativo, quello di abbandonare la natura mondana. E’ degno di nota che in taluni culti questo processo ultimo veniva anticipato da esecuzioni rituali che a modo di sacramenti dovevano effettuare una trasformazione provvisoria o simbolica già in questa vita e garantirne la definitiva consumazione in quella futura. Così i misteri di Mitra imponevano ai loro iniziati il cerimoniale del passaggio attraverso sette porte disposte su scalini ascendenti che rappresentavano i sette pianeti (il cosiddetto “klimax heptapylos”: Orig., “Contra Celsum”, VI, 22); in quelli di Iside troviamo un successivo vestire e svestire di sette (o dodici) abiti o travestimenti animali. Il risultato raggiunto da tutto il rituale prolungato e talvolta tormentoso era chiamato rinascita (“palingenesia”): si riteneva che l’iniziato stesso fosse rinato come il dio. La terminologia di «rinascita», «trasformazione» (“metamorphosis”), «trasfigurazione», fu coniata, nel contesto di questi rituali, come parte del linguaggio dei culti misterici. I significati e le applicazioni che si potevano dare a queste metafore erano abbastanza estesi perché si adattassero a numerosi sistemi teologici; infatti il loro era anzitutto un richiamo «religioso» in senso generale piuttosto che dogmatico specifico. Ma sebbene né per l’origine né per la validità fossero legati all’inquadratura gnostica dottrinale, essi erano notevolmente adatti per gli scopi gnostici. Nel contesto del culto misterico, o in sue sostituzioni private e spiritualizzate, ispirate dal modello generico, il «viaggio celeste» poteva diventare di fatto un’esperienza visiva raggiungibile durante il breve stato estatico. La cosiddetta Liturgia di Mitra (17) dà una descrizione circostanziata di tale esperienza, preceduta da istruzioni sul modo di prepararsi allo stato di visione e come effettuarlo. (Il sistema teologico in questo caso è cosmico-panteistico, non dualistico; lo scopo è l’immortalità per mezzo dell’unione col principio cosmico, anziché la liberazione dalla schiavitù cosmica.) La concezione del viaggio più specificamente gnostica come spogliamento graduale durante l’ascesa attraverso le sfere è sopravvissuta a lungo nell’esperienza mistica e nelle composizioni letterarie. Mille anni dopo il “Poimandres”, Omar Khayyám canta:
«Dal centro della terra attraverso la settima porta
mi sono innalzato, e sul trono di Saturno mi sono seduto,
e molti nodi ho sciolto lungo il cammino;
ma non il nodo maestro del destino umano.
C’era una porta per la quale non ho trovato chiave;
c’era un velo attraverso il quale non potevo vedere:
c’eran momenti di breve discorso tra Me e Te,
e poi non più né Te né Me».
(Ruba’is 31-32, secondo la trad. di Fitzgerald) (17 a).
L’altra versione dell’ascesa, meno spiritualizzata, ha un aspetto più sinistro. L’anima con ansietà e timore anticipa il suo futuro incontro con i terribili Arconti di questo mondo decisi ad impedirne la fuga. In questo caso la gnosi ha due compiti: da una parte, quello di conferire all’anima una qualità magica per la quale diventa inespugnabile e forse persino invisibile agli Arconti in agguato (i sacramenti compiuti in questa vita possono assicurare questo scopo); dall’altra, quello di istruire l’anima per fornire all’uomo i nomi e le formule efficaci con le quali aprirsi il passaggio, e tale «conoscenza» è uno dei significati del termine «gnosi». E’ necessario conoscere i nomi segreti degli Arconti perché questo è un mezzo indispensabile per vincerli. L’autore pagano Celso che ha scritto su tali credenze mette in ridicolo coloro che «con meschinità hanno imparato a memoria i nomi dei guardiani delle porte» (Orig., “Contra Celsum”, VII, 60).
Se questa parte della «gnosi» è magia grossolana, le formule che si rivolgono agli Arconti manifestano aspetti significativi della teologia gnostica. Ne abbiamo citato una più su (confronta cap. 5, a) e aggiungiamo qui alcuni altri esempi. Epifanio riferisce da un vangelo gnostico di Filippo:
«Il Signore mi ha rivelato ciò che l’anima deve dire quando ascende in cielo, e come deve rispondere a ciascuno dei poteri superiori: ‘Sono giunto a conoscere me stesso ed ho raccolto me stesso da ogni parte, e non ho seminato figli per l’Arconte, ma ho estirpato le sue radici e raccolto i membri dispersi, e conosco chi sei tu: perché io sono di coloro che sono dall’alto’. E così essa è liberata» (Epiph., “Haer.” 26,13).
Origene, nella sua preziosa trattazione degli Ofiti, riferisce la lista completa delle risposte che devono essere date «alle porte eternamente sbarrate degli Arconti». Ne riportiamo le due seguenti. A Ialdabaoth, «primo e settimo»:
«Io, essendo una parola del puro Nous, opera perfetta per il Figlio e il Padre, in possesso di un simbolo impresso col carattere della Vita, apro la porta del mondo che tu hai chiuso col tuo eone, e passo attraverso il tuo potere di nuovo libero. Possa la grazia essere con me, sì, Padre, che sia con me».
A Sabaoth:
«Arconte del quinto potere, governatore Sabaoth, avvocato della legge della tua creazione, ora disfatta da una grazia che è più possente del tuo quintuplice potere, osserva il simbolo inespugnabile da parte della tua arte (18) e lasciami passare oltre» (Orig., “Contra Celsum”, VI, 31).
E’ evidente che tali formule hanno la forza di parole d’ordine. Qual è dunque l’interesse degli Arconti nell’ostacolare l’esodo dell’anima dal mondo? La risposta gnostica è così riferita da Epifanio:
«Essi dicono che l’anima è il nutrimento degli Arconti e delle Potenze senza il quale non possono vivere, perché essa proviene dalla rugiada dall’alto e dà loro forza. Quando si è impregnata di conoscenza… essa ascende in cielo e si difende dinanzi a ciascun potere e sale al di là di essi fino alla Madre eccelsa e al Padre del Tutto da dove essa è discesa in questo mondo» (Epiph., “Haer.” 40, 2).
– I primi inizi.
Nel “Poimandres” non è detto che i Governanti siano malvagi, sebbene il fatto di essere soggetti al loro governo, chiamato Destino, sia considerato chiaramente come un’avversità per l’Uomo e una violazione della sua sovranità originaria. Il che suscita la questione circa la qualità teologica della creazione, e si giunge così alla sconcertante prima parte della visione, che tratta delle fasi iniziali della cosmogonia. Tutta la parte della rivelazione che precede la generazione dell’Uomo [4-11] presenta le seguenti suddivisioni: visione diretta della prima fase della cosmogonia, che precede la creazione reale [4-5]; spiegazione del suo contenuto da parte di Poimandres [6); riassunto e completamento della visione, che rivela il mondo intelligibile in Dio secondo il quale è stato formato quello sensibile [7]. In seguito la visione diventa ascolto, ossia la storia della creazione reale è verbalmente spiegata da Poimandres all’intelligenza ora illuminata dell’ascoltatore. Il paragrafo 8 tratta dell’origine degli elementi di natura: il rapporto di questa istruzione con la prima fase della visione [4-5] presenta l’enigma sul quale ora ci soffermeremo in modo particolare. I paragrafi 9-11 riferiscono la generazione del Demiurgo dal primo Dio, la formazione da parte sua delle sette potenze planetarie e delle loro sfere, la messa in moto di questo sistema, e in conseguenza della sua rivoluzione la produzione di animali irragionevoli provocata dagli elementi inferiori della natura. Degli eventi che seguono l’apparizione del Demiurgo nello schema teologico, soltanto lo slanciarsi della Parola dalla Natura nelle sfere superiori richiede una spiegazione. Quanto al resto, tratteremo soltanto delle fasi predemiurgiche.
Anzitutto fisseremo l’attenzione sul contenuto visivo della rivelazione iniziale, che fa dello spettatore un testimone oculare dei primi inizi. La Luce divina e l’orribile Tenebra simile ad un serpente, come primi princìpi, sono ormai familiari al lettore. Due tratti caratteristici, tuttavia, si possono notare nella descrizione che stiamo considerando. Il primo è che il campo della visione, per cominciare da questo, è formato di pura luce e soltanto «dopo un po’» appare in una parte di esso una tenebra che è portata in giù: il che ammette solo la conclusione che questa tenebra non è un principio originario coevo alla luce, ma che in qualche modo ha avuto origine da essa. L’altra caratteristica è l’osservazione misteriosa che un grido triste e lamentoso sorge dalla tenebra agitata. Ci occuperemo sotto delle questioni che entrambe queste affermazioni fanno nascere.
Come prima ipostasi separata del Nous supremo, la “Parola” procede dalla Luce divina e «arriva sulla» natura umida: da ciò che avviene in seguito, bisogna intendere questo «arrivare sopra» come un’intima unione del Logos con la natura umida, nella quale la Parola è trattenuta finché non viene di nuovo liberato dall’opera del Demiurgo. Per il momento, l’effetto della presenza della Parola nella natura tenebrosa è che quest’ultima viene separata in elementi più leggeri ed elementi più pesanti (non in modo completo rispetto a terra e acqua, che sono separate soltanto nella fase demiurgica): tale azione differenziatrice sulla materia caotica è la principale funzione cosmogonica del Logos (Parola), ma per mantenere questa differenziazione fino alla sua consolidazione finale per opera dell’Artefice (Demiurgo), il Logos deve restare “all’interno” della natura così divisa. E’ chiaro che qui il Logos ha il senso greco di principio di ordine, ma nello stesso tempo è un’entità divina e come tale sostanzialmente implicata in ciò che tocca.
Nel paragrafo 7 colui che ha la visione, ricevuto il comando di guardare attentamente alla luce, distingue in essa innumerevoli poteri e scopre che essa da parte sua non è una distesa uniforme, ma è organizzata come un cosmo, che Poimandres gli dice essere la forma archetipa; allo stesso tempo vede il fuoco «trattenuto da un grande potere» e tale potere non può essere che il Logos il quale mantiene gli elementi separati nel loro posto agendo dall’interno (19), mentre il fuoco è la circonferenza più esterna che si è costituita per il balzo del fuoco fuori dalla natura umida. Secondo questa spiegazione, l’inizio della seconda visione non presenta una nuova fase del processo cosmogonico, ma una ricapitolazione, ad un grado più elevato di comprensione, di ciò che si è svolto nella prima visione; il che, se l’ipotesi è corretta, è di importanza decisiva per l’interpretazione del paragrafo seguente [8], in ogni ipotesi, enigmatico.
Come nel paragrafo 7 colui che ha la visione impara qualche cosa di più circa la luce che ha visto per prima, così in questo paragrafo egli chiede e riceve istruzioni su quello che ha già formato il soggetto visivo della prima visione: l’origine degli elementi della natura. Alla domanda che egli rivolge: Da dove hanno avuto origine?, è facile aspettarsi la risposta: Dalla natura umida per l’azione separatrice della Parola; e, se si spinge oltre la domanda, la natura umida proviene dalla tenebra odiosa per sua stessa trasformazione; e allora la domanda seguente sarebbe: Da dove è venuta quella, se non c’era già all’inizio? e secondo la prima visione non c’era – e questa sarebbe la questione delle questioni che qualsiasi dualismo gnostico non iranico deve affrontare e che trova risposta nelle ingegnose speculazioni di tipo valentiniano, di cui forma l’argomento principale. La tesi loro comune è che una frattura o oscuramento all’interno della divinità possa in qualche modo spiegare l’esistente suddivisione della realtà. Ora, l’ipotesi allettante da proporre, visto che ogni altra spiegazione ci lascia più insoddisfatti, è per me che la Boulé (Volontà) di Dio, introdotta in questo paragrafo e abbandonata poi di colpo per non essere più menzionata, sia una variante della Tenebra infernale della prima visione, e come tale sia un elemento isolato del tipo siriaco di speculazione penetrata in qualche modo in questa esposizione. La conferma principale della mia ipotesi è la funzione del Logos in entrambi gli esempi. Allo stesso modo della natura umida, la quale dopo che il Logos «è venuto sopra di lei» si separa negli elementi, così la Volontà di Dio, di genere femminile, avendo «ricevuto» in sé il Logos si organizza «secondo gli elementi che le sono propri». La caratteristica che si aggiunge nell’ultimo caso è che la Boulé ordina se stessa «ad imitazione» dell’ordine archetipo che ha scoperto per mezzo del Logos; ossia, la Boulé è più un agente indipendente di quanto non lo sia la natura umida della prima visione. Di più, oltre gli «elementi» che formano oggetto della domanda, è ricordata una «progenie» psichica della Boulé, che si può ritenere uno dei suoi contributi alla futura creazione. Entrambe le caratteristiche le danno una notevole affinità con la figura della Sophia della gnosi siriaca. In altre parole, avremmo nella Boulé una versione di quel personaggio divino problematico, capace di ogni degradazione, che abbiamo incontrato per la prima volta nell’Ennoia di Simon Mago (20).
Un punto cruciale nell’analogia che abbiamo proposto della Boulé con la «natura umida» è il significato dell’espressione: essa «ricevette» il Logos. Fortunatamente questa stessa espressione ricorre a proposito dell’unione della Natura con l’Uomo, dove non soltanto comporta un evidente significato sessuale, ma vi è un’elaborata descrizione del come in questa unione la Natura assorbe nella sua totalità colui che essa così «riceve» [14]. Se questo è ciò che avviene anche per il Logos «ricevuto» dalla Boulé, allora egli, come Anthropos dopo di lui, ha bisogno di essere liberato da questa immersione. E infatti troviamo che il primo effetto dell’organizzazione sferica del macrocosmo da parte del Demiurgo è lo slancio del Logos dalla Natura inferiore verso lo spirito a lui affine nella sfera superiore. Ora, questo risultato dell’opera del Demiurgo coincide perfettamente con una dottrina, diffusa soprattutto nel manicheismo, ma che si trova anche in altri luoghi nello gnosticismo, la quale afferma che l’organizzazione cosmica è stata effettuata allo “scopo” di liberare un principio divino caduto in potere del regno inferiore nello stadio precosmico. Mi sembra inevitabile ritenere che tutto ciò pone la «Volontà di Dio», femminile, in una posizione intercambiabile con la «natura umida»: è nella prima che il Logos è stato «ricevuto» nel significato di quel termine sostenuto per il nostro trattato; è dalla seconda che esso si slancia in alto verso la sua vera affinità tramite la costruzione dell’universo, la quale costruzione era dunque del genere di una «salvezza» primordiale.
L’autore del “Poimandres” non ha ammesso nella sua composizione che poche tracce di questa dottrina. La liberazione del Logos attraverso la creazione del Demiurgo è perfettamente spiegabile, nei termini stessi del “Poimandres”, come conseguenza del fatto che con l’organizzazione stabile e definita del cosmo la sua presenza non è più richiesta nella Natura inferiore allo scopo di tenere gli elementi separati, cosicché si può piuttosto affermare che egli è liberato da un compito anziché da legami. Resta ancora il fatto che la sua comunione con la Boulé corrisponde in senso terminologico a quella dell’Uomo con la Natura, di cui è menzionata anche una «progenie»: le «anime» come prodotto della Boulé – una rassomiglianza impressionante con ciò che i Valentiniani affermano della loro Sophia (confronta cap. 7, p. 205 in nero). Se allora consideriamo le due entità che pretendiamo siano versioni alternantisi dello stesso principio metafisico, la Volontà di Dio e la prima Tenebra, osserviamo che può naturalmente sorgere l’obiezione che alcuni attributi di quest’ultima, quali il terrore, l’odiosità e la sua rassomiglianza con un serpente, si adattano soltanto ad una Tenebra originaria, antidivina, di tipo iranico e non ad una divina Sophia per quanto oscurata ed estraniata dalla sua sorgente. Ma è degno di nota che questa Tenebra appare “dopo” la Luce e deve essere nata “da” essa (contrariamente al tipo iranico), ed inoltre che si «lamenta»: due tratti caratteristici più secondo la speculazione della Sophia che secondo quella del dualismo primitivo. Si trova perciò nel corpo del “Poimandres”, più come semplice interposizione che come tema autonomo della composizione, un pallido riflesso di quel tipo di speculazione maggiormente rappresentativa che passeremo ora ad esaminare.
NOTE AL CAPITOLO 6.
1. «Che aveva avuto origine in una parte» o «… parte per parte», ossia gradualmente (?).
2. Ossia, «nella mia mente» in quanto identica al Nous assoluto.
3. O, forse, «il principio infinito che precede l’origine»?
4. “Boulé”, parola di genere femminile.
5. «Senza logos», poiché il Logos (Parola) li aveva abbandonati: “logos” significa «parola» e «ragione».
6. O: «della propria dotazione».
7. O: «comprendere pienamente».
8. Aderisco al significato astrologico e dinamico del termine. Gli interpreti più recenti attribuiscono ad “harmonia” il senso concreto che aveva nel linguaggio del carpentiere: «giuntura», «che s’incastra»; perciò Nock propone di tradurre con “composite framework”, Festugière con “armature des sphères”. Entrambi questi eccellenti studiosi, sebbene siano perplessi circa la traduzione più adatta, sono però certi che la parola in tutto il trattato denoti una particolare struttura “materiale” e non, come intendo io, l’essenza generale di un sistema di potere, cioè la legge dei movimenti coordinati del macrocosmo rappresentato dal sette pianeti (questi ultimi tuttavia considerati soprattutto nel loro aspetto «psicologico», come è chiaro dal racconto che segue dall’ascesa dell’anima). Circa le ragioni per cui mi oppongo alla più recente interpretazione, ne indicherò soltanto due: quella fornita dalla frase «(L’Uomo) avendo in sé la natura dell’armonia dei Sette» (16) che ha senso solo in riferimento al significato “astratto” dato in origine ad «armonia» dai Pitagorici; e il rincalzo che riceve dalla stretta relazione in cui il testo pone ripetutamente (16; 19) «armonia» e «heimarméne» (destino). In breve, “harmonia” sta per una totalità di forze (i Governanti) connotata dalla sua caratteristica unificante (la forma del loro governo collettivo), e non solo per una parete separatrice o una qualche altra entità più complessa, come un’impalcatura. Di passaggio, il sistema delle sfere è stato formato dal fuoco, che difficilmente si accorda con uno schema materiale.
9. Il testo ha “ethos” = «carattere», che in certo modo contrasta nel suo significato di carattere morale con tutto il passo (25-26), come pure altre affermazioni in 24.
10. Così nella storia mandea della creazione contenuta nel terzo libro del “Ginza di Destra” leggiamo che dal Grande Mana procedette dapprima la Vita: «e questa si rivolse una richiesta; e alla sua richiesta venne fuori l’Uthra saldamente fondato che la Vita chiamò la Seconda Vita… La Seconda Vita allora creò gli Uthra, stabilì le sh’kina… Tre Uthra rivolsero una richiesta alla Seconda Vita; essi “chiesero il permesso di creare delle sh’kina per se stessi”. La [Seconda] Vita lo accordò… Allora essi le dissero: ‘Dacci del tuo splendore e della tua luce, e noi partiremo e discenderemo giù sotto le correnti dell’acqua. Noi richiameremo in te delle sh’kina, creeremo in te un mondo, e il mondo sarà nostro e tuo’. Ciò piacque [alla Seconda Vita] e disse: ‘Lo accorderò loro’; ma al Grande [Mana] non piacque, e la [Prima] Vita non lo approvò». Per contrapporsi a questo piano degli Uthra il Grande Mana crea Manda d’Hayye, che in questo sistema corrisponde all’incirca all’uomo Primordiale, e lo incarica: «Sali in alto sopra gli Uthra e vedi a che punto sono e che cosa intendono fare, essi che dicono ‘Creeremo un mondo’»; e in seguito: «Tu hai visto, Manda d’Hayye che cosa stanno facendo gli Uthra e che cosa progettano su questo e quello. Tu hai visto che essi hanno abbandonato la Casa della Vita e hanno rivolto i loro volti al luogo delle Tenebre… Chi porterà ordine in mezzo ad essi, chi li libererà dal fallimento e dall’errore… che essi hanno portato su di sé? Chi farà udire loro la chiamata della Grande [Vita]?». Nel seguito di questo trattato, molto mal composto, una figura demiurgica individua diventa l’esecutrice del piano cosmogonico degli Uthra: Ptahil-Uthra, il quale da suo padre (uno degli Uthra, chiamato qui B’haq Ziva, altrove Abathur) riceve il mandato: «Va’, discendi nel luogo senza sh’kina e senza mondi. Crea e fai tu stesso un mondo come i figli della Beatitudine che tu hai visto» [abbiamo qui il motivo di imitazione di un mondo ideale, molto diffuso nella speculazione gnostica e che si trova anche nel “Poimandres”: forse ma non necessariamente una reminiscenza deformata del Demiurgo platonico]. «Ptahil-Uthra venne e discese sotto le sh’kina nel luogo dove non c’è mondo. Egli entrò nel sordido limo, entrò nell’acqua torbida… e il fuoco vivente in lui si trasformò» (G 65 s.s., 97 s.).
11. Per questo significato positivo dei doni dei pianeti confronta MACROBIO, “In somn. Scip.” I, 12; SERVIO, “In Aen.” XI, 51, e nel “Corpus Hermeticum” la “Kore Kosmou”.
12. Quando si trova, è nel senso di un elemento fisico, secondo l’uso stoico del termine.
13. Già Platone usa il paragone seguente assai espressivo per la presente condizione dell’anima in rapporto alla sua vera natura: «La nostra descrizione dell’anima è vera per quanto riguarda la sua apparenza presente, ma abbiamo visto che essa è afflitta da mali innumerevoli, come Glauco il dio del mare, la cui forma originale può a malapena essere distinta, perché parti del suo corpo sono state spezzate o corrose e completamente sfigurate dalle onde, e vi sono cresciute aderendovi su erbe, rocce e conchiglie, che lo hanno reso più simile ad un mostro che al suo essere naturale. Ma noi dobbiamo fissare piuttosto i nostri occhi sul suo amore della sapienza [“philosophia”] e notare che cosa essa cerchi di attingere e con chi mantenere rapporti, essendo congenere col divino, immortale ed eterno, e quale diverrebbe se i suoi affetti seguissero l’impulso che la farebbe salire in alto dal mare nel quale è ora affondata e la libererebbe da tutta quella profusione selvatica di rocce e conchiglie che l’hanno incrostata con la loro sostanza terrena, perché essa cerca ciò che gli uomini chiamano felicità facendo della terra il suo cibo. Allora si potrebbe vedere la sua vera natura…» (“Repubblica”, 611 C – 612 A). E’ notevole come Platone in questo paragone quasi accidentale giochi con parecchie immagini che sarebbero divenute in seguito terribilmente serie per gli Gnostici: il simbolismo del mare e delle «incrostazioni» estranee dell’anima. Per quanto riguarda queste ultime, Platone usa la stessa espressione (“symphyein”) di Isidoro nel titolo del suo libro. Seicento anni dopo Platone, Plotino fa riferimento al passo della “Repubblica” nel suo importantissimo discorso sull’anima superiore e inferiore (Enn. I 1, 12), sul quale avremo occasione di ritornare in rapporto al simbolo dell’immagine riflessa.
14. Tale supremazia è estesa a tutta la persona dello gnostico, nel quale lo «spirito» è diventato predominante: «Ermete afferma che coloro i quali conoscono Dio non soltanto sono salvi dagli attacchi dei demoni, ma non sono più sotto il potere del fato» (LATTANZIO, Div. ist. II, 15, 6; confronta ARNOBIO, Adv. nat. II, 62: «non soggetti alle leggi del fato»). Gli Gnostici cristiani pensavano ugualmente: «Prima del battesimo il fato è reale, dopo di esso le predizioni degli astrologhi non sono più vere» (Exc. Theod. 87, 1).
15. Confronta sopra, cap. 2, g. Diamo qui il resto del passo. «Dio, sempre desideroso di volgere tutto al meglio, la unì alla Materia, di cui la vide così innamorata, distribuendo in essa una moltitudine di forme. Di qui vennero le creature composte – il cielo, gli elementi [eccetera: tutti questi vanno intesi come ricettacoli dell”Anima’]. Ma non volendo lasciare l’Anima nella sua degradazione con la Materia, Dio la dotò di intelligenza e della facoltà di percezione, doni preziosi che avevano lo scopo di richiamarla al ricordo della sua alta origine nel mondo spirituale… di ristabilire in lei la conoscenza di se stessa, di indicarle che essa era straniera quaggiù… Dal momento che essa ebbe questa istruzione tramite la percezione e l’intelligenza, dal momento che riacquistò la conoscenza di se stessa, essa desiderò il mondo spirituale, come un uomo trasportato in terra straniera sospira verso la sua patria lontana. Essa è convinta che per ritornare alla sua condizione originaria deve liberarsi dai legami mondani, dai desideri sensuali, da tutte le cose materiali» (CHWOLSON, “Die Ssabier”, II, p. 493). Anche se l’ultima parte del passo sembra riferirsi all’anima umana (e così è perché è nell’uomo che l’anima del mondo caduta è dotata di intelligenza e percezione) la prima parte parla indubbiamente dell’Anima universale la cui caduta è causa dell’origine del mondo.
16. Confronta il passo mandeo: «Abathur (uno degli Uthra che progettano la creazione del mondo) va nel mondo [della tenebra]… Egli vede la sua faccia nell’acqua nera, e la sua immagine e figlio si forma in lui dall’acqua nera». Questo figlio è Ptahil-Uthra, il demiurgo attuale di questo mondo (G 173). Tale esempio così lontano dall’ambiente intellettuale in cui Plotino incontrò i suoi Gnostici mostra come l’atto di rispecchiarsi sia concepito sempre nella letteratura gnostica come produzione di un “alter ego”, e nello stesso tempo come ciò sia strettamente legato con la cosmogonia.
17. Erroneamente chiamata così poiché è un prodotto letterario, non di fatto un documento di culto.
17 a. Nota del curatore: vedi tuttavia una traduzione italiana alquanto differente in Omar Khayyam, “Roba’yyat”, traduzione italiana a cura di Pierre Pascal e G. degli Alberti (Torino, Boringhieri 1960), p. 90, n. 291*.
18. Tentativo di traduzione; oppure: «il simbolo inespugnabile della tua arte» (?).
19. Nonostante il termine «circondare», che suggerisce un’azione dell’esterno.
20. L’equazione della Boulé con la Sophia (passando per Iside) fu proposta per la prima volta da Reitzenstein (“Poimandres”, p. 45 s.), però con un’interpretazione «monistica» e perciò con conclusioni differenti dalle nostre. Gli argomenti di Festugière contro di essa (“La Révélation d’Hermès Trismégiste”, IV, p. 42 s.s.) non mi hanno convinto, specialmente perché la sua alternativa – la derivazione dalla speculazione pitagorica della diade (tenebra e femmina) dalla monade maschio-femmina – non è necessariamente un’alternativa ma, nel dare e prendere del sincretismo, perfettamente compatibile con l’ipotesi della Sophia. Sono d’accordo con Festugière che non c’è bisogno di tirare in ballo Iside.
Capitolo 7.
LA SPECULAZIONE VALENTINIANA.
a) Il principio speculativo del valentinianismo.
Valentino e la sua scuola rappresentano il culmine di ciò che abbiamo chiamato in questo studio, in mancanza di un termine migliore, il tipo siro-egiziano di speculazione gnostica. Il principio distintivo di codesto tipo è il tentativo di porre l’origine delle tenebre e quindi della frattura dualistica dell’essere “all’interno” della divinità stessa, e quindi di sviluppare la tragedia divina, la necessità di salvezza che ne deriva, e la dinamica di questa stessa salvezza, come una sequenza di eventi all’interno del divino. Inteso in senso radicale, questo principio fa sorgere il compito di derivare non soltanto fatti spirituali quali la passione, l’ignoranza, la malvagità, ma la natura stessa della “materia”, in contrasto con lo spirito, da una sorgente spirituale primitiva: la sua esistenza stessa va spiegata in termini di storia divina; e ciò significa in termini “mentali”, e, in considerazione della natura del prodotto finale, più particolarmente in termini di errore e fallimento divino. In tal modo, la materia apparirebbe una funzione piuttosto che una sostanza in se stessa, uno stato o «affezione» dell’essere assoluto, e l’espressione esterna solidificata di quello stato: la sua esteriorità stabile in realtà non è altro che un prodotto residuo di un movimento deteriorante di “introversione”, che rappresenta e stabilizza il livello più basso della defezione dell’assoluto da se stesso.
Ora, a parte l’interesse teoretico, il significato religioso di tale compito speculativo sta nel fatto che, in questo sistema, «conoscenza» e il suo opposto privativo «ignoranza» sono situati in una posizione “ontologica” di prim’ordine: entrambi sono princìpi di esistenza totale e oggettiva, non semplicemente di esperienza privata e soggettiva. La loro funzione è costitutiva della realtà nel suo insieme. L’«ignoranza», anziché essere, come è in genere nel pensiero gnostico, un “risultato” dell’immersione divina nel basso mondo, qui essa è piuttosto la causa prima dell’esistenza stessa del basso mondo, il suo principio originante come pure la sua “sostanza” permanente: per quanto numerosi possano essere gli stadi intermedi attraverso cui la materia, questo stadio in apparenza ultimo, è collegata con l’unica sorgente suprema, nella sua essenza non è altro che la forma oscurata ed estraniata da sé di ciò con cui essa sembra essere in opposizione – “proprio come ignoranza”, suo principio sottostante, “è la maniera oscurata del suo opposto, la conoscenza”. Perché la conoscenza è la condizione originaria dell’Assoluto, il fatto primordiale, e l’ignoranza non ne è soltanto l’assenza in un soggetto senza connessione con la conoscenza, ma è una perturbazione che ha colpito una parte dell’Assoluto, che proviene da motivi suoi propri e sfocia in una condizione negativa ancora collegata a quella originaria di conoscenza in quanto rappresenta la mancanza o pervertimento di essa. E’ perciò uno stato derivato, quindi revocabile, e così è anche la sua manifestazione esterna o prodotto ipostatizzato: la materialità.
Ma se è questa la funzione ontologica dell’«ignoranza», allora anche la «conoscenza» assume uno stato ontologico che va molto oltre la semplice importanza morale e psicologica che le viene attribuita; e la pretesa di redenzione avanzata in virtù di essa in ogni religione gnostica, riceve qui un fondamento metafisico nella dottrina dell’esistenza totale che la fa diventare, in modo convincente, il solo e sufficiente veicolo di salvezza, e questa salvezza stessa in ogni anima diviene un “evento cosmico”. Perché se non soltanto la condizione spirituale della persona umana, ma anche la stessa esistenza dell’universo è costituita dai risultati dell’ignoranza e come sostanzializzazione dell’ignoranza, allora ogni illuminazione individuale tramite la «conoscenza» aiuta ad annullare di nuovo il sistema totale sostenuto da quel principio; e, poiché tale conoscenza trasferisce infine l’io individuale nel regno divino, ha anche una funzione nella reintegrazione della stessa divinità sminuita.
Così questo tipo di soluzione del problema teoretico dei primi inizi e delle cause del dualismo, se avesse successo, stabilirebbe la posizione assoluta della gnosi nello schema soteriologico: dall’essere una condizione adatta per la salvezza, pur richiedendo la cooperazione della grazia divina e dei sacramenti, dall’essere un mezzo tra altri mezzi, essa diventa la forma adeguata della salvezza stessa. Un’aspirazione originale di tutto il pensiero gnostico viene qui ad essere realizzata. Che la conoscenza influisca non solo sul conoscente, ma sul conosciuto stesso; che il fondamento oggettivo dell’essere sia alterato e modificato da ogni atto «privato» di conoscenza; che soggetto ed oggetto siano gli stessi in essenza (sebbene non nello stesso grado) – sono, questi, princìpi di una concezione mistica della «conoscenza» che può ancora avere una base razionale in adatte premesse metafisiche. Con la pretesa orgogliosa che il loro sistema rappresentasse di fatto la soluzione al compito speculativo così inteso e fornisse le basi teoretiche per la sufficienza mistica della «sola gnosi», i Valentiniani potevano dire, respingendo tutto il rituale misterico e i sacramenti:
«Non si deve compiere il mistero del potere ineffabile e invisibile per mezzo delle cose visibili e corruttibili della creazione, né quello degli esseri impensabili e immateriali per mezzo delle cose sensibili e corporee. La “salvezza perfetta” è la “conoscenza” stessa dell’ineffabile grandezza: perché essendo venuti attraverso l”Ignoranza’, il ‘Difetto’ e la ‘Passione’ (1), tutto il sistema generato dall’Ignoranza è dissolto dalla conoscenza. Perciò la conoscenza è la salvezza dell’uomo interiore; e non è corporea, perché il corpo e corruttibile; non è psichica, perché anche l’anima è un prodotto del difetto ed è come un abitacolo per lo spirito: spirituale deve essere perciò anche la [forma della] salvezza. Per mezzo della conoscenza l’uomo interiore, spirituale, è salvato; perciò “a noi è sufficiente la conoscenza dell’essere universale”: questa è la vera salvezza» (Iren. I, 21, 4).
Questa è la grande «equazione pneumatica» del pensiero valentiniano: l’evento umano individuale della conoscenza pneumatica è l’inverso equivalente dell’evento precosmico universale dell’ignoranza divina, e nel suo effetto redentivo è dello stesso ordine ontologico. L’attualizzazione della conoscenza nella persona è nello stesso tempo un atto che si ripercuote nel fondamento generale dell’essere.
Abbiamo anticipato il risultato della speculazione valentiniana ed ora come argomento probante tale risultato presentiamo il sistema stesso. Precedentemente nel pensiero gnostico abbiamo incontrato due diverse figure simboliche che rappresentano nel loro fato la caduta divina: I’Uomo Primordiale, maschile; il Pensiero di Dio, femminile. Nei sistemi tipici della gnosi siro-egiziana è quest’ultima che personifica l’aspetto defettibile di Dio, in genere sotto il nome di «Sophia», ossia «Sapienza», nome paradossale in considerazione della storia di follia di cui essa è fatta protagonista. Un’ipostasi divina si trova già nella speculazione giudaica post-biblica, la «Sapienza» (“hokmah”), che vi era considerata come aiuto di Dio o agente nella creazione del mondo, simile all’altra ipostasi della «Parola». In che modo questa figura, o almeno il suo nome, sia stato combinato nel pensiero gnostico con la dea-luna, la dea-madre e la dea dell’amore della religione del Vicino Oriente, per formare quella figura ambigua che abbraccia l’intera scala dal più alto al più basso gradino, dal più spirituale al più sensuale (come è espresso dalla combinazione «Sophia-Prunikos», «Sapienza-Prostituta»), non possiamo sapere e in mancanza di documenti di qualsiasi stadio intermedio non possiamo nemmeno ricostruirne un’ipotesi. Già fin dal tempo di Simone la figura è pienamente sviluppata in senso gnostico. Ma l’elaborazione psicologica del suo destino è qui ancora rudimentale, la causa della sua caduta è più nel senso di un accidente capitato su di lei per motivo della sua progenie che nel senso di una motivazione interna. In altri sistemi che si avvicinano alla forma valentiniana, il racconto della Sophia diviene il soggetto di elaborazioni sempre più estese, e la sua partecipazione psicologica diviene sempre più preminente.
L’approssimazione maggiore alla forma valentiniana è rappresentata dai Barbelognostici descritti da Ireneo (I, 29), ora molto più conosciuti per mezzo dell'”Apocrifo di Giovanni”. Essi, come gli Ofiti (ibid. 30), hanno sentito la necessità, per poter spiegare tutta la grande estensione di condizioni rappresentate dall’aspetto femminile di Dio, di differenziare tale aspetto in una Sophia superiore e una Sophia inferiore, quest’ultima come forma decaduta della prima e portatrice di tutta la calamità divina e delle indegnità provenienti dalla caduta. In entrambi i sistemi la differenziazione è espressa da nomi separati: l’aspetto femminile originario di Dio è chiamato dai Barbelognostici «Barbelo» (forse «Vergine») e «Ennoia», dagli Ofiti «Spirito Santo» (questo per i Barbelognostici è uno dei nomi della forma decaduta); il nome «Sophia» è riservato da entrambi i sistemi alla sua sfortunata emanazione chiamata anche «Prunikos» e «La Sinistra». Questo sdoppiamento della Sophia è più completamente elaborato nel sistema valentiniano. La particolare somiglianza dei Barbelognostici con i Valentiniani consiste nel fatto che entrambi hanno sviluppato una dottrina del Pleroma (2) e usato il concetto di emanazione in coppie per la progressiva produzione fuori dell’unità divina, della quale i vari membri per i loro nomi astratti mostrano di essere aspetti differenti (3).
E’ con gli stessi mezzi formali, ma ad un livello superiore di scienza teoretica e di differenziazione spirituale, che Valentino ed i suoi seguaci hanno intrapreso la trattazione dello stesso tema speculativo. Le nostre osservazioni analitiche all’inizio di questo capitolo hanno indicato il doppio compito che si è assunto la speculazione valentiniana: da una parte quello di dimostrare il motivo intrinseco della degradazione divina senza l’intervento e persino partecipazione passiva di un agente esterno, dall’altra parte di spiegare la materia stessa come una condizione spirituale del soggetto universale. Non pretendiamo che questi due temi fossero i soli interessi teoretici dei Valentiniani (o anche che per essi il fronte intellettuale in genere, piuttosto che quello immaginativo, abbia costituito il significato religioso del loro insegnamento); ma la trattazione di quei temi particolari è certamente la parte più originale del loro pensiero che rappresenta quel contributo alla dottrina gnostica generale che giustifica il nostro modo di vedere in essi i rappresentanti più completi di tutto un tipo.
Valentino, il fondatore della scuola, nacque in Egitto e fu educato ad Alessandria; insegnò a Roma all’incirca tra il 135 e il 160 d.C. Egli è l’unico degli Gnostici che ebbe tutta una serie di discepoli conosciuti per nome, tra cui i più importanti furono Tolomeo e Marco. I quali furono anch’essi capiscuola e insegnarono la loro versione personale della dottrina valentiniana. Il principio speculativo del valentinianesimo di fatto invitava a sviluppi indipendenti dell’idea fondamentale da parte dei suoi aderenti; e in realtà conosciamo meglio la dottrina nelle molteplici versioni ed elaborazioni della seconda generazione che nell’insegnamento autentico di Valentino stesso, di cui è rimasto molto poco nelle trattazioni dei Padri (4).
Quanto la speculazione della scuola fosse sbrigliata e fertile, quanto grande la ricchezza della sua differenziazione dottrinale, lo si può costatare dal fatto che si hanno almeno sette versioni (senza contare quella di Marco) solo dello svolgimento della dottrina del Pleroma in Ireneo, Ippolito, Epifanio e negli estratti di Teodoto, le quali divergono notevolmente in alcune parti e rivelano una grande indipendenza di pensiero individuale. Ci sono note controversie teoretiche su alcuni punti intorno ai quali la scuola era divisa in parecchi rami. E’ a proposito dei Valentiniani che Ireneo nota: «Ogni giorno ciascuno di loro inventa qualche cosa di nuovo, e nessuno è considerato perfetto se non è produttivo in tal senso» (I, 18, 5). E lo si comprende bene dalla natura stessa del compito imposto dal tipo valentiniano di teoria gnostica. E’ probabile che la pienezza della speculazione sia stata raggiunta soltanto nell’opera dei discepoli più importanti.
Per quel che riguarda i vari rami che abbiamo ricordato, si sa di un ramo anatolico, conosciuto da noi soprattutto attraverso gli estratti di Teodoto, oltre il ramo italico, più ampiamente documentato, al quale appartenne Tolomeo, forse il più notevole dei fondatori del sistema. Nella ricostruzione abbreviata che facciamo seguire, ci atterremo nell’insieme alla trattazione generale di Ireneo (completata da quella di Ippolito) sui «Valentiniani», cioè probabilmente soprattutto su Tolomeo, e soltanto occasionalmente faremo un confronto con delle versioni divergenti. Ove occorra, daremo delle citazioni dall'”Evangelium Veritatis” (5), recentemente scoperto, il quale nel suo stile succinto dà un colorito nuovo e poetico alla trattazione dottrinale. Non possiamo tentare una completa interpretazione del materiale spesso enigmatico e sempre profondamente simbolico, perché ciò richiederebbe un volume a parte (6). Speriamo soltanto che le indicazioni generali date nelle osservazioni introduttive e i commenti occasionali nel corso del capitolo stesso aiuteranno il lettore ad apprezzare gli aspetti notevoli di questo sistema ingegnoso e affascinante, nonostante la sua eccentricità.
b) Il sistema.
– Lo svolgimento del Pleroma.
I misteri dei primi inizi vengono introdotti con queste parole solenni: «Lo Spirito indistruttibile saluta gli indistruttibili! A voi svelo segreti senza nome, ineffabili, sopracelesti, che non possono essere compresi né dalle dominazioni, né dalle potenze, né dagli esseri inferiori, o dalla completa mescolanza, ma sono stati rivelati solo all’Ennoia dell’Immutabile» (Epiph., “Haer.” 31, 5, 1 s.). Ed è questa la dottrina segreta.
Nelle altezze invisibili e senza nome c’era un perfetto Eone preesistente. Il suo nome è Primo-Principio, Progenitore e Abisso. Nessuna cosa può comprenderlo. Per innumerevoli eternità egli rimase nel più profondo riposo. Con lui era l’Ennoia (Pensiero), chiamata anche Grazia e Silenzio (7). E un tempo questo Abisso pensò di proiettare fuori di sé l’inizio di tutte le cose, e gettò questo progetto come un seme nella matrice del Silenzio che era con lui, ed essa concepì e generò la Mente (“Nous”, maschile), il quale è simile ed eguale al suo genitore e solo comprende la grandezza del Padre. Egli è chiamato anche Unigenito, Padre e Principio di tutti gli esseri. Insieme con lui fu generata la Verità (“Aletheia”, femminile), e questa è la prima Tetrade: Abisso e Silenzio, quindi Mente e Verità (8).
L’Unigenito, comprendendo con quale proposito era stato generato, da parte sua produsse con la sua consorte la coppia Logos e Vita, rispettivamente padre di tutte le cose venute dopo di lui, e principio e forma-madre di tutto il Pleroma. Da essi venne l’Uomo e la Chiesa (“Ecclesia”, femminile), e questo è l’Ogdoade originaria. Questi Eoni, prodotti per la gloria del Padre, vollero glorificare il Padre con la loro propria creazione e produssero ulteriori emanazioni. Da Parola e Vita provennero dieci Eoni supplementari, da Uomo e Chiesa dodici, cosicché da Otto e Dieci e Dodici viene costituita la Pienezza (Pleroma) di trenta Eoni in quindici coppie. Tralasciamo i particolari di questo processo generativo dopo l’Ogdoade, e facciamo soltanto osservare che i nomi dei successivi ventidue Eoni sono tutte astrazioni del tipo dei primi otto, ossia costruzioni artificiali e non nomi propri dalla tradizione mitologica. L’ultimo Eone femminile nella catena di emanazioni è la Sophia. «Pleroma» è il termine tipo per la molteplicità totalmente dispiegata di caratteristiche divine, il cui numero ordinario è trenta, formanti una gerarchia e costituenti nel loro insieme il regno divino. Generalmente il Progenitore o Abisso è contato nel numero, ma anche questa regola ammette delle eccezioni (9).
– La crisi nel Pleroma.
Il Pleroma non è un insieme omogeneo. L’Unigenito Nous soltanto, essendo uscito direttamente da lui, può conoscere il Progenitore: per tutti gli altri Eoni egli rimane invisibile e incomprensibile. «Era un grande prodigio che essi fossero nel Padre senza conoscerlo» (E. V. 22, 27 s.). Così soltanto il Nous gode la contemplazione del Padre e si diletta nella visione della sua infinita grandezza. Ora egli desiderava comunicare la grandezza del Padre anche agli altri Eoni, ma il Silenzio lo trattenne per la volontà del Padre, il quale voleva condurli tutti a considerare il loro Progenitore e cercarlo. Così gli Eoni ardevano in segreto dal desiderio di vedere il generatore del loro seme e ricercare la radice senza principio. «In verità il Tutto [il mondo degli Eoni = Pleroma] era alla ricerca di Colui dal quale essi provenivano. Ma il Tutto era in Lui, quell’Uno Incomprensibile, Inconcepibile, che è superiore ad ogni pensiero» (E. V. 17, 4-9). (Questo è il principio di una crisi nel Pleroma, dal momento che la sua armonia riposa sul suo ordine naturale, e questo nell’osservanza da parte dei suoi membri dei loro propri limiti – i quali membri tuttavia, essendo soggetti spirituali non possono rinunziare all’aspirazione di conoscere più di quanto i loro limiti permettano e così abolire la distanza che li separa dall’Assoluto.) L’ultimo e il più giovane (e perciò il più esterno) degli Eoni, la Sophia, si slanciò più lontano e fu presa da una passione fuori dall’abbraccio del suo consorte. Tale passione era diventata e si era diffusa per la vicinanza della Mente e della Verità, ma colpì ora la Sophia e penetrò in lei cosicché essa andò fuori di mente, in apparenza per amore, ma di fatto per follia o presunzione, perché non aveva la medesima comunione col Padre quale l’Unigenita Mente. «La dimenticanza non venne all’esistenza in prossimità del Padre, sebbene sia venuta all’esistenza a causa di Lui» (E.V. 18,1-3). La passione era una ricerca del Padre, perché essa si sforzava di comprenderne la grandezza. Tuttavia fallì in questo proposito, perché ciò che tentava era impossibile, e si ritrovò in grande agonia; a causa della profondità dell’Abisso (10), nel quale per il suo desiderio era penetrata sempre di più, essa infine sarebbe stata assorbita dalla sua dolcezza e dissolta nell’essere generale, se non si fosse scontrata col potere che rende stabile il Tutto e lo tiene separato dall’ineffabile Grandezza. Questo potere è chiamato Limite (“horos”): da lui essa fu trattenuta, consolidata, ricondotta in sé, e convinta che il Padre è incomprensibile. Così essa abbandonò la sua primitiva intenzione e la passione da questa generata (11). Codeste passioni tuttavia ora sussistono per se stesse come «entità senza forma».
– Conseguenze della crisi. Funzione del Limite.
La passione e il ristabilimento della Sophia hanno un effetto che si estende al di fuori del Pleroma. L’entità informe che essa ha fatto nascere nel suo sforzo verso l’impossibile è l’oggettivazione della sua passione; e alla vista di ciò e riflettendo sul suo fato, essa è scossa da varie emozioni: angoscia, paura, sorpresa e conflitto, pentimento. Anche queste emozioni sono incorporate nell’informità, e la loro serie completa, sviluppata in sempre nuove varianti dai singoli pensatori, ha un’importante funzione ontologica nel sistema: «Da qui, dall’angoscia, dalla paura e dal conflitto, ha avuto la sua prima origine la sostanza materiale» (Iren. I, 2, 3). «E’ stata questa ignoranza riguardo al Padre che ha prodotto Angoscia e Terrore. L’Angoscia divenne densa come nebbia, cosicché nessuno poteva vedere. Perciò l’Errore si fortificò [ossia assunse sussistenza]. Elaborò la sua Materia nel Vuoto» (E.V. 17, 9-16). L’attuale passaggio alla materia avviene soltanto nello stadio rappresentato dalla Sophia inferiore, come vedremo quando tratteremo di essa.
La prima Sophia, come riferiscono i testi citati, venne purificata e consolidata dal Limite e quindi riunita al suo consorte, e così l’integrità del Pleroma fu ristabilita. Ma la sua Intenzione, una volta concepita e divenuta effettiva, non poteva essere annullata: insieme con la Passione che aveva provocato, fu separata da lei e, mentre essa stessa rimaneva all’interno del Pleroma, fu cacciata fuori dal Limite. Come impulso naturale di un Eone, questo complesso separato di stati mentali è ora una sostanza spirituale ipostatizzata, ma senza forma, essendo un «aborto» prodotto senza concepimento. Perciò essi chiamano ciò anche «frutto impotente e femminile».
Il Limite ha dunque una doppia funzione, una stabilizzante e una separatrice: nel primo caso egli è chiamato Croce, nel secondo Limite.
Le due funzioni sono esercitate in posti differenti: tra l’Abisso e il resto del Pleroma per delimitare gli Eoni generati dal Padre ingenerato – è nell’adempiere a tale capacità che esso incontra la Sophia nella sua cieca ricerca -; e come Limite agisce tra il Pleroma nel suo insieme e il di fuori, cioè la sostanza espulsa della passione, per salvaguardare il Pleroma dal rientro della perturbazione dall’esterno (12). Nel seguito del dramma, soltanto la sua funzione ai confini esterni viene sottolineata: «Egli divide il cosmo dal Pleroma» (Exc. Theod. 42,1). Le sue funzioni più spirituali, come il ristabilimento del Pleroma nella sua armonia, passano in seguito a Cristo, mentre la funzione del Limite rimane soprattutto quella preservatrice. Il significato di questa figura particolare che fa la sua apparizione soltanto in seguito all’errore della Sophia, non avendo avuto origine col Pleroma stesso, è precisamente questo, che a causa dell’aberrazione della Sophia un cambiamento decisivo è avvenuto nell’ordine divino che rende necessaria una tale funzione: esso non possiede più la sua integrità semplicemente e senza contrasto, ma soltanto in opposizione ad una negatività posta all’esterno. Tale negatività è il residuo di una perturbazione che attraverso la “conversione” della Sophia e la “separazione” che ha implicato, si è ipostatizzata come regno positivo a sé (13). Solamente a questo prezzo il Pleroma ha potuto liberarsene. Perciò il Limite non era progettato nella costituzione originale della Pienezza, ossia della libera e adeguata espressione della divinità, ma si è reso necessario per la crisi come principio di consolidazione e di separazione protettiva. L’apparizione della figura stessa è quindi un simbolo dell’iniziale dualismo quale sorge dialetticamente dall’Essere originario.
– Restaurazione del Pleroma.
Come l’ignoranza e l’informità apparvero all’interno del Pleroma, un profondo turbamento corse tra gli Eoni, i quali non si sentirono più in sicurezza, temendo avvenimenti simili anche per loro stessi. Inoltre l’esistenza continuata del prodotto dell’ignoranza corretta, dello stato informe, anche se espulso, è nella sua presente condizione un costante rimprovero per la Sophia, la quale è piena di afflizione a riguardo dell’«aborto» e molesta gli Eoni con i suoi sospiri. Essi perciò si uniscono per pregare il Padre e ottenere da lui l’emanazione di una nuova coppia di Eoni, Cristo e lo Spirito Santo, che hanno questo duplice ufficio: di ristabilire all’interno del Pleroma una vera serenità; e, come conseguenza di ciò, di prendersi cura del residuo informe e dargli forma. Perciò Cristo (come rappresentante la parte maschile della coppia) è il primo e solo Eone ad avere una funzione sia da una parte che dall’altra del Limite, mentre l’Eone Gesù, emanato ancora dopo, è già interamente destinato alla missione esterna.
In tal modo lo svolgimento conduce grado a grado all’esterno sotto la necessità imposta dal decadimento, che una volta avvenuto mantiene ora realtà e richiede riparazione. Per prima cosa per garantire che nessuno degli Eoni abbia a soffrire un fato analogo, Cristo stabilisce una nuova armonia nel Pleroma illuminando gli Eoni circa l’inconoscibilità del Padre, cioè portando loro la gnosi («invero di che cosa aveva bisogno il Tutto se non della gnosi del Padre?», E. V. 19, 15 s.), e riconciliandoli coi ranghi loro assegnati, di modo che la consapevolezza dell’unità spirituale comprendente le loro diversità non permettesse il sorgere di aspirazioni individuali. Così essi raggiungono il perfetto riposo. Come frutto della loro nuova unità, tutti insieme, ciascuno dando il meglio della propria essenza, producono un Eone addizionale (e non in coppia), Gesù, nel quale la Pienezza per così dire è riunita insieme e nel quale è simbolizzata l’unità riconquistata degli Eoni. Questo «frutto perfetto del Pleroma», che contiene tutti i suoi elementi, deve in seguito portare nella sua persona la Pienezza al di fuori nel Vuoto, in cui il residuo della perturbazione passata, nel frattempo «formato» da Cristo, attende ancora la salvezza (14).
– Accadimenti all’esterno del Pleroma.
Dapprima è Cristo che si prende cura del residuo informe, facendo ciò parte del compito suo proprio di ristabilire la pace del Pleroma, pace che non poteva essere duratura per la triste condizione dell’«aborto» e l’angoscia della sua colpevole madre. Non era possibile annullare semplicemente ciò che era stato fatto, perché anche nell’errore il pensiero di un Eone costituisce una realtà e continua a vivere nei suoi effetti. Ora l’Intenzione o Desiderio della Sophia, ipostatizzato nella sua separazione da lei, è un nuovo essere personale: la Sophia inferiore o Achamoth (15). Abbiamo visto precedentemente che tale Intenzione, insieme con la Passione, doveva essere «gettata fuori dentro gli spazi dell’Ombra e del Vuoto» e che essa è ora, fuori della Luce e della Pienezza, un aborto senza forma. Cristo, disteso sulla Croce (16), per mezzo del suo potere le impartì una prima forma, solo un inizio di sostanzialità, non ancora «l’informazione» della conoscenza, dopo di che ritornò nel Pleroma all’interno del Limite, lasciandola col risveglio della coscienza della sua separazione dal Pleroma e col desiderio in lei suscitato di raggiungerlo. Ciò inizia un compito redentivo il cui adempimento richiede una lunga strada di sofferenze e di successivi interventi divini. Poiché Cristo non doveva più abbandonare il Pleroma, in quanto il suo compito principale era all’interno di esso, e poiché d’altra parte l’ipostasi femminile imperfetta non poteva divenire perfetta che per mezzo di un permanente accoppiamento spirituale, la sua prima formazione sulla Croce era tutto ciò che il Cristo poteva fare per lei (17).
– Sofferenza della Sophia inferiore.
Essendo divenuta cosciente per la formazione impartita da Cristo, la Sophia abbandonata si mette con tutto l’impeto alla ricerca della luce svanita, ma non può raggiungerla perché il Limite impedisce la sua corsa precipitosa. Essa non può attraversarlo a causa della sua contaminazione con la Passione originaria, e costretta a rimanere sola nell’oscurità esterna, cade in preda ad ogni specie di sofferenze esistenti. In ciò essa ripete al suo livello la scala di emozioni che sua madre provò nel Pleroma, con la sola differenza che ora tali passioni assumono la forma di stati definitivi di essere e come tali possono diventare la sostanza del mondo. Tale sostanza dunque, psichica e materiale, non è altro che la forma estraniata da sé e decaduta dello Spirito, solidificata da atti in condizioni abituali e trasformata da processo interno in fatto esterno. Quanto questo punto fosse fondamentale nella speculazione dei Valentiniani è dimostrato dalla considerazione del numero di varianti in cui la scala di emozioni è stata sviluppata e dai rispettivi corrispondenti assegnati a ciascuna di esse in termini di «sostanza» (18). Il fatto stesso che la correlazione tra emozioni ed elementi non è stata fissata nei particolari ma varia da autore ad autore, e forse anche nel pensiero di un solo e medesimo autore, mostra quanto si sia a più riprese meditato su tale soggetto.
La narrazione sulla quale ci soffermiamo in modo principale offre a questo punto la seguente serie di emozioni: “dolore”, perché essa non poteva prendere possesso della luce; “timore”, che oltre la luce anche la vita potesse abbandonarla; “confusione”, in aggiunta alle altre; e tutte queste unite nella qualità fondamentale di “ignoranza” (essa stessa considerata come una «affezione»). E, come risultante, ancora un altro stato mentale: il “volgersi” (conversione) verso il Datore di Vita. «Questa, dunque, divenne la composizione e la sostanza (19) della Materia, in cui consiste questo mondo; dalla conversione hanno avuto origine tutte le anime del mondo e del Demiurgo; dal timore e dall’angoscia ha avuto inizio tutto il resto». In termini numerici, che sono la sola costante in questa parte della speculazione, abbiamo cinque «affezioni» in tutto, quattro negative o del tutto tenebrose («passioni» nel senso più ristretto), una positiva o semiluminosa. L’ultima, chiamata qui «conversione», altrove (in Ippolito) anche «supplicazione» e «preghiera», è l’origine di tutto ciò che è psichico nel mondo e sta in un grado intermedio tra materia e spirito. Le quattro passioni cieche sono naturalmente le sorgenti dei quattro elementi tradizionali della materia. Vedremo in seguito in che modo la posizione speciale dell’«ignoranza» come denominatore comune delle altre “tre” è situata in tale correlazione. Per quanto riguarda le altre tre, «angoscia» e «timore» sono più di continuo menzionate nelle enumerazioni, «confusione» (“aporia”) è talvolta sostituita da «costernazione» o «spavento» (“ekplexis”), e a volte la triade diventa una tetrade per l’aggiunta di «riso», il cui correlativo fisico è la sostanza luminosa dell’universo (ossia quella del sole e delle stelle, che è considerata differente dal fuoco): «Ora essa pianse e si angosciò perché era stata lasciata sola nella Tenebra e nel Vuoto; ora, considerandosi parte della Luce che l’aveva abbandonata, essa divenne allegra e sorridente; ora cadde di nuovo nel timore e altre volte essa era sconvolta e stordita» (Iren. I, 4, 2).
– Origine della Materia.
Dopo che la Madre ebbe provato tutte le passioni e, appena emersa, si fu rivolta in giro supplichevole cercando la luce scomparsa di Cristo, gli Eoni ebbero pietà di lei, e poiché Cristo stesso non avrebbe abbandonato di nuovo il Pleroma, essi mandarono il «frutto comune» del Pleroma, Gesù, come consorte della Sophia esteriore (essendo egli il solo Eone prodotto senza sposa) per curarla dalle passioni per le quali soffriva nella ricerca del Cristo. Con lui c’erano gli angeli che erano stati emanati con lui come sua scorta. Uscendo dal Pleroma, egli trovò la Sophia nelle quattro primitive passioni: timore, angoscia, confusione e supplica, e la curò da esse impartendole in quel momento la «formazione» di conoscenza (essendo stata la sua precedente «formazione» da parte del Cristo soltanto di sostanza). Egli separò da lei quelle passioni, ma non le abbandonò a loro stesse come era stato fatto con quelle della Sophia superiore; d’altra parte egli non poteva semplicemente annullarle, essendo già diventate «stati abituali ed effettivi», a loro modo eterne e specifiche della Sophia. Perciò egli le distaccò soltanto dalla Sophia, cioè le rese esterne e le solidificò in sostanze indipendenti. Così, mediante l’apparizione del Salvatore, da una parte la Sophia è liberata dalle sue passioni e dall’altra le cose esterne hanno avuto il loro fondamento (20); e con ciò il Salvatore produce (rende possibile) «in potenza» la susseguente creazione demiurgica. Da affezioni incorporee e accidenti egli trasformò le passioni in materia, che era ancora non corporea; ma poi impartì loro la capacità e la tendenza naturale di entrare in composizione e formare corpi, cosicché ebbero origine due tipi di sostanze: quella cattiva delle passioni, quella suscettibile (di bene) dalla conversione. E Achamoth, liberata dalle sue affezioni, con gioia «ricevette» la visione delle luci attorno al Salvatore, ossia dei suoi angeli di scorta, e da tale concezione generò un frutto pneumatico a loro immagine. Questa è l’origine dell’elemento pneumatico nel mondo inferiore. (Riassunto da Ireneo, “Exc. Theod.” e Ippolito.)
– Derivazione degli elementi singoli.
Come abbiamo già notato, la correlazione rispettiva degli elementi con le passioni varia grandemente nelle molteplici versioni di questa parte della dottrina. In genere vi è accordo sul fatto che dalla conversione o supplica è risultata l’«anima» del mondo e del Demiurgo e tutto ciò che è psichico, e dal rimanente delle passioni gli elementi materiali: ossia, dalle lacrime la sostanza umida, dal riso quella luminosa, dall’angoscia e sgomento gli elementi più solidi del cosmo; oppure, «dallo sgomento (terrore) e dalla perplessità come condizione più confusa, gli elementi corporei del cosmo: precisamente, la “terra” in conformità con l’irrigidimento (21) del terrore; quindi l'”acqua”, in conformità col movimento del timore; l'”aria” in conformità con la mobilità dell’angoscia; il “fuoco”, però, è inerente a tutti questi come morte e corruzione, allo stesso modo che l’ignoranza è nascosta nelle tre passioni» (Iren. I, 5, 4) (22).
In conclusione, tre essenze ebbero origine dalle esperienze della Sophia: dalla sua passione, la materia; dalla sua conversione, l’anima; dalla sua ricezione della luce del Salvatore dopo la purificazione, il pneuma. Quest’ultima essenza non può essere soggetta ad alcuna formazione da parte sua, essendo identica alla propria. Perciò essa si volse a formare l’essenza psichica che era stata prodotta dalla sua conversione.
– Il Demiurgo e la creazione del mondo.
Oltre la sostanza psichica la Sophia inferiore forma il padre e re di tutte le cose psichiche e materiali; questi infatti ha creato tutto ciò che viene dopo di lui, guidato, pur senza saperlo, da sua madre. Egli è chiamato «padre» delle realtà della destra, ossia quelle psichiche, «artefice» (demiurgo) delle realtà della sinistra, cioè quelle materiali, e «re» di tutte le cose che sono fuori del Pleroma.
«L’Errore ha elaborato la sua Materia propria nel Vuoto, senza conoscere la Verità. Esso si è applicato a modellare una forma, cercando di produrre in bellezza un sostituto della Verità… Non avendo alcuna radice, esso rimase immerso nella nebulosità riguardo al Padre mentre era occupato a preparare Opere, Dimenticanze e Terrori per attirare col loro aiuto quelli del Mezzo e imprigionarli» (E.V. 17, 15-35).
Egli crea sette cieli, che sono angeli nello stesso tempo, al di sopra dei quali risiede. Perciò è chiamato anche «Heptade» e la Madre sopra di lui «Ogdoade». In tale posizione egli è il «Luogo del Mezzo» (23), avendo al di sopra la Sophia e al di sotto il mondo materiale da lui formato. Sotto altro aspetto la Madre, l’Ogdoade, è nel mezzo, ossia sopra il Demiurgo, ma sotto il Pleroma, da cui è tenuta fuori «fino alla consumazione».
La relazione ontologica tra Sophia e Demiurgo è espressa meglio dall’affermazione: «La Sophia è chiamata ‘pneuma’, il Demiurgo ‘anima’ (Hippol. VI, 34, 1). Per il resto, nel Demiurgo dei Valentiniani riscontriamo tutte le caratteristiche del dio del mondo col quale siamo già familiarizzati e di cui perciò possiamo trattare qui brevemente: per primo la sua “ignoranza”, che i Valentiniani sottolineano con enfasi e che in primo luogo riguarda le cose al di sopra di lui. Queste, compresa sua madre, gli sono del tutto sconosciute; ma anche per quel che riguarda la creazione al di sotto di lui egli «è inconsapevole e pazzo, e non sa quello che fa e quello che produce» (Hippol. VI, 33), il che permette a sua madre di far penetrare i propri disegni in quello che egli crede di fare da sé (24). Ed ecco che sull’ignoranza poggia la seconda caratteristica principale che egli condivide con la concezione gnostica generale del Demiurgo: l'”orgoglio” e la presunzione con cui crede di essere e si dichiara il solo Dio unico e supremo. Perciò bisognoso di correzione, egli è finalmente illuminato dalla Sophia e per mezzo della sua istruzione è portato alla conoscenza e alla consapevolezza di ciò che è sopra di lui; tuttavia egli conserva per sé il grande mistero del Padre e degli Eoni al quale la Sophia lo ha iniziato (25) e non lo trasmette a nessuno dei suoi profeti: che ciò avvenga per volontà della Sophia o per propria volontà non è affermato, ma molto probabilmente per il fatto che il messaggio pneumatico e l’illuminazione non possono essere comunicati tramite un agente psichico. Per comunicare la gnosi salvifica agli elementi pneumatici nella creazione, la Sophia deve perciò ricorrere ad un agente della sua specie, l’incarnazione degli Eoni di Gesù e Cristo provenienti dal Pleroma nella persona del Gesù storico. Il suo avvento, in modo paradossale, è preparato dai profeti, che erano quelli del Demiurgo ma per bocca dei quali la Madre, a lui sconosciuta, comunicava i suoi messaggi, che perciò erano inseriti in quelli del dio del mondo. Non sempre i profeti sono trattati con tanta tolleranza, anzi in un luogo vengono chiamati insieme con la Legge in modo alquanto rude «pazzi ignoranti che parlano per un Dio pazzo» (Hippol. VI, 35, 1).
Un atteggiamento di maggiore moderazione e considerazione nei riguardi della Legge mosaica si trova, d’altra parte, nella “Lettera a Flora” di Tolomeo, scritta per alleviare gli scrupoli di una signora educata cristianamente. L’autore si dà un gran da fare per chiarire fin dall’inizio che la Legge di Mosè, sebbene certamente non provenga dal Padre perfetto, non è nemmeno da Satana, e così pure il mondo: entrambi sono opera di un dio di giustizia. Coloro che attribuiscono la creazione e la legislazione a un dio malvagio sono altrettanto in errore quanto quelli che attribuiscono la Legge al Dio supremo: i primi errano perché non conoscono il dio di giustizia, i secondi perché non conoscono il Padre del Tutto. Da una posizione intermedia riguardo al dio legislatore segue un atteggiamento di mezzo verso la sua Legge, che tuttavia non è identica con l’intero corpo del Pentateuco. Quest’ultimo contiene tre elementi: prescrizioni formulate da «Dio», da Mosè e dagli anziani. Quelle da «Dio» sono a loro volta di tre generi: la pura legislazione non contaminata dal male, che il Salvatore non è venuto ad abolire ma a perfezionare, perché era ancora imperfetta (per esempio, il decalogo); la legislazione corrotta dalla cattiveria e dall’ingiustizia, che il Salvatore ha abolito perché è estranea alla sua natura e a quella del Padre (per esempio: «occhio per occhio»); la legislazione simbolica di realtà pneumatiche e ultramondane, che il Salvatore ha trasposto dal significato letterale e sensibile al significato spirituale (i precetti rituali). Il «Dio» che ha ordinato questa Legge non può essere né il Padre perfetto né il demonio, perciò non può essere che il Demiurgo, il creatore di questo universo, differente nella sostanza da entrambi, il quale detiene un rango intermedio tra di essi e quindi è chiamato «il principio di mezzo». Egli è inferiore al Padre perfetto ingenerato; superiore all’avversario, né buono come il primo né malvagio e ingiusto come il secondo, ma propriamente chiamato «giusto» e arbitro del suo tipo di giustizia (inferiore a quella del Padre).
Questo è il punto di vista più caritatevole assunto nei riguardi del Creatore in tutta la Sophia-gnosi, nell’ambito e al di fuori della scuola valentiniana. Il sinistro Ialdabaoth dei Barbelognostici, per esempio, è molto vicino a identificarsi con la figura dell’avversario. Tuttavia in ultima analisi queste non sono che leggere variazioni di atteggiamento (26) nello sviluppo di un tema fondamentale, e più o meno le caratteristiche che abbiamo riscontrato finora in rapporto alla «teologia» gnostica del dio del mondo sono anche quelle del demiurgo valentiniano.
In genere riguardo alla creazione del mondo la speculazione valentiniana si unisce alla corrente generale di concezioni gnostiche, solamente con pochi lineamenti secondari specifici alla scuola. Due di essi, collegati al Demiurgo, vanno qui ricordati. Come il Demiurgo è una creatura della Madre formato dalla sostanza psichica, così il Demonio, chiamato anche «Cosmocrator», è una creatura del Demiurgo formato dalla «sostanza spirituale di malvagità», che a sua volta ha origine dall’«angoscia» (altrove, dalla «perplessità»): e qui abbiamo l’insegnamento sconcertante che Satana (con i demoni) essendo lo “spirito” (“pneuma”) di malvagità, “conosce” le cose che sono al di sopra, mentre il Demiurgo, essendo soltanto psichico, non le conosce (Iren. I, 5, 4). Se il lettore ha difficoltà a capire come la concezione di uno «spirito» di “malvagità” che gode del privilegio genuino dello spirito, la conoscenza, sia compatibile con la posizione ontologica del pneuma nel sistema, e quella di una gnosi superiore senza santificazione del conoscente con la concezione salvifica di gnosi in quanto tale, non si trova in una condizione peggiore dello scrittore.
Un’altra caratteristica originale nell’esposizione valentiniana della creazione è istruttiva circa la questione tanto dibattuta del «platonismo» degli Gnostici (27). Il mondo è stato creato ad immagine del mondo invisibile del Pleroma da un Demiurgo che attua senza saperlo il proposito di sua madre. La sua ignoranza tuttavia era incompleta, come è dimostrato dalla seguente citazione, che implica da parte sua almeno una certa idea del mondo superiore, per quanto inadeguata e distorta:
«Quando il Demiurgo volle inoltre imitare anche la natura senza limiti eterna, infinita e senza tempo dell’Ogdoade superiore (gli otto Eoni originari del Pleroma), ma non poteva esprimere la loro immutabile eternità, essendo egli stesso un prodotto dell’imperfezione, incarnò la loro eternità in tempi, epoche e gran numero di anni, nell’illusione che con la quantità di tempi avrebbe potuto rappresentare la loro infinità. Così gli sfuggì la verità e seguì la falsità. Perciò la sua opera passerà quando i tempi saranno compiuti» (Iren. I, 17, 2).
Questa è naturalmente una parodia del famoso passo del “Timeo” (37 c s.s.) dove Platone descrive la creazione del tempo come «l’immagine mutevole dell’eternità». E’ evidente per chiunque voglia paragonare i due passi l’abisso profondo che divide lo spirito di questa imitazione dal suo originale.
– La salvezza.
La speculazione intorno alle origini, che fornisce l’ontologia sulla quale si basano tutte le altre parti dell’insegnamento valentiniano, è l’aspetto essenziale del valentinianesimo. La teoria valentiniana sull’uomo e sull’etica sarà mostrata in seguito in un contesto diverso. Per quel che riguarda la dottrina della salvezza ne abbiamo indicato l’idea principale nell’introduzione di questo capitolo e mostrato la connessione con l’essenza della speculazione stessa. Si può perciò comprendere ora in concreto come i Valentiniani fondassero la sufficienza metafisica della gnosi rispetto alla salvezza nella natura stessa dell’essere universale, facendo derivare l’esistenza e la condizione del mondo inferiore, e con esso l’esistenza e la condizione dell’entità composta «uomo», dall'”ignoranza” di un Eone e riducendo tutto il sistema fisico a categorie spirituali. La speculazione valentiniana stessa, intesa nel suo spirito proprio, riassume in forma di conoscenza il processo della caduta, l’odissea dell’ignoranza, e con ciò fa provenire l’esistenza, che è la vittima dell’una e l’agente dell’altra, dalla profondità di cui descrive la generazione. In che modo la «perfetta salvezza» è definita come «la cognizione stessa della grandezza ineffabile» è stato mostrato nel passo di Ireneo citato a p. 192 (in nero, cap. 7, a). Possiamo ora aggiungere alcune linee del “Vangelo della Verità” la cui descrizione ellittica del concetto, rivolta agli iniziati, sarebbe di per sé difficilmente comprensibile in tutte le sue implicanze speculative. «Poiché la Dimenticanza [il mondo inferiore] è venuta all’esistenza per il fatto che essi [gli Eoni] non hanno conosciuto il Padre, perciò se essi raggiungono la conoscenza del Padre, la Dimenticanza in quello stesso istante diventa non-esistente. Quello, dunque, è il Vangelo di Colui che essi cercano e che [Gesù] ha rivelato al Perfetto» (E.V. 18, 7-14). Ci resta soltanto da aggiungere qualche cosa circa il perché ci sono degli uomini che devono essere salvati.
Torniamo alla precedente affermazione che delle tre sostanze, materia, anima e spirito, che erano venute all’essere, la Sophia poteva «formare» soltanto le prime due, ma non il pneuma, perché era della sua medesima essenza. Questo frutto perciò proveniente da lei doveva passare nel mondo e attraverso il mondo per essere «formato» nel suo corso. Il Demiurgo è uno strumento inconsapevole in tale processo. Come parte e in adempimento della sua creazione egli forma l’uomo terreno e spira in lui l’uomo psichico. L’elemento pneumatico, che la Madre aveva prodotto dalla visione degli angeli, non poteva essere percepito da lui perché della stessa essenza della Madre, e pertanto non poteva che essere segretamente depositato nella sua creatura. Così per mezzo di un agente inconsapevole il seme spirituale veniva immesso nell’anima e nel corpo umano per esservi portato come in una matrice fino a che fosse cresciuto sufficientemente per ricevere il Logos. Il pneuma soggiorna nel mondo in modo da essere preformato là per la finale «formazione» per mezzo della gnosi. Questo era lo scopo segreto che la Madre si proponeva con la creazione demiurgica. La gnosi stessa viene infine portata giù, per quella parte del genere umano sufficientemente preparata a riceverla, da Gesù unito al Cristo, che discende nel Gesù umano durante il battesimo nel Giordano e si diparte da lui prima della sua passione, cosicché la Morte è ingannata. La sofferenza del Gesù mortale non aveva altro significato che quello di uno stratagemma (28). La «passione» reale era quella precosmica della Sophia superiore e inferiore, ed è stato ciò che ha reso necessaria la salvezza, non ciò che ha portato la salvezza. Né c’era mai stato un «peccato originale» dell’uomo, una colpa dell’anima umana: c’era stata invece la colpa, prima del tempo, di un Eone, un sovvertimento divino, la cui riparazione richiedeva a sua volta la creazione del mondo e quella dell’uomo. Perciò il mondo, sconosciuto al suo autore immediato, esiste per la salvezza, e non la salvezza per ciò che è avvenuto nell’ambito della creazione e alla creazione. E l’oggetto reale della salvezza è la divinità stessa, il suo scopo l’integrità divina.
Gli spiriti trasformati dalla conoscenza rimangono nella regione mediana dell’Ogdoade, dove la loro Madre, la Sophia, rivestita di essi attende la consumazione del mondo. La sua salvezza finale ha luogo quando tutti gli elementi pneumatici nel mondo sono stati «formati» dalla conoscenza e perfezionati. Allora gli spiriti spogliati delle loro anime, con la loro Madre entrano nel Pleroma, che diviene la camera nuziale dove ha luogo il matrimonio della Sophia con Gesù e quello degli spiriti con i loro sposi, gli angeli intorno a Gesù. Con ciò, la Pienezza è ristabilita nella sua integrità, la violazione originaria infine riparata, la perdita pretemporale recuperata; materia e anima, espressione della caduta, col loro sistema organizzato, il mondo, cessano di esistere. Per concludere, ancora una volta, citiamo il “Vangelo della Verità”.
«Il Padre… rivela ciò che di Se stesso era stato nascosto (ciò che di Se stesso era nascosto era suo Figlio), cosicché mediante la compassione del Padre gli Eoni possano conoscerlo e cessare di affannarsi nella ricerca del Padre, riposando in Lui, conoscendo che il riposo consiste in questo: avendo colmato la Deficienza, Egli abolì la Forma. La sua Forma è il cosmo, al quale egli (il Figlio?) era stato assoggettato. Perché il luogo in cui c’è invidia e dissenso, è la Deficienza ma il luogo che è Unità è la Pienezza. Essendo la Deficienza venuta all’esistenza perché essi non conoscevano il Padre, così quando conoscono il Padre, la Deficienza scompare nello stesso istante. Come l’ignoranza di una persona, nel momento che essa viene a conoscere scompare spontaneamente; come la tenebra si dissolve all’apparire della luce, così anche la Deficienza si dissolve di fronte al fatto della Pienezza. Quindi da quel momento in poi, la Forma non è più apparente, ma scompare nella fusione con l’Unità – perché ora le loro opere sono divenute uguali l’una all’altra – nel momento in cui l’Unità perfeziona gli spazi» (E.V. 24, 11 – 25, 10).
NOTE AL CAPITOLO 7.
1. Tutti e tre i nomi di questo periodo si riferiscono al mito cosmogonico.
2. «Pienezza», cioè il mondo spirituale degli «Eoni» che circondano la divinità e ne esprimono l’abbondanza interiore in aspetti particolari per mezzo di figure personali.
3. Ved. Appendice 2 a questo capitolo per la dottrina barbelognostica come è ora conosciuta dall’Apocrifo di Giovanni.
4. Nel Vangelo della Verità, recentemente trovato, abbiamo in traduzione copta un’opera originale dello stesso Valentino.
5. Citato E.V., seguendo le pagine e le linee del codice.
6. Confronta F. M. M. SAGNARD, “La Gnose Valentinienne” (Paris, 1947), per una sinossi e analisi più completa dei vari filoni della tradizione.
7. Tutti e tre i nomi di genere femminile. Circa la questione se il Progenitore o Abisso fosse in origine solo, oppure se dall’inizio fosse unito al Silenzio c’è grande differenza di opinione tra i Valentiniani (confronta Iren. I, 11, 5; Hippol. VI, 29, 3).
8. Già il primo stadio è spiegato in modi diversi. La versione data sopra è una di quelle riferite da Ireneo. Tra le molte alternative ricordiamo quella di Epifanio: «Poiché al principio il Padre di Sé racchiudeva in se stesso il Tutto, che rimaneva inconscio in lui… l’Ennoia in lui, che è anche chiamata Grazia… ma con più verità Silenzio… volle una volta spezzare i legami eterni, e fece in modo che la Grandezza desiderasse giacere con lei. E unita con lui essa generò il Padre della Verità che gli iniziati chiamano con ragione ‘Uomo’, perché è l’immagine del preesistente Ingenerato. Dopo ciò il Silenzio generò la Verità come unione naturale della Luce e dell’Uomo» (Epif., loc. cit.). La differenza principale dalla precedente versione consiste in ciò che qui (come in Simone) l’iniziativa del processo creativo proviene dall’Ennoia e non dal Padre.
E un’altra versione: i seguaci di Tolomeo dicono che «l”Abisso’ ha due consorti, che essi chiamano anche ‘stati’, ossia ‘Pensiero’ e ‘Volontà’. Perché al principio egli ‘pensò’ di proiettare qualcosa e poi lo ‘volle’. Così, dalla mescolanza reciproca, per così dire, dei due stati e poteri venne la proiezione, come una coppia, dell”Unigenito’ e della ‘Verità’» (identico in Iren. I, 12, 1; Hippol. VI, 38, 5 s.). Queste non sono naturalmente tutte le varianti. Confronta anche il riassunto in E.V. 37, 7-14: «Quando essi (gli Eoni) erano ancora nella profondità della Sua mente la Parola (“logos”), che fu la prima ad essere generata, li fece apparire, unita alla Mente (“nous”) che pronunzia la Parola unica nella Grazia Silenziosa e che è anche chiamata ‘Pensiero’ perché essi erano in esso prima di divenire manifesti».
Per quanto riguarda il termine «proiezione», esso è l’equivalente latino del greco “probolé”, che è termine costantemente usato in questi testi per l’attività creativa, più comunemente tradotto con «emanazione».
9. Così Ippolito ha questa versione (VI, 29, 5 s.s.), eccezionale anche per il fatto che omette il Silenzio o Ennoia e concepisce il primo principio senza il corrispondente femminile: «Il Padre esisteva solo, ingenerato, senza luogo, senza tempo, senza consigliere, e senza nessuna delle proprietà che possono essere pensate… solitario e riposante solamente in se stesso. Ma poiché aveva in sé potere generativo, piacque a lui di generare e produrre ciò che di più bello e perfetto egli aveva in se stesso, perché non amava la solitudine. Infatti egli era tutto amore, ma l’amore non è amore se non c’è un oggetto di amore. Così il Padre, solo come era, proiettò e generò ‘Mente’ e ‘Verità’… [e così via]». Il numero di emanazioni al principio qui è 28 (il padre non è incluso nel numero), ed è portato a 30 solo dopo la crisi per l’aggiunta dell’emanazione della coppia Cristo e Spirito Santo.
10. Per la «profondità» del Padre come causa dell’«Errore» confronta E.V. 22-23 s.s.: «essi s’erano smarriti (dai loro luoghi) quando ricevettero l’Errore a causa della profondità di Colui che circonda tutti gli spazi».
11. Questa è la prima restaurazione e (incipiente) «salvezza» nella storia spirituale della totalità dell’essere, e avviene interamente all’interno del Pleroma, sebbene sia la causa di una catena di avvenimenti al di fuori, come vedremo. La crisi stessa è descritta in maniere diverse nelle svariate versioni. La scuola anatolica in questo caso concorda con la versione data qui, come mostra il resoconto condensato degli Exc. Theod: «L’Eone che desiderava afferrare ciò che è al di là della conoscenza cadde nell’ignoranza e nell’informità. Da qui essa portò all’essere il Vuoto-di-conoscenza che è l’Ombra del Nome» (31, 3 s.s.). Molto differente è la follia della Sophia in Hippol. VI, 30, 6, che riassumiamo: Slanciandosi nella profondità del Padre, essa si accorge che mentre tutti gli Eoni generati generano per copulazione, il Padre solamente genera da se stesso (essendo in questa versione senza consorte, v. nota 9); essa desidera emularlo in ciò e genera da se stessa senza sposo, in modo da non esser da meno del Padre nel suo operare. Essa non comprese che questo è il potere dell’Unico Ingenerato, perciò essa non fece che produrre un’entità senza forma. Su questo punto – l’esistenza di un’entità senza forma – tutte le versioni concordano e per il seguito della narrazione è un fatto importante se la causa dell’errore è la presunzione di imitare l’Assoluto, cioè pura “hybris”, come qui oppure desiderio di conoscerlo in modo completo, ossia amore invadente, come nella maggior parte delle versioni.
12. Per questi due compiti Valentino sembra aver assunto due Limiti, che in seguito furono contratti in un’unica persona.
13. «Questa, dunque, non fu un’umiliazione per Lui… Perché essi erano un Niente, ossia quell’Angoscia e quella Dimenticanza e quella formazione di Falsità» (E.V. 17, 21 s.).
14. Il resoconto di Ippolito introduce soltanto a questo punto la figura del Limite (Croce), prodotto «perché niente del difetto potesse giungere vicino agli Eoni all’interno del Pleroma» (VI, 31, 6).
15. Dall’ebraico “hokmah”, ossia sapienza, lo stesso che «Sophia», che però in queste speculazioni denota la forma caduta.
16. E’ assai significativo che la prima azione del Pleroma all’esterno avvenga nel segno della Croce, sebbene questo abbia poco in comune con il significato cristiano familiare. Per comprendere la situazione graficamente bisogna ricordare che in quel tempo la Croce era immaginata in forma di T. Nel simbolismo valentiniano, perciò, la barra orizzontale è il Limite tra il mondo superiore e il mondo inferiore su cui il Cristo si distende per raggiungere la Sophia inferiore, mentre la barra verticale divide in due zone di destra e di sinistra il mondo inferiore, ossia pneumatici e psichici, oppure separa il potere della «destra» e quello della «sinistra» del campo psichico, o psichico e materiale
17. Lo stesso Valentino propone una spiegazione del tutto diversa della relazione Cristo-Sophia (da questo stadio in poi «Sophia» è quella inferiore), e il ramo anatolico si è attenuto a questa forma di dottrina. Secondo la quale «Cristo non è provenuto dagli Eoni nel Pleroma, ma insieme ad un’ombra è stato prodotto secondo l’idea del Migliore dalla ‘Madre’ (Sophia) che era caduta fuori del Pleroma. Egli tuttavia, essendo maschio tagliò via l’ombra da sé e ascese al Pleroma. La Madre, rimasta indietro con l’ombra e svuotata di elemento pneumatico, generò un altro figlio: il Demiurgo, che è anche chiamato Governatore di Tutto ciò che è al di sotto» (Iren. I, 11, 1). Gli Exc. Theod. confermano che questa versione è valida per il ramo anatolico (23, 2; 32, 2; 39).
18. Ved. Ia beffa di Ireneo che «ciascuna di esse espone diversamente con frasi altisonanti da quali emozioni ebbero origine gli elementi di essere» (4, 3).
19. O: Codesta combinazione (di affezioni) divenne anche sostanza…
20. Qui è invocato Giov. 1, 3: «Tutte le cose vennero all’essere per mezzo di lui (eccetera)»!
21. Leggendo “ptesin” per “pexin”, «indurimento, congelamento» (mio tentativo di emendamento).
22. Per la correlazione di “fuoco” con «ignoranza» e la sua speciale posizione nel sistema «fisico» dei Valentiniani, ved. Appendice 1 alla fine di questo capitolo. Un’altra sottile correlazione è la seguente, in Ireneo: la sostanza materiale deriva dalle tre passioni paura, angoscia e smarrimento; lo psichico dalla paura e dal voltarsi indietro combinati, e nell’ambito di questa combinazione l’elemento del voltarsi indietro spiega il Demiurgo, quello della paura tutte le altre sostanze psichiche nelle bestie e negli uomini. Qui la paura partecipa alla creazione della sostanza materiale “e” psichica ed è così intermedia tra gli estremi superiore e inferiore della scala extra-spirituale. Molto differente è la seguente correlazione in Ippolito: dalla paura provenne la sostanza psichica, dall’angoscia la fisica; dallo smarrimento la demoniaca; e dal voltarsi indietro il cosiddetto «potere destro» dello psichico (in quanto opposto al «sinistro», che deriva dalla paura), ossia ascesa e pentimento. Il Demiurgo proviene dall’affezione della paura e appartiene perciò interamente al «potere sinistro» dell’anima (VI, 32, 6 s.).
23. In Exc. Theod. anche semplicemente «Luogo» (“topos”), che nella tradizione giudaica serviva come circonlocuzione per Dio.
24. Confronta la descrizione «platonizzante» in Iren. I, 5, 3 e in Exc. Theod. 49, 1: «Il Demiurgo, data la sua natura pronta all’azione, credeva di aver fatto queste cose da solo, inconsapevole che Achamoth operava per mezzo di lui. Egli fece un cielo senza conoscere ‘il cielo’; formò un uomo senza conoscere niente dell”uomo’; fece apparire una terra senza conoscere ‘la terra’; egli era completamente ignorante delle idee di qualunque cosa che creava e della Madre stessa, e credeva di essere egli solo tutto». Ciò, naturalmente, è una consapevole revisione della descrizione del Demiurgo di Platone, il quale, sì, conosceva le idee.
25. Questo tema dottrinale che ha il suo parallelo quasi letterale nell’antico “Libro di Baruch” di Giustino lo Gnostico (Hippol. V, 26 s.) è forse un’intrusione estranea nel corpo di dottrina valentiniano. Perché come è compatibile col sistema del “Libro di Baruch” (dove l’«Elohim» [= Demiurgo] è pneuma), è altrettanto incompatibile con la principale dottrina valentiniana al punto che il principio stesso e rappresentante di tutto ciò che è «psichico», il Demiurgo, diverrebbe il ricettacolo della più alta gnosi: sul piano umano i Valentiniani negano assolutamente questa possibilità per lo “psychicós”; e in genere il solo organo capace di «conoscenza», il soggetto che può essere «informato» da essa, è lo “pneuma”.
26. O di astuzia: la “Lettera a Flora” è decisamente uno scritto esoterico.
27. Confronta sopra, nota 24.
28. Questa affermazione deve essere precisata per il Vangelo della Verità. Qui, dove forse parla lo stesso Valentino, troviamo toni genuinamente cristiani nel passo sulla passione di Gesù: «Per tale ragione, Gesù, il misericordioso e fedele, accettò pazientemente di sopportare la sofferenza fino al momento in cui avrebbe preso possesso di quel Libro, poiché sapeva che la sua morte significava vita per molti… Egli fu inchiodato ad un legno e attaccò l’atto della disposizione del Padre alla Croce. Oh! grande sublime insegnamento. Egli si umilia fino alla morte, sebbene sia rivestito di vita immortale» (E. V. 20,10-30). Il sentimento di queste linee non può essere alterato, nemmeno dall’affermazione posteriore più docetista: «Egli venne “in somiglianza” di carne, sebbene niente potesse impedire il suo corso, perché era incorruttibile e incoercibile» (31, 4 s.s.). Circa il significato teologico della sofferenza di Cristo è detto soltanto che essa è dovuta alla collera di «Errore», e si ha l’impressione che ciò non esaurisca il significato religioso che risuona nel passo citato, qualunque possa essere tale significato (e certamente non c’è alcuna allusione anche lontanamente paolina). Ma anche con tutte queste nuove testimonianze, è pur vero che nella teologia generale dei Valentiniani la sofferenza della Sophia, non quella di Cristo, è il fatto centrale, dottrinalmente ed emotivamente.
Appendice 1 al capitolo 7.
LA POSIZIONE DEL FUOCO TRA GLI ELEMENTI.
Abbiamo visto come gli elementi materiali fossero derivati dalle emozioni successive attraverso le quali la Sophia era passata nella sua sofferenza. Il numero di queste emozioni è fissato a quattro o tre, a seconda che l’«ignoranza» è calcolata tra di esse o no. La condizione fondamentale della Sophia errante, antecendentemente alla sua differenziazione nella pluralità di affezioni, è l’ignoranza. D’altra parte, nelle enumerazioni della serie completa di affezioni, talvolta l’ignoranza, messa in capo alla lista e congiunta alle altre con un semplice «e», sembra essere una, seppure la prima, nel loro numero coordinato. Tuttavia l’ignoranza non è mai solamente una di loro, ma precedendole nella loro genesi, è anche esplicitamente detto che persiste come loro “genus” comune e principio piuttosto che come una condizione separata. Di fatto, propriamente parlando, ci sono soltanto tre affezioni o passioni – angoscia, timore, confusione (o spavento) – e di esse si afferma che «sono tutte “nell’ignoranza”» o che «l’ignoranza è immanente in tutte e tre». Ciò spiega come la guarigione della Sophia dalle sue affezioni può avvenire per mezzo della comunicazione della conoscenza, la sua «formazione di conoscenza», poiché questo mette fine alla loro condizione soggiacente. Ora, dato che gli elementi di materia dovevano essere messi in relazione uno per uno con le affezioni come loro princìpi originanti, e il numero tradizionale di elementi era quattro, era necessario che l’ignoranza fosse considerata come un principio “particolare” per formare il numero, tuttavia non doveva perdere per tale correlazione il suo “status” unico come principio “generale” di tutte esse. I Valentiniani hanno fatto di questa apparente difficoltà un’occasione eccellente per sottolineare la funzione fondamentale dell’ignoranza nel loro sistema ontologico: all’ignoranza nel regno mentale hanno fatto corrispondere nel regno fisico il fuoco, che come il suo archetipo non è tanto un elemento tra elementi, quanto una forza attiva in ognuno di essi. Perciò abbiamo citato a p. 205 (in nero) la correlazione della terra con lo spavento, dell’acqua col timore, dell’aria con l’angoscia, terminando: «il fuoco, tuttavia, è inerente a tutti questi con morte e corruzione, appunto come l’ignoranza è nascosta nelle tre passioni». Soltanto a causa di questa correlazione spirituale i Valentiniani hanno speculato intorno alla posizione eminente del fuoco tra gli elementi, non certo perché interessati in una teoria fisica per se stessa. Tale elaborazione dell’aspetto fisico si può trovare negli “Estratti da Teodoto”, 48, 4: «Nei tre elementi agisce, si diffonde fuori e giace nascosto il fuoco; da essi è acceso e con essi muore, perché non ha un suo proprio carattere separato dagli altri elementi coi quali sono formate le cose composte».
Ciò naturalmente richiama la posizione del fuoco in Eraclito, che è stata poi ripresa e sviluppata dagli Stoici nella loro cosmologia. In quel tempo la dottrina era così largamente conosciuta nella versione stoica che la funzione fondamentale del fuoco nel sistema valentiniano della natura può essere considerata come una di quelle appropriazioni intenzionali che riuniscono l’accettazione di uno schema cosmologico con la sua radicale e rinnovata valutazione secondo uno spirito anticosmico. Questa è la maniera in cui gli Stoici consideravano la posizione cosmica del fuoco: «Questa essenza calda e ardente è così diffusa in tutta la natura che è inerente ad essa il potere di procreazione e la causa del divenire» (Cic., “Nat. deor.” II, 9, 28); per essi è «il fuoco razionale», «la Mente ignea dell’universo», l’elemento realmente divino del cosmo. Ma ciò che per gli Stoici è portatore della Ragione cosmica, per i Valentiniani è per la stessa onnipresenza in tutto il creato l’incarnazione dell’Ignoranza. Mentre Eraclito parla del «fuoco immortale», essi parlano del fuoco come «morte e corruzione» in tutti gli elementi. Tuttavia perfino loro accetterebbero che la cosiddetta «vita» “cosmica” e la cosiddetta «ragione» “demiurgica” siano in modo conveniente simbolizzate nel fuoco, e infatti in molti sistemi gnostici il Demiurgo è espressamente chiamato il dio del fuoco; ma poiché questa «vita» e questa «ragione» nella loro vera natura sono morte e ignoranza, l’accordo di fatto si limita ad una sottile caricatura della dottrina stoico-eraclitea. Si nota qui la transizione alla concezione del fuoco come elemento infernale: come tale lo ritroveremo nel «fuoco bruciante delle tenebre» che i Manichei consideravano una delle proprietà della «Materia».
Appendice 2 al capitolo 7.
IL SISTEMA DELL’«APOCRIFO DI GIOVANNI».
Vogliamo dare qui come termine di confronto un riassunto del capolavoro della gnosi barbeliota, l'”Apocrifo di Giovanni”, pubblicato di recente da W. TILL, “Die gnostischen Schriften des koptischen Papyrus Berolinensis 8502” (Texte u. Untersuchungen 60), Berlino 1955. Esso presenta sotto certi aspetti uno stretto parallelismo col sistema valentiniano, con un’abbondanza di simbolismo non inferiore a quello del mito valentiniano, sebbene in generale ad un livello intellettuale più primitivo, e in particolare senza quella profondità di concezioni che costituiscono l’originalità unica del pensiero valentiniano. Per tale ragione, possiamo considerarlo con più precisione come espressione del pensiero comune della gnosi siro-egiziana o di quella della Sophia.
– Il Primo Dio.
Come tutta la speculazione gnostica, la rivelazione dell'”Apocrifo” (una volta stabilito che si tratta di un certo grado di rivelazione) inizia con una dissertazione sul Primo Principio ultra-trascendente; e qui ritroviamo quel genere di verbosità enfatica e patetica che «l’ineffabile» sembra aver suscitato in coloro che lo professavano: le quattro e più pagine di descrizione diffusa dedicate all’ineffabilità dell’Assoluto divino – che spaziano sul tema della sua purezza, infinità, perfezione eccetera che è oltre misura, qualità, quantità e tempo; al di là della comprensione, descrizione, nome, distinzione; oltre la vita, la beatitudine, la divinità e persino l’esistenza – sono un esempio tipico della nascente «teologia negativa», i cui sostenitori non si stancarono per secoli, nonostante la natura per sé deludente della loro impresa. A giusto titolo più reticenti, i Valentiniani si contentarono di alcuni simboli eloquenti (come «Abisso», «Silenzio»).
– Barbelo e gli Eoni (Pleroma).
Lo Spirito-Padre è circondato dalla «pura [anche: viva] acqua della sua luce» (1); e abbiamo riferito precedentemente (v. citazione al cap. 3, nota 4) in che modo avvenga, mediante il suo riflesso in essa, il primo spontaneo raddoppiamento della divinità, risultante nell’ipostatizzazione del suo Pensiero, la Prima Ennoia. Essa è anche «Primo Uomo» (nome applicato in seguito al Padre stesso), «spirito originario», «maschio-femmina», ed è chiamata Barbelo. Di qui procede la generazione del Pleroma. «Barbelo chiese a Lui di darle la ‘Prima Conoscenza’ ed Egli l’accordò: dopo che Egli l’ebbe concessa, la Prima Conoscenza divenne manifesta [venne a manifestazione, ossia passò dall’immanenza all’essere separato]» (2), ed in maniera simile anche gli Eoni vengono prodotti – astrazioni personificate che si uniscono nel glorificare l’Invisibile e Barbelo – finché il Pleroma è completo; eccetto l’Unigenito Figlio (Cristo) che è «nato» in modo più sessuale dall’Ennoia, mediante la sua «intensa» contemplazione del Padre. Non si trova qui l’emissione degli Eoni a coppie che come tale è fonte di ulteriori emissioni (schema valentiniano, riferito da Ireneo che lo afferma anche per i Barbelognostici). Ma la coppia-principio è improvvisamente menzionata al momento della violazione: al momento dell’aberrazione della Sophia.
– Sophia e Ialdabaoth.
Con ciò la narrazione giunge all’evento cruciale della trasgressione e della crisi da cui ha origine l’ordine inferiore. «Ma nostra sorella (3) (minore), Sophia, essendo un Eone, concepì un pensiero da se stessa; e pensando allo Spirito [Padre] e alla Prima Conoscenza volle far apparire fuori da se stessa l’immagine, sebbene lo Spirito non avesse consentito o accordato ciò, né il suo compagno (di coppia) fosse d’accordo con lei (4)… Essa non trovò più il suo consorte a mano a mano che procedeva senza il consenso dello Spirito e senza che il suo consorte sapesse, gonfiandosi [?] per il prurito che era in lei. Il suo pensiero non poteva rimanere latente [inattivo] e la sua opera venne fuori, imperfetta e brutta di aspetto, perché essa l’aveva fatta senza il suo compagno. E non somigliava a sua Madre, essendo di forma diversa… [cioè a forma di serpente e leone]… Essa lo cacciò via da sé, fuori da quei luoghi, in modo che nessuno degli Immortali lo vedesse, perché lo aveva generato nell’ignoranza. E lo coprì con una nube di luce per timore che qualcuno lo vedesse… e lo chiamò Ialdabaoth. Questo è il Primo Arconte. Egli ricavò grande potere da sua Madre. Si ritirò da lei e si allontanò dal luogo dove era nato. Prese possesso di un luogo differente. Creò egli stesso un eone che fiammeggia con fuoco splendente dove tuttora dimora».
– Gli Arconti e gli Angeli.
«E si unì all’Irragionevolezza che era con lui e produsse i poteri che sono sotto di lui… [angeli, secondo l’ordine numerico degli Eoni incorruttibili, moltiplicati con un gioco numerico non troppo chiaro fino al totale di 360]… Essi vennero a manifestazione del Progenitore, il Primo Arconte delle Tenebre, dall’Ignoranza di lui che li aveva generati…».
I poteri principali sono dodici, di cui sette sono posti sopra i cieli e cinque sopra il caos del mondo inferiore (non più menzionati in seguito). I nomi dei sette, con una sola eccezione, sono i nomi del Dio degli Ebrei o corruzioni di essi, e i loro soprannomi di bestie (per esempio, Eloaios dall’aspetto d’asino, Iao dall’aspetto di serpente, Adoni dall’aspetto di scimmia) mostrano la profondità del disprezzo o repulsione che gli Gnostici provavano per i reggitori del mondo. Tutti personificano «avidità e ira».
Ma la figura che realmente è la contrapposizione del Dio dell’Antico Testamento è il loro padrone e genitore Ialdabaoth. Abbiamo riferito precedentemente in che modo egli si sia assicurato il dominio sopra le sue creature rifiutando loro il potere che aveva ricevuto da sua Madre (v. citazione a cap. 5, a, p. 151 in nero). Il quadro fosco è alquanto rischiarato dal fatto che egli accorda a ciascuno dei sette un potere migliore (alcuni di questi in apparenza copie degli Eoni corrispondenti, come «provvidenza», «intelligenza», «sapienza»): il testo non permette di decidere se i sette siano sul serio ciò che i loro nomi fanno supporre, o uno scherno della «cosa reale»; ma in considerazione della funzione posteriore dello «spirito contraffatto», come l’espressione di vita più caratteristica degli arconti, la seconda ipotesi è la più probabile.
– Pentimento, sofferenza e correzione della Sophia.
Di fronte alla millanteria di Ialdabaoth, il quale ignorava l’esistenza di qualche altra cosa più elevata di sua Madre, questa si sentì gravemente agitata: la cattiveria e l’apostasia di suo figlio, «l’aborto imperfetto delle tenebre», le fecero comprendere la propria colpa e deficienza, dovute al fatto che aveva agito senza il consenso del suo compagno. «Essa si pentì e pianse amaramente e, movendosi qua e là nella tenebra dell’ignoranza, era vergognosa di se stessa e non osava più far ritorno». Questa è la vera «sofferenza della Sophia» nel sistema: viene dopo i fatti seguenti alla sua aberrazione ed è perciò un episodio puramente emotivo paragonato alla funzione cruciale, letteralmente «sostanziale» che ha nel sistema valentiniano.
In risposta alla sua preghiera dolente e all’intercessione dei suoi «fratelli», gli Eoni, lo Spirito supremo permette che il suo compagno discenda fino a lei per correggere la sua deficienza; ma a causa dell’ignoranza eccessiva che era apparsa in lei, essa doveva restare nella «condizione di Nona», ossia sopra l’Ogdoade cosmica al di fuori del Pleroma fino alla sua restaurazione completa. In aiuto a tale scopo una voce giunse fino a lei: «L’Uomo esiste e il Figlio dell’Uomo» (il Primo Dio e l’Unigenito).
– La creazione arcontica dell’uomo (Adamo psichico).
Ora anche Ialdabaoth udì questa voce, e come sembrerebbe (lacuna nel testo) produsse anche lui nell’acqua un’immagine del Padre perfetto, il «Primo Uomo», in forma di «un uomo» (5). Ciò ispirò a Ialdabaoth (come avviene al Re-Arconte di Mani) un’ambizione creativa alla quale consentirono i sette arconti. «Essi videro nell’acqua l’apparizione dell’immagine e si dissero l’uno con l’altro: ‘Facciamo un uomo ad immagine e somiglianza di Dio’». Così la forma plurale sconcertante del famoso versetto della Bibbia, che ha suscitato molte interpretazioni mistiche nell’ambito del giudaismo stesso e al di fuori di esso, è qui utilizzata per attribuire la creazione dell’uomo agli arconti. L’imitazione illecita ed errata del divino da parte delle potenze inferiori è un’idea largamente diffusa nello gnosticismo: talvolta già una caratteristica dell’attività demiurgica come tale (valentiniana), essa culmina nella creazione dell’uomo naturale; sotto questo aspetto la troveremo di nuovo in modo più particolareggiato nel mito di Mani.
Il racconto continua: «Da se stessi e dalle loro potenze hanno creato e composto una forma. E ciascuno ha creato dal [suo] potere l’anima: la crearono secondo l’immagine che avevano visto e per imitazione di Colui che esiste dall’inizio, l’Uomo Perfetto». Questa finora è solamente la creazione dell’Adamo “psichico”: «da loro stessi» significa dalla loro sostanza che è «anima» e non materia. Ciascun arconte dà il suo contributo «all’anima», che è perciò settemplice; le diverse parti sono riferite alle differenti parti del corpo: un’«anima delle ossa», un’«anima dei nervi», eccetera; gli altri 360 angeli compongono il «corpo» (6). Ma per lungo tempo la creatura rimase immobile e le potenze non potevano farla alzare.
– L’infusione dell’uomo pneumatico.
Ora, la presunzione e l’abborracciamento dell’opera degli arconti risultavano vantaggiosi per la Madre, che voleva ricuperare il potere che nel suo stato di ignoranza aveva concesso al figlio, il Primo Arconte. Alla sua supplica il Dio-Luce mandò Cristo con le sue quattro «Luci» (Eoni), che sotto la forma di angeli di Ialdabaoth (il Dio supremo non è considerato superiore a tale parte ingannatrice!) diedero a quest’ultimo il consiglio, calcolato in modo da farlo strumento del «potere della Madre» in lui: «Soffia sulla sua faccia un po’ dello spirito [pneuma] che è in te e la cosa si alzerà». Egli così fece e Adamo cominciò a muoversi. Perciò l’uomo pneumatico venne ad essere infuso nell’uomo psichico. Osserviamo che in linea generale ci sono due spiegazioni gnostiche della presenza del pneuma nell’uomo creato: una, che è una sconfitta della Luce, dovuta alla sua inclinazione verso il basso (per esempio, Poimandres), oppure al disegno arcontico (Mani); l’altra, al contrario, che è uno stratagemma della Luce nella sua lotta contro gli arconti (come qui e nel mito valentiniano). La seconda versione non dev’essere considerata più «ottimistica» della prima, perché lo stratagemma sfrutta meglio che può un male fondamentale, ossia l’allontanamento avvenuto dapprima della sostanza divina dal mondo della Luce.
– Mozione e contromozione.
Gli arconti si accorsero con spavento che la creatura che aveva i loro poteri e le loro anime li superava in sapienza, e allora la portarono giù nella regione al fondo di tutta la materia. Il Padre intervenne di nuovo per amore del «potere della Madre» ora racchiuso nella creatura, e mandò giù lo Spirito Buono, il Pensiero della Luce chiamato da lui «Vita» (femminile), che si nascose in lui di modo che gli arconti non si accorgessero di lei. «E’ lei che opera attorno alla creatura, che si adopera in lui, lo stabilisce nel suo tempio perfetto, lo illumina sull’origine della sua deficienza e gli mostra la [via di] ascesa». Adamo fu splendente per la luce dentro di lui e il suo pensiero si innalzò sopra quello dei suoi creatori.
– L’uomo incatenato in un corpo materiale.
Questi perciò presero una nuova decisione d’accordo con gli angeli e le potenze. «Essi provocarono un grande sconvolgimento [degli elementi]. Lo portarono nell’ombra della morte. Fecero una forma di terra [‘materia’], acqua [=’tenebre’], fuoco [= ‘desiderio’] e vento [= ‘spirito contrario’]… Questa è la catena, questa è la tomba del corpo con cui l’uomo è stato rivestito, di modo che ciò fosse [per lui] la catena della Materia». Così l’uomo terreno è completo ed è posto da Ialdabaoth nel paradiso. (Su questo e sulla distinzione dei due alberi, v. citazione a p. 108 in nero, cap. 2, o.)
– Creazione di Eva.
Ialdabaoth, per estrarre da Adamo il potere nascosto che la Tenebra inseguiva ma non poteva raggiungere, fece scendere su Adamo l’insensibilità (impotenza a conoscere), e «dalla sua costola» diede corpo al Pensiero di Vita (contenuto dentro?) in una forma femminile. Ma essa tolse il velo dai suoi sensi ed egli «rinsavendo dalla ubriacatura delle Tenebre» riconobbe la sua essenza in lei (7). Per mezzo dell’Epinoia in Eva, Cristo insegnò ad Adamo a mangiare dell’albero della conoscenza, che Ialdabaoth gli aveva proibito di mangiare «per timore che egli vedesse in alto la sua perfezione e si accorgesse della sua nudità riguardo ad essa». Ma il serpente (ad uno stadio seguente: vedi sotto) gli insegnò la concupiscenza della procreazione che serviva l’interesse dell’Arconte.
– Il combattimento per l’uomo: Spirito e Contro-Spirito.
Quando Ialdabaoth si accorse che Adamo ed Eva, per la conoscenza che avevano acquisito, stavano allontanandosi da lui, li maledisse e li mandò fuori dal «paradiso» nella tenebra oscura. Allora si infiammò di concupiscenza per la vergine Eva, la rapì e generò con lei due figli: Javè dall’aspetto di orso ed Eloim dall’aspetto di gatto, chiamati tra gli uomini fino ad oggi Caino ed Abele. Eloim «il giusto», egli lo stabilì sopra il fuoco e il vento (gli elementi superiori), Javè «l’ingiusto» sopra l’acqua e la terra (gli elementi inferiori): insieme governano la «tomba» (ossia il corpo) – un’acrobazia di esegesi dell’Antico Testamento! Inoltre egli suscitò in Adamo la concupiscenza di generare (cioè, il Demiurgo è il «serpente»), e Adamo generò con Eva Seth, iniziando così la catena delle procreazioni. La Madre mandò il suo Spirito alle generazioni dell’uomo, per risvegliare in essi l’essenza simile a lui dall’impotenza della conoscenza e dal male della «tomba». Questa azione continuata dello Spirito materno serve a prepararli alla venuta dello Spirito inviato dai santi Eoni stessi, che li condurrà alla perfezione.
Gli arconti contrastano questa azione con una contro-azione altrettanto continua del loro «Spirito contraffatto» (8), che penetra nelle anime, cresce, si indurisce, le rinchiude, pesa sopra di loro, le conduce alle opere malvage, e le rende così impotenti a conoscere. Per mezzo di ciò anche la generazione carnale continua.
– Istituzione dell’«heimarméne».
Bisogna ricordare un’altra mossa delle Tenebre nella grande lotta: l’ordinamento dell'”heimarméne”, l’invenzione diabolica dell’Arconte. Osservando il successo degli sforzi dello Spirito nel pensiero dell’uomo, «egli volle prendere possesso (controllo) delle loro facoltà di pensiero… Egli prese una decisione con le sue potenze: fecero venire all’essere il Fato, e per mezzo di misura, periodi e tempi incatenarono gli dèi dei cieli [pianeti e stelle], gli angeli, i demoni e gli uomini, affinché tutto fosse posto sotto il suo legame ed esso [Fato] fosse il signore sopra tutti loro: un piano diabolico e perverso!».
A lungo andare tutto questo risulta vano, sebbene impedisca e ritardi l’opera di salvezza.
Tralasciamo gli avvenimenti ulteriori e chiudiamo qui la nostra esposizione.
NOTE ALL’APPENDICE 2.
1. Analogo negli insegnamenti mandei.
2. Analogo negli insegnamenti mandei.
3. «Cristo» è colui che parla.
4. Abbiamo incontrato questa spiegazione della colpa della Sophia anche in una versione dissenziente della scuola valentiniana, citata da Ippolito (v. cap. 7, nota 11).
5. Confronta il mito di Poimandres e la discussione sull’immagine riflessa, p. 174 s.s. in nero.
6. Il quale in questo stadio deve essere considerato immateriale, una forma di sostanza psichica.
7. La mia traduzione è congetturale, poiché il testo è oscuro.
8. “Antimimon pneuma”, conosciuto anche dalla Pistis Sophia: un termine che sembra molto diffuso in un ramo dello gnosticismo.
Capitolo 8.
CREAZIONE, STORIA DEL MONDO E SALVEZZA SECONDO MANI.
a) Il metodo di Mani; la sua vocazione.
Col sistema valentiniano abbiamo imparato a conoscere il vertice toccato dal tipo siro-egiziano di speculazione gnostica. Il suo opposto per il tipo iranico è il sistema di Mani. Sebbene abbia avuto origine un secolo più tardi, esso rappresenta per il suo contenuto teoretico, in ragione del tipo come tale e nonostante l’alto grado di elaborazione, un livello più arcaico di pensiero gnostico. In realtà il semplice e schietto dualismo «zoroastriano» dei due princìpi opposti e coeterni, che Mani assume come punto di partenza, rende inutile il compito teoretico di sviluppare il dualismo stesso in una storia trascendentale interna, impresa che provocò le sottigliezze della speculazione valentiniana. D’altra parte, e forse proprio per tale ragione, quello di Mani è l’unico sistema gnostico che divenne una forza storica di ampia portata, e la religione basata su di esso, nonostante il suo tramonto finale, dev’essere annoverata tra le maggiori religioni dell’umanità. Mani infatti, solo tra i fondatori di sistemi gnostici, “ebbe intenzione” di fondare una nuova religione universale, e non raccogliere un gruppo scelto di iniziati; perciò la sua dottrina, a differenza dell’insegnamento di tutti gli altri Gnostici, ad eccezione di Marcione, non contiene niente di esoterico. I Valentiniani si consideravano una “élite” di persone che hanno la scienza, i «pneumatici», separati a ragione della profondità della conoscenza dalla gran massa dei cristiani di semplice fede; e la loro esegesi pneumatica della Scrittura sottolineava la differenza tra il significato manifesto accessibile agli «psichici» e quello nascosto riservato a loro stessi.
Il compito di Mani non fu quello di penetrare gli aspetti segreti di una data rivelazione e di stabilire una minoranza di alta iniziazione all’interno di una chiesa già esistente, ma piuttosto quello di fornire una nuova rivelazione, un nuovo corpo di Scrittura, e gettare le fondamenta di una nuova chiesa che avrebbe dovuto soppiantare ogni altra esistente ed essere altrettanto ecumenica quanto la Chiesa cattolica affermava di essere. Di fatto il manicheismo fu per un certo tempo un serio rivale per la Chiesa cattolica, col suo tentativo di una religione organizzata di massa che si occupava della salvezza del genere umano e di un’attività missionaria sistematica per raggiungere questo fine. In breve, si trattò di una chiesa sul modello della Chiesa cattolica incipiente.
Sotto un certo aspetto la «cattolicità» di Mani superò il modello cristiano: sia per amore d’un appello universale sia per le sue molteplici affinità, egli diede alla sua chiesa una base dottrinale tanto sincretistica quanto era compatibile con l’unità dell’idea gnostica centrale. In linea di principio egli riconobbe l’autenticità e la validità provvisoria delle grandi rivelazioni primitive (1); in pratica, nel primo tentativo in questo senso conosciuto dalla storia, egli fuse deliberatamente elementi buddisti, zoroastriani e cristiani col suo insegnamento, cosicché non soltanto poteva dichiararsi il quarto e ultimo profeta in una serie storica e la sua dottrina il compendio e la conclusione di quella dei suoi predecessori (2), ma la sua missione in ciascuna delle tre aree dominate dalle rispettive tradizioni religiose poteva sottolineare quell’aspetto della sintesi manichea che era familiare alla mente dei suoi ascoltatori. Il successo sembrò dapprima giustificare questo indirizzo eclettico. Il manicheismo si estese dall’Atlantico all’Oceano Indiano e fin nel profondo dell’Asia centrale. In Oriente i suoi missionari raggiunsero punti molto oltre le aree penetrate dalla cristianità, e là alcuni rami della chiesa sopravvissero per secoli dopo che in Occidente i suoi rami erano stati soppressi dalla Chiesa cattolica vittoriosa.
Tuttavia non bisogna supporre che a causa del metodo sincretistico il sistema stesso fosse sincretistico. Al contrario, fu la rappresentazione più monumentale ed unica del principio religioso gnostico, per la quale furono impiegati di proposito nella dottrina e nella mitologia gli elementi delle religioni più antiche. Non si può negare che il pensiero di Mani fosse di fatto influenzato dalle tre religioni, i cui fondatori – Budda, Zoroastro, Gesù – egli riconosceva come suoi precursori. Se cerchiamo di misurare tale influenza, potremmo dire che quella della religione iranica fu più forte nella sua cosmogonia, quella della religione cristiana nell’escatologia e quella del buddismo nell’ideale etico e ascetico di vita umana. Il cuore del manicheismo tuttavia fu la versione speculativa personale di Mani del mito gnostico dell’esilio cosmico e della salvezza, e questa versione si è mostrata di una vitalità sorprendente: come principio astratto, spogliato della maggior parte dei particolari mitologici con cui Mani lo aveva abbellito, riapparve continuamente nella storia delle sètte cristiane medievali, dove spesso «eretico» equivaleva a «neo-manicheo». Perciò, mentre in profondità e sottigliezza di pensiero fu certamente inferiore alle migliori creazioni della gnosi siro-egiziana, che con le loro sofisticazioni si rivolgevano ad un gruppo scelto, dal punto di vista della storia delle religioni il manicheismo fu il prodotto più importante dello gnosticismo.
Mani nacque a Babilonia, che apparteneva allora al regno parto, probabilmente da genitori persiani, intorno al 216 d.C. Pare che suo padre appartenesse ad una setta «battista», nome che con ogni probabilità indica i Mandei (o più probabilmente gli Elcesaiti o Sabei a questi molto affini): infatti la poesia degli inni manichei mostra la netta influenza dei modelli mandei. Durante la sua infanzia avvenne la ricostruzione del regno persiano sotto i Sassanidi. La sua attività principale come insegnante e organizzatore di una nuova religione si svolse sotto Shapur Primo (241-272) e fu crocifisso sotto il successore Bahram Primo nel 275 d.C. circa. Ricevette la sua «vocazione» durante il regno di Ardashir Primo, il fondatore della dinastia Sassanide, morto nel 241. Ecco come egli stesso ci descrive l’avvenimento:
«Negli anni di Ardashir, re di Persia, crebbi e raggiunsi la maturità. In quell’anno particolare in cui Ardashir… (3), il Paraclito Vivente scese su di me e mi parlò. Egli mi rivelò il mistero nascosto che era stato celato ai mondi e alle generazioni: il mistero della Profondità e dell’Altezza; mi rivelò il mistero della Luce e delle Tenebre, il mistero del conflitto e della grande lotta che la Tenebra suscitò. Mi rivelò in che modo la Luce [respinse? vinse?] la Tenebra mediante il loro frammischiarsi e come [di conseguenza] fu stabilito questo mondo… mi illuminò sul mistero della formazione di Adamo il primo uomo. Mi istruì sul mistero dell’Albero della Conoscenza di cui Adamo mangiò, per cui i suoi occhi si aprirono e videro; il mistero degli Apostoli che furono mandati nel mondo a scegliere le chiese [ossia a fondare le religioni]… Così mi fu rivelato dal Paraclito tutto quello che è stato e che sarà, tutto quello che gli occhi vedono e le orecchie odono e il pensiero pensa. Per lui imparai a conoscere ogni cosa, vidi il Tutto per mezzo di lui, e divenni un “solo” corpo e un “solo” spirito» (Keph. I, 14, 29 -15, 24).
Questa narrazione autobiografica della sua chiamata (non riferita integra) contiene già in sunto i punti principali e i princìpi della dottrina sviluppata in seguito da Mani. Tale dottrina vuole esporre «l’inizio, il mezzo e la fine» del dramma completo dell’essere, dove la triade designa le tre maggiori divisioni dell’insegnamento: «Il fondamento della dottrina di Mani è l’infinità dei “primi princìpi”; la parte di mezzo riguarda il loro “mescolamento”; e la fine, la “separazione” della Luce dalle Tenebre» (4).
b) Il sistema.
La seguente ricostruzione del sistema nei suoi particolari segue in linea generale il resoconto siriaco di Teodoro bar Konai, con l’aggiunta di qualsiasi altro materiale, ricavato da testi paralleli, che si adatti a un dato passo e contribuisca ad una più piena presentazione dell’idea esposta. Le versioni parallele sono prese dagli “Acta Archelai” (citati come «Hegemonius»), da Alessandro di Lycopolis, Tito di Bostra, Severo di Antiochia, Teodoreto, sant’Agostino, e il musulmano En-Nadim. Poiché questa non è un’opera di analisi delle fonti che si indirizzi a studiosi, risparmiamo al lettore l’attribuzione dei singoli passi nel corso della nostra presentazione che non segue un ordine preciso, ma si muove con libertà tra le fonti. Ne consegue un metodo a mosaico che non vuole essere una ricostruzione dell’originale ipotetico, ma semplicemente un’utilizzazione sinottica dei resti dispersi ad uso del lettore non specialista.
– I Princìpi Primordiali.
«Prima dell’esistenza del cielo e della terra e di quanto è in essi c’erano due nature, una buona e l’altra malvagia (5), separate l’una dall’altra. Il principio buono dimora nel luogo della Luce ed è chiamato ‘Padre della Grandezza’. Fuori di lui dimorano le sue cinque Sh’kina (6): Intelligenza, Conoscenza, Pensiero, Deliberazione, Risoluzione. Il principio cattivo è chiamato ‘Re della Tenebra’ e dimora nella terra della Tenebra circondato dai suoi cinque Eoni (o ‘Mondi’), gli Eoni del Fumo, del Fuoco, del Vento, dell’Acqua e della Tenebra. Il mondo della Luce confina con quello della Tenebra e non c’è una parete di divisione tra di essi» (Teodoro bar Konai).
Questo è il «fondamento» della dottrina e tutti i riassunti lasciatici da Mani s’iniziano con la contrapposizione dei due arciprincìpi. I Manichei persiani, seguendo la loro tradizione zoroastriana, chiamarono la Tenebra personificata Ahriman, le fonti arabe Arcidiavolo o Iblis (corruzione del greco “diabolos”). Le fonti greche quasi all’unanimità vi unirono il termine “Hyle”, ossia Materia; e la parola greca è usata anche nelle traduzioni siriache e latine della dottrina, per non parlare del suo uso nei testi manichei in lingua copta. Non c’è dubbio che Mani stesso abbia usato nei suoi scritti (per la maggior parte in siriaco) questo termine greco per indicare il principio del male; ma è altrettanto certo che «Materia» nel suo pensiero ha sempre la funzione di una figura mitologica e non quella di un concetto filosofico. Non soltanto è personificata, ma possiede anche una sua propria natura spirituale attiva senza la quale non potrebbe essere «male»: la malvagità positiva è la sua essenza, non la materialità passiva che è «cattiva» solo in senso privativo, ossia per l’assenza del bene. Si comprende perciò l’apparente contraddizione di chiamare la Tenebra nello stesso tempo «materia» e «immateriale e intellettuale» (Severo); e si dice di questa Materia che «una volta acquistò la facoltà di pensiero» (Ephraem) (7). La distinzione più accentuata tra l'”hyle” di Mani e quella di Platone e Aristotele è messa in evidenza dal resoconto dato da Alessandro (versato in filosofia), il quale sottolinea che Mani attribuisce ad essa poteri, movimenti, azioni che differiscono da quelli di Dio soltanto per il fatto che sono cattivi: i suoi movimenti sono «movimenti disordinati», le sue tendenze «concupiscenza malvagia», e i suoi poteri sono simbolizzati nell’«oscuro fuoco che consuma». Qui la Materia è così lontana dall’essere il sustrato passivo, come definita dai filosofi, che la Tenebra ad essa identica è persino la sola attiva dall’origine tra i due princìpi opposti, mentre la Luce nel suo riposo è spinta all’azione solo per un attacco iniziale della Tenebra.
I due regni sono coeterni per quanto riguarda il passato: essi non hanno origine ma sono essi stessi le origini, sebbene talvolta sia affermato che Satana come incarnazione “personale” della Tenebra è stato procreato dai suoi elementi preesistenti (8). In ogni modo i due regni come tali esistono a fianco a fianco senza nessuna relazione, e la Luce, anziché considerare l’esistenza della Tenebra come una sfida, non desidera altro che la separazione e non ha alcuna tendenza benevola o ambiziosa ad illuminare il suo opposto. Perché la Tenebra è ciò che è destinata ad essere, e lasciata a sé attua la sua natura come la Luce attua la propria. Tale autosufficienza della Luce, che desidera brillare soltanto per se stessa e non per ciò che è privo di lei, e che, per propria deliberazione, potrebbe rimanere senza tentazione attraverso le eternità, dimostra la profonda differenza del manicheismo non soltanto dal sentimento cristiano (9), ma anche dalla gnosi siriaca, la quale fa iniziare un movimento verso il basso nella Luce stessa e la rende cosi responsabile del dualismo attuale.
C’è un elemento aristocratico, nel quale sopravvive qualche cosa dello spirito originale della religione iranica, nella credenza di Mani in un’immutabilità interiore della Luce, la quale nella soddisfazione di sé non dà motivo al divenire e può accettare come stato naturale delle cose la frattura profonda dell’essere insieme all’esistenza di una Tenebra che infuria in se stessa, finché, naturalmente, infuria soltanto dentro di sé. Anche nella maniera in cui la Luce minacciata reagisce di fronte alla necessità di battaglia e alla prospettiva di una disfatta e del sacrificio, sopravvive il coraggioso spirito dell’antico dualismo iranico, seppure nella trasformazione gnostica, ossia anticosmica.
Ora, se la separazione dualistica è lo stato normale e soddisfacente per la Luce, allora il destino dev’essere messo in movimento non da un impulso dall’alto verso il basso ma da un sollevamento dal basso. L’inizio perciò sta nella profondità e non nell’altezza. Tale idea di un’iniziativa originaria della profondità che costringe l’altezza ad abbandonare il suo riposo è di nuovo un punto che distingue la gnosi iranica da quella siriaca. Nondimeno, questi due differenti modi di causalità devono rendere ragione dello stesso effetto valido in senso gnostico – l’imprigionamento della Luce nella Tenebra – e perciò il cammino della Luce verso la profondità, ossia il movimento verso il basso, è in ambedue i casi, in qualunque posto abbia origine, il tema cosmogonico.
– L’attacco della Tenebra.
Qual è stata la causa per cui la Tenebra è salita e ha combattuto contro la Luce? Quale fu l’occasione esterna? La percezione della Luce, che prima di allora le era sconosciuta. Per giungere a tale percezione, la Tenebra doveva in primo luogo raggiungere i suoi confini estremi, e vi fu spinta ad un certo momento nel corso della lotta interna in cui era senza tregua impegnata la passione distruttiva dei suoi membri. Poiché la natura della Tenebra è odio e contesa, ed essa deve attuare questa natura contro se stessa finché l’incontro con la Luce non offra un oggetto esterno e migliore. Riferiamo questo punto della dottrina nella seguente compilazione di Severo, Teodoreto e Tito.
[La Tenebra era divisa contro se stessa: l’albero contro i frutti e i frutti contro l’albero. Lotta e amarezza appartengono alla natura delle sue parti; la dolce tranquillità è aliena ad esse che sono piene di ogni malignità, e ciascuna distrugge ciò che le è vicino.
Tuttavia fu proprio il loro tumulto che fornì loro l’occasione di sollevarsi ai mondi della Luce. Perché, in verità, questi membri dell’albero della morte, in partenza, non si conoscevano nemmeno l’uno con l’altro. Ognuno aveva soltanto la propria mente, ognuno non conosceva che la propria voce e non vedeva che quello che aveva dinanzi agli occhi. Solo quando uno di essi gridava essi lo udivano e si voltavano con impeto verso il suono.
Così, eccitati e incitandosi a vicenda, si combatterono e si divorarono uno con l’altro senza smettere di urtarsi con forza a vicenda, finché non s’accorsero della Luce. Nello svolgimento della guerra, infatti, alcuni inseguiti altri inseguitori, giunsero ai confini della Luce, e quando scorsero la Luce – una visione meravigliosa e gloriosa, molto superiore alla loro – ne provarono piacere e meraviglia; e si riunirono – tutta la Materia della Tenebra – e si consultarono sul modo di potersi unire ad essa. Ma a causa del disordine delle loro menti non si accorsero che il forte e potente Dio vi abitava. E si sforzarono di sollevarsi all’altezza perché non era mai giunta fino a loro una conoscenza di Dio e della Divinità. E così senza comprendere gettarono uno sguardo forsennato su di essa suscitato dalla concupiscenza allo spettacolo di quei mondi benedetti, e pensarono di potersene appropriare. E trascinati dalla passione che era in loro, desiderarono ora con tutte le loro forze di combattere per ridurli in loro potere e mescolare la loro Tenebra con la Luce. Riunirono tutta l’oscura e dannosa “Hyle”, si sollevarono tutti insieme con le loro innumerevoli forze, e, nel desiderio del meglio, sferrarono l’attacco. Attaccarono in un corpo solo, per così dire, senza conoscere il loro avversario, perché non avevano mai sentito parlare della Divinità.]
Una fantasia così accesa non si trova ovunque nell’inventiva di Mani. Il zoroastrismo ortodosso forniva il modello originale e già almeno un secolo prima di Mani il modello iranico era stato adattato agli scopi gnostici (10). Ma il contributo originale ed ingegnoso di Mani alla dottrina (11), sembra consistere nell’idea che la lotta fratricida della Tenebra conduce inevitabilmente all’iniziale visione della Luce e tale visione a sua volta conduce alla terribile unificazione delle forze divise della Tenebra. A parte ciò, è nella linea generale iranica che la percezione della Luce ecciti nella Tenebra invidia, avidità e odio e provochi la sua aggressione. Il suo primo impeto è selvaggio e caotico, ma nel seguito della guerra esso sviluppa un’intelligenza diabolica, e nella formazione dell’uomo e nell’invenzione della riproduzione sessuale ha una trovata d’ingegnosità mefistofelica: tutto allo scopo di possedere e trattenere la Luce e di sfuggire all’odiosità della propria compagnia. Infatti l’odio è paradossalmente mescolato al riconoscimento e al desiderio di una superiorità agognata ed è così al tempo stesso l’odio di sé che la Tenebra concepisce in vista del meglio (12). La frase «desiderio del meglio» che ricorre spesso a questo riguardo permette un netto confronto delle concezioni iraniane e greche. Nel “Simposio” di Platone è precisamente l’«eros» di ciò che è imperfetto verso il meglio che anima la lotta di tutte le cose verso la partecipazione all’immortalità, e nel caso dell’uomo è l’agente principale della sua ascesa verso la conoscenza e la perfezione. La facilità con cui nel contesto manicheo il «desiderio del meglio» da parte della Tenebra è considerato come presunzione perversa e bramosia peccaminosa sottolinea l’abisso che separa questo mondo di pensiero da quello della Grecia non meno che dal cristianesimo. Il «desiderio» non è di essere, ma di possedere il meglio (13); e il riconoscerlo non produce amore, ma risentimento.
L’attacco minaccioso della Tenebra strappa il regno della Luce dal suo riposo e lo costringe a qualche cosa che altrimenti non sarebbe avvenuta, ossia le «creazioni».
– Il pacifismo del Mondo della Luce.
«Quando il Re della Tenebra progettò di salire al posto della Luce, il timore si sparse tra le cinque Sh’kina. Allora il Padre della Grandezza ne prese atto e disse:
‘Io non manderò in battaglia nessuno
di quei miei Eoni, le cinque Sh’kina,
poiché le ho create per la pace e la beatitudine.
Io stesso andrò in vece loro
e condurrò la guerra contro il nemico’»
(Teodoro bar Konai).
Circa l’incapacità del mondo della Luce di far guerra, cioè di recar danno in qualche modo, riportiamo per esteso il seguente passo: «Dio non aveva niente di malvagio con cui castigare la Materia, perché nella casa di Dio non vi è alcuna cosa cattiva. Non aveva né fuoco divoratore con cui scagliare tuoni e fulmini, né acqua straripante con cui mandare un diluvio, né ferro tagliente o altra arma; ma in lui tutto è Luce e sostanza nobile [lett.: ‘posto’] e non poteva recar danno al Malvagio» (14). Tale concezione radicale della disposizione pacifica del mondo della Luce conduce talvolta alla versione che la nuova ipostasi divina suscitata da Dio per l’incontro con le forze della Tenebra è stata fin dall’inizio creata, non per la battaglia, ma per un sacrificio salvifico (15), e in tal caso è chiamata Anima anziché Uomo Primordiale, che è una figura di combattente (16). Poiché la concezione prevalente, sia per l’importanza delle testimonianze che per tutta la struttura del sistema, è la lotta precosmica dell’Uomo Primordiale con l’arcinemico, seguiremo in linea di massima le fonti che riferiscono tale versione. Talvolta si trova persino l’affermazione opposta: «I suoi eserciti sarebbero stati abbastanza forti da sopraffare il nemico, ma egli voleva compierlo solo con la sua forza» (En-Nadin) (17). Ciò che conta per l’andamento del mito è il fatto, comune a tutte le versioni, che la divinità per incontrare l’aggressore doveva produrre una «creazione» speciale rappresentante il suo io – poiché questo è il significato di «marcerò io stesso» – e che come conseguenza del destino incorso da questa ipostasi divina deriva l’ulteriore moltiplicazione delle figure divine dalla sorgente suprema. E’ questo il principio gnostico generale di emanazione, che s’unisce all’idea di una necessità esterna piuttosto che interna che provoca il processo.
– La prima creazione: l’Uomo Primordiale.
«Il Padre della Grandezza creò la Madre della Vita, e la Madre della Vita creò l’Uomo Primordiale, e l’Uomo Primordiale creò i suoi cinque Figli, come un uomo che si cinge della sua armatura per la battaglia. Il Padre lo incaricò della lotta contro la Tenebra. E l’Uomo Primordiale si armò delle cinque specie, che sono i cinque dèi: la brezza leggera, il vento, la luce, l’acqua e il fuoco. Ne fece la sua armatura… [tralasciamo la descrizione particolareggiata di come egli si riveste di questi elementi ad uno ad uno, prendendo infine il fuoco come scudo e lancia] e si precipitò dal Paradiso verso il basso finché giunse al confine della zona prossima al campo di battaglia. Lo precedeva un angelo che proiettava luce davanti all’Uomo primordiale» (18).
La «prima creazione» produce all’inizio stesso della storia divina la figura centrale soteriologica del sistema: l’Uomo Primordiale. Creato per mantenere la pace dei mondi della Luce e per combattere la loro battaglia, a causa della sua sconfitta coinvolge la divinità in una lunga e travagliata opera di salvezza, di cui fa parte la creazione del mondo. La figura compare frequentemente lungo tutta la speculazione gnostica: ne abbiamo visto un esempio nel “Poimandres” di Ermete. Non possiamo addentrarci qui negli antecedenti della più antica speculazione orientale. Per gli Gnostici l’esistenza di un dio «Uomo» precosmico esprimeva uno dei maggiori segreti della loro conoscenza ed alcune sètte si spingevano al punto di chiamare «Uomo» la stessa divinità suprema: «Questo [secondo un ramo dei Valentiniani] è il grande e nascosto segreto, che il nome della potenza che è al di sopra di tutte le cose, all’inizio di tutte le cose, è Uomo» (19).
E’ significativo che i Manichei persiani chiamassero l’Uomo Primordiale «Ormuzd», che nel zoroastrismo era il nome dello stesso Dio della Luce (“Ahura Mazda”), al quale veniva opposto il Dio della Tenebra, Ahriman. Lo si identifica ora con l’Uomo Primordiale, un'”emanazione” della divinità suprema: prova, da una parte, dell’enorme diffusione religiosa dell’idea di uomo e, dall’altra, dell’accentuazione della trascendenza divina, che impediva di coinvolgere direttamente il Primo dio nella lotta metafisica, caratteristica preminente dell’Ormuzd persiano. Nemmeno la sconfitta subita dal combattente contro la Tenebra nella versione gnostica era compatibile con la condizione della divinità suprema. Così per i Manichei Ormuzd come equivalente dell’Uomo Primordiale diviene l’organo esecutivo degli Dei originari della Luce: «Ormuzd venne con i Cinque Dei per combattere secondo il comando di tutti gli Dei contro il Demonio. Egli discese e combatté contro l’Arcidemonio e i Cinque Diavoli» (“Chuastuanift”, cap. 1). I cinque elementi di Luce che l’Uomo Primordiale riveste come armatura sono rappresentazioni più concrete delle cinque ipostasi originarie della divinità, le Sh’kina; nonostante i loro nomi piuttosto materiali essi sono, come risulta evidente in seguito, nature spirituali, e come tali origini di tutto ciò che è «anima» nell’universo.
– La sconfitta dell’Uomo Primordiale.
«Anche l’Arcidiavolo prese i suoi cinque generi, cioè il fumo, il fuoco consumatore, la tenebra, il vento bruciante e la nebbia, si armò di questi e venne incontro all’Uomo Primordiale. Appena il Re della Tenebra vide la luce dell’Uomo Primordiale divenne pensieroso e disse: ‘Quello che cercavo lontano, lo trovo qui vicino’. Dopo che ebbero lottato a lungo l’uno con l’altro, l’Arcidiavolo vinse l’Uomo Primordiale. Perciò l’Uomo Primordiale diede sé e i suoi cinque Figli come cibo ai cinque Figli della Tenebra, come un uomo, che ha un nemico, mescola un veleno mortale ad una torta e gliela offre. L’Arcidiavolo divorò parte della sua luce [cioè i suoi cinque figli] e nello stesso tempo lo circondò con i suoi generi ed elementi. Appena i Figli della Tenebra li ebbero divorati, i cinque dèi luminosi furono privati di intelligenza e mediante il veleno dei Figli della Tenebra divennero come un uomo morso da un cane arrabbiato o da un serpente. E le cinque parti della Luce furono mescolate alle cinque parti della Tenebra» (20).
Da ora in poi l’interesse metafisico si sposta ai «Cinque Dei», armatura e scorta dell’Uomo Primordiale, come vittime maggiormente coinvolte nella sua sconfitta, e a proposito di essi si parla ovunque si tratti dell’aspetto più importante dal punto di vista religioso del fato divino: «quella luminosità degli Dei che dall’inizio di tutte le cose fu vinta da Ahriman, dai Demoni [eccetera], ed è tuttora trattenuta prigioniera» (21); «dai cinque elementi di Luce, l’armatura di Ormuzd, essa formò [?] l’anima buona e la incatenò nel corpo. La fece come cieca e sorda, inconscia e confusa, cosicché al principio non conoscesse la sua vera origine e parentela» (Saleman: confronta cap. 2, nota 23). Ecco la ragione dell’importanza del destino dell’«armatura»: dalla sua sostanza derivano le nostre anime, e la nostra condizione è una conseguenza di ciò che è accaduto ad essa. Così è affermato molto semplicemente in Egemonio: «Gli Arconti della Tenebra mangiarono della sua armatura, “ossia l’anima”». Questa equivalenza è uno dei punti cardinali del sistema.
– Il sacrificio e l’adulterazione dell’Anima.
Il divorare ha anche effetto sul divoratore. Non soltanto fa deviare la Tenebra dal suo obiettivo iniziale, il mondo della Luce, ma all’interno di essa la sostanza divorata agisce come un veleno sedativo, e sia che il suo desiderio sia stato soddisfatto o assopito, l’attacco viene in tal modo arrestato. Le due sostanze agiscono come un veleno l’una sull’altra, tanto che alcune versioni riferiscono che l’Uomo Primordiale non è stato sconfitto ma si è fatto volontariamente divorare dalla Tenebra prevedendone l’effetto. In ogni modo, la resa dell’Anima alla Tenebra non soltanto svia la minaccia immediata dal mondo della Luce esposto al pericolo, ma nello stesso tempo fornisce il mezzo con cui alla fine la Tenebra è conquistata. Il primo scopo, a breve scadenza, è espresso dall’idea di «allettamento» e «veleno sedativo»; lo scopo a lunga scadenza dell’astuzia (perché il sacrificio è un’astuzia, anche se imposto dalla divinità) si trova nell’idea che un’eventuale nuova separazione significa la «morte» della Tenebra, ossia la sua finale riduzione all’impotenza.
Nelle fonti che concentrano il loro interesse sull’Anima, trascurando l’Uomo Primordiale, si dice: «Egli inviò contro la Materia una forza che noi chiamiamo Anima, particella della sua luce e della sua sostanza, per proteggere i confini, ma in realtà come un’esca (22), così da assopire la Materia contro sua volontà e mescolarsi interamente con essa; perché se in un secondo tempo tale potere si fosse separato di nuovo dalla Materia, sarebbe stata la morte di quest’ultima. E così avvenne: appena la Materia ebbe la sensazione del potere che era stato mandato, fu trascinata verso di esso da un desiderio appassionato e in un assalto più violento lo prese e lo divorò, e rimase legata come una bestia selvaggia o (come essi dicono anche) cadde addormentata come per un incantesimo. Così per la provvidenza di Dio l’Anima si mescolò alla Materia, dissimile con dissimile. A causa della mescolanza, tuttavia, l’Anima fu soggetta alle affezioni della Materia e contro la sua vera natura fu degradata partecipando al male» (23).
La descrizione più impressionante di questa fase della lotta, che riunisce l’Uomo Primordiale, il guerriero, e l’Anima, l’arma e la vittima, si trova in quattro stanze del Salmo duecentoventitreesimo del Libro dei Salmo manicheo, che sebbene sia un po’ un duplicato di quanto abbiamo riferito non deve essere sottratto al lettore.
«Come un pastore che vede un leone entrare a distruggere il suo ovile: poiché egli adopera astuzia e prende un agnello e lo colloca come una trappola per poter prendere il leone; difatti con un solo agnello egli salva l’ovile; e dopo questi avvenimenti egli risana l’agnello che è stato ferito dal leone.
Questa è anche la via del Padre, il quale ha mandato il suo forte figlio; ed egli [il figlio] ha prodotto da se stesso una Vergine fornita di cinque poteri, per poter combattere contro i cinque abissi della Tenebra.
Quando il Guardiano [?] stette nei confini della Luce, mostrò ad essi la sua Vergine che è la sua anima, quelli si agitarono nei loro abissi per il desiderio di esaltarsi al di sopra di lei, essi aprirono la loro bocca nel desiderio di inghiottirla.
Egli ne trattenne saldamente il potere, la distese sopra di loro, come rete sopra i pesci, la fece piovere su di loro come nuvole purificate di acqua, essa si gettò dentro di loro come un lampo penetrante. Si insinuò nelle loro parti più interne, li legò tutti, senza che lo notassero» (9,31- 10,19).
Il lettore noterà nella mutevole immaginativa di questo passo che l’«armatura» della maggior parte dei testi è sostituita dalla «vergine» come simbolo dell’anima (certamente un’immagine più conforme al nostro gusto), e che quest’ultima viene deliberatamente, e più efficacemente, adoperata dall’Uomo Primordiale come mezzo di guerra offensiva: non vi è cenno di disfatta. Un esempio della libertà con cui il pensiero manicheo maneggiava il simbolismo. Tuttavia anche qui l’Uomo Primordiale, apparentemente così vittorioso, deve essere in seguito «aiutato a uscire dall’abisso» da «suo fratello» (lo Spirito Vivente: v. sotto), il che ci conduce di nuovo al tema dominante della dottrina. Per riprendere la narrazione, l’emissario della Luce – l’Uomo Primordiale con l’Anima e il suo quintuplo armamento – nonostante il successo nel fermare il nemico, è afferrato dalla Tenebra, «stretto», intorpidito e fuori dei sensi, «perciò Dio fu costretto a creare il mondo» per separare ciò che era stato mescolato.
– La seconda creazione: lo Spirito Vivente; la liberazione dell’Uomo Primordiale.
«L’Uomo Primordiale riprese coscienza e per sette volte rivolse al Padre della Grandezza una preghiera. Il Padre udì la sua preghiera e come seconda creazione produsse l’Amico delle Luci, e l’Amico delle Luci creò il Grande Architetto, e il Grande Architetto produsse lo Spirito Vivente. E lo Spirito Vivente produsse cinque figli [uno per ciascuna delle cinque nature spirituali di Dio; omettiamo i loro nomi]. Ed essi accorsero al Paese della Tenebra e dalla frontiera guardarono nell’abisso del profondo Inferno, dove scorsero l’Uomo Primordiale e i suoi cinque figli inghiottiti nella Tenebra. Allora lo Spirito Vivente chiamò a voce alta; e la voce dello Spirito Vivente fu come una spada affilata che mise a nudo la forma dell’Uomo Primordiale. E gli parlò:
‘Pace a te, o buono tra i cattivi,
essere luminoso tra quelli tenebrosi,
Dio che dimori tra bestie irose,
che non conoscono il suo onore’.
Al che l’Uomo Primordiale rispose dicendo:
‘Vieni per la pace di colui che è morto,
vieni, o tesoro di serenità e di pace!’.
e inoltre disse:
‘Come stanno i nostri Padri,
i Figli della Luce nella loro città?’.
E la Chiamata gli disse: ‘Stanno bene’. E Chiamata e Risposta si unirono l’uno all’altro e ascesero alla Madre di Vita e allo Spirito Vivente. E lo Spirito Vivente assunse la Chiamata e la Madre di vita assunse la Risposta, suo diletto Figlio. L’Uomo Primordiale fu liberato dalle sostanze demoniache dallo Spirito Vivente che discese e tese a lui la mano destra, e nell’ascesa divenne di nuovo un Dio. Ma lasciò dietro di sé l’Anima [perché queste particelle di Luce erano troppo strettamente unite a quelle della Tenebra]» (24).
L’«Anima» è perciò il potere che l’Uomo Primordiale, ormai liberato e ristabilito prima della creazione del mondo, ha abbandonato alla Materia. A causa di queste particelle perdute e completamente inabissate, il cosmo doveva essere creato come un grande meccanismo per la separazione della Luce. Per quanto riguarda la liberazione pretemporale dell’Uomo divino, essa ha per i Manichei un significato analogo a quello della risurrezione di Cristo per i Cristiani: non è semplicemente un avvenimento del passato (nella visione escatologica del tempo non c’è un «puro passato»), ma è l’archetipo simbolico e la garanzia efficace di ogni futura salvezza. Per il credente ha una realtà essenziale, perché nella sofferenza e redenzione è l’esemplare del proprio destino: non è senza motivo che questo Dio porta il nome «Uomo».
Perciò quello che nel tempo esterno del mito sembra un semplice episodio, non necessario per il suo progresso, anzi quasi interferendo con esso (poiché questo progresso si muove proprio sulla continuazione stessa dello stato di mescolanza), appartiene invece per il significato analogico interno all’attualità immediata della salvezza. A prova di ciò, oltre il richiamo umano frequente della scena mitologica, sta la cerimonia di vita quotidiana in cui i Manichei si mettevano in relazione con la liberazione archetipa dell’Uomo Primordiale ripetendo il gesto cruciale: «Per questo motivo i Manichei, quando si incontravano, si stringevano la mano destra uno con l’altro per significare che essi erano tra coloro che sono salvati dalla Tenebra» (Egemonio). «La prima ‘mano destra’ è quella che la Madre di Vita dette all’Uomo Primordiale quando stava per andare alla guerra. La seconda ‘mano destra’ è quella che lo Spirito Vivente dette all’Uomo Primordiale per condurlo fuori dalla guerra. Dall’immagine del mistero della mano destra ha avuto origine la stretta della mano destra in uso tra gli uomini» (Keph., p.p. 38, 20; 39, 20-22) (25).
Altra prova è la funzione che le due ipostasi Chiamata e Risposta (o anche, per quest’ultima, Ascolto) svolgono durante il processo storico della salvezza, e soprattutto nella consumazione finale alla fine del tempo. Riporteremo alla fine del capitolo i passi importanti dei “Kephalaia”, ma qui vogliamo citare l’eccellente osservazione del primo commentatore: «Con ciò il mito dell’ascesa dell’Uomo Primordiale con l’aiuto dello Spirito Vivente è messo in relazione con la salvezza alla fine del tempo come suo prototipo e condizione previa: la ‘Chiamata’ dello Spirito Vivente e l”Ascolto’ con cui l’Uomo Primordiale risponde ad essa sopravvivono nelle porzioni di Luce che egli abbandonò come disposizione e attitudine ad effettuare da se stesse il ritorno al regno della Luce alla fine del mondo» (26). Senza tale mistica «presenza», le molte «salvezze» precosmiche nella speculazione gnostica non sarebbero comprensibili (27).
– Creazione del macrocosmo.
Nella narrazione che segue della creazione possiamo tralasciare molti particolari mitologici che sono più fantastici che significativi. Come primo passo, lo Spirito Vivente e gli dèi a lui associati separano la «mescolanza» dalla massa principale della Tenebra. Quindi «il Re della Luce gli ordinò di creare il mondo formandolo con queste particelle mescolate, per liberare le particelle luminose da quelle tenebrose». Dopo di che gli Arconti che avevano incorporato la Luce (e perciò si erano indeboliti) sono vinti, e dalla loro pelle e carcassa sono formati il cielo e la terra. Sebbene si dica che gli Arconti sono imprigionati nel firmamento (tuttora legato alle loro pelli distese che formano i cieli), e sebbene d’altra parte si dica che terra e cielo sono stati formati dalla loro carne e dalle loro ossa, il seguito rende manifesto che con tutto ciò essi non hanno perduto la loro vita demoniaca né che la Tenebra in genere ha perduto il suo potere di azione. Ma il pessimismo manicheo ha inventato qui l’espressione immaginosa estrema di una visione negativa del mondo: tutte le parti della natura che ci circonda provengono dai cadaveri impuri dei poteri del male (28). Come dice brevemente un testo persiano-manicheo, «il mondo è un’incarnazione di Arci-Ahriman». Esso è anche una prigione per le potenze della Tenebra che sono ora confinate nel suo ambito; ed è anche un luogo di ri-purificazione dell’Anima:
«Egli ha sparso i poteri dell’Abisso nei dieci cieli e nelle otto terre, li ha chiusi in questo mondo [“cosmos”], ha fatto di esso una prigione per i poteri della Tenebra. Esso è anche un luogo di purificazione per l’Anima da loro inghiottita» (Salmo man. CCXXIII, 10, 25-29).
Dopo ciò, quella parte della Luce divorata che è meno macchiata viene estratta (29) dalla “Hyle”, purificata in «Luce» nel senso fisico, e dalla parte più pura di essa vengono formati il sole e la luna – i due «vascelli» – e dal resto le stelle. Così le stelle, ad eccezione dei pianeti che appartengono agli Arconti, sono «residui dell’Anima». Ma con tale organizzazione macrocosmica soltanto una piccola parte di Luce è salvata, «tutto il resto è ancora imprigionato, oppresso, contaminato», e i celesti ne fanno lamento.
– La terza creazione: il Messaggero.
«Allora la Madre della Vita, l’Uomo Primordiale e lo Spirito Vivente sorsero in preghiera e supplicarono il Padre della Grandezza: ‘Crea un nuovo dio e incaricalo di andare a vedere quella prigione sotterranea dei Demoni, e di costituire la rivoluzione annuale e la scorta protettiva per il sole e la luna, e di essere un salvatore e liberatore per quella luminosità degli dèi che dalle origini di tutte le cose è stata vinta da Ahriman, i Demoni [eccetera], e che tuttora è trattenuta prigioniera nei regni cosmici del cielo e della terra e ivi soffre, e di preparare per il vento, l’acqua e il fuoco una via e un cammino verso l’Altissimo’. E il Padre della Grandezza li ascoltò, e creò il Messaggero come terza creazione. Il Messaggero creò le dodici Vergini (personificazione delle virtù e delle proprietà divine, secondo i loro nomi), e con esse costruì una macchina con dodici recipienti» (30). Il Messaggero si recò ai vascelli della Luce, che fino ad allora erano stati stazionari, e li mise in movimento e iniziò la rivoluzione delle sfere. Codesta rivoluzione diviene il veicolo del processo “cosmico” della salvezza, in quanto distinto da quello che agisce attraverso la mente degli uomini, perché funziona come un meccanismo per la separazione e l’ascesa della Luce imprigionata nella natura.
– Origine delle piante e degli animali.
In principio il Messaggero tenta una via più breve: «Appena i vascelli si mossero e giunsero nel mezzo dei cieli, il Messaggero rivelò le sue forme, la maschile e la femminile, e fu visibile a tutti gli Arconti, i figli della Tenebra, maschi e femmine. Alla vista del Messaggero, che era di bella forma, tutti gli Arconti furono eccitati di concupiscenza per lui, quelli maschili per la sua forma femminile e quelli femminili per la sua apparenza maschile. E nella loro concupiscenza cominciarono a liberare la Luce dei cinque Dei Luminosi che essi avevano divorato» (Teodoro bar Konai). Strana maniera naturalistica di estrarre la Luce dai suoi catturatori, tema mitico che gli Gnostici prima di Mani avevano già incorporato nei loro sistemi (31). La Luce che fugge è ricevuta dagli angeli della Luce, purificata e caricata sui «vascelli» per essere trasportata nel suo regno nativo. Ma l’inganno fallace del Messaggero risulta a doppio taglio quanto al successo, perché insieme con la Luce e nella stessa quantità fugge dagli Arconti anche la sostanza della Tenebra («peccato») e, mescolata con la Luce, cerca di entrare nei vascelli del Messaggero. Accorgendosi di ciò, il Messaggero nasconde di nuovo la sua forma e, per quanto è possibile, separa la mescolanza sfuggita. Mentre le particelle pure salgono in alto, le particelle contaminate, ossia quelle troppo strettamente combinate col «peccato», cadono sulla terra ove quella sostanza mista forma il mondo vegetale. Perciò tutte le piante, «semi, erbe e tutte le radici e gli alberi sono creature della Tenebra, non di Dio, e la Divinità è incatenata in queste forme e generi di cose». Un’origine altrettanto miserabile, solo ancora peggiore, è attribuita al mondo animale, che proviene dagli aborti delle figlie della Tenebra alla vista del Messaggero e analogamente trattiene imprigionata la sostanza luminosa (32).
– Creazione di Adamo ed Eva.
Il breve svelarsi delle forme del Messaggero, oltre a condurre a questi nuovi generi di imprigionamento della Luce, ispirano anche alla Tenebra l’idea di un ultimo ed efficace mezzo per trattenere la preda minacciata, cioè legarla ad una forma maggiormente adeguata ad essa. Forma che viene suggerita dalla stessa forma divina che è stata vista (33). Prevedendo l’eventuale perdita di tutta la Luce per mezzo dell’effetto continuo di separazione delle rivoluzioni celesti; preso dall’ambizione di creare da se stesso qualche cosa di simile a ciò che aveva visto; pensando con questo mezzo di escogitare la prigione più sicura per la forza forestiera; e infine, desiderando di avere nel proprio mondo un sostituto della figura divina, altrimenti irraggiungibile, sul quale governare e per il quale poter essere talvolta liberato dalla compagnia odiosa della sua specie, il Re della Tenebra produce Adamo ed Eva ad immagine della forma gloriosa, e infonde in essi tutta la Luce rimasta a sua disposizione.
Codesta procreazione è descritta con particolari assai ripugnanti, con la copulazione dei demoni maschili e femminili, col divorare da parte del loro Re la progenie, “et cetera”. Il punto essenziale di dottrina in questa fantasia è che, mentre la genesi di piante e animali non era progettata, ma era il fallimento di una manovra tattica della Luce, la creazione dell’uomo è una contromanovra deliberata, anzi la grande contromanovra, della Tenebra contro la strategia della Luce. E usando la forma divina stessa per il proprio scopo, essa trasforma ingegnosamente la minaccia più pericolosa per il suo regno nella principale arma di difesa.
Ecco che cosa è diventata l’idea biblica dell’uomo creato ad immagine di Dio! L’«immagine» è diventata un’invenzione della Tenebra, e la copia non soltanto è in se stessa una specie di bestemmia, ma è anche un inganno diabolico contro l’originale. Perché tutte le fonti sono d’accordo in questo: siccome in genere lo scopo della Tenebra è la «non-separazione della Luce dalla Tenebra», così nella somiglianza della forma divina una parte “grande” di Luce poteva essere imprigionata come «anima» e trattenuta “in maniera più efficace” che in qualsiasi altra forma. Da ora in avanti la lotta tra Luce e Tenebra si concentra sull’uomo, che diviene la posta principale e nello stesso tempo il principale campo di battaglia delle due parti contendenti. In lui entrambe le parti hanno in gioco tutta la loro posta: la Luce quella della propria restaurazione, la Tenebra quella della propria sopravvivenza. Questo costituisce il centro metafisico della religione manichea, e innalza le gesta e il destino dell’uomo singolo ad un’importanza assoluta nella storia dell’esistenza intera.
Il corpo umano è di sostanza diabolica e – in tale caratteristica supera la deviazione generale dell’universo – di “disegno” diabolico. L’ostilità manichea verso il corpo e il sesso, con le sue conseguenze ascetiche, riceve con questo il suo fondamento mitologico. Tale ostilità e tale ascetismo hanno la loro base razionale nella visione gnostica della realtà, qualunque siano gli argomenti mitologici particolari; ma raramente essi sono stati così fortemente e inflessibilmente sostenuti come nel mito manicheo. Nel contesto di questo appoggio teoretico, il soffermarsi sui particolari repulsivi della generazione dell’uomo da parte dei demoni aggiunge un elemento nauseante ad una ostilità che altrimenti poggerebbe solo sul «razionale».
La creazione di Eva aveva uno scopo particolare. Essa è più completamente soggetta ai demoni, divenendo così il loro strumento contro Adamo; «ad essa infusero la loro concupiscenza per sedurre Adamo»: una seduzione non soltanto di concupiscenza carnale, ma per mezzo di questa un desiderio di riproduzione, l’invenzione più potente della strategia di Satana.
Perché non soltanto avrebbe prolungato indefinitamente la cattività della Luce, ma avrebbe anche disperso la Luce per mezzo della moltiplicazione così da rendere infinitamente più difficile l’opera di salvezza, la cui unica via consiste nel risvegliare ogni anima individuale. Per la Tenebra, dunque, tutto stava nella seduzione di Adamo, come per i Celesti nel suo risveglio in tempo per impedire la seduzione.
– Missione del Gesù Luminoso; il Gesù «patibilis».
«Quando i cinque angeli videro la Luce di Dio insozzata, implorarono il Messaggero della Buona Novella, la Madre della Luce e lo Spirito Vivente di mandare qualcuno a questa creatura primordiale per liberarla e salvarla, rivelarle la conoscenza e la giustizia, e renderla libera dai demoni. Così essi mandarono Gesù. Il Gesù Luminoso si avvicinò all’innocente Adamo…». Segue qui la descrizione della scena, di cui abbiamo dato il testo a p. 103 (in nero, cap. 2, n). Gesù compare qui come il dio che ha la missione di portare la rivelazione all'”uomo”, una ipostasi più particolare o emanazione del Messaggero, la cui missione era di essere inviato alla Luce prigioniera e precedeva la creazione dell’uomo. Il fatto che sia lui a spingere Adamo a mangiare dell’Albero della Conoscenza spiega l’accusa cristiana ai Manichei di aver uguagliato il Cristo al serpente del Paradiso (34). Per quanto riguarda il contenuto della sua rivelazione, la dottrina del «proprio io disperso in tutte le cose» richiede un commento. Essa esprime l’altro aspetto di questa figura divina: oltre ad essere la sorgente di ogni attività rivelatrice nella storia del genere umano, egli è la personificazione di tutta la Luce mescolata alla materia; ossia, egli è la forma sofferente dell’Uomo Primordiale. Questa interpretazione originale e profonda della figura di Cristo era un articolo importante della fede manichea ed è conosciuta come dottrina del “Gesù «patibilis»”, del Gesù patibile, il quale «pende da ogni albero», «è servito legato in ogni vivanda», «ogni giorno nasce, soffre e muore». E’ disperso in tutta la creazione, ma il suo regno più genuino e la sua incarnazione sono nel mondo vegetale, cioè nella forma di vita più passiva e la sola innocente (35). Tuttavia insieme a questo aspetto attivo della sua natura, egli è anche il “Nous” transmondano che, provenendo dall’alto, libera la sostanza prigioniera e fino alla fine del tempo la raccoglie, ossia raccoglie se stesso, dalla dispersione fisica. I vari aspetti di questo principio redento e redentore sono espressi magnificamente in un salmo:
«Vieni a me, mio congiunto, o Luce, mia guida…
Da quando sono entrato nella Tenebra mi fu data dell’acqua da bere… mi sforzo sotto un peso che non è mio proprio.
Sono nel mezzo dei nemici, bestie feroci mi circondano, il fardello che sopporto è quello delle potenze e dei principati.
Essi arsero nella loro rabbia, si levarono contro di me…
La Materia e i suoi figli mi divisero tra di loro, mi bruciarono nel loro fuoco, mi diedero un’amara somiglianza.
I forestieri coi quali mi sono mescolato, non mi conoscono; hanno provato la mia dolcezza, hanno desiderato di trattenermi con loro.
Ero vita per loro, ma essi erano morte per me; resistevo sotto di loro; mi indossarono come un vestito.
Io sono in tutte le cose, reggo i cieli, ne sono il fondamento, sostengo le terre, sono la Luce che brilla, che dà gioia alle anime.
Sono la vita del mondo: sono il latte che è in ogni albero: sono la dolce acqua che è sotto i figli della Materia…
Ho sopportato queste cose finché non ebbi adempiuto la volontà di mio Padre; l’Uomo Primordiale è mio Padre la cui volontà ho adempiuto.
Ecco, ho sottomesso la Tenebra; ecco, ho estinto il fuoco delle fonti; ecco come le Sfere ruotano in cerchi veloci, come il sole riceve la parte più pura della vita.
O anima, solleva i tuoi occhi verso l’alto e contempla la tua catena… ecco, i tuoi Padri ti chiamano.
Ora sali a bordo della Nave di Luce e ricevi la ghirlanda di gloria e torna al tuo regno e rallegrati con tutti gli Eoni»
(Salmo man. CCXLVI, 54,8 – 55,13).
La rivelazione di Gesù ad Adamo comprende un avvertimento affinché non s’avvicini a Eva. Adamo all’inizio obbedisce, ma in seguito con l’aiuto dei demoni è sedotto da lei, e comincia così la catena della riproduzione, la continuazione nel tempo del regno della Tenebra. Il che rende necessaria una storia temporale di rivelazione, che attraverso ripetizioni periodiche conduce tramite Budda, Zoroastro e il Gesù storico a Mani stesso e nella sua essenza rinnova continuamente la rivelazione originaria del Gesù Luminoso, adatta secondo il progresso storico della comprensione religiosa.
«Da eone ad eone gli apostoli di Dio non cessarono di portare quaggiù la Sapienza e le Opere. Così in una data epoca la loro venuta [cioè quella ‘della Sapienza e delle Opere’] si manifestò nelle regioni dell’India per mezzo dell’apostolo che fu Budda; in altra epoca, nella terra di Persia per mezzo di Zoroastro, in un’altra ancora, nella terra di Occidente, per mezzo di Gesù. Dopo ciò in quest’ultima epoca, codesta rivelazione discese e lo spirito di profezia per mezzo di me, Mani, l’apostolo del vero Dio, giunse nella terra di Babilonia» (36).
In questa missione profetica Mani riprende un antico insegnamento gnostico, più chiaramente esposto nelle Pseudo-Clementine, a proposito del «vero Messaggero che dall’inizio del mondo, mutando forma secondo i nomi che assume, vaga attraverso gli Eoni finché avrà raggiunto il suo tempo e, unto dalla grazia di Dio per il suo compito, arriverà al riposo eterno» (Homil. III, 20).
Se riflettiamo sulla cosmogonia, ci rendiamo conto delle seguenti divisioni. Tre «creazioni» vengono imposte alla divinità dall’aggressione della Tenebra e dalle sue conseguenze: quella dell’Uomo Primordiale per la battaglia e il sacrificio; quella dello Spirito Vivente (chiamato anche Demiurgo) per la liberazione del campione e, poiché questa rimane incompleta, per la costruzione dell’universo dalla sostanza frammischiata; quella del Messaggero (chiamata anche Terzo Messaggero) per mettere in moto l’universo e la liberazione della Luce incorporata in esso. Questa terza missione è contrastata dalla Tenebra con la creazione dell’uomo, che a sua volta necessita la missione del Gesù Luminoso presso Adamo. Per mezzo della seduzione di quest’ultimo e il fatto conseguente della riproduzione, il dramma e con esso la missione di «Gesù» sono prolungati nella storia dell’umanità. Questa storia del mondo nel senso più stretto della parola appartiene nell’insieme alla partizione della storia divina rappresentata dall’emanazione del Messaggero: sono le sue ipostasi mutevoli che agiscono come divinità della rivelazione nella storia religiosa umana, cioè «Gesù» presso Adamo all’inizio, il Paraclito presso Mani al culmine, e il Grande Pensiero alla fine apocalittica della storia. Ritorneremo in seguito all’ultimo atto apocalittico.
– Conclusioni pratiche; la moralità ascetica di Mani.
Le conclusioni pratiche ricavate da questo sistema cosmo-soteriologico sono estremamente ben definite, riassumendosi tutte in un rigoroso ascetismo. «Poiché la rovina della “Hyle” è decretata da Dio, bisogna astenersi da tutte le cose animate e mangiare soltanto vegetali e qualsiasi altra cosa non sensitiva, astenersi dal matrimonio, dalle gioie dell’amore e dalla generazione dei figli, in modo che la Potenza divina non rimanga lungamente nella “Hyle” per mezzo della successione delle generazioni. Tuttavia non è permesso commettere suicidio, allo scopo di aiutare l’attuazione della purificazione delle cose» (Alessandro). L’astinenza in materia di cibo è regolata da due punti di vista oltre che dall’atteggiamento ascetico generale: non incorporare senza necessità e quindi legare dell’altra sostanza di Luce; ed evitare almeno, poiché non è possibile evitarlo del tutto (anche le piante ne contengono), di “ferire” la Luce nella sua forma sensitiva negli animali (37). Inoltre, dal fatto che bisogna ridurre ad un minimo il contatto con la sostanza di Tenebra e non sentirsi a proprio agio in un mondo il cui scopo è promuovere la «separazione», ne deriva il comandamento di povertà, che comprende tra le altre cose la proibizione o il consiglio di non costruire una casa. Infine il pan-animismo, conseguenza dell’idea di mescolanza e affermazione della presenza della sostanza vulnerabile di Luce dappertutto (anche nella natura «inanimata»), porta all’idea di peccato più esagerata che sia mai stata concepita: «Quando qualcuno cammina sul terreno danneggia la terra [ossia, più precisamente, la Luce mescolata in essa]; colui che muove le mani fa danno all’aria, perché questa è l’anima di uomini e animali… [e così via]» (Egemonio). «S’addice all’uomo che guardi in terra quando cammina per la sua strada, nel timore di calpestare sotto i piedi la croce della Luce e distruggere le piante» (Keph., p. 208, 17).
Il peccato perciò è “ipso facto” implicito in tutte le azioni ed è inevitabile; è stato inventato come tale dalla Tenebra nel creare l’uomo, ma è pur sempre peccato e deve essere incluso in una confessione regolare (38). Tale concezione, volta in criterio pratico, genera un estremo quietismo che tende a ridurre l’attività come tale al minimo indispensabile.
Tuttavia il rigorismo così completo dell’etica manichea è riservato ad un gruppo speciale, gli «Eletti» o «Veri», che devono aver condotto una vita monastica di straordinario ascetismo, forse plasmata sul monasticismo buddista e che certamente ebbe una grande influenza sulla formazione del monacheismo cristiano. La gran massa dei credenti, chiamati «Auditori» o «Soldati», viveva nel mondo sotto regole meno rigide e tra le azioni meritorie c’era il mantenimento degli Eletti, che rendeva possibile la loro vita di santificazione. Vi erano dunque tre categorie di persone: gli Eletti, i Soldati e i peccatori, un evidente parallelo della triade dello gnosticismo cristiano formata di pneumatici, psichici e sarkici («uomini carnali»). Di conseguenza ci sono tre «vie» per le anime dopo la morte: gli Eletti vanno al «Paradiso della Luce»; i Soldati, i «guardiani della religione e sostenitori degli Eletti», devono ritornare «nel mondo e nei suoi terrori» così spesso e così a lungo «fintantoché la loro Luce e il loro spirito siano stati liberati e dopo molto vagabondare raggiungono l’adunanza degli Eletti»; i peccatori cadono in potere del Demonio e finiscono nell’Inferno (En-Nadim).
– La dottrina delle ultime realtà.
Perciò la storia del mondo e dell’uomo è un processo continuo di liberazione della Luce, e da questo punto di vista vengono considerati tutti gli assestamenti dell’universo come pure tutti gli eventi della storia. Strumenti di salvezza nella storia sono le vocazioni degli apostoli, i fondatori delle «chiese» (religioni), col loro effetto di risveglio, istruzione e santificazione. Strumento di salvezza dell’universo è la rivoluzione cosmica, in specie quella del sole che «circolando attorno ai cieli raccoglie coi suoi raggi i membri di Dio anche dai canali di scolo» (Agostino). Ossia il sole automaticamente, come processo di natura, estrae, attrae e purifica le particelle di Luce dalla Materia, e come una nave le trasporta nell’orbita dello Zodiaco, la cui rotazione le porta nel mondo della Luce (39). I due strumenti di salvezza si completano uno con l’altro: «La liberazione, separazione e ascesa delle particelle di Luce è favorita dalla lode, dalla santificazione, dalla parola pura e dalle opere pie. Perciò le particelle di Luce [ossia le anime dei morti] salgono per mezzo dell’aurora alla sfera della luna, e la luna le riceve di continuo dall’inizio alla metà del mese, cosicché cresce e diventa piena e quindi le guida al sole fino alla fine del mese; allora diminuisce perché viene alleggerita del suo carico. E in tal modo la nave-traghetto si carica e scarica incessantemente, e il sole trasmette la Luce alla Luce nel mondo della lode; il processo continua in quel mondo finché tutto arriva alla Luce suprema e pura. Il sole non cessa di operare così finché niente delle particelle di Luce rimane in questo mondo, tranne una piccola parte tanto strettamente legata che il sole e la luna non possono distaccarnela [questa sarà liberata dalla conflagrazione finale]» (40).
«Sempre più esiguo di giorno in giorno
diventa il numero di anime [sulla terra]
mentre ascendono purificate».
(Ephraem, v. Mitchell I, 109).
C’è qualcosa di innegabilmente grandioso in questa visione cosmica, e per i Manichei era così convincente che potevano dire: «Tutto ciò è evidente anche per un cieco» (Alessandro). Noi non saremo facilmente convinti, ma possiamo essere disposti ad ammettere che l’immagine di una luna crescente e decrescente per un carico di anime, di un sole che separa e purifica di continuo la Luce divina, di uno Zodiaco simile ad una ruota d’acqua che continuamente attinge e trasporta in alto, ha un grande fascino e attribuisce all’ordine dell’universo un significato religioso che manca alle sinistre «sfere» di altri sistemi gnostici.
Così nel susseguirsi dei tempi, delle chiamate e delle rivoluzioni, «tutte le particelle di Luce ascendono incessantemente e salgono alla sommità, mentre le particelle di Tenebra discendono e affondano nel profondo, finché le une sono liberate dalle altre e la mescolanza si annulla; i componenti si scompongono e ciascuno raggiunge la sua totalità e il suo mondo. Questa è la risurrezione e la restaurazione» (Shahrastani). Compiuto ciò fino al residuo più intimamente mescolato, allora «il Messaggero manifesta la sua immagine e l’angelo che sostiene la terra getta via il suo fardello e il gran fuoco dall’esterno del cosmo scoppia e consuma l’intero mondo e non cessa di bruciare finché ciò che ancora rimane di Luce nella creazione è liberato» (compilato da Egemonio [= Epifanio] e En-Nadim).
L’apocalisse finale di ciò che le precedenti citazioni hanno definito sommariamente «il Messaggero» (41) è descritta con maggiori particolari in due passi dei “Kephalaia” (cap. 5, 16), il primo intitolato «Sui quattro Cacciatori della Luce e i quattro della Tenebra», dove il quarto ed ultimo Cacciatore (o Pescatore) della Luce (42) è chiamato «il Grande Pensiero»; a questi si aggiunge un passo dal Libro dei Salmi che fornisce un’appropriata conclusione.
«Alla fine, quando il cosmo è dissolto, lo stesso Pensiero di Vita si riunirà e formerà la sua Anima [cioè il suo io] nelle sembianze dell’Ultima Statua. La sua rete è lo Spirito Vivente, perché col suo Spirito si impadronirà della Luce e della Vita che è in tutte le cose e ne formerà il suo corpo.
La Chiamata e l’Ascolto, il Grande Pensiero, che è venuto agli elementi frammischiati… ed è stato là in silenzio… fino a quel tempo… in cui si risveglia e prende posto nel grande fuoco raccogliendo in se stesso la sua Anima e formando se stesso nella forma dell’Ultima Statua. E lo troverai che spazza via da sé e getta via l’impurità che gli è estranea, ma raccoglie per sé la Vita e la Luce che sono in tutte le cose, per costruire il suo corpo. Poi quando quest’Ultima Statua è perfetta in tutti i suoi membri fuggirà e sarà tirata fuori da quella grande lotta per mezzo dello Spirito Vivente, suo padre, che viene… per portare fuori i membri dalla… dispersione e dalla fine di tutte le cose».
«E’ (43) il consiglio di morte, tutta la Tenebra, sarà raccolta da lui per formarne una sembianza di se stesso…
Improvvisamente lo Spirito Vivente verrà… egli porterà soccorso alla Luce. Ma il consiglio di morte e la Tenebra saranno rinchiusi da lui nell’abitazione stabilita per essi, di modo che saranno legati per sempre.
Non c’è altro mezzo di legare il Nemico tranne questo; perché non può essere accolto dalla Luce essendo un estraneo per essa; né può essere lasciato nella terra della Tenebra, affinché non possa tentare una guerra maggiore della prima.
Un nuovo Eone sarà formato al posto del mondo che si dissolverà, affinché in esso possano regnare i poteri della Luce, avendo essi eseguito e adempiuto interamente la volontà del Padre, sottomesso colui che è odioso… Questa è la Dottrina di Mani, adoriamolo e benediciamolo».
Così, mentre talvolta si può dire della condizione finale che «le due nature sono ristabilite e gli Arconti abiteranno d’ora in avanti nelle loro regioni inferiori, ma il Padre nelle regioni superiori dopo aver ripreso in se stesso ciò che gli appartiene» (Egemonio), l’idea reale è che il potere della Tenebra, sebbene non la Tenebra in se stessa, sarà distrutto per sempre e in contrasto con la lotta feroce del principio giacerà ora in una tranquillità di morte. Il sacrificio iniziale della Luce ha trovato la sua ricompensa e raggiunto il suo scopo percorrendo una lunga strada: «La Luce d’ora in poi è al sicuro dalla Tenebra e da ogni danno da parte sua» (En-Nadim).
c) Ricapitolazione: due tipi di dualismo nella speculazione gnostica.
Dopo questo lungo viaggio attraverso il labirinto del pensiero gnostico e la fantasmagoria che può aver fatto perdere di vista al lettore i contorni principali del paesaggio, egli accoglierà volentieri una ricapitolazione di alcuni punti di vista di orientamento generale, anche a prezzo di qualche necessaria ripetizione.
Gli Gnostici furono i primi «teologi» speculativi della nuova età della religione che rimpiazzava l’antichità classica. Il loro compito era stabilito dall’esperienza gnostica fondamentale che comportava una visione generale della realtà esistente in certo modo “a priori”, valida per coloro che partecipavano di tale esperienza. Questa visione comportava come princìpi fondamentali le idee di un universo antidivino, dell’estraneità dell’uomo all’interno di esso e della natura acosmica della divinità. La realtà essendo quella che è, presuppone una storia durante la quale ha assunto la sua presente condizione «innaturale». Il compito della speculazione era quello di narrare codesta storia, ossia di rendere ragione del presente stato di cose riferendo gli stadi successivi della sua genesi dai primi inizi, quindi di sollevare la visione della realtà nella luce della gnosi e dare fondata assicurazione di salvezza. L’esecuzione era invariabilmente mitologica; ma i simboli che ne risultano, con le loro personificazioni, ipostasi e narrativa quasi cronologica, sono simboli della teoria metafisica coscientemente costruiti.
I due tipi di sistemi, chiamati qui per brevità (e senza debito riferimento ad una teoria genetica effettiva) il tipo iranico e il tipo siriaco, si svilupparono per spiegare in sostanza gli stessi fatti di una condizione metafisica anormale, entrambi «dualistici» per quanto riguarda il loro comune risultato: la frattura esistente tra Dio e il mondo, tra il mondo e l’uomo, tra lo spirito e la carne.
Il tipo iranico, in un adattamento della dottrina zoroastriana che parte dal dualismo di due opposti princìpi, si applica soprattutto a spiegare come la Tenebra originaria abbia potuto assorbire elementi di Luce: ossia descrive il dramma del mondo come una guerra dall’alterna fortuna e il fato divino, di cui l’uomo è parte e il mondo una conseguenza involontaria, nei termini di mescolanza e separazione, prigionia e liberazione.
La speculazione siriaca intraprende il compito più ambizioso di far derivare il dualismo stesso, e la conseguente situazione del divino nel sistema di creazione, dall’unica e indivisa fonte dell’essere, per mezzo di una genealogia di stati divini personificati che si evolvono l’uno dall’altro e descrivono il progressivo oscuramento della Luce originaria in categorie di colpa, errore e fallimento. Questa interna «involuzione» divina termina nella decadenza completa dell’alienazione di sé che è questo mondo.
Entrambi i drammi s’iniziano con una perturbazione nelle altezze; in entrambi l’esistenza del mondo segna una sconfitta del divino e un mezzo necessario, non desiderabile in se stesso, della sua futura restaurazione; in entrambi la salvezza dell’uomo è quella della stessa divinità. La differenza sta in questo che la tragedia della divinità è imposta ad essa dall’esterno, con la Tenebra che ne ha la prima iniziativa, oppure è motivata dal suo interno stesso, con la Tenebra come prodotto della sua passione, non come sua causa. Alla sconfitta e al sacrificio divino in un caso, corrisponde la colpa e l’errore nell’altro; alla compassione per la Luce resa vittima, il disprezzo spirituale per la cecità demiurgica; alla futura liberazione divina, corrisponde la rinascita per mezzo dell’illuminazione.
La nostra suddivisione è tipologica e perciò non prende in considerazione ciò che proviene dai richiami geografici ed etnici dei nomi scelti per essa. I sistemi valentiniano e manicheo esemplificano i due tipi. La differenza di princìpi speculativi significa, sul fondamento gnostico comune, una differenza importante nell’atteggiamento religioso; e mentre il tipo iranico permette una drammatizzazione più concreta e cattivante, il tipo siriano è più profondo e solo tra i due, accordando uno stato metafisico alla conoscenza e all’ignoranza, come modalità della stessa vita divina, può rendere piena giustizia alla pretesa redentiva risolta a favore della conoscenza in tutta la religione gnostica.
NOTE AL CAPITOLO 8.
1. Della sua larghezza di vedute sotto questo aspetto i “Kephalaia” copti mostrano un chiaro esempio in un bel passo. Parlando dei suoi predecessori, o delle «Chiese scelte» da essi, Mani introduce la similitudine dei messaggeri reali: «Le regioni e le lingue dove sono mandati sono differenti una dall’altra, l’una non è simile all’altra. Così è anche per il Potere glorioso che invia fuori di sé tutti gli apostoli: le rivelazioni e la sapienza che ha dato loro, le ha date in forme differenti, cioè l’una non è uguale all’altra, perché le lingue a cui sono mandati non rassomigliano l’una all’altra» (Keph. cap. 154).
2. Come ha fatto Maometto dopo di lui e il “Libro di Baruch” gnostico prima di lui, quest’ultimo con una tetrade di rivelazioni storiche, differente però da quella riconosciuta da Mani (Gesù è l’unico membro della serie comune ad entrambi: JONAS, “Gnosis”, p. 285, n. 1). L’omissione di Mosè e dei profeti nella lista di autentici «Apostoli» di Mani non è naturalmente accidentale.
3. La condizione del manoscritto non permette di identificare l’evento durante il regno di Ardashir, data riferita come quella della vocazione.
4. Confronta WEST, “Pahlavi Texts”, III, p. 234. Nella breve esposizione della dottrina usata nei catechismi, questa divisione appare sotto titoli come «la dottrina dei tre tempi», o «dei tre giorni», o «dei tre momenti» come nell’esempio seguente: «Poiché abbiamo imparato a conoscere il vero Dio e la sacra dottrina, conosciamo… la dottrina dei tre tempi;… conosciamo (1) ciò che si dice sia stato prima che fosse la terra e il cielo; conosciamo (2) perché Dio e Satana combatterono, come la Luce e la Tenebra si mescolarono e chi si dice che abbia creato la terra e il cielo; conosciamo inoltre (3) perché infine la terra e il cielo passeranno e come la Luce e la Tenebra saranno separate l’una dall’altra, e ciò che avverrà in seguito» (“Chuastuanift”, ed. Bang, p. 157).
5. «Nature»: anche «princìpi», «sostanze», «esseri», «radici». Nelle Gatha di Zoroastro, che han servito qui come modello, erano chiamati «i due spiriti iniziali» e «gemelli». «Bene e male»: anche «luce e tenebra», «Dio e materia».
6. Ved. la spiegazione nel Glossario. Nelle fonti non siriache sono chiamati «membri di Dio», anche «potenze» ed «eoni».
7. Confronta la dottrina più antica dei Setiani: «La Tenebra tuttavia non è senza comprensione ma conosce e sa che se la Luce si allontanasse dalla Tenebra, questa sarebbe lasciata sterile, oscura, impotente, inerte, debole. Perciò essa esercita tutta la sua arte e intelligenza per trattenere a forza la Luce [eccetera]» (Hippol., “Refut.” V, 19, 6).
8. Una formula cristiana di abiura cita come manicheo l’insegnamento che «il Demonio è stato creato dal mondo della tenebra» e oppone a questo come insegnamento della Chiesa che «egli fu creato angelo buono da Dio e cambiato in seguito per la sua stessa perversità» (Anathema XI di Milano, circa 600 d.C.).
9. Severo (Omilia 123), trattando dell’insegnamento di Mani che «l’Albero della Vita» (il mondo della Luce) nasconde per prudenza i suoi «frutti» (la sua luce e bontà) e li racchiude nella sua gloria «in modo da non dare occasione al desiderio dell’Albero del Male», obietta secondo lo spirito platonico che sarebbe stato più confacente alla bontà di Dio di trasformare la Materia cattiva lasciandola partecipare alla sua natura superiore, e che Dio potrebbe giustamente essere accusato di gelosia per il fatto di nascondere se stesso anziché attirare col suo splendore il suo nemico verso il bene. Tuttavia il resoconto di Severo suggerisce che il nascondimento della Luce può essere stato dettato dalla carità come dalla prudenza, perché l’affermazione circa «il non fornire occasione» continua dicendo «per timore che ciò potesse divenire per l’albero cattivo motivo di eccitamento, tormento e pericolo». Di fatto, poiché la Tenebra, incapace di riforma secondo le idee manichee, non può trarre profitto dalla visione della Luce, l’alternativa di Severo riguardo alla condotta del Dio buono non ha senso e il vero punto in questione tra Cristiani e Manichei non è la natura della bontà divina, ma precisamente l’idea che il male è senza redenzione per l’eternità.
10. Basilide verso il 140 d.C. cita come una dottrina esistente prima di lui che «ci sono due princìpi di tutte le cose, a cui essi [i pensatori in questione] attribuiscono il bene e il male… Finché questi se ne stettero per conto loro, ciascuno di loro condusse la propria vita… Tuttavia, dopo che giunsero a percepirsi uno con l’altro e la Tenebra contemplò la Luce, essa fu presa dal desiderio del meglio e inseguì la Luce e desiderò unirsi ad essa e aver parte di essa». Ne segue un rapimento di particelle di Luce, o meglio, di un riflesso e immagine della Luce (v. sopra, cap. 6, p. 178 in nero), e la formazione del mondo con l’aiuto di questa preda (Hegemonius 67).
11. Egli perciò ha fatto un uso speculativo dell’idea, forse diffusa prima di lui e naturale conseguenza della vecchia concezione di un caos primordiale che è stato spiritualizzato, che la Tenebra è in continuo tumulto di guerra interna. Confronta il passo mandeo: «Il Re di questo Eone cinse una spada e una corona di tenebra… Egli prese una spada nella mano destra, egli sta là e uccide i suoi figli, e i suoi figli si uccidono uno con l’altro», che contrasta con l’altro: «Il Re dell’al di la dei mondi cinse una corona di luce… Egli prese il Kushta nella destra, egli sta là istruisce i suoi figli, … e i suoi figli si istruiscono uno con l’altro» (J 55).
12. Confronta di nuovo un parallelo mandeo: «Il Re della Tenebra vide il mondo della Luce da lontano ai confini tra Tenebra e Luce, come un fuoco sulla sommità di alte montagne, come stelle che brillano nel firmamento… Egli meditò nel suo cuore, provò rabbia… e disse: «Se c’è un tale mondo, che cosa è per me questa abitazione di tenebre?… Salirò a quella terra luminosa e farò guerra al suo Re’» (G 279).
13. Tuttavia, nel primo Salmo di Tommaso, un discepolo di Mani, leggiamo: «Dove li ha visti il Figlio del Male – il povero che non ha niente, non ricchezze nel suo tesoro, non Eternità in suo possesso? Egli si alzò e disse: ‘Potessi essere come uno di loro’» (Libro dei Salmi mandeo, p. 203, 25 s.s.; la frase «potessi essere come uno di loro» è ripetuta continuamente).
14. Sunteggiato da Severo e Teodoreto.
15. Il greco Simplicio a questo punto dirige il rimprovero di vigliaccheria contro il Dio manicheo (v. sotto, nota 23). Senza condividere l’accusa si può far notare che c’è almeno una certa verità nell’idea che la Luce non può affrontare la Tenebra, o lo spirito della forza bruta, con le proprie armi, e può prevalere contro di essa solo indirettamente.
16. Confronta Salmo mandeo CCXIX: «Il Guerriero, il forte dalle molteplici attività, che sottomise i ribelli col suo potere, nostro Padre, il Primo Uomo di gloria» (1, 125 s.).
17. Confronta Salmo mandeo CCXXIII: «C’era una moltitudine di angeli nella Terra della Luce, che avevano il potere di andare a sottomettere il nemico del Padre, al quale piacque [tuttavia] di sottomettere i ribelli per mezzo della sua Parola che egli avrebbe mandato» (9, 26-29).
18. Sunteggiato da Teodoro bar Konai e En-Nadim.
19. Iren. I, 12, 4: analogamente gli Ofiti (ibid. 30, 1), i Naasseni di Ippolito, e l'”Apocrifo di Giovanni”.
20. Sunteggiato da Teodoro bar Konai e En-Nadim. Vedere anche la drammatica versione del “Chuastuanift”, cap. 1: «Dio e Demonio, Luce e Tenebra, erano mescolati a quel tempo. Le scorte di Ormuzd, i Cinque Dei, [cioè] le nostre anime, combatterono per un poco con i Demoni e furono oltraggiate e ferite. E mescolandosi con la malvagità del Signore di tutti i Demoni e del Demonio insaziabile, svergognato, della Cupidigia… [e così via], esse furono private di pensiero e sentimento: [esse], che sono nate da se stesse e originate da se stesse dimenticarono completamente la terra eterna degli Dei e furono separate dagli Dei della Luce».
21. ANDREAS-HENNING, p. 179.
22. Severo: «come un allettamento di adulazione e inganno».
23. Sunteggiato da Alessandro e Tito; confronta il resoconto di Severo: «E a causa di questo attacco che era preparato dalla Profondità contro la Terra della Luce, una parte della Luce dovette mescolarsi a quelle [sostanze] malvage, affinché per mezzo della mescolanza i nemici fossero incatenati, la calma tornasse tra i Buoni e la natura del Bene fosse conservata». A questa parte della dottrina si riferisce la critica del neoplatonico Simplicio: «Essi hanno fatto sì che Dio fosse disprezzabile, perché quando il Male venne in vicinanza dei suoi confini egli ebbe timore che potessero invadere il suo territorio, e per questa vigliaccheria egli ingiustamente e inadeguatamente gettò al potere malvagio le anime, parti e membra di se stesso, che non avevano fatto del male, per poter salvare il rimanente degli esseri buoni» (In Encheir. Epict. 27).
24. Compilato da Teodoro bar Konai, Egemonio e En-Nadim.
25. Confronta anche Epiph., “Haer.” 66, 25, 7-8. La stretta di mano è stata in uso nell’antichità come atto simbolico in certe occasioni legali (conclusione di contratti), ma non come saluto. Anche in Gal. 2, 9, «porgere la destra in segno di società» sigilla un patto (tra gli apostoli, riguardo alla missione tra Gentili e Giudei rispettivamente). Il saluto tra i primi cristiani era il bacio di fratellanza, che cessò di essere praticato relativamente presto. Se la stretta di mano come forma di saluto si sia diffusa tra i popoli dell’Europa e del Medio Oriente per un’abitudine manichea o cristiana, non sono in grado di dire, tranne che gli “Acta Archelai”, uno scritto cristiano del principio del quarto secolo (citati qui come «Hegemonius») fanno notare che era una caratteristica manichea. Era condivisa dai Mandei; v. Glossario alla fine del cap. 2: «Kushta», «passare Kushta», fino ad oggi presso di loro parte del rito battesimale.
26. H. J. Polotsky in C. SCHMIDT und H. J. POLOTSKY, “Ein Mani-Fund in Ägypten”, Sitzungsberichte d. Preuss. Akad., 1933, vol. 1, p. 80.
27. Il significato archetipico dell’episodio precosmico è chiaramente affermato, per esempio nel “Libro di Baruch”, dove è detto dell’«Elohim» riabilitato dopo la sua separazione dall’Eden, ossia dalla Natura inferiore, che «ascendendo a colui che è Buono egli ha mostrato il cammino a tutti coloro che desiderano ugualmente ascendere» (Hippol., “Refut.” V, 27).
28. Confronta CUMONT, “Recherches”, p. 26 s.
29. Per uno strano stratagemma che descriveremo quando si presenterà di nuovo in seguito.
30. Lo Zodiaco, visto come una «ruota d’acqua». Tutto il passo è compilato da Teodoro bar Konai, Egemonio, e da un frammento di Turfan che fornisce il testo della preghiera (ANDREAS-HENNING, p. 179 s.).
31. Per il materiale completo riguardo all’origine e all’uso gnostico di questa mitologia, vedi l’Appendice «La séduction des Archontes», in CUMONT, “Recherches”, p. 54 s.s.
32. Le fonti di questo paragrafo sono Teodoro bar Konai e Agostino.
33. Ancora un tema gnostico molto diffuso: la contraffazione del divino da parte degli Arconti.
34. Confronta a questo riguardo la sezione «Allegoria gnostica», par. o del cap. 2.
35. «Che cosa è ‘l’anima che è massacrata, venendo uccisa, oppressa, assassinata nel nemico’? Ciò che è stato chiamato ‘l’anima massacrata, oppressa, uccisa, assassinata è la forza [vita] dei frutti, cetrioli e semi, che sono battuti, strappati, fatti a pezzi e dati in nutrimento ai mondi della carne. Anche il legno, quando è seccato, e la veste, quando diventa vecchia, moriranno: anch’essi sono parte della totalità dell”anima massacrata, uccisa’» (Kephal., p.p. 176, 23; 178, 5 s.s.).
36. Dal «Shahpurakan» di Mani, citato nella “Cronologia” di Al-Biruni. Quando anche Mani si chiama «l’apostolo di Gesù Cristo», lo fa nel senso in cui anche il Gesù storico era apostolo, ossia dell’eterna «Luce-Gesù», e non implica subordinazione alcuna al predecessore, né nella persona, né nel messaggio, né nella condizione della Chiesa «eletta». Sotto questi due ultimi aspetti Mani al contrario pretende la superiorità della forma conclusiva e più universale.
37. La condizione «ferita» dell’«anima» nella creazione fisica, che risale, in ultima analisi, alla lotta primordiale, spiega il frequente appellativo di Gesù «il Medico dei feriti» nei salmi manichei.
38. Il “Chuastuanift”, un manuale di confessione, ricava in modo sistematico questa categoria di peccato dalla dottrina cosmogonica. Dopo aver prima riferito il fato dei «Cinque Dei», i figli dell’Uomo Primordiale, enumera i tipi di peccati provocati da questa condizione fondamentale: con le dita e con i denti, col mangiare e bere; in rapporto alla terra, alle piante e agli animali. I differenti atti sono chiamati «frattura», «violazione», «danno», «travaglio» dei Cinque Dei. Nel formulario della confessione leggiamo: «Signore! Siamo pieni di difetti e di peccati, siamo profondamente colpevoli: a causa del demone insaziabile e vergognoso della cupidigia noi sempre e di continuo, in pensieri, parole e opere, vedendo coi nostri occhi, udendo con le nostre orecchie, parlando con le nostre bocche, toccando con le nostre mani, camminando coi nostri piedi, tormentiamo la Luce dei Cinque Dei, la terra asciutta e umida, le cinque specie di animali, le cinque specie di erbe e alberi» (cap. 15).
39. I particolari «astronomici» della concezione sono elaborati diversamente nelle fonti, e, fatta eccezione per la funzione della luna, non hanno qui interesse particolare.
40. Compilato seguendo Shahrastani, En-Nadim e Egemonio.
41. Secondo l’emendazione convincente di “presbytes” in “presbeutes” in Act. Arch. 13, ed Epiph., “Haer.” 66, 31 (et al.) (Flügel, Bousset, Cumont).
42. I tre precedenti Cacciatori della Luce: il primo è l’Uomo Primordiale, la sua «rete» l’Anima stesa su tutti i Figli delle Tenebre (v. sopra, p. 237 s.s. in nero), il «mare» la Terra della Tenebra (confronta p. 134 in nero); il secondo Cacciatore è il Terzo Messaggero, la sua «rete» la sua forma di Luce che ha mostrato alla Profondità e con la quale ha allacciato la Luce in tutte le cose, la sua «nave» il sole (v. sopra p. 241 in nero), il terzo Cacciatore è la Luce-Gesù, la sua «rete» la Sapienza della Luce con cui allaccia le anime, la sua «nave» la Santa Chiesa (o piuttosto le Chiese, v. sopra, p. 246 in nero).
43. Da qui avanti Ps. CCXXIII, 11, 10s.s.; le due linee che precedono dicono: «Tutta la Vita, le vestigia della Luce dovunque siano, egli raccoglierà a sé e con questo formerà un’immagine» (“andrías”, tradotto sopra con «statua»), che chiaramente collega questo passo con quello dei “Kephalaia”.
Parte terza.
GNOSTICISMO E PENSIERO CLASSICO.
Fin qui abbiamo considerato il mondo gnostico delle idee in se stesso, facendo solo riferimenti occasionali allo sfondo culturale sul quale si staglia. Abbiamo fatto cenno delle sue relazioni con gli ambienti ebraico e cristiano, quest’ultimo, anch’esso, un nuovo venuto nel mondo della civiltà greco-romana. Non ortodosso e sovversivo com’era lo gnosticismo in rapporto a questi sistemi di pensiero più simili, il suo carattere rivoluzionario viene pienamente in luce solamente in un confronto col mondo “classico-pagano” di idee e di valori col quale si scontrò frontalmente. Questo mondo, come abbiamo sottolineato nel capitolo introduttivo, rappresentava nella sua versione ellenistica la cultura cosmopolita e secolare dell’epoca, che aveva alle spalle una storia lunga e imponente. Paragonato ad esso, il movimento gnostico, oltre ad essere un estraneo, era un “parvenu” senza parentela legittima: di quel tanto di eredità che gli proveniva dai suoi numerosi antecedenti orientali, fece un uso tanto libero fino al punto di sovvertirne il significato. Basta questo soltanto a testimoniare il suo essere non-tradizionale. Così il vero fondamento della sua novità nel quadro della storia universale è fornito dal più vasto mondo nel quale emerse ed ai cui atteggiamenti mentali e morali di lunga data sembrò formare un’antitesi quasi intenzionale. Quegli atteggiamenti erano sostenuti da una tradizione ideologica, greca in origine, venerabile per le sue realizzazioni intellettuali, che agirono come grande fattore di conservazione in un’epoca di crescente tensione spirituale e di minacciosa dissoluzione. La sfida gnostica era un’espressione della crisi cui la cultura generale era soggetta. Comprendere lo gnosticismo come una sfida di tal fatta significa comprenderne l’essenza. Per certo, le intuizioni che il suo messaggio aveva diffuso per la prima volta hanno una loro ragion d’essere. Ma senza la contrapposizione ellenistica sulla quale irruppe, lo gnosticismo non avrebbe avuto quell’importanza nella storia del mondo delle idee che esso assunse sia per configurazione storica sia per contenuto intrinseco. L’importanza di ciò che esso sfidò è un segno certo della sua statura storica. E il suo essere «primo» e «differente» con quelle intuizioni, permeato della consapevolezza della sua novità, dà una particolare colorazione alle sue vedute non meno che alla loro formulazione.
Il raffronto che segue, ponendo lo gnosticismo nel quadro contemporaneo che gli è proprio, mostrerà con maggiore chiarezza ciò che in esso era nuovo, che cosa sfidò e che cosa ha rappresentato nella storia della conoscenza che l’uomo ha di sé.
Capitolo 9.
IL COSMO NELLA CONCEZIONE GRECA E GNOSTICA.
a) L’idea di «cosmo» e la posizione dell’uomo in esso.
– La posizione greca.
Nel paragonare i due mondi, il nuovo e l’antico, l’attaccante e l’attaccato, non c’è simbolo più significativo nel quale si riveli l’essenza di ciascuno che il concetto di «cosmo». Per lunga tradizione questo termine aveva assunto nel pensiero greco la più alta dignità religiosa. La parola stessa nel suo significato letterale esprime una valutazione positiva dell’oggetto – qualsiasi oggetto – a cui si riferisce come termine descrittivo. Perché “cosmos” significa «ordine» in generale, sia del mondo che di una famiglia, di uno stato o di una vita: è un termine di lode e persino di ammirazione. Così quando è applicato all’universo e viene attribuito ad esso come all’esemplare più importante, non significa semplicemente il fatto neutro di tutto ciò che è, una somma quantitativa (com’è il caso del termine «il Tutto»), ma esprime una qualità specifica, e, per la mentalità greca, nobilitante di questo tutto: che è ordine. E sebbene l’attribuzione del termine divenisse col tempo indissolubilmente legata all’universo, soprattutto perché la forma enfatica «”il” cosmo» non poteva denotare che l’universo, tuttavia non giunse mai a monopolizzare il significato della parola e ad eliminare gli altri usi (1). Se così fosse stato, il nome, isolato dal suo ambito semantico originale, sarebbe decaduto all’indifferenza della parola «mondo». Tale fato non toccò mai al «cosmo». Molteplici applicazioni ad oggetti e situazioni della vita quotidiana – applicazioni che si estendevano dal generale al particolare, dal morale all’ascetico, dall’interiore all’esteriore, dalla qualità materiale a quella spirituale – rimasero in uso accanto a quello supremo, e tale compresenza di significati familiari, tutti laudativi, aiutarono a tener viva la consapevolezza del valore che aveva fatto scegliere un nome così qualificativo per il più vasto e in un certo senso più remoto di tutti gli oggetti.
Ma oltre che essere l’esempio più vasto, l’universo era considerato il più perfetto esemplare di ordine e nello stesso tempo la causa di ogni ordine riscontrato nelle realtà particolari, che soltanto in gradi diversi si avvicinano a quello del tutto. Inoltre, poiché l’aspetto sensibile dell’ordine, la sua principale ragione interna è la bellezza, il Tutto in quanto ordine perfetto deve possedere bellezza e razionalità al massimo grado. In verità, questo universo fisico circoscritto, indicato dal nome «cosmo», era considerato un’entità divina e spesso chiamato addirittura dio, e infine persino “il” Dio. Come tale era naturalmente più di un sistema fisico, nel senso in cui intendiamo ora il termine «fisico». Come i poteri generativi, creatori di vita della natura, segnalano la presenza dell’anima, e la regolarità eterna e l’armonia dei moti celesti rivela l’azione di una mente ordinatrice, così il mondo deve essere considerato un tutto animato e intelligente e persino saggio. Già Platone, sebbene non considerasse il cosmo come lo stesso essere supremo, lo chiamava l’essere sensibile più alto, «un dio» e «in verità una creatura vivente con anima e ragione» (2). E’ superiore all’uomo, che non è nemmeno la cosa migliore del mondo: i corpi celesti sono migliori di esso, sia per la sostanza che per la purezza e fermezza dell’intelligenza che attiva i loro moti (3).
Il monismo stoico portò all’identificazione completa del cosmico e del divino, dell’universo e di Dio. Cicerone nel secondo libro del “De natura deorum” esprime eloquentemente questa dignità teologica dell’universo visibile. Poiché la sua argomentazione, che riunisce elementi tratti da fonti stoiche, è grandemente istruttiva, la citiamo quasi per intero, indicando i punti principali di sviluppo logico mediante titoli esplicativi.
(Affermazione generale)
«C’è allora una natura [il calore] che tiene unito e sostiene l’universo, e possiede sensibilità e ragione. Perché tutto quello che non è separato e semplice ma unito e connesso con altre cose deve avere in sé un qualche principio reggitore. Nell’uomo è la mente, nelle bestie qualche cosa di simile alla mente [il senso] da cui sorgono gli appetiti… In ciascuna classe di realtà niente può essere o dovrebbe essere più eccellente di questo principio governante. Di qui deriva che quell’elemento in cui ha sede il principio governatore della Natura come un tutto deve essere il migliore di tutte le realtà e il più degno di potere e dominio su tutte le cose. Ora noi vediamo che in alcune parti del cosmo – e non c’è niente in nessun posto del cosmo che non sia una “parte del tutto” – risiedono sensibilità e ragione. Perciò in quella parte dove risiede il principio governatore del cosmo, devono essere presenti per necessità quelle stesse qualità, soltanto più intensamente e in scala maggiore. Quindi il cosmo deve essere anche saggio, perché quella sostanza che circonda e tiene tutte le cose deve eccellere per la perfezione della ragione; e ciò significa che il cosmo è Dio e che tutti i suoi poteri particolari sono compresi nella natura divina…
(Argomenti speciali: a. Sensibilità e anima)
«Visto che gli uomini e gli animali sono resi vivi da questo calore e che per la sua azione si muovono e sentono, è assurdo dire che il cosmo è privo di sensibilità, esso che è vivificato da un calore che è intero, libero e puro ed anche sottilissimo ed agile… Poiché quel calore non è mosso da un impulso esterno ma spontaneamente da se stesso [e poiché secondo Platone l’automobilità è soltanto dell’anima], la conclusione è che il cosmo è animato.
(b. Intelligenza)
«Quindi, che il cosmo sia dotato di intelligenza è anche evidente dalla considerazione che il cosmo [come il tutto] deve essere superiore ad ogni entità particolare. Perché, come ciascun membro del nostro corpo separatamente è meno degno di quanto siamo noi stessi, così la totalità del cosmo è necessariamente di maggior valore che ciascuna parte di esso. Se ciò è vero, allora il cosmo deve essere intelligente (4); perché se così non fosse, l’uomo, che è parte dell’universo e partecipa della ragione, sarebbe di maggior valore che l’intero cosmo.
(c. Sapienza)
«Inoltre, se cominciamo dagli esseri primitivi e rudimentali e procediamo fino a quelli ultimi e perfetti, arriveremo inevitabilmente all’ordine degli dèi… [il procedimento ascensionale va dalle piante, agli animali, fino all’uomo]… Ma il quarto e supremo ordine è quello degli esseri che sono nati naturalmente buoni e sapienti e nei quali è innata fin da principio la giustizia e il ragionamento costante, qualità che deve essere considerata superumana e può essere attribuita soltanto a “Dio, ossia al cosmo”, in cui è perfetta e in cui risiede necessariamente la ragione assoluta.
Ancor più, non è possibile negare che per ciascun tutto ordinato c’è uno stato che rappresenta la sua perfezione ultima. Nel caso delle viti o del bestiame possiamo percepire come la Natura, a meno che sia soffocata da una qualche violenza, prosegue il suo retto corso verso il compimento… E così anche per la Natura come un tutto, ma in grado molto più elevato, deve esserci qualche cosa che la rende completa e perfetta. Ora, ci sono numerose circostanze esterne che impediscono la perfezione degli altri esseri; ma nessun impedimento può esserci per la Natura universale, perché essa stessa comprende e contiene tutte le nature particolari. Perciò è necessario che ci sia un quarto e supremo ordine col quale nessuna forza estrinseca può interferire, ed è in quest’ordine che deve essere situata la Natura universale.
(Conclusione da tutta l’argomentazione)
«Ora poiché essa è tale che eccelle in tutte le realtà e nessuna può esserle di ostacolo, è necessario che il cosmo sia intelligente ed anche sapiente. Che cosa può essere più stolto che negare che la Natura che comprende tutte le cose è più eccellente o, se si ammette questo, negare che essa è in primo luogo animata, in secondo razionale e riflessiva, e in terzo luogo sapiente? In che altro modo potrebbe essere la più eccellente? Poiché se fosse come le piante o gli animali dovrebbe essere considerato l’infimo anziché il supremo degli esseri. Inoltre se fosse razionale ma non sapiente fin dall’inizio, lo stato del cosmo sarebbe inferiore a quello dell’uomo; perché l’uomo può “diventare” sapiente, ma se il cosmo durante gli infiniti eoni del passato avesse difettato di sapienza, certamente non potrebbe mai raggiungerla e sarebbe perciò “inferiore all’uomo”. Poiché “ciò è assurdo” [!], bisogna affermare che il cosmo fin dall’inizio è stato sapiente e Dio. Né vi è alcun’altra cosa, tranne il cosmo, che non manchi di niente e sia in ogni particolare e in tutte le parti atto, perfetto e completo.
(La posizione dell’uomo)
«Crisippo osserva giustamente che, come la custodia esiste per lo scudo e il fodero per la spada, così ogni cosa tranne l’universo è venuta all’essere a causa di qualche altra cosa… [le piante a beneficio degli animali, gli animali a beneficio dell’uomo]. L’uomo stesso, tuttavia, è nato per “contemplare e imitare il cosmo”; è lontano dall’essere perfetto, ma è una piccola parte di ciò che è perfetto» (5).
L’affermazione conclusiva circa lo scopo dell’esistenza umana nello schema delle realtà ha un significato profondo. Stabilisce il legame tra cosmologia ed etica, tra l’apoteosi dell’universo e l’ideale di perfezione umana: il compito dell’uomo è quello teoretico di contemplare e quello pratico di «imitare» l’universo; imitazione che viene più pienamente spiegata: «imitando l'”ordine dei cieli” nella maniera e durata di tutta la vita dell’uomo» (Cic., “Cato Major”, XXI, 77). Per il lettore cristiano non sarà fuori luogo ricordare che sono i cieli “visibili” (non il «cielo» spirituale della fede) che forniscono il paradigma dell’esistenza umana. Non si può immaginare un contrasto più significativo con l’atteggiamento gnostico. Ecco i punti che Cicerone accentua. Questo mondo è il Tutto, e non c’è nulla all’infuori di esso; è perfetto, e non c’è niente che eguagli la sua perfezione; è perfetto come il tutto delle sue parti, e le parti partecipano in gradi diversi alla sua perfezione; come un tutto è animato, intelligente e sapiente, e qualche cosa di questi attributi si ritrova in alcune delle sue parti; la dimostrazione della sua sapienza è l’ordine perfetto del tutto (specialmente l’eterna armonia dei moti celesti); le parti sono necessariamente meno perfette del tutto: ciò si applica anche all’uomo, il quale, sebbene partecipi dei supremi attributi cosmici di anima e mente, non è il più perfetto degli esseri, poiché non è per natura sapiente ma lo è solo in potenza, mentre l’intelligenza del cosmo è perpetuamente in stato di sapienza; ma l’uomo, oltre la partecipazione naturale in quanto “parte” alla perfezione dell’universo divino, ha anche la capacità di perfezionare se stesso assimilando il suo essere a quello del tutto, contemplandolo con la sua intelligenza e imitandolo nella sua condotta.
La venerazione del cosmo è la venerazione del tutto di cui l’uomo stesso è una parte. Il riconoscimento e l’accettazione della propria posizione come parte è uno degli aspetti della relazione dell’uomo con l’universo nella condotta della sua vita. E’ fondata sull’interpretazione dell’esistenza umana nei termini del tutto più vasto, la cui perfezione consiste nell’integrazione di tutte le sue parti. In tal senso la pietà cosmica dell’uomo “sottomette” il suo essere alle richieste di ciò che è migliore di se stesso e fonte di tutto quello che è buono (6). Ma nello stesso tempo l’uomo non è solo una parte come le altre parti che formano l’universo, ma per il possesso di una mente è una parte che fruisce dell'”identità” col “principio regolatore” del tutto. Perciò l’altro aspetto della relazione propria dell’uomo con l’universo è quella di adeguare la sua esistenza, limitata com’è in quanto semplice parte, all’essenza del tutto, di riprodurre quest’ultima nel proprio essere mediante la comprensione e l’azione. La comprensione è quella della ragione con la ragione, della ragione cosmica con la ragione umana, ossia del simile col simile: portando a compimento tale relazione di conoscenza, la ragione umana assimila se stessa alla ragione affine del tutto, e con ciò trascende la posizione di semplice parte (7). Nella tranquillità e nell’ordine della vita morale, condotta su questa base intellettuale, il cosmo è «imitato» anche praticamente, e così il tutto è ancora una volta fatto proprio dalla parte nella funzione di esemplare.
Noi siamo spettatori e attori insieme del grande spettacolo, ma possiamo essere attori con successo e per la nostra felicità soltanto se siamo spettatori in un arco sempre più comprensivo, che contenga il nostro stesso agire.
«La Natura non ci ha destinato ad un’esistenza bassa e ignobile, ma ci ha introdotto nella vita e nell’universo come in una grande riunione festiva (8), perché possiamo essere spettatori della gara per i premi della vittoria e noi stessi assidui gareggianti con loro… [Se qualcuno potesse vedere il mondo dall’alto e mirare l’abbondanza della sua bellezza] egli comprenderebbe immediatamente a quale scopo siamo nati» (9).
– La pietà cosmica come posizione di ritiro.
Per quanto grande e ispiratrice sia codesta concezione, non bisogna trascurare il fatto che rappresentava una posizione di isolamento in quanto il suo appello era rivolto ad un soggetto umano che non era più parte di alcuna cosa “tranne dell’universo”. La relazione dell’uomo col cosmo è un caso particolare della relazione della parte col tutto, tema fondamentale nel pensiero classico. Sia la filosofia che la scienza politica avevano ripetutamente discusso questi problemi, che in ultima analisi conducono al problema più fondamentale dell’antica ontologia, quello dei Molti e dell’Uno. Secondo la dottrina classica, il tutto ha la precedenza sulle parti, è migliore delle parti, e perciò è ciò per cui le parti sono e in cui hanno non soltanto la causa ma anche il significato della loro esistenza. L’esempio vivente di un simile tutto era stato la classica “polis”, la città-stato, nella quale i cittadini avevano una partecipazione al tutto e potevano affermarne lo stato superiore nella conoscenza che esse, le parti, per quanto transitorie e scambievoli, non soltanto erano “dipendenti” dal tutto “per” il loro essere, ma “mantenevano” anche quel tutto “con” il loro essere: come la condizione del tutto condizionava l’essere e la possibile perfezione delle parti, così la loro condotta condizionava l’essere e la perfezione del tutto. Così questo tutto, rendendo possibile la vita stessa e quindi la vita buona dell’individuo, era al tempo stesso affidato alla cura dell’individuo e riceveva il suo supremo compimento nel superarlo e nel sopravvivergli.
Ora tale complementarietà giustificatrice della supremazia del tutto in termini socio-politici – la funzione vitale e perfezionatrice della parte nel tutto – era venuta a mancare nelle condizioni di vita della tarda antichità. L’assorbimento delle città-stato nelle monarchie dei Diadochi e infine nell’Impero Romano aveva privato la classe intellettuale della polis della sua funzione costruttiva. Ma il principio ontologico era sopravvissuto alle condizioni della sua realizzazione concreta. Il panteismo stoico, e in genere la teologia fisica del pensiero postaristotelico, aveva sostituito alla relazione tra i cittadini e la città quella tra l’individuo e il cosmo, il più vasto tutto vivente. Con questo spostamento di rapporto, la dottrina classica del tutto e delle parti era tenuta in vigore, anche se non rifletteva più la situazione pratica dell’uomo. Era ora il “cosmo” ad essere chiamato la grande «città degli dèi e degli uomini» (10), ed essere un cittadino dell’universo, un “cosmopolita”, era considerata la mèta verso la quale l’uomo, altrimenti isolato, poteva dirigersi. Gli si chiedeva, per così dire, di adottare la causa dell’universo come sua propria, ossia di identificarsi con quella causa direttamente, al di là di qualsiasi intermediario, e di riferire il suo io interiore, il suo “logos”, al “logos” del tutto.
Il lato pratico di codesta identificazione consisteva nell’accettare e adempiere fedelmente la “funzione” assegnatagli dal tutto in quel posto e grado che il destino cosmico gli aveva stabilito. La sapienza conferiva libertà interiore per assumere i compiti, compostezza per affrontare i capricci della fortuna che ne accompagnavano l’esecuzione, ma non stabiliva o cambiava i compiti stessi. «Rappresentare la propria parte» – questa espressione su cui l’etica stoica si sofferma tanto – rivelava involontariamente l’elemento fittizio della costruzione. Una parte recitata si sostituiva ad una reale funzione compiuta. Gli attori sulla scena si comportavano «come se» agissero di propria scelta, e «come se» le loro azioni avessero importanza. Ciò che di fatto importa è recitare bene piuttosto che male, senza che la riuscita abbia grande importanza. Gli attori, che recitano con arte, sono essi stessi l’uditorio.
Nella frase «recitare la propria parte» c’è una vanteria che nasconde una rassegnazione più profonda, seppure orgogliosa, ed è necessario soltanto una mutazione di atteggiamento per vedere il grande spettacolo in modo del tutto differente. Il tutto ha realmente importanza, si interessa della parte che sono io? Gli Stoici affermavano che è così identificando l'”heimarméne” con la “prónoia”, il destino cosmico con la provvidenza. E la mia parte, comunque la rappresenti, contribuisce davvero, apporta qualche cosa al tutto? Gli Stoici lo affermavano mediante l’analogia tra cosmo e città. Ma il paragone stesso mette in luce la debolezza dell’argomento, perché – in contrasto con ciò che è vero nella polis – non si può in realtà sostenere che io abbia importanza nello schema cosmico, che è del tutto fuori del mio controllo e nel quale la mia parte è ridotta ad una passività che non aveva nella polis.
Indubbiamente, il fervore eccessivo col quale era mantenuta l’integrazione dell’uomo nel tutto, per la sua affinità con esso, serviva a salvare la dignità dell’uomo e con ciò a sancire una morale positiva. Tale fervore, che aveva preso il posto di quello che era stato precedentemente ispirato dall’ideale di virtù civica, rappresentava un tentativo eroico da parte della classe intellettuale di trasferire la forza vitale di quell’ideale in condizioni fondamentalmente mutate. Ma le masse recentemente disperse nell’Impero, che non avevano condiviso la nobile tradizione dell'”areté”, avrebbero potuto reagire molto diversamente ad una situazione in cui si trovavano coinvolte passivamente: una situazione nella quale la parte era insignificante per il tutto, e il tutto estraneo alle parti. Tuttavia l’idea di ordine come qualcosa di divino e dell’universo come un simile ordine conservava comune validità e rappresentava una specie di religione degli intellettuali.
– La nuova valutazione gnostica.
L’attacco gnostico contro la posizione classica scelse questo concetto dell’alta considerazione del cosmo per una nuova radicale valutazione. Aveva contro di sé la piena forza della tradizione come abbiamo descritto, di cui gran parte era compresa nel nome stesso di «cosmo». Conservando questo nome per il mondo, gli Gnostici ritenevano l’idea di ordine come la caratteristica principale di quello che si apprestavano a deprezzare. Di fatto, anziché negare al mondo l’attributo di ordine (cosa che in teoria un pessimismo cosmico avrebbe potuto fare), essi volsero l’attributo ad esprimere obbrobrio anziché lode, caricando semmai le tinte nel processo. Come vedremo in seguito parlando del concetto di fato, proprio le caratteristiche di ordine, regola e legge non solo furono lasciate al mondo rivalutato in senso gnostico, furono anzi accresciute nel loro potere e nella loro influenza sull’uomo, ma mutate radicalmente nella loro qualità spirituale, nel loro significato, nel loro valore. Ed è quasi esagerando la divinità dell’ordine cosmico che la si trasforma nell’opposto del divino. Anche qui il cosmo è ordine e legge, ma un ordine rigido e nemico, una legge tirannica e malvagia, priva di significato e di bontà, estranea agli scopi dell’uomo e alla sua essenza interna, non oggetto della sua comunicazione e affermazione. Un mondo svuotato di contenuto divino aveva un suo proprio ordine: un ordine vuoto di divinità. Così la svalutazione metafisica del mondo si estende alla radice concettuale dell’idea di cosmo, ossia al concetto di ordine stesso, e lo include con la sua qualità pervertita in un concetto ora svalutato di universo fisico. In tal modo il termine «cosmo», con tutte le sue associazioni semantiche, poteva passare nell’uso gnostico e poteva diventarvi, col segno-valore rovesciato, altrettanto simbolico quanto lo era stato nella tradizione greca.
«Cosmo» diviene così nella visione della realtà di recente apparizione un concetto enfaticamente negativo, forse più fortemente negativo di quanto non fosse stato un concetto positivo nella visione greca, appunto perché fornito di maggior carica emotiva. Tale concezione negativa è naturalmente controbilanciata da una positiva, quella della divinità transmondana. Nel passo citato di Cicerone troviamo che il cosmo è il Tutto, cioè che non vi è nulla al di fuori di esso e nulla che non sia parte di esso, e questo tutto è Dio. Questa è la posizione specifica del panteismo stoico; ma anche nello schema aristotelico la relazione della Natura col Nous divino, sebbene quest’ultimo non sia immanente al mondo, conduce allo stesso risultato di fare del mondo una manifestazione del divino; e persino il supremo trascendentalismo di Plotino mantiene intatta tale relazione. Il Dio gnostico non è semplicemente estramondano e sopramondano, ma nel suo significato ultimo contromondano. L’unità sublime del cosmo e di Dio è spezzata, i due vengono separati e si apre tra di essi un abisso che non sarà mai completamente colmato: Dio e il mondo, Dio e la natura, spirito e natura, fanno divorzio, estranei l’uno all’altro, persino contrari. Ma se questi due sono estranei l’uno all’altro, allora anche l’uomo e il mondo sono estranei l’uno all’altro, e questo in termini di sentimento è molto probabilmente il fatto primario. C’è una fondamentale esperienza di una frattura assoluta tra l’uomo e ciò in cui si trova situato, il mondo. Il pensiero greco era stato una grande espressione dell’appartenenza dell’uomo al mondo (se non, senza riserva, alla pura vita terrestre) e per mezzo della conoscenza che genera l’amore aveva cercato di accrescere l’intimità con la sostanza affine di tutta la natura: il pensiero gnostico è ispirato dalla scoperta angosciosa della solitudine cosmica dell’uomo, della totale alterità del suo essere rispetto a quello dell’universo in genere. Codesta impostazione dualistica è alla base di tutto l’atteggiamento gnostico e unifica le espressioni grandemente diverse, più o meno sistematiche, che quell’atteggiamento assunse nel rituale e nella fede gnostica. E’ su questo primo fondamento umano di atteggiamento dualistico, un’esperienza appassionatamente sentita dell’uomo, che poggiano le dottrine gnostiche.
Il dualismo tra uomo e mondo postula come corrispettivo metafisico quello tra Dio e mondo. E’ una dualità di termini non complementari ma contrari, una polarità di incompatibili, e questo fatto domina l’escatologia gnostica. La dottrina gnostica espone la dualità, o piuttosto il sentimento che ne è alla base, nei suoi diversi aspetti oggettivi. L’aspetto teologico sostiene che il divino non ha parte in ciò che riguarda l’universo fisico: che il vero Dio, strettamente transmondano, non è rivelato né indicato dal mondo, ed è perciò lo Sconosciuto, totalmente Altro, inconoscibile nei termini di qualsiasi analogia mondana. Analogicamente, l’aspetto cosmologico afferma che il mondo non è creazione di Dio ma di un principio inferiore, la cui inferiorità è perversione del divino e le cui caratteristiche principali sono dominazione e potere. E l’aspetto antropologico afferma che l’io interiore dell’uomo non è parte del mondo, creazione e dominio del demiurgo, ma sta in quel mondo come totalmente trascendente e incommensurabile a tutti i modi cosmici di essere perché è il loro corrispondente transmondano, il Dio sconosciuto che è al di fuori.
Il nuovo vocabolario riflette il rivolgimento di significato come un fatto semantico ormai stabilito: «cosmo» e le espressioni derivate come «cosmico», «del cosmo», eccetera, figurano come termini detrattivi nel linguaggio gnostico, e ciò con tutta la forza di una terminologia fissa. E’ da notare però che la negatività del concetto «cosmo» non consiste soltanto nell’assenza di valori divini nell’universo: la sua combinazione con termini quali «tenebra», «morte», «ignoranza» e «male» mostrano che possiede anche una sua propria controqualità. Ossia, al contrario dell’analogo moderno, il ritirarsi del divino dal cosmo lascia quest’ultimo non come un fatto neutro, di valore indifferente, puramente fisico, ma come una potenza separatistica che si pone fuori di Dio e tradisce così una direzione di volontà lontana da Dio; e la sua esistenza è l’incarnazione di quella volontà. Così la tenebra del mondo denota non soltanto il suo essere estraneo a Dio e la mancanza della sua luce, ma anche il suo essere una “forza alienante” da Dio. In breve, denota in ultima analisi un fatto spirituale, non puramente fisico, e in modo paradossale il cosmo gnostico è un’entità non meno teologica del cosmo degli Stoici. Di conseguenza, il mondo ha il suo spirito, il suo dio: il principe di questo mondo. Ma non è più il Tutto che era per i Greci: è limitato ed è trasceso da tutto ciò che è essenzialmente non-mondo e la negazione di tutto ciò che è mondo. Per la pietà gnostica il vero Dio è soprattutto definito da questa contrapposizione. Come il mondo è ciò che aliena da Dio, così Dio è ciò che aliena e libera dal mondo. Dio in quanto negazione del mondo ha una funzione nichilistica rispetto ad ogni attaccamento e valore intramondano. Ma il mondo è nondimeno reale per tale posizione nichilistica. In altre parole, l’allontanamento della vera divinità dal mondo non lo priva di realtà facendolo diventare una semplice ombra o illusione (come in certe dottrine di misticismo indiano). Come il cosmo stoico era in senso profondamente teologico oggetto di amore, di venerazione e confidenza, così il cosmo gnostico è oggetto di odio, disprezzo e timore. E a questo proposito richiamiamo ancora una volta la funzione del concetto di ordine. Come abbiamo già detto, l’universo della visione gnostica, sebbene non abbia niente della venerabilità del cosmo greco, è pur sempre cosmo, ossia un ordine, ma un ordine con un senso vendicativo. E’ ora chiamato così con una nuova e paurosa accentuazione, un’accentuazione insieme timorosa e irriverente, inquieta e ribelle: perché tale ordine è estraneo alle aspirazioni dell’uomo. La macchia della natura non sta in una deficienza di ordine, ma in una completezza che tutto pervade. Lungi dall’essere caos, la creazione del demiurgo, quell’antitipo della conoscenza, è un sistema comprensivo governato dalla legge. Ma la legge cosmica, che una volta era considerata come espressione di una ragione, con la quale la ragione dell’uomo poteva comunicare nell’atto di conoscenza e che poteva far sua nel regolare la propria condotta, è vista ora soltanto nel suo aspetto di costrizione che soffoca la libertà dell’uomo. Il “logos” cosmico degli Stoici è sostituito dall'”heimarméne”, il fato cosmico oppressivo. Di questa caratteristica speciale diremo qualche cosa di più tra breve. Come principio generale, la vastità, la potenza e la perfezione dell’ordine non invitano più alla contemplazione e all’imitazione, ma destano avversione e rivolta.
– La reazione greca.
Agli occhi dell’antichità ciò non era soltanto una visione stravagante, ma aperta bestemmia, e ogni volta che l’avvertiva chiaramente la caratterizzava come tale: come un atteggiamento sacrilego di cui poteva essere capace solamente un’anima profondamente irreligiosa ed empia. L’opera di Plotino contro gli Gnostici (Enn. II, 9) è una testimonianza eloquente di questa reazione. Perfino il titolo l’annuncia come polemica contro i detrattori del mondo, e in tutta l’opera si sente l’indignazione che l’antica pietà cosmica provava per la follia e l’arroganza di tali insegnamenti.
«Rifiutando onore a questa creazione e a questa terra, essi pretendono che una nuova terra è stata fatta per loro, verso la quale si dirigeranno partendo di qui [cap. 5]. Essi biasimano questo Tutto… e denigrano i suoi governanti identificando il demiurgo con l’Anima e attribuendo a lui le stesse passioni delle anime individuali [cap. 6]. Bisognerebbe istruirli, seppure hanno la grazia di accettare istruzioni, riguardo alla natura di queste cose, cosicché cessino di diffamare con leggerezza realtà che meritano onore [cap. 8]. Anche questo cosmo viene da Dio e guarda verso di lui [cap. 9]. Perciò colui che condanna la natura del cosmo non sa quello che fa né dove la sua audacia lo porta [cap. 13]. Inoltre, non è disprezzando il cosmo e i beni e le altre cose belle che esso contiene che si può diventar buoni… Come si può essere pio negando che la Provvidenza penetra in questo mondo e in tutte le cose?… Chi tra coloro che sono così irragionevoli e orgogliosi è altrettanto ben ordinato e perspicace come il Tutto? [cap. 16]».
Un’analoga protesta era stata sollevata dalla Chiesa nascente, che, nonostante le tendenze acosmiche del cristianesimo, era ancora un erede dell’antichità in opposizione agli eccessi del dualismo anticosmico. Al posto dell’immanenza greca del divino nell’universo, era la dottrina biblica della creazione e del governo del mondo da parte di Dio che forniva l’argomento contro l’antitesi gnostica tra Dio e il mondo. Anche in questo caso il disprezzo del mondo è respinto come bestemmia. «Dire che il mondo è un prodotto della caduta e dell’ignoranza è la più grande bestemmia» (Iren., “Adv. Haer.” II, 3, 2). La provocazione peggiore venne dall’empio disprezzo di Marcione per il creatore e la sua opera, ed abbiamo citato da Tertulliano alcune espressioni che più lo offendevano (confronta cap. V, b). Il tono di scherno adottato da Marcione contro il mondo non ha l’equivalente neppure nella letteratura gnostica. Ma soltanto in quell’epoca era possibile parlare del mondo in modo così ribelle e spregiativo. Mai, né prima né dopo, si era aperto un tale abisso tra l’uomo e il mondo, tra la vita e il suo creatore, e un tale senso di solitudine cosmica, di abbandono e di superiorità trascendentale dell’io aveva pervaso la coscienza dell’uomo.
b) Il destino e le stelle.
Quell’aspetto del cosmo che per gli Gnostici ne rivelava nel modo più evidente il carattere è l'”heimarméne”, ossia il fato universale. L'”heimarméne” è amministrata dai pianeti, o dalle stelle in genere, esponenti mitici della legge inesorabile ed ostile dell’universo. Il mutamento del contenuto emotivo del termine «cosmo» non si trova meglio simbolizzato che in questa svalutazione della parte anticamente più divina del mondo visibile, le sfere celesti. Il cielo stellato – che da Platone agli Stoici era la più pura incarnazione della ragione nella gerarchia cosmica, il paradigma di intellegibilità e quindi di divinità del regno sensibile – ora fissava in faccia l’uomo con lo sguardo fisso di un potere estraneo e ineluttabile. Il suo governo è tirannia e non provvidenza. Il firmamento stellare, privato della venerabilità con la quale la pietà siderale lo aveva investito fino ad allora, ma pur sempre in possesso della posizione eminente e rappresentativa che aveva acquisito, diviene ora il simbolo di tutto ciò che atterrisce l’uomo nell’attualità dominante dell’universo. Sotto questo cielo senza pietà, che non ispira più confidenza reverenziale, l’uomo diventa consapevole della sua completa solitudine, del non essere una parte del sistema che lo circonda, ma inspiegabilmente situato in esso senza protezione.
– Forme della pietà astrale nel mondo antico.
Consideriamo che cosa significhi questo sviluppo nel contesto dell’antica religione e della cosmogonia. La deificazione dei cieli o dei principali corpi celesti è un elemento in tutte le religioni antiche (eccetto il giudaismo) per ragioni le più naturali e di universale efficacia. Dimora della luce e sorgente di calore nella sua stella più grande che alimenta tutta la vita sulla terra e che causa, con i suoi movimenti, l’avvicendamento delle stagioni che regolano il ritmo dell’esistenza terrena; esso stesso maestoso per lo spettacolo della sua grandezza, bellezza e lontananza; incorruttibile e puro; che unisce sublimità, infinità e legge in forma visibile – il cielo era l’oggetto naturale di una forma di pietà la più sublime, in quanto si ergeva al di sopra dell’adorazione delle forze terrestri. Aristotele giunse al punto di affermare che lo spettacolo del cielo stellato è una delle due origini della religione (l’altra sono i sogni; fr. 14, Cic., “Nat. deor.” II, 37, 95); e l’autore del trattato “Sul cosmo” porta la testimonianza del genere umano: non solleviamo le mani al cielo nell’atto di pregare? (cap. 6).
“Monoteismo solare”. Nella forma primitiva dei culti del cielo, il sole e la luna avevano una naturale preminenza, con gli altri ospiti celesti, specialmente con i cinque pianeti e i dodici segni dello Zodiaco, aggiunti con funzioni varie. Viene così stabilita fin dal principio una gerarchia, e una delle linee di sviluppo è quella che accentua sempre di più la naturale preminenza del sole. In certe condizioni ciò può portare ad una specie di monoteismo solare o panteismo, il quale, già realizzato per breve tempo nella religione del sole di Amenhotep Quarto, al tempo dell’Impero Romano, periodo che stiamo appunto considerando, sorse nella forma della religione siriaca del sole ed ebbe grande rilievo, anzi per un certo tempo diventò una specie di religione di stato dei Cesari.
“Pluralismo astrologico”. Un’altra linea lungo la quale si è sviluppata la pietà astrale è rappresentata dalla tarda religione babilonese, che è l’adorazione degli astri più fortemente pronunziata dell’antichità. Nelle speculazioni di una casta sacerdotale che fin dalla caduta della monarchia babilonese non era più la custode teologica di un sistema politico che esigeva una monarchia celeste, si era delineato un caratteristico livellamento della gerarchia originaria dei poteri celesti, pur conservandone la pluralità: il sole e la luna figurano come eguali in mezzo al rimanente dei pianeti; le divinità principali dell’antico panteon babilonese, spogliate del loro carattere concreto personale, vengono assegnate a funzioni causali ben definite e in tali funzioni sono identificate coi sette pianeti come unici poteri rimasti. In relazione a questa spersonalizzazione, l’aspetto di legge e di regolarità calcolabile nelle operazioni è messo sempre più in evidenza. Si unì a questo processo religioso col suo prestigio e la sua dottrina l’astronomia scientifica, già da lunga data esistente in Babilonia. Ebbe così origine la concezione di un’influenza reciproca di un numero fisso di poteri impersonali che insieme costituiscono un sistema di governo a cui ogni evento è sottoposto. Codesto sistema di governo cosmico ha il suo corrispondente in un corpo sistematizzato di conoscenze umane che riguarda questo governo. In altre parole, la religione divenne astrologia.
Dal tempo dei Diadochi la religione astrologica babilonese avanzò potentemente verso occidente. Dappertutto nell’ellenismo, specialmente in Egitto, le idee astrologiche e la pratica astrologica guadagnarono influenza e fornirono la struttura, sebbene non il contenuto ultimo, del concetto gnostico di “heimarméne”. Il processo che abbiamo descritto è di massima importanza generale. Per la prima volta nella storia dell’umanità, il mondo è considerato il risultato necessario, in ogni momento, di una pluralità di poteri cosmici che semplicemente in virtù di date qualità e delle leggi dei loro movimenti, cioè non spontaneamente, si influenzano l’uno con l’altro e insieme determinano il corso delle cose fino agli eventi più particolari della terra. Con ciò l’astrazione teologica ha fatto molta strada dall’intuizione originaria della religione naturalistica astrale. Quell’efficacia dei poteri celestiali, che è o direttamente sperimentata o facilmente associata nell’immaginativa mitica alle loro proprietà visibili, ha dato luogo a funzioni definite in un sistema del destino in cui le entità originali non figurano più nei loro lineamenti sensibili, ma semplicemente come segni della legge generale che impongono. Il sole, per esempio, non è più il sole dell’esperienza concreta e della religione della natura, il dio che dispensa luce, calore, vita, crescita, ed anche aridità, pestilenza e morte, il quale sorge vittoriosamente dalla notte, mette in fuga l’inverno e rinnova la natura: ora è un numero tra forze coordinate, quasi una cifra in un insieme calcolabile di determinanti. E’ la cifra-valore che gli è assegnata che ora conta, e non la sua originaria qualità fenomenica.
Lo svanire della qualità naturale toglieva il più grande ostacolo ad una rivalutazione peggiorativa del panteon astrale. Come semplice rappresentazione di un destino astratto, staccato dal richiamo immediato, ingenuo dello spettacolo celeste, il sistema avrebbe potuto facilmente essere assimilato a visioni del mondo opposte. Di fatto, la visione del mondo dell’astrologia era già ambigua; e fino ad un certo punto la consapevolezza fatalistica di una soggezione ad una necessità rigida come tale, e la passività alla quale sembrava condannare l’uomo, furono carte favorevoli per la rivoluzione gnostica dell’atteggiamento totale verso il mondo. Ma l’astrologia non costituisce per se stessa codesta rivoluzione. Si richiedeva un nuovo principio attivo di valutazione per riempire le forme svuotate di valore del simbolismo astrale con un nuovo significato specifico e renderle adatte ad esprimere una visione più che cosmica. E lo gnosticismo riuscì in questo trascendendo il sistema cosmico come tale e voltandosi a guardarlo da quella trascendenza.
“La religione filosofica delle stelle”. Infine dobbiamo ricordare un terzo sviluppo della pietà astrale nell’antichità: la considerazione delle stelle nella filosofia greca. Non si tratta qui, come nella religione della natura, della funzione empirica dei corpi celesti nel mantenere la vita, e neppure, come nell’astrologia, della loro funzione nel destino umano, ma è la loro stessa esistenza paradigmatica che le rende oggetto di venerazione. La purezza della loro sostanza, la perfezione del loro moto circolare, la libertà senza ostacoli con cui così movendo seguono la loro legge propria, l’incorruttibilità del loro essere e l’immutabilità del loro corso, tutti questi attributi le rendono «divine» nel senso della filosofia greca, ossia nel senso di un predicato ontologico impersonale che appartiene ad un oggetto in virtù di tali qualità, che in genere contribuiscono ad un’eminenza di essere. Tra queste la costante di essere e l’immortalità di vita sono predominanti. Le stelle perciò sono divine non tanto per la loro azione quanto per il rango che occupano nella gerarchia delle cose secondo le loro proprietà immanenti. E queste sono appunto le proprietà di ordine, eternità e armonia che costituiscono il carattere «cosmo» del Tutto in generale: queste esse rappresentano nel modo più puro e completo (11). Per l’uomo dunque esse sono la manifestazione convincente del cosmo come tale al di sopra di tutte le restrizioni e impedimenti dei processi terrestri, l’evidenza visibile della sua divinità, il cui spettacolo rende certo l’osservatore di ciò che quaggiù è così spesso oscuro (12). Oltre questo significato ideale, la loro perfezione è anche la garanzia reale della durata del tutto, ossia dell’eternità del movimento cosmico e della vita (13). Esse sono perciò la prova più cogente che l’affermazione greca del mondo sia stata capace di concepire.
Anche qui sono i sette pianeti, o piuttosto le sette sfere in cui si pensa che essi siano collocati, circondate dalle sfere esterne delle stelle fisse, che col loro mutuo movimento in accordo formano il sistema che mantiene l’universo in movimento. Esse muovono secondo la legge o, ciò che è lo stesso, secondo la “ragione”, perché l’intelligibilità della loro legge presuppone intelligenza nella loro attivazione (14). Il grado di intelligibilità, che consiste nella razionalità intrinseca, è misura del grado di essere; e per l’induzione accennata, è anche misura dell’intelligenza che risiede nell’oggetto stesso. (Secondo la concezione moderna, è soltanto misura dell’intelligenza del soggetto conoscente.) La percezione della razionalità dei moti stellari per mezzo della ragione matematica è niente di meno che la comunione dell’intelligenza umana con l’intelligenza divina.
I Pitagorici avevano trovato nell’ordine astrale le proporzioni della concordante scala musicale, e di conseguenza avevano chiamato il sistema delle sfere in azione un'”harmonia”, ossia l’accordarsi insieme di molti in un tutto unificato. Essi avevano con ciò creato il simbolo più incantevole della pietà cosmica greca: l’«harmonia», che si effonde dalla tacita «musica delle sfere», è l’espressione idealizzata dello stesso fatto di irrefragabile ordine che l’astrologia accentua meno ottimisticamente nel suo proprio contesto (15). La filosofia stoica si sforzava di integrare l’idea di destino come veniva proposta dall’astrologia contemporanea col concetto greco di armonia: l'”heimarméne” per gli Stoici è l’aspetto pratico dell’armonia, cioè la sua azione come si riflette nelle condizioni terrestri e nella breve vita degli esseri quaggiù. E poiché i movimenti stellari sono attuati dal “logos” cosmico e questo “logos” funziona nel processo del mondo come provvidenza (“prónoia”), ne consegue che in tale sistema totalmente monistico l'”heimarméne” stesso è “prónoia”, ossia, il fato e la provvidenza divina sono la stessa cosa. Ciò che distingue l’uomo sapiente è la comprensione e il consenso volontario a questo fato interpretato come ragione del tutto, perciò egli sopporta l’avversità nel suo destino individuale come prezzo pagato dalla parte per l’armonia del tutto.
In questo schema teologico l’esistenza del tutto come tale, tuttavia, è il fine ultimo, indiscutibile, giustificato in se stesso: le sue parti costituenti esistono in funzione del cosmo, come le membra esistono per il bene dell’intero organismo. L’uomo è un tale membro, e per la sua ragione è chiamato ad inserirsi consapevolmente nel tutto; ma il suo non è in alcun modo il più alto modo di essere, egli non è il fine della natura e il cosmo non esiste per lui.
Dal tempo di Posidonio (uno dei maestri di filosofia di Cicerone, dal secondo al primo secolo a.C.), l’elevazione dell’intelletto alle regioni stellari si colorisce di un entusiasmo che rivela l’influenza orientale e assume talvolta la caratteristica di un’evasione mistica dalla miseria delle condizioni terrestri. Un misticismo astrale si sviluppò in seno alla Stoà, senza tuttavia rompere le barriere del monismo cosmico.
– La rivalutazione gnostica.
Su tutto questo complesso di pietà astrale il dualismo gnostico appare come un nuovo principio di interpretazione, si appropria gli elementi che può sfruttare per i suoi scopi e li sottopone ad una radicale reinterpretazione. In modo particolare, lo schema astrologico lasciato dalla spersonalizzazione della religione babilonese si prestava all’uso gnostico e permetteva la trasposizione in un nuovo contesto di valori. Come simbolo della legge cosmica generale, il regno delle sostanze astrali era diventato così formale che poteva essere riempito a piacere di contenuto qualitativo molto diverso. Tale contenuto in ultima analisi poteva essere una funzione di ciò che era concepito essere il mondo nella sua qualità teologica fondamentale. Così il dualismo gnostico assumendo i pianeti nella funzione in cui li aveva trovati, ossia quella di rigido governo cosmico, in ragione di questa stessa funzione ne fa l’espressione estrema di tutto quello di antidivino che il mondo come tale ora rappresenta. Nonostante tutta la dipendenza dal materiale della tradizione, non è uno sviluppo, ma una totale frattura che porta dalla posizione di religione astrale alla concezione gnostica di governo astrale. La legge inevitabile di dominazione cosmica, che anche nella mescolanza di adorazione e timore caratteristica del fatalismo astrologico aveva fatto delle stelle le divinità supreme, provocava ora la rivolta violenta di una nuova consapevolezza di libertà acosmica, che le faceva trasferire in blocco dalla parte nemica. Qualunque fossero le ragioni, l’esperienza di tale «ordine» si era trasformata da quella di adorazione a quella di terrore. La necessità del suo dominio che tutto investe, diviene esecrazione dei poteri che la esercitano. Il nuovo dualismo «chiudeva in una morsa», per così dire, l’intero universo con tutte le sue gradazioni di livelli più bassi e più alti e lo trasportava come un tutto da una parte della dualità. L’architettura sferica era accettata così come era stata elaborata dalla cosmologia tradizionale; ma mentre prima aveva incluso il divino, si chiudeva ora al divino, che era posto in modo irrevocabile al di fuori di essa. E mentre le sfere celesti avevano rappresentato la divinità del cosmo nella sua massima purezza, esse ora lo separavano radicalmente dal divino. Racchiudendo il mondo creato, esse lo trasformavano in una prigione per quelle particelle di divinità che erano state rinchiuse in questo sistema.
Possiamo immaginare con quali sentimenti gli Gnostici devono aver guardato il cielo stellato. Quanto malvagia deve essere apparsa loro la sua luminosità, quanto allarmante la sua vastità e la rigida immutabilità del suo corso, quanto crudele la sua silenziosità! La musica delle sfere non era più percepita e l’ammirazione per la forma sferica perfetta aveva fatto posto al terrore per tanta perfezione diretta all’asservimento dell’uomo. La pia meraviglia con cui l’uomo una volta guardava le regioni superiori dell’universo divenne un senso di oppressione per la volta di ferro che trattiene l’uomo esiliato dalla sua patria al di là. Ma è proprio questo «al di là» che in realtà qualifica la nuova concezione dell’universo fisico e la posizione dell’uomo in esso. Senza ciò non avremmo altro che un pessimismo terrestre senza speranza. La sua presenza trascendente mantiene il cosmo nella condizione di semplice parte della realtà, e perciò di qualche cosa da cui è possibile un’evasione. Il regno del divino inizia dove finisce quello del cosmo, ossia all’ottava sfera. La totale visione gnostica non è né pessimistica né ottimistica, ma escatologica: se il mondo è malvagio, vi è la bontà del Dio oltremondano; se il mondo è una prigione, c’è un’alternativa; se l’uomo è prigioniero del mondo, c’è una salvezza da esso e un potere che salva. E’ in questa tensione escatologica, nella polarità di mondo e Dio, che il cosmo gnostico assume la sua qualità religiosa.
Abbiamo visto nei capitoli precedenti che in tale polarità i poteri cosmici sono sottoposti ad una nuova “personificazione” mitologica. I lineamenti spaventevoli degli Arconti sono ben distanti da un puro simbolismo di astratta necessità cosmica: sono figure ostinate, antidivine, ed esercitano il loro governo con tutto lo scopo e la passione di una causa egoista. Così, dopo l’astrazione filosofica ed astrologica della speculazione ellenistica, le stelle-divinità assumono una nuova concretezza nell’immaginativa mitica, non per un ritorno, ma per un maggior allontanamento della visione «naturale» della primitiva mitologia. Questo non è che un esempio del fatto che nell’ambiente ellenistico lo gnosticismo agiva come sorgente di nuova creazione del mito. Ma bisogna notare che questa nuova mitologia, nonostante una certa genuina «prima» creazione, era secondaria per il fatto che si aggiungeva ad una tradizione mitologica e costruiva il suo sistema con gli elementi coscientemente reinterpretati di un’eredità complessa. A tal riguardo l’eminenza accordata ai poteri astrali non è tanto una autentica scelta da parte dei mitologi gnostici quanto un cambiamento della loro funzione prestabilita nella funzione che era richiesta dal nuovo sistema di valori. La loro eminenza è altrettanto negativa quanto prima era stata positiva.
– La reazione greca; la fraternità dell’uomo e delle stelle.
Plotino di nuovo offre testimonianza della resistenza con cui la pietà greca si oppose a tale detrazione del mondo stellare; di nuovo s’incontra il tono di indignazione che era stato diretto contro la detrazione del mondo in genere.
«Essi dovrebbero cessare dal raccontare storie orribili di cose spaventose che asseriscono aver luogo nelle sfere cosmiche, quelle sfere che in verità sono donatrici di ogni cosa benefica. Che cosa hanno di spaventoso in esse con cui atterrire coloro che sono inesperti per quanto riguarda la ragione e non hanno mai sentito parlare della conoscenza ben ordinata [“gnosis”] acquisita con l’educazione? Se i loro corpi sono di fuoco, non c’è ragione di temerli, perché sono nelle giuste proporzioni col Tutto e con la terra; ma bisogna piuttosto considerare le loro anime – dopo tutto gli Gnostici stessi non affermano il valore della propria in conformità della loro?… Se gli uomini sono superiori alle altre creature viventi, quanto più lo sono esse (le sfere) che sono nel Tutto, non per una funzione tirannica, ma per conferire ad esso ordine ed armonia [Enn. II, 9, 13]. Anche le stelle hanno anime, che superano di gran lunga la nostra per l’intelligenza, la bontà, e il contatto col mondo spirituale [ibid., 16]».
Evidentemente l’argomento di Plotino è valido solamente nella comune ammissione greca (tacitamente presupposta da lui) della generale “omogeneità” di tutta l’esistenza cosmica, che permette un paragone tra le parti per mezzo di un criterio uniforme di valutazione. Il criterio è quello di «cosmo», ossia lo stesso ordine, e per tale criterio certamente l’uomo deve essere posto molto al di sotto delle stelle, che compiono senza deviazioni e per il tutto ciò che l’uomo può tutt’al più compiere transitoriamente e sulla sua piccola scala, cioè un’attività ordinata. L’argomento, quanto al valore, è scarsamente convincente per noi. Quanto Plotino, come rappresentante della mentalità classica, si trovi a questo riguardo più distante dalla nostra posizione di quanto non lo siano gli Gnostici con tutta la loro fantasia mitologica, risulta chiaro dalla seguente citazione:
«Anche gli infimi fra gli uomini essi giudicano degni di essere chiamati fratelli, mentre con bocca frenetica dichiarano che il sole, la luna e le stelle nel cielo, e persino l’anima del mondo, sono indegni di essere chiamati fratelli. Coloro che sono vili non hanno in verità il diritto di pretendere tale parentela, ma coloro che sono diventati buoni [ne hanno acquistato il diritto]» (ibid., 18).
I due campi s’affrontano qui con inimitabile chiarezza. Plotino sostiene l’unità dell’essere nell’universo, senza separazione essenziale dell’umano dal regno non umano. L’uomo nella sua essenza è affine a tutto il cosmo, anche alle entità macrocosmiche che sono dotate di anima come lui stesso; solamente queste sono incomparabilmente migliori di lui, superiori per la forza e la purezza di ciò che è anche il meglio in lui, ossia la ragione, e in tale caratteristica imitabili da lui. Quanto migliore egli è, tanto più realizza la sua affinità con i poteri cosmici, cioè tanto più aumenta l’originale comunanza generica del suo essere con quello dell’intero cosmo.
Lo gnosticismo, al contrario, toglie all’uomo, per la sua appartenenza essenziale ad un altro regno, ogni somiglianza col mondo che ora non è altro che nudo «mondo», e mette l’uomo a confronto con la totalità di esso come qualche cosa di assolutamente differente. A parte gli strati accessori esterni forniti dal mondo, l’uomo per la sua intima natura è acosmico; a un simile essere il mondo tutto è indifferentemente estraneo. Dove c’è estrema alterità di origine, non può esserci affinità né col tutto né con qualcuna delle parti dell’universo. L’io è simile soltanto agli altri «io» umani viventi nel mondo, e al Dio transmondano col quale il centro non mondano dell’io può entrare in comunicazione. Questo Dio deve essere acosmico, perché il cosmo è diventato il regno di ciò che è estraneo all’io. Possiamo scorgere qui la connessione profonda che esiste tra la scoperta dell’io, la privazione di spiritualità del mondo e l’affermazione del Dio trascendente.
– La fratellanza acosmica di salvezza.
La fiducia panteistica o panlogica dell’antichità è svanita nello gnosticismo. L’io è scoperto come incommensurabile con tutte le cose della natura. La scoperta al principio fa emergere l’io nella sua profonda solitudine: l’io viene scoperto mediante una rottura col mondo. Nello stesso tempo questo ripiegamento su di sé dall’estraneità cosmica porta ad una nuova accentuazione della «comunità» dell’uomo come unico campo che rimane di affinità, dove ci si trova uniti non soltanto per la comunità di origine, ma anche per l’uguaglianza della situazione in quanto stranieri nel mondo. Codesta «comunità» non si riferisce però all’aspetto sociale e naturale dell’uomo, ossia all’esistenza terrena dell’uomo, ma soltanto all’io interiore e acosmico e a ciò che riguarda la salvezza. Viene fondata così la nuova fratellanza degli eletti, o dei credenti, o di coloro che possiedono la gnosi, a cui appartengono anche coloro che per il grado di virtù terrena sono gli «infimi», se sono portatori del pneuma. Che questi «infimi» siano superiori al sole e alle stelle è di per sé evidente, data la nuova valutazione della personalità e della natura. E’ ugualmente evidente che l’interesse scambievole della fratellanza escatologica non può consistere nel promuovere l’integrazione dell’uomo nel tutto cosmico, per quanto riguarda il sentire, e neppure nel fargli «compiere la propria parte», per quanto riguarda l’agire. L’uomo non è più parte del tutto, a meno di violare la sua reale essenza. Invece, l’interesse mutuo della fratellanza degli uomini, riuniti dalla comune solitudine cosmica, è di approfondire tale alienazione e promuovere la redenzione degli altri, che diviene per ciascun essere veicolo della propria.
Nel prossimo capitolo diremo di più circa le implicanze etiche dell’orientamento anticosmico. Qui, nel raffronto di concezione gnostica e classica della legge cosmica specialmente per quel che riguarda la condizione delle stelle, dobbiamo considerare il significato simbolico della polemica di Plotino. Ciò che eccita la sua collera – che l’infimo degli uomini sia riconosciuto come fratello, ma che anche agli elementi più nobili dell’universo (persino «all’anima del mondo nostra sorella») sia negato tale onore – è una precisa espressione di un nuovo atteggiamento di cui noi oggi a grande distanza siamo tuttora eredi. L’atteggiamento gnostico che sostiene un’assoluta differenza di essere, non una semplice differenza di valore, ci colpisce come qualcosa di più «moderno» della posizione greca assunta da Plotino, che negli ordini estesi del mondo oggettivo riconosce un esempio più perfetto del nostro essere e garantisce al saggio e virtuoso un’affinità con questi molto più stretta di quella che lo unisce con l’imperfetto della sua stessa razza. Collocato in questa opposizione, nella quale condivide col cristianesimo una base comune, lo gnosticismo diviene visibile per ciò che realmente è: un fattore nella svolta storica della mentalità collettiva che abbiamo spesso sentito descrivere in modo puramente negativo come il declino dell’antichità, ma che è al tempo stesso il sorgere di una nuova forma dell’uomo. In ciò che critica, Plotino ci mostra una delle radici del nostro mondo.
NOTE AL CAPITOLO 9.
1. Eccone alcuni. Per le cose di ogni genere: disposizione, struttura, regola; conformità alla regola, ossia regolarità. Nella sfera pubblica: costituzione politica o legale; conformità a quella, ossia condotta o condizione legale. Nella sfera militare: disciplina, ordine di battaglia. Nella sfera privata: decenza, proprietà, decoro (l’aggettivo “cosmios” significa «di buon comportamento», il suo opposto, «sregolato»). Come riflesso sociale di qualità: onore, fama. Come forma di convenzione: etichetta, cerimoniale. Come forma di esibizione: ornamento, decorazione, specie nell’abbigliamento, da cui «fronzoli».
2. “Timaeus”, 30 B; 34 A. Riportiamo alcuni argomenti di Platone. «[Il creatore] era buono; e nella bontà non può sorgere gelosia in alcuna questione. Perciò, non avendo gelosia, egli desiderava che tutte le cose arrivassero ad essere il più possibile simili a se stesso… Desiderando, allora, che tutte le cose fossero buone, e per quanto possibile non imperfette, il dio prese tutto ciò che è visibile… e lo portò dal disordine all’ordine, poiché giudicava che l’ordine fosse il meglio per ogni verso… Egli trovò che… nessuna opera che sia senza intelligenza può mai essere meglio di una che ha intelligenza,… e inoltre che l’intelligenza non si può trovare che nell’anima. In virtù di tale ragionamento, quando formò l’universo, egli creò la ragione nell’anima e l’anima nel corpo, al fine che l’opera compiuta fosse per natura eccellente e perfetta quanto possibile. Questo, dunque, è ciò che dobbiamo dire… che questo mondo venne ad essere, per la provvidenza di dio, in tutta verità una creatura vivente con anima e ragione» (29 D – 30 C; trad. secondo F. M. CORNFORD, “Plato’s Cosmology”, London, 1952). Il lettore noterà che il ragionamento che nel racconto della Genesi si applica implicitamente all’uomo si applica qui al cosmo.
3. «Sarebbe strano pensare che l’arte della politica, o sapienza pratica, è la conoscenza migliore, dal momento che l’uomo non è la cosa migliore nel mondo… Ma se si dice invece che l’uomo è il migliore degli animali, non c’è differenza; perché ci sono altre cose nella natura molto più divine dell’uomo, per esempio, nella maniera più cospicua, i corpi di cui sono formati i cieli» (ARISTOT., Eth. Nic. VI, 7, 1141 a 21 s.; 33 s.; trad. secondo W. D. ROSS).
4. “Sapiens”, tradotto altrove con «saggio», in questa particolare fase dell’argomentazione (se Cicerone è coerente) sta per «intelligente» in genere.
5. CIC., “De Natura Deorum”, II, 11-14. Le sottolineature sono mie.
6. L’affermazione classica di questa posizione la si trova nelle Leggi di Platone. «Il governatore dell’universo ha ordinato tutte le cose in considerazione dell’eccellenza e della conservazione del tutto, e ciascuna parte, per quanto è possibile, ha azione e passione appropriate. Su queste, fino all’ultima porzione di esse, sono stati designati a presiedere dei ministri, che hanno realizzato la loro perfezione con esattezza infinitesimale. E una di queste porzioni dell’universo è la tua, uomo infelice, che per quanto piccola, contribuisce al tutto; e non sembra che tu sappia che questa e ogni altra creazione è stata fatta a causa del tutto e perché la vita del tutto sia felice; e che tu sei creato per il tutto e non il tutto per te. Perché ogni medico e ogni artista abile fanno ogni cosa per il tutto, dirigendo i loro sforzi al bene comune eseguendo la parte per il tutto, e non il tutto per la parte. E tu sei infastidito perché sei ignorante del fatto che ciò che accade a te e all’universo è il meglio per te, per quanto lo permettano le leggi della creazione comune» (“Leggi”, X, 903 B-D; trad. secondo Jowett).
7. Secondo il trattato pseudo-aristotelico “Sul cosmo” (di autore sconosciuto del primo secolo d.C.) questa è la vera definizione del compito della “filosofia”; nella contemplazione del Tutto, la filosofia «riconosce ciò che le è connaturale e con occhi divini contempla il divino» (cap. 1, 391 a 14). In unione all’affermazione di Cicerone che «l’uomo è nato per contemplare il Tutto», ciò significa: l’uomo è nato per essere filosofo! L’opera, che citeremo ancora, è uno dei più nobili documenti della pietà cosmica postclassica.
8. Come i giochi olimpici.
9. “Sul Sublime” (primo secolo d.C.), 25, 2.
10. E’ caratteristico tuttavia che il trattato “Sul cosmo” nello sviluppare il paragone tra l’universo e uno stato usi il modello di monarchia piuttosto che quello di repubblica: ved. al cap. 6 la trattazione particolareggiata del governo del Gran Re persiano e il parallelo col governo divino dell’universo.
11. Confronta “De mundo”, cap. 5, 397 a 8 s.: «Quale delle realtà individuali può uguagliare l’ordine che il sole, la luna e le stelle mostrano nella rivoluzione celeste, movendo in misura perfettamente accordata di eternità in eternità? E quale può compiere il moto infallibile che osservano le Ore, le buone, generatrici di tutte le cose, che con ordine preciso portano il giorno e la notte, l’estate e l’inverno, così da completare mesi e anni? Veramente, di tutte le cose il cosmo [qui = i cieli] è superiore in grandezza, più dolce nel movimento, più lucente nello splendore; il suo potere è immutabile e non passa mai».
12. Ibid., cap. 6, 397 b 27 s: «La sfera più vicina a Dio partecipa maggiormente del suo potere che quella al di sotto, e così via fino alle regioni abitate da noi. Perciò la terra e le cose terrestri, essendo più lontane dall’influsso di Dio, sembrano essere incostanti, disarticolate e piene di confusione». Questa versione della questione si adatta al monoteismo del “De mundo” che pone Dio (come Aristotele aveva posto la Mente) al di sopra delle Sfere: con una leggera variazione l’argomento è valido anche per il panteismo stoico.
13. Confronta ARISTOT., “Metafisica”, IX, 8, 1050 b 23 s.: «E così il sole e le stelle e tutto il cielo sono sempre attivi, e non c’è timore che possano mai arrestarsi, come temono i filosofi naturalisti. E non si stancano in questa attività; perché il movimento non è da loro, come avviene per le cose periture, legate alla potenzialità per gli opposti, cosicché la continuità del movimento debba essere faticosa; perché è quel genere di sostanza che è materia e potenza, non attualità, che ne è causa» (trad. secondo Ross).
14. Confronta PLAT., “Leggi”, X, 898 C: «… ci sarebbe empietà nell’affermare che qualche altra cosa che non l’anima perfettissima, o le anime, porta in giro i cieli» (trad. secondo Jowitt). L’idea fu sviluppata da Aristotele.
15. «Essi tutti insieme, cantando in accordo e muovendo intorno al cielo con la loro danza uniforme, sono uniti in un’armonia la cui causa è una sola (Dio) e il cui fine è uno solo (il cosmo): è questa armonia che autorizza a chiamare il Tutto ‘ordine’ e non disordine» (“De mundo”, cap. 6, 399 a 12 s.).
Capitolo 10.
VIRTU’ E ANIMA NEL PENSIERO GRECO E GNOSTICO.
a) Il concetto di virtù: sua assenza nello gnosticismo.
Tra le critiche che Plotino muove contro gli Gnostici (che si riferiscono tutte a ciò che in essi è tipicamente non-ellenico) c’è quella di non avere una teoria sulla virtù; ed egli sostiene che ciò è da attribuirsi al loro disprezzo del mondo.
«Questo punto non deve sfuggire alla nostra attenzione: quale influenza i loro insegnamenti abbiano sulle anime degli ascoltatori e di coloro che sono persuasi da essi a disprezzare il mondo e quanto contiene… La loro dottrina, anche più audace di quella di Epicuro [il quale ha solo “negato” la provvidenza], “dando colpa” al Signore della provvidenza e alla provvidenza stessa, disprezza tutte le leggi di quaggiù e la virtù che è sorta tra gli uomini fin dall’inizio del tempo, e mette in ridicolo la temperanza, “di modo che niente di buono può trovarsi in questo mondo”. Così la loro dottrina annulla la temperanza e la giustizia, innate nel carattere umano e perfezionate dalla ragione e dall’esercizio, e in generale tutto ciò per cui l’uomo può diventare degno e nobile… Perché delle cose di quaggiù “niente” è nobile per essi, tranne qualcosa di ‘diverso’ che raggiungeranno ‘nella vita futura’. Ma non dovrebbero coloro che hanno raggiunto la ‘conoscenza’ [“gnosis”] cercare il Bene fin da quaggiù e cercandolo per prima cosa mettere in ordine le cose qui, appunto perché essi [gli Gnostici] pretendono di essere derivati dall’essenza divina? E’ infatti della natura di tale essenza di considerare ciò che è nobile… Ma coloro che non partecipano della virtù nulla hanno che li trasporti da quaggiù alle cose dell’aldilà.
E’ rivelatore che la loro condotta non ricerchi affatto la virtù e che la trattazione di tali cose sia totalmente assente dai loro insegnamenti: essi non indagano su ciò che è la virtù e su quante specie ve ne siano, e neppure sono informati sulle molte e preziose cognizioni che si possono trovare negli scritti degli antichi, né essi mostrano come abbia origine la virtù e come sia possibile acquisirla, né come tendere a purificare l’anima. Perché il dire semplicemente: ‘Guarda verso Dio’ non è di alcun vantaggio senza l’insegnamento sul “come” guardare. Che cosa impedisce, qualcuno potrebbe dire, di guardare Dio e non astenersi dai piaceri e dominare l’emozione violenta? o dal ricordare il nome di Dio e tuttavia restare in potere delle passioni?… Di fatto soltanto la virtù può rivelarci Dio, a mano a mano che progredisce e diviene reale nell’anima insieme con l’intuizione. Senza vera virtù, Dio rimane una parola vuota» (Enn. II, 9, 15).
La polemica è molto istruttiva. Mette in evidenza molto più che una semplice omissione da parte degli Gnostici. L’assenza di una dottrina sulla virtù nell’insegnamento gnostico è collegata all’atteggiamento anticosmico, cioè al negare ogni valore alle cose di questo mondo e di conseguenza alle azioni dell’uomo in questo mondo. La virtù in senso greco (“areté”) è l’attualizzazione per modo di eccellenza delle molteplici facoltà di cui l’anima è fornita per trattare col mondo. Facendo le cose giuste nel modo giusto al tempo giusto, l’uomo non soltanto compie il suo dovere verso i concittadini e la città, ma promuove anche il bene della sua anima mantenendola nella forma di eccellenza, come il correre mantiene in forma un cavallo di razza, mentre nello stesso tempo è ciò per cui si deve essere in forma. Così «l’azione secondo virtù» è mezzo e fine nello stesso tempo. Il bene del cavallo di razza e il bene dell’uomo sono assai differenti ma entrambi sono il bene dei loro soggetti fondamentalmente nello stesso senso: ciascuno rappresenta in termini di “attività” lo “stato” più perfetto del soggetto secondo la natura innata. Nel caso dell’uomo tale natura implica una gerarchia di facoltà, di cui la più elevata è la ragione. Il suo essere «naturalmente» superiore alle altre facoltà dell’uomo non significa che tale superiorità sia accordata nella vita attuale di una persona. La virtù perciò, sebbene perfezioni la «natura» intesa come la vera natura umana, non è presente per natura, ma richiede istruzione, sforzo e scelta. La giusta maniera delle nostre azioni dipende dalla giusta forma delle nostre facoltà e disposizioni, e ciò quando di fatto prevalga la gerarchia «naturalmente» vera. Comprendere quale sia la gerarchia naturale e la posizione della ragione in essa è di per sé un atto di ragione; perciò coltivare la ragione fa parte della virtù. In altre parole, sta all’uomo trasformare la natura ricevuta in modo incoativo nella sua vera natura, perché solo nel suo caso la natura non realizza automaticamente se stessa. Questa è la ragione per cui la virtù è necessaria sia “per” la piena realizzazione che “come” piena realizzazione dell’essere umano. Poiché questo essere è un essere nel mondo insieme ad altri esseri umani, nel contesto delle necessità e interessi determinati da tale situazione, l’esercizio della virtù si estende a tutte le relazioni naturali dell’uomo come parte del mondo. Egli è tanto più perfetto in se stesso quanto più perfettamente è la parte che deve essere; ed abbiamo visto precedentemente quanto questa idea di perfezione individuale sia collegata all’idea di cosmo come il tutto divino.
E’ chiaro che nello gnosticismo non c’è posto per una simile concezione della virtù umana. «Guardare a Dio» ha per esso un significato totalmente diverso da quello che aveva per i filosofi greci. Qui significava rispettare i diritti di tutte le realtà come espressioni graduali del divino nell’ambito della divinità che comprende l’universo. L’elevazione di sé nella scala dell’essere per mezzo di sapienza e virtù non implicava il rinnegare i livelli superati. Per gli Gnostici, «guardare a Dio» significa appunto tale rinnegamento: è un saltare al di là delle realtà interposte, che per questa diretta relazione non sono altro che legami ed ostacoli, o tentazioni che distraggono, o, tutt’al più, realtà irrilevanti. La somma di queste realtà interposte è il mondo, compreso il mondo sociale. L’interesse eminente per la salvezza, l’occuparsi esclusivamente del destino dell’io trascendentale, «snatura», per così dire, tali realtà e distacca il cuore da esse quando è inevitabile occuparsene. Un’essenziale riserva mentale caratterizza la partecipazione nelle cose del mondo, e persino la propria persona, in quanto implicata in tali cose, è vista dalla distanza dell’aldilà. Questo è lo spirito comune nella nuova religione trascendentale, che non si trova solo nello gnosticismo. Ricordiamo al lettore le parole di san Paolo:
«Questo io dico, o fratelli: il tempo è breve, e resta che anche quelli che hanno moglie siano come non l’avessero; e quei che piangono come non avessero motivo di pianto; e quelli che sono allegri, come non lo fossero; e quelli che comprano, come non dovessero conservare gli acquisti fatti; e quelli che si servono di questo mondo, come quelli che non ne usano; poiché passa la figura di questo mondo» (1 Cor. 7, 29-31).
Il mondo e la propria appartenenza ad esso non vanno presi seriamente. Ma la virtù è serietà nell’esecuzione dei diversi modi di appartenenza ed è prendere seriamente se stessi nell’aderire alle esigenze del mondo, cioè dell’essere. Se come nel platonismo il mondo non è identico al vero essere, tuttavia è un’introduzione ad esso. Ma il «mondo» del dualismo gnostico non è nemmeno ciò. E come dimensione dell’esistenza non offre all’uomo occasione di perfettibilità. Il meno dunque che l’atteggiamento acosmico produce in rapporto all’esistenza inframondana è la riserva mentale del «come-se-non».
Ma il dualismo gnostico va oltre tale posizione spassionata. Perché considera l’«anima» stessa, l’organo spirituale dell’appartenenza dell’uomo al mondo, non meno che il suo corpo, come un’effusione dei poteri cosmici e perciò come uno strumento del loro dominio sul vero io, per quanto sommerso. Come «rivestimento terrestre del pneuma», l’«anima» è l’esponente del mondo all’interno dell’uomo: il mondo è nell’anima. Una profonda sfiducia, perciò, della propria interiorità, il sospetto di inganno diabolico, il timore di essere ridotti in schiavitù, ispirano la psicologia gnostica. Le forze alienanti sono situate nell’uomo stesso in quanto composto di carne, anima e spirito. Il disprezzo del mondo inteso radicalmente include il disprezzo della “psyche”. Perciò ciò che è della “psyche” non può essere elevato alla condizione di virtù. Non c’è che abbandonarla a se stessa, al gioco delle sue forze e appetiti, oppure ridurla per mezzo della mortificazione; o qualche volta estinguerla nell’esperienza estatica.
L’ultima affermazione indica che l’atteggiamento negativo verso il mondo, o la qualità negativa del mondo stesso, sebbene non faccia posto alla virtù in senso greco, pure lascia aperta la scelta tra parecchi modi di condotta in cui la negatività è volta in principio di prassi. Nella misura in cui tali forme di condotta sono poste come norme ed esprimono il «si deve» gnostico, rappresentano in concreto ciò che può essere chiamato la morale gnostica. In tale contesto può persino riapparire la «virtù»; ma il significato del termine è allora radicalmente mutato, e così pure il contenuto materiale delle virtù particolari. Daremo alcuni esempi dei vari tipi di morale gnostica e del genere di «virtù» piuttosto paradossale che essa ammette; e potremo occasionalmente spostarci oltre il campo strettamente «gnostico», perché la dissoluzione e il travisamento del concetto classico di areté è un fenomeno molto vasto collegato al sorgere dell’acosmismo o della religione trascendentale in genere.
b) La morale gnostica.
L’elemento negativo che abbiamo finora sottolineato, rappresenta naturalmente solo un lato della condizione gnostica. Proprio come il cosmo non è più il Tutto, ma è sorpassato dal regno divino che è al di là, così l’anima non è più l’intera persona, ma è superata dal pneuma acosmico che è all’interno: qualche cosa di molto differente dalla «ragione» e dall’«intelletto» dell’insegnamento greco. E come il profondo pessimismo cosmico è contrapposto all’ottimismo della certezza escatologica, così il profondo pessimismo psicologico, che dispera dell’anima in quanto schiava del cosmo, è contrapposto alla confidenza presuntuosa nella libertà, in definitiva inattaccabile, del pneuma. E se la contrapposizione del cosmo con tutto quello che non è cosmo, significa che c’è un’evasione dalla prigionia del primo, così la dualità interiore di «anima» e «spirito», ossia la presenza interna di un principio trascendente, che è indefinibile per la sua differenza da tutto ciò che è «mondano», offre la possibilità di spogliarsi della propria anima e sperimentare la divinità dell’io assoluto.
– Nichilismo e libertinismo.
La più assoluta e radicale espressione della rivolta metafisica è il nichilismo morale. Nella critica di Plotino era implicata l’indifferenza morale degli Gnostici, cioè non soltanto l’essenza di una dottrina sulla virtù, ma anche la noncuranza di ritegni morali nella vita pratica. La polemica dei Padri della Chiesa ci dice qualche cosa di più sulla teoria o metafisica di ciò che è noto come libertinismo gnostico. Citiamo da Ireneo:
«Gli uomini psichici sono istruiti nelle cose psichiche, sono irrobustiti dalle opere e dalla semplice fede e non possiedono la perfetta conoscenza. Così siamo noi della Chiesa (secondo loro). Perciò per noi, essi affermano, è necessaria per la salvezza una vita morale. Essi stessi, tuttavia, sarebbero salvi, secondo il loro insegnamento, in modo assoluto e in qualsiasi circostanza, non per le opere, ma per il semplice fatto di essere ‘spirituali’ per natura. Perché, come è impossibile che l’elemento terreno partecipi della salvezza, non essendo suscettibile di essa, così è impossibile che l’elemento spirituale (che essi pretendono di essere) soffra la corruzione, qualunque siano le azioni in cui si sono compiaciuti. Come l’oro immerso nella sporcizia non perde la sua bellezza, ma conserva la sua natura propria, e la sporcizia non è in grado di deteriorare l’oro, così niente può recar loro danno, anche se le loro azioni li immergono nella materia, perché nulla può cambiare la loro essenza spirituale. Perciò ‘il più perfetto’ di loro compie senza vergogna tutte le cose proibite di cui la Scrittura ci assicura che ‘coloro che fanno tali cose non erediteranno il regno di Dio’… Altri servono con intemperanza i desideri della carne e dicono che bisogna dare carne alla carne e spirito allo spirito» (Adv. Haer. I, 6, 2-3).
In questo brano ci sono molti argomenti importanti. Uno è fondato sull’idea di nature o sostanze invariabili, e secondo tale argomento il pneumatico è «salvato naturalmente», cioè è salvato per virtù della sua natura. La conseguenza pratica di ciò è la massima dissolutezza, che permette al pneumatico l’uso indiscriminato del regno naturale. La differenza all’interno del mondo tra buono e cattivo è stata sommersa nell’indifferenza essenziale di tutto ciò che è cosmico nei confronti del destino dell’io acosmico. Ma l’indifferenza non è la storia completa del libertinismo gnostico. L’ultimo periodo nel passo di Ireneo suggerisce già un’ingiunzione positiva dell’eccesso. Prima di passare a questa strana dottrina dell’immoralismo gnostico su base religiosa, dobbiamo stabilire con maggiore ampiezza la posizione di indifferentismo.
L’unica cosa a cui il pneumatico è legato è il regno della divinità transmondana, trascendenza del genere più radicale. Tale trascendenza, a differenza del «mondo intelligibile» del platonismo o del Signore del mondo del giudaismo, non ha alcuna relazione positiva col mondo sensibile. Non è l’essenza di questo mondo, ma ne è la negazione e la cancellazione. Il Dio gnostico, in quanto distinto dal demiurgo, è il totalmente differente, l’altro, lo sconosciuto. In lui l’assoluto che è al di là trasparisce attraverso gli involucri cosmici che lo racchiudono. E poiché questo Dio ha più del “nihil” che dell'”ens” nel suo concetto, così anche la sua copia umana, l’Io acosmico o pneuma, altrimenti nascosto, si rivela nell’esperienza negativa di alterità, di non-identificazione e di proclamata indefinibile libertà. Comunque si consideri la relazione dell’uomo con la realtà esistente, sia il Dio nascosto che il pneuma nascosto appaiono concezioni nichilistiche: non emana da essi alcun “nomos”, cioè nessuna legge sia di natura che di condotta umana come parte dell’ordine naturale. C’è certamente una legge di creazione, ma ciò che è straniero nell’uomo non deve alcuna fedeltà a colui che ha creato il mondo; e né la sua creazione, sebbene circondi l’uomo in modo incomprensibile, né la sua proclamata volontà offrono le norme con le quali l’uomo isolato può fissare il suo cammino. Ne consegue l’argomento antinomico degli Gnostici, in quanto puramente “negativo”: come tale non stabilisce altro che le norme del regno non-spirituale non sono obbliganti per colui che è dello spirito.
A questo proposito troviamo talvolta nel ragionamento gnostico l’argomento “soggettivistico” dello scetticismo morale tradizionale: nulla è naturalmente buono o cattivo, le cose in se stesse sono indifferenti e «solamente secondo il giudizio umano le azioni sono buone o cattive». L’uomo spirituale nella libertà della sua conoscenza può usare di tutte indifferentemente (Iren., op. cit. I, 25, 4-5). Sebbene ciò richiami il ragionamento di certi Sofisti classici, una più profonda riflessione gnostica sulla “sorgente” di tali «opinioni umane» trasforma l’argomento da scettico a metafisico, e muta l’indifferenza in opposizione: la sorgente ultima non è umana ma demiurgica, e perciò comune con quella dell’ordine di natura. In ragione di questa sorgente la legge non è in realtà indifferente, ma è parte del grande disegno formato contro la nostra libertà. Essendo legge, il codice morale non è che il complemento psichico della legge fisica, e come tale è l’aspetto interno della regola cosmica che tutto pervade. Entrambe le leggi emanano dal signore del mondo come agenti del suo potere, unificate nel doppio aspetto del Dio giudaico creatore e legislatore. Come la legge del mondo fisico, l'”heimarméne”, integra i corpi individuali nel sistema generale, così fa la legge morale per le anime, rendendole strumenti nello schema demiurgico.
Perché, che cos’è la legge – sia rivelata per mezzo di Mosè e dei profeti sia operante nelle abitudini reali e nelle opinioni degli uomini – se non il mezzo di regolare e stabilizzare l’uomo negli affari del mondo e negli interessi mondani; di mettere con le sue regole il sigillo di serietà, di lode e di biasimo, ricompensa e punizione, sul suo totale impegno; di fare della sua volontà una parte condiscendente del sistema costrittivo che così funzionerà in modo tanto più liscio e inestricabile? Per quanto il principio di questa legge morale è giustizia, ha lo stesso carattere di obbligo sulla parte psichica di quello che ha il fato cosmico sulla parte fisica. «Gli angeli che hanno creato il mondo stabilirono ‘giuste azioni’ per condurre l’uomo in schiavitù con tali precetti» (1). Nella legge normativa la volontà dell’uomo è guidata dagli stessi poteri che controllano il suo corpo. Colui che obbedisce ha abdicato l’autorità del proprio io. Abbiamo qui, oltre la pura indifferenza dell’argomento «soggettivistico» e oltre il privilegio puramente permissivo della libertà, un interesse metafisico positivo nel ripudiare fedeltà alle norme oggettive e perciò un motivo per la loro trasgressione. E’ il doppio interesse di affermare l’autentica libertà dell’io sfidando gli Arconti e di danneggiare la causa generale frustrando individualmente il loro disegno.
Anche questa non è la storia completa del libertinismo gnostico. Oltre il motivo di sfida, si trova talvolta che la libertà di fare qualsiasi cosa è trasformata in un “obbligo” positivo di compiere ogni genere di azioni, con l’idea di restituire alla natura ciò che le è proprio e così esaurirne i poteri. La dottrina, accennata brevemente nel passo di Ireneo che abbiamo citato (I, 6, 2-3), è esposta più ampiamente da lui nella trattazione di Carpocrate e dei Cainiti. Nel primo è unita alla dottrina della trasmigrazione e in tale combinazione l’amoralismo è il mezzo con cui viene raggiunta la libertà, piuttosto che la maniera in cui è posseduta.
«Le anime nella trasmigrazione di corpo in corpo devono passare attraverso ogni genere di vita e ogni tipo di azioni, a meno che qualcuno non abbia già compiuto tutto in una sola venuta… Secondo i loro scritti, le anime prima di partire dal corpo devono aver provato ogni modo di vita e non devono aver lasciato residuo di sorta da compiere: altrimenti devono essere mandate di nuovo in un altro corpo perché qualche cosa manca ancora alla loro libertà. Gesù ha indicato ciò con le parole: ‘…Ti dico che tu non uscirai di là, finché tu non abbia pagato fino all’ultimo spicciolo’ (“Luca” 12, 59)… Ciò significa che egli non potrà essere liberato dal potere degli angeli che hanno fatto il mondo, ma dovrà sempre reincarnarsi finché non abbia compiuto tutte le azioni che ci sono nel mondo, e soltanto quando non ci sia più niente da compiere sarà libero di giungere a quel Dio che è al di sopra degli angeli creatori del mondo. Così le anime sono liberate e salvate… dopo che hanno pagato il loro debito e reso il dovuto» (Iren. I, 25, 4; confronta Eus., “Hist. eccl.” IV, 7).
E a proposito dei Cainiti Ireneo dice:
«In nessun altro modo si può essere salvi fuorché passando attraverso tutte le azioni, come insegna anche Carpocrate… Un angelo è presente ad ogni fatto peccaminoso e infame, e colui che lo commette… si rivolge a lui per nome e dice: ‘O angelo, sfrutto il tuo agire! O tu Potenza di N. N., compio la tua opera!’. E questa è la perfetta conoscenza che non ha paura di deviare in quelle azioni che sono addirittura innominabili» (Iren. I, 31, 2).
L’idea che nel peccare si porta a termine una specie di programma, un debito pagato come prezzo della libertà definitiva, è il sostegno dottrinale più potente della tendenza libertinistica inerente alla ribellione gnostica come tale e la trasforma in prescrizione positiva di immoralismo. Il peccato come via di salvezza, l’inversione teologica di peccato stesso: uno degli antecedenti del satanismo medievale, e, anche, un archetipo del mito di Faust. D’altra parte, la combinazione in Carpocrate di questa dottrina col tema della trasmigrazione rappresenta un curioso adattamento dell’insegnamento pitagorico e forse anche della dottrina del “karma” indiano, dove la liberazione dalla «ruota delle nascite» è l’interesse dominante, sebbene in uno spirito molto diverso.
Possiamo mettere in dubbio con Ireneo che i predicatori di tale concezione vivessero in conformità con la loro professione. Scandalizzare è sempre stato l’orgoglio dei ribelli, ma gran parte di esso può essere soddisfatto con la provocazione della dottrina piuttosto che dei fatti. Tuttavia non dobbiamo sottovalutare gli estremi a cui la sfida rivoluzionaria e la vertigine della libertà possono arrivare nella mancanza di qualsiasi valore creata dalla crisi spirituale. La scoperta stessa di una nuova prospettiva che invalida tutte le norme precedenti costituiva una condizione anarchica, e gli accessi di pensiero e di vita erano la prima risposta al significato e alle dimensioni di tale prospettiva.
– L’ascetismo, la rinunzia di sé e la nuova «virtù».
Il libertinismo ha un’alternativa nell’ascetismo. Per quanto opposti siano questi due tipi di condotta, essi tuttavia nel caso gnostico hanno la stessa radice, e lo stesso argomento fondamentale è di sostegno ad entrambi. L’uno rifiuta obbedienza alla natura per mezzo dell’eccesso, l’altro per mezzo dell’astensione. Sono tutte e due maniere di vivere all’infuori delle norme del mondo.
Libertà da abuso e libertà da non-uso, equivalenti nell’indiscriminatezza, sono soltanto espressioni alternative dello stesso acosmismo. Il libertinismo era l’espressione più insolente della rivolta metafisica, che si esprime in una bravata: il massimo di disprezzo per il mondo consiste nel non considerarlo affatto, nemmeno come un pericolo o un avversario. L’ascetismo riconosce il potere corruttore del mondo: prende sul serio il pericolo di contaminazione ed è perciò animato più da paura che da disprezzo. Ed anche nell’estremo del negativismo, la vita ascetica può essere considerata produttrice di una qualità positiva – la purezza – e perciò già “realizzatrice” in certo modo del futuro stato di salvezza nella condizione presente. Questo avviene specialmente ove l’ascetismo è praticato quasi come un metodo tecnico per preparare l’anima a ricevere l’illuminazione mistica in cui la consumazione ultima dell’aldilà è, per così dire, sperimentata in anticipo. Qui l’ascetismo è messo al servizio della santificazione e le qualità che conferisce al soggetto, sia esso un soggetto mistico nel senso che abbiamo detto o semplicemente morale, sono valide in se stesse; ossia, l’ascetismo ha relazione con la «virtù», se la si definisce in un senso nuovo immettendola nella cornice della struttura concettuale acosmica. Questo significato positivo tuttavia non è in nessun modo un aspetto necessario dell’ascetismo gnostico, come mostra Marcione con abbondante chiarezza: il suo argomento morale, come abbiamo visto (cap. 5, b), è interamente fondato sul tema del disprezzo e dell’inimicizia verso il mondo e non affida all’astensione dalle opere terrene il perfezionamento del soggetto. L’astensione è essenzialmente un fatto di rigetto e perciò è espressione della rivolta verso il creatore quanto l’indulgenza libertina.
Abbiamo incontrato l’atteggiamento ascetico in gran parte dei testi citati nei precedenti capitoli e non occorre ripeterci. Per Marcione rinviamo alle p.p. 161 ss. (in nero), per Mani alle p.p. 247 s. (in nero). Questi due sono gli esempi più notevoli di un ascetismo rigido che è conseguenza pratica del nucleo essenziale della dottrina. Nel caso di Mani lo troviamo collegato col tema della compassione, che impone di aver riguardato alle particelle di Luce disperse nella creazione. Ma l’idea dell’impurità della sostanza cosmica è presente con altrettanta forza, cosicché, qualunque sia la parte di «compatimento», il rifiuto è un fattore essenziale della vita ascetica.
Non in tutti i casi la tendenza ascetica raggiunge il rigore estremo che abbiamo visto in questi due autori. L’atteggiamento acosmico si può esprimere mettendo la sordina a tutti i rapporti con le cose del mondo, riducendone l’impero sull’anima e mantenendo una cauta distanza da esse. «Non amate l’oro e l’argento e il possedere di questo mondo»; «Non siate un figlio della casa… non amate ghirlande dal piacevole profumo, e non prendete piacere in una bella donna… non amate la concupiscenza, né le ombre ingannevoli»: così leggiamo nelle fonti mandee citate al cap. 2, m, e il senso generale di queste ingiunzioni è espresso dalle parole: «Tu non sei di quaggiù, e la tua radice non era di questo mondo» (G 379). Perciò la posizione acosmica si esprime in una moralità di ritiro dal mondo che sviluppa un suo codice di «virtù» negative.
Non è un fatto occasionale che, mentre la versione libertina della moralità gnostica era rappresentata da tipi decisamente esoterici, gli esempi della versione ascetica sono presi da ciò che possiamo chiamare i tipi esoterici dello gnosticismo. Sia Marcione che Mani intesero fondare una chiesa generale, non una minoranza di iniziati; il mandeismo, per quanto sia rimasto numericamente piccolo, era una religione comunitaria a struttura popolare. L’anarchia non è compatibile con l’istituzione in quanto tale ed ogni fondazione religiosa condurrà nella direzione della disciplina. Per certi rispetti la chiesa assume le funzioni della “polis”; idealmente aspira ad essere una “civitas” che comprende tutto, in questo mondo, sebbene non di questo mondo, e che sostituisce la “civitas” secolare nel regolare la vita dei suoi membri. Il che fa sorgere necessariamente un canone di «virtù» appropriate allo scopo di queste nuove società. In breve, la salvezza divenuta istituzione, ossia l’idea stessa di «chiesa», favorisce la disciplina della moralità ascetica al di sopra di una comprensione letterale dell’ideale di libertà pneumatica, che la posizione anticosmica come tale suggerisce. Le conclusioni letterali erano tratte solo dai settari, che in modo deciso consideravano se stessi come tali. Gli Gnostici cristiani citati da Ireneo come sostenitori di vedute libertine consideravano la «libertà» come loro esclusivo privilegio da non potersi concedere ai membri ordinari della Chiesa, quelli di «fede semplice». Ed anche all’interno delle sètte ve n’erano probabilmente molti, come gli Encratiti e gli Ebioniti, che nonostante mettessero l’accento sulla differenza tra gli iniziati e la gente comune sceglievano l’alternativa ascetica della posizione anticosmica. In genere possiamo ritenere che, tranne un breve periodo di estremismo rivoluzionario, le conseguenze pratiche delle vedute gnostiche fossero più spesso in direzione dell’ascetismo che del libertinismo. In fin dei conti, la ribellione (e il libertinismo gnostico era l’espressione impudente di una ribellione contro una tradizione culturale non meno che contro il demiurgo) non è uno stato che possa essere mantenuto indefinitamente. Viene meno quando la nuova visione ha creato la propria tradizione.
– «Areté» e le «virtù» cristiane.
La negazione della statura naturale nell’uomo e di conseguenza dell’«eccellenza» (virtù) raggiungibile per mezzo del suo sviluppo, è universale nel clima di opinione acosmica. Sotto questo aspetto gli Gnostici sono parte di una più vasta corrente che minò e infine travolse la posizione classica. Il lettore cristiano si trova su terreno familiare; egli rievocherà immediatamente le «virtù» e i vizi corrispondenti che si possono ricavare dalle ammonizioni del Nuovo Testamento. Umiltà, modestia, sopportazione, pazienza, anche timore e afflizione, vengono lodate; orgoglio, vanagloria, fantasia, «tutto quello che s’esalta contro la conoscenza [“gnosis”] di Dio», sono riprovati (2). La prima epistola di Giovanni (2, 15-16; vedere a p. 91 in nero) mostra chiaramente l’inquadratura anticosmica dell’orientamento etico. Queste maniere di condotta, la cui qualità comune è l’umiltà, possono essere chiamate virtù di rinnegazione di sé: il sé rinnegato è quello dell’uomo naturale. Esse hanno, è vero, il loro complemento positivo nella fede, speranza e carità. Ma sebbene queste tre siano state di fatto chiamate in seguito «virtù» e come tali aggiunte alle quattro «virtù cardinali» degli antichi, è evidente che giudicate secondo il significato originale del termine possono essere chiamate così solo in un senso paradossale. Perché invece di confermare la personalità nel suo valore autonomo, esse presuppongono la radicale incapacità dell’uomo a raggiungere la propria perfezione e includono nel loro stesso significato il riconoscimento di tale insufficienza, ossia la posizione negatrice di sé dell’umiltà. In verità, esse sono ugualmente la negazione dell'”areté” (3).
La relazione di tutte queste «virtù» col mondo al di là e la disistima dei valori naturali, compresa l’autonomia personale, sono abbastanza note da non richiedere ulteriore spiegazione. Per timore tuttavia che ciò sembri toccare unicamente la posizione cristiana e sia necessariamente legato alla dottrina del peccato originale e della salvezza per mezzo della Croce, porteremo a modo di disgressione il caso meno conosciuto di Filone Giudeo, nel quale possiamo osservare la trasformazione del classico concetto di “areté” in una trattazione che unisce le sue conclusioni alla tradizione filosofica. Vedremo allora che è in genere l’influenza della religione trascendentale che conduce a questa reinterpretazione del mondo etico.
– La virtù in Filone Giudeo.
Filone era troppo erede della tradizione stoica e platonica per non accordare un posto importante nel suo pensiero al concetto e al nome di “areté”. Ma come appare la virtù nella sua presentazione? Per prima cosa, Filone non si stanca mai di sottolineare che le virtù hanno origine nell’anima non per opera nostra, ma per intervento di Dio: esse penetrano nell’anima «dall’esterno», come egli dice, o «dall’alto», per la grazia divina e senza alcun contributo della persona. Soltanto Dio ne è l’autore. L’anima non ha eccellenza sua propria e può solo desiderarla (4). Ma nemmeno tale desiderio, né lo sforzo fatto per raggiungere la virtù, devono essere attribuite all’anima: anch’essi sono da attribuirsi a Dio, che «dà» l'”eros”, cioè la tendenza verso la virtù (5). Filone adopera varie immagini per descrivere la relazione tra l’attività divina e la ricettività umana, soprattutto quelle di seminagione e di generazione. Questa immagine mette in rilievo l’idea diffusa anche nel mondo gnostico, di una relazione quasi sessuale in cui l’anima è la parte femminile che concepisce ed è fatta pregnante da Dio. «Dio soltanto può aprire il seno delle anime, seminare in esse la virtù, renderle pregnanti, e far loro produrre la Bontà» (6). L’idea non è affatto greca, se si ricorda che il significato originario di areté implica attività della persona.
L’immagine riguarda non soltanto la “genesis” della virtù nell’anima, ma anche il modo di possederla. Perché, secondo Filone, la “consapevolezza” di questa origine dovrebbe (e questo «dovrebbe» è un nuovo imperativo etico) diventare elemento essenziale della virtù stessa, appunto nel suo aspetto negativo, ossia di non attribuzione alla persona, nella misura in cui tale riflessione di fatto costituisce la virtuosità della virtù, la quale, posseduta diversamente, non sarebbe affatto virtù. La riflessione in questione è quella sulla “nullità” dell’uomo (7). Ciò crea una situazione altamente paradossale per il significato di virtù. Le parecchie virtù primarie della tradizione etica, nonostante Filone le lodi alla maniera stoica, non consistono più nel loro contenuto intrinseco, poiché questo contenuto è diventato ambiguo. E’ piuttosto la maniera in cui l’io determina il suo rapporto con la loro presenza che diviene la vera dimensione di virtù e vizio in un senso nuovo. Il soggetto può attribuire la virtù a se stesso come proprio acquisto (e questo è il significato originario di “areté” come eccellenza): per Filone questa attribuzione a se stesso consuma, per così dire, il valore morale di quelle «virtù» e le perverte in vizi; piuttosto che modi di perfezionamento della persona, esse sono tentazioni per il fatto che possono essere prese come tali. «Egoista e ateo è il “nous” che pensa se stesso uguale a Dio e crede di agire mentre in realtà patisce. Perché è Dio che semina e pianta i beni nelle anime, è empio per il “nous” dire: Io pianto» (Leg. all. I, 49 s.s.; confronta III, 32 s.). Al contrario, l’io può rinunziare alla pretesa di attribuzione propria e riconoscere la sua essenziale insufficienza: e questa riflessione secondaria, o piuttosto l’atteggiamento generale che esprime, diviene l’oggetto reale del comando morale ed è “esso stesso considerato come «virtù»”, sebbene sia la negazione che esista una qualsiasi virtù dell’io. Così il significato stesso di “areté” viene tolto alle facoltà positive della persona e posto nella conoscenza della nullità. Confidenza nelle proprie potenze morali, ricerca della perfezione fondata su ciò, attribuzione a sé del raggiungimento della perfezione – aspetti integrali della concezione greca della virtù – sono considerati qui come il vizio dell’amore di sé e dell’orgoglio. Riconoscimento e confessione della propria incapacità, fiducia in Dio che accorda all’anima ciò che non può ottenere da se stessa, e riconoscimento dell’origine divina di ciò che è stato accordato: tutto ciò fa parte dell’atteggiamento della «virtù» come tale (8).
E’ caratteristico della posizione di compromesso di Filone tra il punto di vista greco e quello «nuovo» che egli aggiunga la «virtù» così definita alla lista delle virtù tradizionali che conserva di nome, mettendola in testa ad esse come se fosse dello stesso ordine, mentre in realtà invalida lo stato indipendente di tutte queste e diventa la sola condizione del loro valore; e altrettanto per il vizio corrispondente. Perciò «regina delle virtù», «la più perfetta tra le virtù», è la fede (9), che unisce il volgersi a Dio con il riconoscimento e il disprezzo della propria nullità (10). Nell’acquistare questa «virtù», l’uomo acquista tutte le altre virtù come suoi frutti. D’altra parte, «il vizio più odioso a Dio» è la vanagloria, l’amor proprio, l’arroganza, la presunzione, in breve, l’orgoglio di considerare se stesso come proprio padrone e reggitore e di fare assegnamento sulle proprie capacità (11).
Questa completa disintegrazione dell’ideale greco di virtù implica quella dei suoi fondamenti antropologici: «In noi stessi ci sono tesori di cattiveria, in Dio quelli del bene solamente» (Fug. et inv. 79). Mentre per i Greci da Platone a Plotino la via dell’uomo a Dio passava attraverso la perfezione morale della persona, per Filone passa attraverso la disperazione di sé nel riconoscere la propria nullità. «Conosci te stesso» è un elemento essenziale di entrambe le vie. Ma per Filone la conoscenza di sé significa «conoscere la nullità della razza mortale» (Mut. nom. 54), e attraverso questa conoscenza si giunge alla conoscenza di Dio: «Perché allora è il tempo per la creatura di incontrare il Creatore, quando ha riconosciuto la propria nullità» (Rer. div. her. 30). Conoscere Dio e disconoscere se stessi è una correlazione normale in Filone (12). Tra le immagini espressive che egli costruisce a questo riguardo (secondo l’allegoria scritturistica) c’è quella di «allontanarsi da se stessi»; e la favorita «sfuggire a se stessi e fuggire a Dio». «Colui che si allontana da Dio fugge verso se stesso… colui che sfugge al proprio “nous” fugge verso quello del Tutto» (Leg. all. III, 29; confronta ibid., 48).
Questa fuga da se stessi, oltre al significato etico che abbiamo finora considerato, può assumere un significato mistico, come nel passo seguente: «Allontanati (13) non soltanto dal tuo corpo… [«patria»] e dalla percezione dei sensi… [«consanguinei»] e dalla ragione… [«casa del padre»], ma fuggi anche da te stesso, e va’ fuori di te, delirante e posseduto da Dio come i Coribanti Dionisiaci» (Rer. div. her. 69; confronta ibid., 85). Su questa versione mistica del distacco da se stessi dobbiamo soffermarci nel contesto della psicologia gnostica.
c) Psicologia gnostica.
– L’interpretazione demonologica dell’interiorità.
Dopo questa digressione in un più vasto ambiente spirituale, ritorniamo nell’aera propria dello gnosticismo. La deplorazione dello stato naturale dell’uomo e dei suoi poteri, che troviamo come caratteristica generale nella nuova economia della religione trascendentale, è collegata nello gnosticismo con la metafisica dualistica e lo stato problematico dell’anima in questo sistema. Mentre il monoteismo di Filone con la sua dottrina della creazione divina difettava di una vera teoria della derogazione, e il cristianesimo ne aveva una nella teoria del peccato originale, lo gnosticismo fondava il carattere ambiguo dell’anima e l’incapacità morale dell’uomo nella situazione cosmica come tale. L’asservimento dell’anima ai poteri cosmici deriva dalla sua stessa origine da questi poteri. E’ una loro emanazione; ed essere afflitto dalla psiche, o abitare in essa, fa parte per lo spirito della situazione cosmica. Il cosmo è per se stesso un sistema demoniaco: «non c’è parte del cosmo vuota di demoni» (C.H. IX, 3); e se l’anima rappresenta il cosmo nell’interiorità dell’uomo, ovvero per mezzo dell’anima «il mondo» è nell’uomo, allora l’interiorità dell’uomo diventa la scena naturale per l’attività demoniaca e il suo io è esposto al gioco di forze che non può controllare. Queste forze si può considerare che agiscano dall’esterno, ma possono agire così perché hanno il corrispettivo nella stessa costituzione umana, pronta a ricevere la loro influenza. Ed esse hanno un capo potente che si oppone all’influenza divina, separato com’è il sistema cosmico dal regno trascendente e avvolto com’è lo spirito dalla psiche. E’ pertanto condizione naturale dell’uomo di essere preda di forze estranee che tuttavia sono tanta parte di lui stesso, ed occorre l’intervento miracoloso della gnosi dal di fuori per dare la capacità al pneuma imprigionato di ritornare a ciò che gli è proprio. «Coloro che sono illuminati nella parte spirituale da un raggio della luce divina – e non sono che pochi – sono lasciati in pace dai demoni… tutti gli altri sono trascinati e mantenuti nelle loro anime e corpi dai demoni, amando e apprezzando le loro opere… Questo governo terreno è esercitato dai demoni attraverso gli organi del corpo, e tale governo è chiamato da Hermes ‘heimarméne’» (C.H. XV, 16).
Questo è l’aspetto interiorizzato del destino cosmico, che denota il potere del mondo come principio morale: in tal senso l'”heimarméne” è quel governo che le potenze cosmiche esercitano su di noi per mezzo di noi stessi e la sua manifestazione è il vizio umano di ogni genere, il cui principio comune non è altro che l’abbandono dell’io al mondo. Perciò l’esistenza nel mondo è essenzialmente uno stato di essere posseduto dal mondo, nel senso letterale, ossia demonologico del termine. In una fonte piuttosto tarda (14) troviamo, come termine di opposizione all’uomo spirituale, l’espressione «uomo demoniaco» invece dell’abituale «psichico» o «sarchico» (carnale). Ogni uomo, spiega il testo, è posseduto dalla nascita dal proprio demone, che soltanto il potere mistico della preghiera può espellere dopo l’estinzione di tutte le passioni. In questo stato di vuoto l’anima si unisce allo spirito come la sposa allo sposo. L’anima che non riceve Cristo in questo mondo resta «demoniaca» e diviene abitazione dei «serpenti». Per valutare esattamente la profonda frattura tra questa posizione e quella greca, basta richiamare la dottrina greca del «demone guardiano che è con noi fin dalla nascita» (15), e in genere paragonare il concetto depravato di «demone» nello gnosticismo e nel cristianesimo con quello classico, che denotava un essere superiore all’uomo nella gerarchia divina. La frattura è altrettanto profonda di quella tra le due concezioni del cosmo, di cui il concetto di demone è funzione diretta.
Come si vede, rimane poco dell’idea classica dell’unità e autonomia della persona. Contro l’orgogliosa e alquanto superficiale fiducia della psicologia stoica nell’io come padrone completo nella sua casa, che gode piena conoscenza di ciò che è e di ciò che vi capita, lo sguardo atterrito degli Gnostici vedeva la vita intima come un abisso dal quale sorgono potenze tenebrose per governare il nostro essere, non controllato dalla nostra volontà, tale volontà essendo strumento ed esecutrice di quelle potenze. Questa è la condizione fondamentale dell’umana insufficienza. «Che cosa è Dio? bene immutabile; che cosa è l’uomo? male immutabile» (Stob., “Ecl.” I, 277, 17). Abbandonata al turbine demoniaco delle proprie passioni, l’anima empia grida: «Brucio, ardo… sono consumata, misera me, dai demoni che mi possiedono» (C.H. X, 20). Anche l’esperienza contraria di libertà spirituale è esperienza di ricettività piuttosto che di attività: «La parte spirituale dell’anima è immune dalla schiavitù dei demoni ed è atta a ricevere Dio in se stessa» (C.H. XV, 15).
– L’anima come parte femminile.
Mantenendosi in questa concezione generale di vita intima, l’anima è spesso considerata come un ricettacolo occupato dalle diverse forze spirituali che combattono per il suo possesso. Valentino paragona il cuore umano ad un albergo dove tutti quelli che arrivano abitano, e dice: «In tal modo il cuore, finché non ha incontrato la provvidenza, è impuro essendo abitazione di molti demoni» (Clem. Alex., “Strom.” II, 20, 114). Basilide chiama l’uomo «un accampamento di molti spiriti diversi» (ibid., 113); e persino il filosofo neoplatonico Porfirio si esprime in tal guisa: «Dove prevale l’ignoranza di Dio, là necessariamente deve abitare il demone malvagio; perché come hai imparato, l’anima è un ricettacolo o degli dèi o dei demoni» (Ad Marc. XXI). Abbiamo visto che in Filone questo concetto della ricettività dell’anima porta all’immagine della sua funzione femminile in una relazione a due. In Filone l’immagine si riferisce soltanto ai rapporti dell’anima con Dio, perché la sua teologia biblico-giudaica non riconosce i demoni come un’alternativa a Dio. Nell’uso gnostico dell’immagine, pensieri buoni e cattivi sono tutti considerati come «concezioni» (rispettivamente) divine e demoniache dell’anima. «Lo spirito fa nascere tutti i pensieri, quelli buoni quando ha ricevuto i semi da Dio, quelli contrari da uno dei demoni, perché non c’è parte dell’universo vuota da qualche demonio… che entrando nell’anima può seminarvi il seme delle proprie opere» (C.H. IX, 3). Oltre tale aspetto pessimistico del concetto, troviamo l’immagine sessuale dell’anima in tutto il linguaggio della tarda pietà ellenistica, che è resa satura dallo spirito di religiosità soprannaturale. Il «matrimonio sacro» dei culti misterici è un esempio; e molte descrizioni cristiane dell’azione della grazia e della diffusione dello Spirito Santo nell’anima appartengono allo stesso genere di metafore.
– Illuminazione estatica.
L’illuminazione per mezzo del raggio di luce divina (v. p. 298 in nero) che trasforma la natura psichica dell’uomo può essere un articolo di fede, ma può anche essere un’esperienza. Codesta esperienza superlativa è talvolta affermata e persino descritta (più spesso desiderata e posta come fine) nella letteratura religiosa dell’epoca, dentro e fuori dello gnosticismo. Essa implica l’estinzione delle facoltà naturali, e il riempimento del vuoto con un contenuto oltremodo positivo e nello stesso tempo negativo nella sua ineffabilità. Annichilamento e deificazione della persona sono fuse nell’estasi spirituale che significa sperimentare la presenza immediata dell’essenza acosmica.
Nel contesto gnostico, questa esperienza trasfigurante faccia-a-faccia è la gnosi nel senso più alto e nello stesso tempo più paradossale del termine, poiché è conoscenza dell’inconoscibile. Finora abbiamo trovato che la gnosi significava una di queste cose: conoscenza dei segreti dell’esistenza come riferita nel mito gnostico, e questi comprendevano la storia divina per cui ha avuto origine il mondo, la condizione dell’uomo in esso e la natura della salvezza; poi, in modo più intellettuale, l’elaborazione di questi princìpi in un sistema coerente di speculazione; poi, in modo più pratico, la conoscenza della «via» della futura ascesa dell’anima e della retta via per preparare tale evento; e, in modo più tecnico o magico, la conoscenza dei sacramenti, delle formule efficaci e di altri mezzi strumentali per i quali viene assicurato il passaggio e la liberazione. Tutti questi generi interdipendenti di «conoscenza», teoretica o pratica, trasmettono informazione “riguardo” a qualche cosa e sono perciò differenti dal loro oggetto, da ciò che intendono promuovere (16).
La mistica “gnosis theoû” – visione diretta della divina realtà – è già un pegno della consumazione futura. E’ la trascendenza divenuta immanente; e sebbene sia preparata dagli atti umani di trasformazione dell’io che attuano la giusta disposizione, il fatto stesso è da attribuirsi all’attività divina e alla grazia. Perciò è altrettanto un «essere conosciuti» da dio quanto un «conoscerlo», e in questa reciprocità finale la gnosi va molto oltre la «conoscenza» propriamente detta. Come visione di un oggetto supremo può essere detta teoretica – di qui «conoscenza» o «cognizione»; come assorbimento, trasfigurazione, la presenza dell’oggetto può essere considerata pratica – di qui «apoteosi» o «rinascita»: ma né la qualità mediatrice della conoscenza…. né quella strumentale della prassi… valgono quando l’essere del conoscente è assorbito in quello dell’oggetto – il quale «oggetto» significa la cancellazione di tutto il regno degli oggetti.
L’«esperienza» dell’infinito nel finito non può che essere paradossale in tutti i sensi. Per sua stessa testimonianza in tutta la letteratura mistica, riunisce il vuoto e la pienezza. Illumina e acceca. Con una apparente, breve sospensione del tempo, è posta nell’esistenza per il fine di tutta l’esistenza: «fine» nel doppio senso negativo-positivo di cessazione di tutto ciò che è terreno e di termine in cui la natura spirituale giunge a compimento. A questo riguardo l’esperienza estatica presenta il duplice carattere del vero “eschaton” della religione escatologica trascendentale, che attira – illegittimamente, noi pensiamo – nell’ordine di vita temporale e nelle possibilità che si aprono ad essa. Possiamo chiamarlo un’anticipazione della morte, e di fatto viene spesso descritto con le metafore del morire.
Abbiamo visto (cap. 6 b, «L’ascesa dell’anima», p. 181 s.s.) che l’escatologia mitica descrive la futura ascesa dell’anima come un progressivo spogliamento durante la salita in alto attraverso le sfere cosmiche. E abbiamo detto allora che tale processo, che si immagina si svolga nella dimensione esterna dell’oggettività mitologica, era capace di interiorizzazione per cui la scala mitica era trasformata in quella mistica interiore. E’ la trasposizione dell’escatologia nell’interiorità che fornisce il concetto eminente di gnosi, di cui abbiamo parlato. L’esperienza culminante, in sé, è ineffabile, ma può essere circoscritta simbolicamente. Il processo che vi conduce ammette descrizione. Così il trattato ermetico della rinascita (C.H. XIII) descrive gli stadi attraverso i quali nelle condizioni mistiche l’anima astrale è dissolta e si genera l’io spirituale: ad uno ad uno i poteri demoniaci (provenienti dallo Zodiaco) (17) vengono espulsi dal soggetto e sostituiti dai «poteri di Dio» che discendono in lui mediante la grazia e progressivamente col loro ingresso «compongono» la persona nuova. L’iniziato, preparato asceticamente, è del tutto ricettivo anziché attivo. Col dissolversi dell’io precedente egli va al di fuori e al di là di se stesso in un essere differente. Il processo è portato al culmine e termina nell’esperienza estatica di deificazione.
Gran parte delle immagini e dei termini psicologici di tali descrizioni (che sono rare, come è comprensibile) derivano dal rituale delle religioni misteriche. Com’era il caso per l’argomento della «virtù», siamo qui in presenza di un fenomeno che lo gnosticismo ha in comune con la più vasta corrente religiosa dell’epoca. Di fatto, la vera elaborazione “concettuale” dell’idea di un’ascesa interiore che termina nell’estasi mistica, è opera di Plotino e della scuola neoplatonica dopo di lui – anticipata in una certa misura da Filone – ossia di una «filosofia» diventata mistica; e poco più tardi dei monaci mistici dell’Oriente cristiano (dove la base teoretica era derivata da Origene). In maniera meno raffinata, tuttavia, l’esperienza o idea di illuminazione pneumatica era precedente e in parte almeno un fenomeno gnostico. Il concetto stesso di potere salvifico della gnosi come tale, che supera quello della pura fede, suggerisce il ricorso ad un certo genere di dimostrazione interiore che per la sua natura esaltata pone il fatto della trasformazione e del possesso di una verità più alta al di fuori di ogni dubbio. E con la disposizione così diffusa ed intensa, non può essere mancata la reale occorrenza, in tutti i gradi, di tali esperienze che per loro stessa testimonianza potevano essere considerate come un incontro diretto proprio con l’assoluto trascendente. D’allora in poi il soggetto «ha conosciuto» Dio e «ha conosciuto» anche che egli era salvo.
Sono le conseguenze piuttosto che quelle «esperienze» stesse alquanto elusive – ossia ciò che poteva essere considerato l’effetto duraturo in una vita «riformata» – che possono parlarci, e non è possibile mettere in dubbio il fervore e l’emozione profonda delle due seguenti preghiere ermetiche di ringraziamento.
«Ti ringraziamo, con tutta l’anima e tutto il cuore tesi a te, o Nome ineffabile… che tu abbia mostrato a tutti noi la tua paterna bontà, amore e benevolenza, e un potere ancora più dolce nel concederci per mezzo della tua grazia mente, parola, gnosi: mente perché possiamo pensarti, parola perché possiamo lodarti, gnosi perché nella tua conoscenza possiamo rallegrarci.
Salvati dalla tua luce, ci rallegriamo che tu abbia mostrato te stesso a tutti noi, ci rallegriamo che tu ci abbia fatti buoni mentre siamo ancora nel corpo mediante la visione di te.
L’unica offerta di ringraziamento che l’uomo può presentarti è di riconoscere la tua grandezza. Siamo giunti a conoscerti, o luce della vita umana, siamo giunti a conoscerti, o luce della gnosi, siamo giunti a conoscerti, o seno pregnante del seme del Padre…
Nell’adorazione della tua grazia, non chiediamo altra grazia che tu ci conservi nella tua gnosi e che noi non manchiamo alla vita così acquistata» (Preghiera finale del “Logos Teleios”: pseudo-Apuleio, “Asclepius”, 41).
«Santo è Dio, Padre del Tutto, santo è Dio la cui volontà è compiuta dalle sue potenze, santo è Dio che vuole essere conosciuto ed è conosciuto dai suoi.
Santo sei tu che con la tua parola hai creato tutte le cose. Santo sei tu del quale tutta la natura è un’immagine, santo sei tu che la natura non esprime nelle sue forme.
Santo sei tu che sei più potente di ogni potenza, santo sei tu che superi ogni sublimità, santo sei tu che sei al di sopra di ogni lode.
Ricevi puri sacrifici spirituali da un cuore ed un’anima tesi verso di te, tu ineffabile, inesprimibile, nominabile col silenzio.
Esaudisci la mia preghiera che io non perda possesso della gnosi adatta alla nostra natura, e dammi a ciò la forza; e con la stessa grazia illumina quelli della mia razza, miei fratelli e tuoi figli, che sono nell’ignoranza.
Perciò confido in te e rendo testimonianza che entrerò nella vita e nella luce. Che tu sia lodato, o Padre, che il tuo Uomo desideri di essere santo [o: compiere opere sante] con te, dal momento che tu gli hai accordato pieno potere» (C.H. I, 31-32).
d) Conclusione: il Dio sconosciuto.
Il principio e la fine del paradosso che è la religione gnostica è il Dio sconosciuto in se stesso che, inconoscibile in linea di principio, perché «altro» da tutto ciò che è conosciuto, è tuttavia oggetto di conoscenza e domanda di essere conosciuto. Egli provoca altrettanto quanto frustra la brama di conoscerlo; si rivela nella mancanza di ragione e parola; e il resoconto dell’insuccesso fornisce il linguaggio per nominarlo. Egli che secondo Valentino è l’Abisso, secondo Basilide persino il «Dio che non è» (Hippol., “Refut.” VII, 20); la cui essenza acosmica nega ogni determinazione derivante dal regno terreno; la cui trascendenza trascende ogni sublimità postulata dall’estensione del mondo, toglie valore a tutti i simboli di lui così immaginati; il quale, in breve, sfida ogni descrizione in senso stretto – egli tuttavia è enunziato nel messaggio gnostico, comunicato nel discorso gnostico, predicato nella lode gnostica. La conoscenza stessa di lui è “conoscenza della sua inconoscibilità” (18); ciò che si predica di lui in tal modo è per via di negazione: nasce così la “via negationis”, la teologia negativa, la cui melodia risuonò qui per la prima volta come modo di confessare ciò che non poteva essere descritto, di qui si diffuse come coro potente nella pietà occidentale.
«Tu sei il solo infinito,
tu sei il solo profondo,
tu sei il solo inconoscibile,
tu sei colui che ogni uomo cerca ardentemente
ed essi non ti hanno trovato
e nessuno può conoscerti contro la tua volontà
e nessuno può nemmeno lodarti contro la tua volontà…
Tu sei il solo non-contenibile,
tu sei il solo non-visibile
e tu sei il solo non-sussistente»
(Inno gnostico, conservato in copto; confronta C. SCHMIDT, “Koptisch-gnostische Schriften”, 1905, p. 358).
«O tu al di là di tutte le cose
che altro si può trovare per chiamarti?
Come può la parola lodarti?
perché tu non puoi essere espresso da nessun discorso.
Come può la ragione abbracciarti?
perché tu non puoi essere compreso da nessuna mente.
Tu che sei il solo ineffabile
mentre tu hai generato tutto quello che si apre alla parola.
Tu che sei il solo inconoscibile
mentre tu hai generato tutto quello che si schiude al pensiero…
Fine di tutte le cose sei tu
e uno e tutti e nessuno;
non essendo né uno né tutti, a te sono dovuti tutti i nomi,
come ti chiamerò?»
(Versetti iniziali di un inno di Gregorio Nazianzeno; confronta E. NORDEN, “Agnostos Theos”, p. 78).
Nella voce di queste professioni il messaggio del Dio straniero risuona attraverso i secoli, libero da riferimenti polemici a un Demiurgo detronizzato. Il suo invito misterioso può ancora, e sempre, raggiungere il cuore dell’uomo che cerca Dio.
NOTE AL CAPITOLO 10.
1. Simon Mago: confrontare l’intero passo a p. 126 in nero (cap. 3).
2. Per esempio, Eph. 4, 1-2; Phil 2, 3; 2 Cor. 10, 5; Rom. 5, 3-4; 2 Cor. 7, 10; Ep. Barnab. 2, 2.
3. La parola stessa è raramente usata nell’Antico Testamento. Nelle epistole paoline, con il loro ricco vocabolario parenetico ricorre una volta sola, e senza particolare significato (Phil. 4, 8; l’altra sola ricorrenza in rapporto all’uomo è 2 Pet. 1, 5). Il silenzio stesso è significativo: la parola non si accorda con le intenzioni dei primi scrittori cristiani.
4. Confronta “Mut. nom.” 141, 258 s.
5. Confronta “Leg. all.” III, 136.
6. Ibid., 180. Nel paragrafo seguente l’immagine cambia: c’è la «virtù» a sua volta il cui seno Dio apre per seminarvi le buone azioni. Questa ripetizione dell’attività divina accentua la passività dell’anima fino all’esagerazione; confronta Cherub. 42 s.s.; Post. Cai. 133 s.; Deus immut. 5.
7. Sacr. Ab. et Cai. 55; Somn. I, 60.
8. Simbolizzata in Caino ed Abele, confronta “Sacr. Ab. et Cai.” 2 s.
9. Abrah. 270; Rer. div. her. 91.
10. Mut. nom. 155.
11. Somn. I, 211; Rer. div. her. 91.
12. Il seguente è un buon esempio delle variazioni frequenti di Filone su questo tema: «Quando Abramo conobbe di più, disconobbe di più se stesso per poter raggiungere la conoscenza perfetta del Vero Esistente. Questo è il procedimento naturale: chi comprende se stesso totalmente, rinunzia totalmente al nulla che scopre nella creazione, e colui che rinunzia a se stesso giunge a conoscere l’Esistente» (Somn. I, 60).
13. Il passo è un’esegesi di Gen. 12, 1: «Ora il Signore disse ad Abramo: ‘Lascia il tuo paese e la tua gente e la casa di tuo padre, e vai nella terra che io ti mostrerò’».
14. L'”Asceticon” dei Messaliani, una setta eretica monastica menzionata nella letteratura eresiologica dal quarto secolo d.C. in poi: ved. la ricostruzione e l’analisi delle loro credenze in REITZENSTEIN, “Historia Monachorum”, p. 197 s.s.
15. «Ciascuno ha con sé dalla nascita un demone come buon mistagogo della vita» (Menandro in AMMIAN. MARCELL., “Rer. gest.” XXI, 14, 4).
16. Questo veramente non si applica alla «conoscenza» speculativa dei Valentiniani, se è presa nel senso delle loro pretese speculative (v. p. 190 s.s. in nero). Si applica ad essa secondo i fatti attuali della conoscenza teoretica come tale.
17. Nell’astrologia egiziana i sette segni dello Zodiaco prendono il posto dei sette pianeti (astrologia babilonese) come simboli del governo cosmico – nella versione gnostica – della corruzione cosmica.
18. Anche per gli Eoni del Pleroma: ved. l’insegnamento valentiniano, p. 197 s. in nero.
Capitolo 11.
LE RECENTI SCOPERTE NEL CAMPO DELLO GNOSTICISMO*
La scoperta verso il 1945 a Nag Hammadi in Egitto (l’antica Chenoboskion) di ciò che probabilmente era stata la completa biblioteca sacra di una setta gnostica, è uno di quegli eventi sensazionali, nella storia della scienza storico-religiosa, che l’archeologia e il caso hanno fornito a profusione dall’inizio di questo secolo. Era stata preceduta nei primi anni del secolo (per parlare soltanto dei resti scritti) dal ritrovamento di scritti manichei a Turfan nel Turkestan cinese; dalla posteriore esumazione verso il 1930 a Fayum in Egitto di parti di una biblioteca manichea in lingua copta; e seguita a breve distanza dalla scoperta degli scavi del Mar Morto in Palestina. Se aggiungiamo a queste nuove fonti gli scritti mandei, il cui rinvenimento progressivo nella seconda metà del secolo è dovuto non tanto agli scavi degli archeologi o all’opera di pastori e contadini, quanto ai contatti con la setta stessa ancora vivente, seppure dimenticata, ci troviamo in possesso di una letteratura abbondante di «cause perse» di quei cinque secoli cruciali, dal primo secolo a.C. in avanti, durante i quali prendeva forma il destino spirituale del mondo occidentale: la voce di credi e le correnti di pensiero che, facendo parte di quel processo creativo, erano nutriti da esso e lo stimolavano, e che stavano per essere dimenticati nel consolidamento di fedi ufficiali che seguirono la confusione della novità e di una visione senza limiti.
A differenza dei ritrovamenti del Mar Morto, la scoperta gnostica di Nag Hammadi è stata contrastata dall’inizio e fino ad ora dalla disgraziata politica di ostacoli persistenti, da liti e, ancor peggio, da gelosie di studiosi e corsa alla precedenza, il cui risultato combinato è che quindici anni dopo il primo riconoscimento della natura dei documenti, soltanto due di 46 [49] (1) scritti sono stati pubblicati (2), altri tre sono stati completamente tradotti (3); e altri due [4] (4) sono utilizzabili da un papiro differente che li contiene, pubblicato non molto tempo fa nelle parti gnostiche, dopo essere stato per 60 anni nel Museo di Berlino (5). Per tutto il resto, su cui sono trapelate informazioni frammentarie nel corso degli anni, vedi la postilla al cap. 11, oltre alle descrizioni provvisorie, estratti e riassunti che si trovano nel libro di J. Doresse, “Les livres secrets des gnostiques d’Egypte” (6). Lo scopo di questo capitolo è di considerare tutto il corpo delle nuove scoperte, come è permesso al presente [nel 1963] e come è pertinente per la nostra trattazione generale del problema gnostico.
1. Osservazioni sulla biblioteca di Chenoboskion.
Facendo le debite riserve dettate dalla situazione attuale, ci domandiamo: Che cosa aggiungono le nuove scoperte (7) alla nostra conoscenza e comprensione dello gnosticismo cristiano? Non si può naturalmente dire che la nostra conoscenza per il passato fosse insufficiente. La testimonianza patristica è ricca ed è confermata da tutti i testi originali di recente scoperta (ossia testi conservati integralmente e non attraverso la dossografia). Inoltre, per quel che riguarda l’autenticità dell’informazione in genere, non è inutile ricordare che le nuove fonti, essendo tutte traduzioni (dal greco in copto), sono testimonianze dirette allo stesso titolo di quelle dei Padri greci (come, per esempio, la “Lettera a Flora” di Tolomeo) che riproducono gli stessi originali greci, anche se una più lunga lista di copisti interviene poi tra loro e il più antico manoscritto. Tale aspetto è facilmente dimenticato nell’euforia sull’età fisica degli scritti che sono capitati nelle nostre mani. Ma negli scrittori della Chiesa non si trovano molti riferimenti completi o estesi alla lettera (v. p. 58 in nero), mentre le opere copte originali, che finora costituivano la nostra fonte di informazione indipendente, non erano nel periodo classico di sviluppo eretico (secondo o terzo secolo d.C.), sul quale invece si soffermavano gli scrittori ecclesiastici. E’ di questo periodo che ora possediamo un’intera biblioteca (8): con ciò siamo realmente «contemporanei» dei critici cristiani, e questo rappresenta un vantaggio inestimabile.
A priori, e a parte le questioni dottrinali, si può dire che un così largo accrescimento di scritti originali ci permette un’esperienza più completa e viva dell’autentico sapore della letteratura gnostica, una visione più intima del lavorio e della maniera di comunicazione del pensiero gnostico, più di quanto possa trasmettere qualsiasi estratto dossografico o esposizione di contenuto dottrinale. Come è già avvenuto nel caso di documenti manichei, la forma e il tono della presentazione in tutta la sua estensione aggiunge una voce ben distinta al «contenuto» oggettivo, ai «temi», per così dire, che gli eresiologi a scopo di polemica potevano distaccare dal frastuono della loro polifonica trattazione: e si tratta di sostanza anche se ciò non sarà necessariamente a suo vantaggio. Se il quadro diventa più oscuro anziché più chiaro, ciò fa parte della verità dell’argomento.
Inoltre, apprendiamo quale fosse il materiale di lettura di una comunità gnostica (9) del quarto secolo, forse tipica dell’area copta, ma anche, forse, molto al di là di essa. Dal peso relativo dei documenti dei Setiani nel complesso possiamo concludere che la comunità era setiana. Ma la presenza di molti scritti di affiliazioni assai differenti (10) mostra la larghezza di vedute, il sentimento di solidarietà, o la mutua compenetrazione, che deve essere stata la regola tra gli Gnostici. Sorprendente invero sotto questo aspetto è l’inclusione di cinque trattati ermetici in una collezione per altra parte gnostica «cristiana»: il che prova una prossimità, o almeno un sentimento di affinità percepito in quell’epoca, tra queste due correnti di speculazione, maggiore di quanto generalmente si attribuisca loro. D’altra parte, come fa notare Doresse (op. cit., p. 250), nessuno dei «grandi maestri eretici» della letteratura patristica «compare esplicitamente negli scritti di Chenoboskion», ossia nessuno è nominato come autore di scritti o menzionato in uno scritto. Da ciò tuttavia non si può dedurre, specie in un’epoca di letteratura di rivelazione che favorisce l’anonimità di autore o addirittura la pseudoepigrafia, che alcuni testi non possano essere dell’uno o dell’altro dei maestri conosciuti. Alcune congetture sono state presentate riguardanti l’attribuzione a Valentino o Eracleone delle parti fortemente valentiniane del Codice Jung; e Doresse crede di riconoscere «Simon Mago» in due trattati (op. cit., Appendice 1). In ogni modo l’assenza dei «grandi nomi» del secondo secolo non va presa nel senso di una diminuzione dell’importanza che la testimonianza patristica attribuisce loro (e quindi del valore di quella testimonianza); riflette semplicemente il livello intellettuale e le abitudini letterarie del gruppo di Chenoboskion e di quelli simili nel quarto secolo.
Quanto ai Setiani, nessun eresiologo attribuisce loro in alcun modo un maestro storico. Il loro stesso insegnamento è ora ampiamente documentato. La dottrina (iranica) delle «tre radici», ossia di un terzo principio primordiale intermedio tra Luce e Tenebra – che essi condividono con i Perati, Giustino, i Naasseni e altri – risulta chiara e in pieno accordo col resoconto di Ippolito. Naturalmente il relativo rilievo di questo tratto cosmogonico nella collezione di Chenoboskion – conseguenza del suo accento setiano – non è una ragione per vedere in esso qualcosa di più di una caratteristica del tutto specifica, particolare di un gruppo di insegnamenti, di quanto sia apparsa in precedenza. Nella speculazione sull’emanazione, sull’eone e la Sophia della gnosi «siro-egiziana», non si trova traccia di ciò; non è essenziale nemmeno alla stessa gnosi «iranica» a cui appartiene (come prova non soltanto Mani, ma molto prima di lui il sistema citato da Basilide – v. sopra, nota 10); ed anche nel caso dei Setiani la funzione speculativa del principio intermedio è di fatto irrilevante: il significato reale è dualistico e in generale il terzo principio fornisce – come «Spazio» – solo il terreno topologico di incontro degli opposti, oppure, nella descrizione sostanziale – come «Spirito» – è una forma attenuata (nonostante l’affermazione di condivisa primarietà) del principio superiore, suscettibile di mescolamento. Come mostrano le diverse alternative, tale capacità, che la speculazione gnostica esige, non richiede in realtà un principio originario separato.
In ragione della loro scarsa importanza sistematica – in quanto distinta dall’importanza per le questioni circa le affiliazioni storiche – non abbiamo citato nella nostra scelta dei miti gnostici (11) nessun esempio di questo tipo. Tuttavia la pubblicazione intera delle “Parafrasi di Shem”, la principale cosmogonia setiana della collezione (e la più lunga delle «rivelazioni» di tutta la biblioteca), può suggerire col tempo una nuova valutazione su questo punto (12).
Passiamo ora ad alcune osservazioni che possono essere provvisoriamente raccolte dal nuovo materiale e collegate alla documentazione anteriore. E’ sorprendente, come conferma e in parte rafforzamento di quest’ultima, la persistente ricorrenza di alcuni motivi i quali, per quanto già ben documentati, ricevono ora nuovo credito, come articoli fondamentali di fede, dal semplice peso della costanza numerica e persino verbale.
1. Rilevante tra questi motivi è il tema – familiare al lettore – che per brevità chiamerò «l’orgoglio del demiurgo», cioè la storia della sua ignoranza, perversità e presunzione. L’ubiquità di tale tema, con ripetizioni quasi invariabili delle sue formule in tutti gli scritti cosmogonici della collezione di Chenoboskion, è un fatto che colpisce, anche se non è sorprendente nella nuova fonte di informazioni: concorda con la testimonianza patristica fino alla lettera delle frasi che riportano: a) il pensiero del demiurgo che egli solo esiste e al di sopra di lui non c’è nulla; b) il suo vantarsi della creazione che termina nel grido: «Sono Dio e non c’è altro Dio all’infuori di me»; c) la sua umiliazione per il grido che viene dall’alto: «Ti sbagli (o ‘non mentire’)…! C’è sopra di te…». Questo gruppo di caratteristiche, già conosciute attraverso Ireneo (13), Ippolito (14), Epifanio (15), e attribuite da essi ad una varietà di sètte gnostiche, si trova in tutti i seguenti scritti della «biblioteca»: n. 27 (16), “Parafrasi di Shem” (Doresse, p. 149); n. 39, “Ipostasi degli Arconti” (17); n. 40, “Origine del mondo” (18); n.n. 2-7, “Libro sacro del Grande Spirito invisibile”, o “Vangelo degli Egiziani” (Doresse, p. 178); n. 4, “Sophia di Gesù” (19); n.n. 1-6-36, “Apocrifo di Giovanni” (20). Se non sbaglio, questi sono tutti i trattati cosmogonici della collezione che Doresse ha sunteggiato nel suo libro.
Alcuni particolari sono degni di nota. Riguardo a b): la dichiarazione da parte del demiurgo della sua arrogante pretesa assume sempre la forma di un’«esclamazione», nello stile inconfondibile dell’Antico Testamento nelle affermazioni che Dio fa di Sé (per es. Is. 45, 5; 46, 9; LXX), qualche volta aggiungendo alla professione di unicità quella di gelosia (21).
Tranne il particolare atteggiamento psicologico che si nota nell'”Apocryphon”, la caratteristica è nota dalle trattazioni patristiche ed appare ora chiaro che è una delle costanti di tutto quel tipo di cosmogonia gnostica in cui l’«inferiore» rappresenta una defezione dal «superiore» (22). L’animo antigiudaico di queste identificazioni trasparenti di Ialdabaoth (eccetera) col Dio giudaico è uno degli elementi da tener presenti nella formazione di ipotesi sulle origini dello gnosticismo.
Riguardo a c): il rimprovero che viene dall’alto, soprattutto da parte della madre Sophia, rivela al demiurgo, e a tutti i poteri inferiori in genere, l’esistenza del Dio supremo «che è al di sopra del Tutto» (“Sophia di Gesù”, BG 126, 1-5), disingannandolo e umiliando il suo orgoglio; ma la sua forma più espressiva è: «L’Uomo esiste [sopra di te = prima di te] e così pure il Figlio dell’Uomo» (23). Anche questa formula, che mostra l’«Uomo» elevato a divinità supercosmica, è nota dalla testimonianza patristica (per esempio Iren. I, 30, 6) e su questo punto alcuni dei sistemi citati giungono fino a identificarlo senz’altro col primo e supremo Dio (24), e così fanno alcuni, se non tutti i passi delle nuove fonti. Ora questa elevazione – che vada così lontano o no dell’«Uomo» a divinità transmondana, precedente e superiore al creatore dell’universo, o l’attribuzione di quel nome ad una tale divinità, è una delle caratteristiche più significative della teologia gnostica nella storia generale della religione, che unisce speculazioni tanto divergenti come quelle del “Poimandres” e di Mani.
Ciò significa una nuova posizione metafisica dell’uomo nell’ordine delle cose e l’avvertimento datone al creatore del mondo riporta questi al posto che gli compete. Se si aggiunge al concetto teologico il fatto che il nome stesso indica, ossia che l’uomo terrestre può identificare il suo essere intimo («spirito», «luce», eccetera) col potere sopracosmico e può perciò disprezzare i suoi oppressori cosmici e contare sul proprio trionfo finale su di essi, allora diviene chiaro, nella dottrina del dio Uomo e nella storia della creazione in particolare, che l’umiliazione del demiurgo in suo nome segna un aspetto rivoluzionano dello gnosticismo sul piano cosmico, aspetto che sul piano morale appare nella sfida di antinomismo, e sul piano sacramentale nella fiducia di sconfiggere il Fato e di giocare gli arconti. L’elemento di rivolta col suo tono emotivo può essere messo in luce solamente se è collegato all’elemento di oppressione e alla conseguente idea di liberazione, di reclamare cioè una libertà perduta: bisogna ricordare che la funzione del demiurgo non si esaurisce nello sforzo di creazione, ma che per mezzo della sua «Legge», come per mezzo del Fato cosmico, esercita un governo dispotico sul mondo allo scopo soprattutto di rendere l’uomo schiavo. Nella “Rivelazione di Adamo a suo figlio Seth” (n. 12, Doresse, p. 182), Adamo racconta che dopo aver appreso (da Eva?) circa «gli angeli eterni» (eoni) che «erano superiori al dio che ci ha creato… l’Arconte in collera ci separò dagli eoni delle potenze… La gloria che era in noi ci lasciò… la conoscenza primordiale che era stata infusa in noi ci abbandonò… Fu allora che conoscemmo gli dèi che ci hanno creato… e lo servimmo in timore ed umiltà» (25): che soddisfazione, allora, apprendere che l’Arconte stesso era stato umiliato dalla rivelazione che sopra di lui c’è «l’Uomo»! (26).
2. Il tema che ricorre in pratica con altrettanta frequenza dell’«orgoglio del demiurgo» è quello che chiamerò brevemente «la follia della Sophia», cioè la storia della sua aberrazione e caduta dall’ordine divino superiore, del quale essa è e continua ad essere un membro anche durante il suo esilio di colpa. Nello svolgimento del mito tale tema, come abbiamo visto, precede l’orgoglio del demiurgo: di fatto, la caduta della Sophia è la causa generatrice dell’esistenza del demiurgo e della sua natura inferiore “ab initio”. Ma storicamente la figura è di provenienza diversa. Il riferimento giudaico, e quindi la punta antigiudaica, sono assenti (27); e nonostante la connessione genealogica e la colpevolezza, il tono emotivo del simbolo è diverso; la Sophia evoca un tragico «spavento e compassione», non rivolta e disprezzo.
La presenza di questo tema è un segno infallibile che siamo in presenza del tipo «siro-egiziano» di speculazione gnostica, in cui il processo cosmogonico, che sommerge parte della divinità, ha origine dalla discesa dalla sommità causata da se stessa e non, come nel tipo «iranico», da una lenta usurpazione della tenebra primordiale dall’esterno. Uno dei nuovi testi, l'”Origine del mondo”, col suo inizio polemico fornisce la prova che coloro che proposero il mito della Sophia, erano bene al corrente di questo punto dottrinale: «Poiché tutti, gli dèi del mondo e gli uomini, affermano che non esisteva niente prima del Caos, proverò che tutti si sbagliano, perché non hanno mai saputo l’origine del Caos, né la sua radice… Il Caos ha avuto origine da un’Ombra e fu chiamato ‘Tenebra’; e l’Ombra a sua volta ha avuto origine da un’opera che esiste fin dal principio»: tale opera primordiale fu intrapresa dalla Pistis Sophia al di fuori del regno degli «Immortali», che all’inizio esisteva da solo e da dove essa si sviò (145, 24 – 147,7). Perciò l’esistenza stessa della tenebra è la conseguenza di una colpa divina. Sophia, «Sapienza», è l’agente e il veicolo di codesta colpa (non l’ultimo dei paradossi di cui si dilettava lo gnosticismo); il dramma della sua anima prefigura la situazione dell’uomo all’interno della creazione (sebbene la sua «colpa» sia da considerare tale solo per la fase precosmica); e le varie possibilità di motivazione che si offrono alla scelta lasciano considerevole libertà nell’evoluzione psicologica del racconto dell’avventura trascendentale. Di questa libertà è testimone il numero di varianti che si trovano nella letteratura: persino per la sola scuola valentiniana sono registrate due diverse concezioni della prima causa e della natura della colpa della Sophia. Così non si ha qui, con tutta l’uguaglianza dell’idea fondamentale, la stessa norma stereotipa come per il tema del «demiurgo».
Ci è sembrato opportuno citare alcuni esempi presi dalle nuove fonti e metterli in relazione con i loro corrispondenti nelle fonti antiche.
L'”Ipostasi degli Arconti” e l'”Origine del mondo”, dicono entrambi che la Pistis Sophia a) desiderava produrre da sola, “senza il suo consorte”, un’opera che fosse simile alla Luce preesistente: fu prodotta come un’immagine celestiale che b) costituiva uno “schermo” tra i regni superiori della luce e gli eoni inferiori, generati dopo; e un'”ombra” si distese al di sotto dello schermo, cioè dalla sua parte esterna che è volta in direzione opposta alla luce. L’ombra, che fu chiamata «Tenebra», divenne “materia”; e da questa materia fu generato, come un aborto, Ialdabaoth dall’aspetto di leone.
Commenti:
a) “Natura della colpa”. «Senza consorte» (Ipostasi, 142, 7): lo stesso motivo si trova nell'”Apocrifo di Giovanni” (BG 36,16 – 37,4; v. sopra, p. 215 in nero) ed anche nella Sophia di Gesù (28); è ampiamente spiegato nella versione di Ippolito del mito valentiniano, cioè, come una impossibile imitazione della maniera di creatività del Padre «da se stesso», che non richiede unione sessuale (v. sopra, p. 198 s. in nero, nota 11). Così l’errore della Sophia è presunzione, “hybris”, che porta direttamente all’insuccesso, ma indirettamente, nell’ulteriore catena di conseguenze (tramite il demiurgo in cui l'”hybris” riappare unita all’ignoranza e all'”amor dominandi”), porta al divenire del mondo materiale: questo, perciò, e con esso la nostra condizione, è il frutto finale del tentativo abortivo di una sottodivinità traviata di creare per conto proprio. Lo studioso del valentinianismo sa da Ireneo (Tolomeo: scuola italica) e dagli “Estratti da Teodoto” (scuola anatolica) di una motivazione diversa e più sofisticata dell’errore della Sophia: il desiderio eccessivo di una conoscenza completa dell’Assoluto (v. sopra, p. 197 s. in nero). Non sembra che ci sia un equivalente di questa variante nei nuovi documenti, come non c’era nei vecchi. E alla luce della testimonianza copta è possibile affermare con sicurezza ciò che l’evidenza interna secondo criteri di sottigliezza e rozzezza ha sempre suggerito, ossia che la versione di Ippolito, in perfetto accordo con la Volgata gnostica, ora attestata, rappresenta un arcaismo nella letteratura valentiniana, che si manteneva in circolazione per mezzo della mitologia gnostica della Sophia, mentre la versione prevalente all’interno della scuola stessa rappresenta una rifinitura esclusivamente valentiniana.
b) “Conseguenza della colpa”. Lo «schermo», che negli esempi precedenti è evidentemente un effetto diretto dell’opera della Sophia, è, invece, nella “Sophia di Gesù”, una creazione del Padre in risposta a tale «opera»: egli distende una cortina separatrice tra «gli Immortali e quelli che furono generati dopo di loro», cosicché la «colpa della donna» potesse sopravvivere e potesse unirsi con l’Errore (BG 118, 1-17) (29). Ciò richiama il «limite» (“horos”) dei Valentiniani nella seconda delle sue funzioni (30). Secondo questa interpretazione, quindi, la «cortina», o «limite», è stata posta con l’intento di separazione e protezione: mentre nell’altra versione, dove sorge con l’opera stessa della Sophia, diviene la causa involontaria della «tenebra» formatasi al di sotto, che diventa «materia» nella quale la Sophia continua la sua «opera»; secondo tale aspetto preteritenzionale richiama piuttosto la «nebbia» del “Vangelo di Verità” (31), il quale a sua volta richiama la dottrina valentiniana che la Sophia, cadendo nell’ignoranza e nell’informità, «portò all’essere il Vuoto-di-Conoscenza, che è l’Ombra del Nome [ossia il cono di tenebra prodotto dal suo interdire la luce]» (Exc. Theod. 31, 3 s.). Così, dove la «cortina» non è distesa dal Padre ma risulta direttamente dall’errore della Sophia, forma un anello nella deduzione genealogica della tenebra dall’errore primordiale, sebbene secondo un genere di causalità in certo modo estraneo. E’ la forma incipiente o più cruda di quella derivazione della materia dalla colpa primordiale (32), la cui forma perfetta si trova nella dottrina valentiniana dell’origine della sostanza psichica e hylica (materiale) “dalle” affezioni “mentali” della Sophia stessa, e non solo in conseguenza delle affezioni. Nel “Vangelo di Verità”, questa dottrina sottile sembra presupposta (33). Ancora una volta i nuovi testi ci permettono di misurare il passo fatto dal valentinianismo oltre il livello primitivo del gruppo in genere.
c) “La passione della Sophia”. Questo passo avanti dei Valentiniani appare anche dal significato dato alla “sofferenza” della Sophia, cioè, se questa era accidentale (pur essendo espressa in modo patetico) oppure, come seconda fase, avesse un significato decisivo nel processo cosmogonico. Poiché tale processo era iniziato dall’«errore» che in qualche modo dava origine nella prima fase alla tenebra e al caos che non c’erano prima (dando luogo così all’atteggiamento monistico nella teoria del dualismo), c’era ampio motivo, senza ragione ulteriore, di miseria, rimorso e altre emozioni da parte della Sophia colpevole. E’ ovvio che queste emozioni formavano parte della storia prima che la speculazione se ne impossessasse. Che cosa ci dicono a tal riguardo le fonti copte? Nell'”Apocrifo di Giovanni” l’angoscia della Sophia nasce dalla considerazione delle imprese creative del demiurgo, suo figlio (34): un commento, non un fattore originante nel processo cosmogonico, che era già in atto (sebbene un fattore nella conversione e redenzione della Sophia). Ricordiamo che nella Pistis Sophia (confronta p. 86 nero) la diffusa narrazione epico-drammatica di tali sofferenze non ha altro scopo che quello emotivo. Ma nell'”Origine del mondo”, segnalato sopra, per la sua consapevolezza delle implicanze teoretiche del tema della Sophia, viene assegnata una funzione originante alla sua angoscia, che di conseguenza precede lo stadio demiurgico: la Sophia guardando la «tenebra infinita» e le «acque senza fondo» (= Caos), è spaventata da questi prodotti della sua colpa iniziale e la sua costernazione si muta nella comparsa (sopra le acque?) (35) di un’«opera di terrore», che fugge via da lei nel Caos (147, 23-34); che questa figura sia l’Arconte maschio-femmina, menzionato in seguito, oppure la sua prima adombrata rappresentazione, è certo che il futuro creatore del mondo è mediatamente o direttamente una proiezione della disperazione della «Sapienza». Questo s’avvicina assai alla funzione ipostatizzante che gli «affetti» della Sophia assumono nella speculazione valentiniana; così pure lo sviluppo in due tempi (prima il caos, poi il demiurgo) adombra la differenziazione di una Sophia superiore e una inferiore (36). Tuttavia ancora ci corre di qui alla derivazione ben definita dei molti elementi psichici e materiali da quelle passioni; e fino ad ora niente fa supporre nei nuovi testi l’esistenza di qualche cosa di così sottile al di fuori della cerchia valentiniana, di cui ancora una volta si dimostra l’originalità del sistema.
La particolare importanza cosmogonica dei due scritti barbelognostici, tradotti da H. M. Schenke, l'”Ipostasi degli Arconti” e (secondo quanto suggerisce il titolo da lui dato) il “Discorso sull’origine del mondo”, autorizza la citazione dei principali passi cosmogonici di entrambi. Schenke (37) ha riassunto nei seguenti punti concordanti la stretta relazione tra i due scritti: decadenza della Pistis Sophia mediante la creazione di una cortina posta dinanzi al mondo della luce; formazione di un’ombra e della materia; origine di Ialdabaoth maschio-femmina e dei suoi figli maschi-femmine; orgoglio e punizione di Ialdabaoth; elevazione di suo figlio Sabaoth, penitente; origine della Morte e dei suoi figli. L'”Origine” offre una descrizione più circostanziata e il nome «Uomo immortale» per il Dio supremo ricorre soltanto qui. Nella seguente scelta dei testi, i passi sono ordinati in modo da presentare l’ordine del processo cosmogonico.
L’Ipostasi degli Arconti (Cod. II, 4).
«In alto, negli Eoni sconfinati, esiste l’Incorruttibilità. La Sophia, che è chiamata Pistis, volle compiere un’Opera per conto proprio senza il suo consorte. E la sua opera divenne un’immagine celeste, cosicché una cortina esiste tra quelli che sono in alto e gli eoni che sono in basso. E un’ombra si formò al di sotto della cortina, e quell’ombra si trasformò in materia e… fu gettata da una parte (esterna). E la sua forma divenne un’opera di materia, paragonabile ad un aborto. Essa ricevette l’impronta (“typos”) dall’ombra e divenne una bestia arrogante dalla forma di leone (Ialdabaoth)… Egli aprì gli occhi e guardò la materia immensa e senza fine; si inorgoglì e disse: ‘Sono Dio e non c’è nessuno al di fuori di me’. Dicendo ciò, peccò contro il Tutto. Una voce venne dall’alto della Sovranità… ‘Sei in errore, Samael’, cioè il dio cieco o il dio della cecità (142, 4-26). I suoi pensieri erano ciechi (135, 4). Egli si considerò capace di creare figli da sé. Essendo maschio-femmina, egli creò sette figli maschi-femmine e disse loro: ‘Io sono il Dio del Tutto’ (143, 1-5). [Zoe, figlia della Pistis Sophia fece legare Ialdabaoth da un angelo di fuoco emanato da lei e lo fece gettare nei Tartaro in fondo all’Abisso (143, 5-13).]
Quando suo figlio Sabaoth vide il potere di questo angelo, si pentì. Si nascose a suo padre e sua madre, la Materia; provò avversione per essa… Sophia e Zoe lo portarono in alto e lo posero sopra i sette cieli, al di sotto della cortina tra l’alto e il basso (143, 13-22). Quando Ialdabaoth vide che si trovava in quel-a grande gloria… Io invidiò… e l’invidia generò la morte e la morte generò i suoi figli… (144 3-9).
L’Incorruttibilità guardò giù verso le regioni dell’acqua. La sua immagine si rivelò nell’acqua e i poteri della tenebra se ne innamorarono (135, 11-14). Gli arconti si consigliarono e dissero: ‘Venite, formiamo un uomo dalla polvere…’ (135, 24-26). Essi formarono (il loro uomo) secondo il loro corpo e secondo l’immagine di Dio che si era rivelata nell’acqua… ‘Faremo un’immagine uguale alla nostra forma, cosicché l’immagine possa vedere questa somiglianza con se stessa [possa essere attirata da essa] e possiamo trattenerla nella nostra struttura’ (135,30 – 136,1)».
[Tralasciamo la storia che segue di Adamo, Eva, il paradiso, il serpente, Norea, eccetera]
Discorso sull’origine del mondo (Cod. II, 5).
«Quando la natura degli Immortali si fu perfezionata dall’Infinità, un’immagine provenne dalla Pistis che era chiamata Sophia. Essa desiderò che divenisse un’opera simile alla Luce che esisteva dapprima. E subito il suo desiderio produsse e apparve un’immagine celestiale… che era a metà tra gli Immortali e coloro che sorsero dopo di loro secondo il modello celeste, che era una cortina che separava gli uomini dagli esseri superiori. L’Eone della Verità non ha ombra dentro (38) di sé… Ma il suo esterno è ombra, che fu chiamata ‘Tenebra’. Da essa provenne un potere (per governare) sulla Tenebra. Ma i poteri che vennero all’essere dopo di esso chiamarono l’Ombra ‘Caos sconfinato’. Da esso spuntò la progenie degli dèi… cosicché la prima opera fu seguita da una razza di aborti. L’Abisso (Caos), perciò, ha origine dalla Pistis (146, 11 – 147,2).
L’Ombra allora divenne consapevole che c’era qualcuno più forte di lei. Fu invidiosa e, divenuta immediatamente pregnante da se stessa, generò l’Invidia… Quell’Invidia fu un aborto privo di Spirito. Sorse come ombre (nebulosità) in una sostanza acquosa. Quindi l’Invidia fu gettata… in una parte del Caos… Come quando una donna ha partorito tutta la sua grossezza se ne va (placenta e membrane), così la Materia fu prodotta dall’Ombra (147, 3-20).
Dopo questi avvenimenti, la Pistis venne e si rivelò alla Materia del Caos che era stata gettata (là) come un aborto…: una tenebra sconfinata e un’acqua senza fondo. Quando la Pistis vide ciò che era venuto dalla sua trasgressione ebbe paura; e lo spavento si cambiò nell’apparizione di un’opera di terrore, che fuggì via da lei nel Caos. Essa si volse ad esso e soffiò sulla sua faccia, nell’abisso al di sotto dei cieli [del Caos] (147,23 – 148,1).
Quando la Sophia desiderò che questo (aborto) ricevesse l’impronta (“typos”) di un’immagine e governasse sulla materia, allora venne dall’acqua un Arconte dalla forma di leone… che possedeva grande potere ma non sapeva di dove fosse venuto (Ialdabaoth)… Quando l’Arconte vide la propria grandezza… vedendo soltanto se stesso, e niente altro tranne acqua e tenebre, credette di esistere da solo. Il suo pensiero uscì e apparve come uno spirito che si muoveva qua e là sulle acque (148,1 – 149,2).
[149, 10 – 150, 26]: creazione da parte di Ialdabaoth di sei ‘figli’ maschi-femmine (arconti); i loro nomi maschili e femminili (tra cui Sabaoth); creazione di un cielo per ciascuno di essi, con troni, potenze, arcangeli, eccetera].
Quando i cieli (dopo un aiuto della Pistis) furono fermamente stabiliti, con i loro poteri e le loro disposizioni, il Progenitore si gonfiò di orgoglio. Ricevette omaggio da tutte le schiere degli angeli… si vantò… e disse: ‘Io sono Dio…’ (eccetera, con la replica della Sophia più estesa qui di quella stereotipata): ‘Sei in errore, Samael’, ossia dio cieco. ‘Un Uomo immortale di Luce esiste prima di te, il quale si rivelerà nella tua creazione (plasma). Egli ti calpesterà… e tu e i tuoi discenderete da tua madre, l’Abisso (39). Perché alla fine delle vostre opere la Deficienza che è venuta dalla Verità, sarà dissolta: passerà e sarà come se non fosse mai stata’. Così detto, la Pistis fece vedere l’immagine della sua grandezza nell’acqua, e quindi ritornò alla sua luce (151, 3-31).
Dopo che il Progenitore ebbe visto l’immagine della Pistis nell’acqua divenne triste… e si vergognò della sua trasgressione. E quando riconobbe che un Uomo immortale di Luce esisteva da prima di lui, si agitò fortemente, poiché avendo detto prima a tutti gli dèi: ‘Sono Dio, e non c’è nessuno al di fuori di me’, temeva che essi scoprissero che c’era qualcuno prima di lui, e lo sconfessassero. Ma non avendo sapienza… ebbe l’insolenza di dire: ‘Se c’è qualcuno prima di me, si riveli!’. Subito una luce provenne dall’Ogdoade superiore. Passò tutti i cieli della terra… e in forma di Uomo apparve… Quando la Pronoia (la consorte di Ialdabaoth) vide quest’angelo, si innamorò di lui; ma egli la odiò perché apparteneva alla Tenebra. Essa volle abbracciarlo ma non poté… (155,17 -156, 18) (40).
Dopo che Sabaoth, il figlio di Ialdabaoth, ebbe udito la voce della Pistis (cioè nel suo discorso minaccioso a Ialdabaoth) la glorificò e sconfessò suo padre. La glorificò per il suo insegnamento circa l’Uomo immortale e la sua Luce. Pistis Sophia… profuse su di lui luce dalla sua luce… e Sabaoth ricevette grande potere su tutte le forze del Caos… Egli odiò suo padre, la Tenebra, e sua madre, l’Abisso. Detestò sua sorella, il Pensiero del Progenitore, che si muove qua e là sull’acqua… Quando Sabaoth, come ricompensa per il suo pentimento, ebbe ricevuto il posto di riposo (nel settimo cielo), Pistis gli dette anche sua figlia Zoe (Vita)… perché lo istruisse su tutti (gli Eoni) che esistono nell’Ogdoade (151, 32 -152, 31).
Quando il Progenitore del Caos vide suo figlio Sabaoth nella sua gloria… Io invidiò. E quando fu in collera generò la Morte dalla propria morte (eccetera) (154, 19-24)». (Fine della traduzione.)
Il trattamento favorevole usato a Sabaoth in questi due scritti molto affini, tradisce una vena di simpatia verso il giudaismo, stranamente contrastante con l’animosità antigiudaica che gli stessi scritti mostrano nell’identificazione trasparente dell’odioso Ialdabaoth con il Dio dell’Antico Testamento.
Dopo esserci soffermati su alcune caratteristiche principali, ci sembra opportuno registrare alcune osservazioni più particolari. L'”Apocrifo di Giovanni”, che abbiamo riassunto dalla versione di Berlino (v. p.p. 215-222), ricorre tre volte nei codici di Chenoboskion, due di queste in lunghe versioni (n.n. 6 e 36). Tra le amplificazioni c’è un finale appiccicato che mostra la facilità con cui un materiale eterogeneo era accettato nelle composizioni gnostiche di genere letterario ben stabilito. Il finale aggiunto è il racconto in prima persona fatto da una divinità salvatrice che narra la sua discesa nella profondità delle Tenebre per risvegliare Adamo; la particolare parentela gnostica è di facile identificazione per via di passi come i seguenti: «Penetrai nel mezzo della prigione… e dissi: ‘Colui che ascolta si risvegli dal sonno pesante!’. Allora Adamo pianse e versò abbondanti lacrime…: ‘Chi mi chiama? E da dove viene questa speranza, mentre sono nelle catene della prigionia?’… ‘Alzati e ricorda che sei tu stesso che hai udito, e ritorna alla tua radice… Cerca scampo dai… demoni del Caos… e alzati dal profondo sonno della dimora infernale’» (Doresse, p. 209). Lo stretto parallelismo che si riscontra con gli scritti manichei (ed anche mandei) dice che si tratta dell’intrusione di gnosi «iranica» in un contesto per altro verso «siriaco».
Il n. 12, la “Rivelazione di Adamo a suo figlio Seth”, presenta la dottrina (originariamente iranica?) di una successione di (tredici o più?) Istruttori che discendono nel mondo nel corso della storia, per mezzo della nascita miracolosa dei profeti. Variazioni su questo tema si trovano nelle Pseudo-Clementine, in Mani e altrove nello gnosticismo (v. p.p. 246; 244 in nero, nota 2): è questa la prima concezione di una «storia del mondo», come progresso divinamente attuato dalla gnosi. L’autore del trattato in questione non si accorge del contrasto tra questa idea di una rivelazione intermittente e quella di una continua trasmissione segreta dei «segreti di Adamo» attraverso Seth e i suoi discendenti, che egli sostiene contemporaneamente (Doresse, p. 183). Per quest’ultima dottrina Doresse porta un parallelo (p. 185) tratto da una tarda “Cronaca” (41) siriaca, che noi useremo piuttosto per confrontare le diverse posizioni. Nella redazione cristiana della “Cronaca”, Adamo, quando comunica le rivelazioni a suo figlio Seth, gli mostra la sua originaria grandezza prima della trasgressione e dell’espulsione dal Paradiso e lo ammonisce di non trasgredire mai la giustizia come egli, Adamo, aveva fatto; nella redazione gnostica della “Rivelazione”, Adamo non è il peccatore, ma la vittima della persecuzione arcontica, in ultima analisi della Caduta primordiale a cui sono dovute l’esistenza del mondo e la sua propria. E’ questo un criterio molto semplice per stabilire ciò che è «cristiano» (ortodosso) o «gnostico» (eretico): se la colpa è attribuita ad Adamo o all’Arconte, se è umana o divina, se nasce prima o dopo la creazione. La differenza tocca il cuore stesso del problema gnostico.
A titolo di curiosità facciamo osservare che il n. 19 (manca il titolo) – interessante anche per una polemica di veemenza marcionista contro la Legge – lancia un attacco sorprendente al battesimo di Giovanni: «Il fiume Giordano… è la forza del corpo, ossia l’essenza dei piaceri, e le acque del Giordano il desiderio di coabitazione carnale»; Giovanni stesso è «l’arconte della moltitudine»! (Doresse, p. 219 s.). Ciò è veramente unico. Che fosse una replica ai Mandei e alla loro preferenza per Giovanni contro Cristo, l’altro lato dell’aspra contesa di cui abbiamo la parte mandea nei loro scritti? Un’idea allettante. Ma le notizie di cui si dispone sono troppo frammentarie e permettono solo di suggerirla come possibilità.
Per passare ancora una volta da materie dottrinali infra-gnostiche alla questione delle «relazioni forestiere», di cui abbiamo un esempio nell’inclusione di scritti ermetici nella collezione di Nag Hammadi, si pone in modo quasi irresistibile la domanda se non vi siano contatti tra i codici di Nag Hammadi e gli scavi del Mar Morto, tra «Chenoboskion» e «Qumran», i due gruppi le cui reliquie, per una delle più grandi coincidenze immaginabili, sono venuti alla luce quasi nello stesso tempo. In realtà possono essercene stati, secondo l’ipotesi affascinante di Doresse (op. cit., p. 259 s.s.), che in sintesi è la seguente: “Qumran” potrebbe essere “Gomorra”, ipotesi suggerita per la prima volta da F. de Saulcy su basi linguistiche e topografiche; Gomorra e Sodoma sono nominate da antichi scrittori come colonie di Esseni, e a questo riguardo i significati biblici dei due nomi pare non abbiano importanza; il n. 2 dei testi di Nag Hammadi, il “Libro sacro del Grande Spirito invisibile” o “Vangelo degli Egiziani”, ha il seguente passo: «Il grande Seth venne e portò il suo seme, e lo seminò negli eoni che sono stati generati e il cui numero è il numero di Sodoma. Alcuni dicono: ‘Sodoma è l’abitazione del grande Seth, che [o: il quale?] è Gomorra’. E altri dicono: ‘Il grande Seth prese il seme di Gomorra e lo trapiantò nel secondo luogo che è stato chiamato Sodoma’» (Doresse, p. 298). Ciò suggerisce che, posteriore com’è il testo in rapporto alla data di cessazione della comunità di Qumran, possa riferirsi ad essa come «il seme del grande Seth» e persino alludere alla sua ricostituzione più a sud, a Sodoma, dopo la catastrofe che sopraggiunge a Qumran. Ci sarebbe allora una certa continuità tra il movimento esseno che scompariva e una gnosi sethiana che nasceva. In mancanza di maggiori dati, è impossibile stabilire il valore di questa ardita congettura. Certamente le implicanze di un tale legame tra Esseni e Gnostici, come è imposto qui da un riferimento «storico» mitologizzato, sarebbero vaste e complesse.
I commenti da me fatti finora si riferiscono alla biblioteca di Chenoboskion nel suo insieme, sulla quale non si hanno ancora che informazioni frammentarie. Dei due scritti completamente pubblicati e tradotti (v. sopra, nota 2), tralascio il “Vangelo secondo Tommaso”, una raccolta di «detti segreti di Gesù vivente», apparentemente raccolti da Didimo Giuda Tommaso (circa 112 di essi) (42), il cui rapporto con i Detti del Signore nei quattro Vangeli (perciò con tutto il problema della tradizione sinottica) è materia di intensi studi da parte degli studiosi del Nuovo Testamento. Per il nostro scopo è sufficiente dire che alcuni di questi «detti» (più di 20) sono quasi identici o molto vicini a quelli canonici, altri (circa 30) sono paralleli più liberi, solo parzialmente in accordo nelle parole e nel contenuto; un altro gruppo (circa 25) non sono che pallida eco dei logia conosciuti, e il rimanente gruppo sostanziale (circa 35) non ha corrispondenza nel Nuovo Testamento: costituisce per ora il più largo corpo di «detti sconosciuti di Cristo». Il carattere gnostico della raccolta (seppure lo possiede nel suo insieme) non è facilmente riconoscibile: soltanto in alcuni casi è inconfondibilmente chiaro, spesso può essere soltanto intuito dall’accentuazione data ad un detto nella versione aberrante; inoltre il significato della maggior parte è velato ed elusivo, o almeno tale finora.
Mentre questo testo, a causa delle sue implicanze di ampia portata per la questione storica e sostanziale della tradizione di Gesù, è forse per lo studioso del Nuovo Testamento lo scritto più interessante di tutti quelli scoperti a Nag Hammadi, lo studioso di gnosticismo trova il suo più grande compenso nel cosiddetto “Vangelo della Verità” (“Evangelium Veritatis”), che è stato pubblicato dal codice Jung. Dedicherò l’ultima parte di questo capitolo ad alcune osservazioni su questo documento affascinante (43).
2. Il Vangelo di Verità (Cod. I,2).
La composizione non ha titolo nel codice, ma comincia con le parole «Il Vangelo di verità…». Questo fatto e il carattere fortemente valentiniano del linguaggio e del contenuto hanno portato i primi editori a vedere in questa meditazione sui segreti della salvezza e sul salvatore quel «Vangelo di Verità» che Ireneo attribuisce ai Valentiniani (Adv. haer. III, 11, 9). L’identificazione è del tutto plausibile, ma naturalmente non è dimostrabile. Non c’è dubbio che questo scritto sia molto diverso da ciò che un «vangelo» dovrebbe essere secondo l’uso del Nuovo Testamento, cioè una testimonianza della vita e dell’insegnamento di Cristo. La grande libertà con cui il sacro titolo era usato nei circoli gnostici è stata ampiamente dimostrata dai n.n. 2-7 della collezione di Chenoboskion: senza la minima somiglianza con un «vangelo» nel senso nostro (non tratta affatto di Gesù ma del Grande Seth) ha come secondo titolo, oltre “Libro sacro del Grande Spirito invisibile, Vangelo degli Egiziani”. Se il nostro testo è il «Vangelo di Verità» citato da Ireneo, la sua autorità tra i Valentiniani doveva essere già stabilità al suo tempo, il che fa porre la sua origine in precedenza, cioè durante la prima generazione valentiniana (circa il 150 d.C.), e non si può nemmeno rigettare la possibilità che l’autore sia lo stesso Valentino.
La forma è quella di omelia o meditazione; lo stile è allusivo e spesso è una retorica mistica elusiva con sempre mutevole ricchezza di immagini; il fervore emotivo corrisponde una volta tanto al mistero dell’incarnazione e della sofferenza di Cristo (v. sopra, p. 211 in nero, nota 28); specialmente sotto quest’ultimo aspetto il “Vangelo di Verità” aggiunge una nuova voce al coro gnostico che abbiamo udito prima. Quanto al contenuto dottrinale, sceglierò un seguito di pensieri che costituiscono una specie di argomento: l’argomento, di fatto, che senza esagerazione può essere chiamato il punto centrale della soteriologia valentiniana.
Nelle prime righe introduttive il Vangelo di Verità dichiara di essere «una gioia per coloro che hanno ricevuto dal Padre di Verità il dono di conoscerlo per mezzo della potenza della Parola (“Logos”) che è venuta dal Pleroma… per la redenzione di coloro che erano nell’ignoranza del Padre»; il nome «vangelo» (“evangelium”) è quindi spiegato come «la manifestazione della speranza» (cioè di colui che era atteso per la salvezza). In altre parole, “evangelium” ha qui il significato originario e letterale di «buona novella» che offre una speranza e dà l’assicurazione di realizzarla. Di conseguenza, i due temi salienti in ciò che segue sono: il contenuto o oggetto della speranza e il fondamento della speranza. Mescolato a questi due c’è un terzo tema, cioè la funzione che hanno le «novelle» stesse nella realizzazione della speranza.
L’oggetto della speranza è naturalmente la salvezza, e di conseguenza troviamo larghe parti del libro dedicate a spiegare la natura o essenza della salvezza, che è chiamata di preferenza «perfezione»; ed essendo un trattato gnostico non sorprende di trovare l’essenza della perfezione intimamente collegata con la “gnosi”, conoscenza. Il termine «gnosi» specifica il contenuto della speranza e richiede esso stesso un’ulteriore specificazione circa il contenuto della conoscenza.
E’ il fondamento della speranza che fa sorgere una questione: infatti la connessione di presupposto e conseguenza è del tipo «poiché questo è (o era) così, allora questo è (o sarà) così», che è la forma del ragionamento. Quindi il contenuto è in ogni caso determinato dalla dottrina particolare: se lo scritto in esame è valentiniano, vi dobbiamo trovare il ragionamento speculativo proprio della teoria valentiniana; una conformità su questo punto sarà quindi la prova cruciale del valentinianismo di tutto il documento.
Ora è valentiniana, come pure gnostica in generale, la dottrina che il fondamento della speranza escatologica si trova negli inizi di tutte le cose, che le prime cose assicurano le ultime cose, come quelle hanno causato la necessità di queste. Il compito quindi di fornire un fondamento alla speranza escatologica è di stabilire un nesso convincente tra ciò che si afferma essere il mezzo e il modo di salvezza, ossia la conoscenza, e gli eventi iniziali che richiedono tale modo come loro complemento adeguato. Quel nesso soltanto può fornire una risposta alla questione perché la conoscenza, e proprio la conoscenza, può essere il veicolo e persino (nella versione valentiniana) l’essenza della salvezza. La forza dimostrativa di quel nesso, che è parte della verità stessa che il vangelo deve rivelare, e quindi parte della stessa conoscenza salvifica, costituisce in verità la felicità della buona novella. Essa infatti, ciò che altrimenti sarebbe uno scopo personale per pura preferenza soggettiva – lo stato psicologico della conoscenza lo rende oggettivamente valido come redenzione dell’uomo interiore e persino (di nuovo nella versione valentiniana) come consumazione dell’Essere (in tutte lettere). Dobbiamo perciò cercare in questa direzione quando ci chiediamo che cosa può essere non soltanto evangelium in genere – «una manifestazione di speranza» – ma anche che cosa possa essere l'”evangelium veritatis” del nostro messaggio specifico.
Il nostro testo ci dà una formale e concisa risposta, alla fine di una breve trattazione dei primi inizi: «”Poiché” la ‘Dimenticanza’ venne all’essere “perché” essi non conoscevano il Padre, “perciò” se essi conoscono il Padre, la ‘Dimenticanza’ in quello stesso momento diventa non-esistente» (18, 7-11). Di questa audace proposizione si dice poi con enfasi che essa rappresenta il punto principale della rivelazione della verità, la formulazione, per così dire, della sua logica: «Questo dunque è il Vangelo di Colui che cercano, che Gesù il Cristo ha rivelato al Perfetto, grazie alla misericordia del Padre, come un mistero nascosto» (18, 11-16). L’autore non avrebbe potuto dichiarare più espressamente ciò che egli considerava come la manifestazione del segreto più profondo del suo vangelo.
La proposizione, nella sua formulazione audace, per nulla chiara in se stessa, e richiedente perciò un contenuto speculativo da cui ricevere significato, ha di fatto la qualità di una formula: è registrata altre due volte con l’identica struttura grammaticale di «poiché – perciò» e con riferimento alla storia passata: una volta nello stesso “Evangelium Veritatis”, e una volta nelle citazioni valentiniane di Ireneo. Tale ripetizione da sola mostrerebbe già che è un punto importante e perciò stereotipato della dottrina in questione: una dottrina valentiniana, secondo la testimonianza di Ireneo. Nel Vangelo di Verità la formula riappare nella stessa brevità ma con una leggera variazione di espressione: «Poiché la ‘Deficienza’ venne all’essere perché essi non conoscevano il Padre, perciò quando conoscono il Padre la ‘Deficienza’ nello stesso momento diventa non-esistente» (24, 28-32). Da questa versione apprendiamo che «dimenticanza» (della prima versione) può essere sostituita da «Deficienza»; e questo stesso termine «deficienza» ci conduce all’espressione più completa che si ha della formula, che era conosciuta prima e da alcuni riconosciuta come la proposizione valentiniana più importante, quale è ora esplicitamente confermata dal Vangelo di Verità. E’ citata da Ireneo nel famoso passo Adv. haer. I, 21, 4, che abbiamo riportato per esteso a p. 192 e di cui ripetiamo qui soltanto la formula stessa: «”Poiché” dall”Ignoranza’ è venuta la ‘Deficienza’ e la ‘Passione’, “perciò” tutto il sistema prodotto dall’Ignoranza è dissolto dalla Conoscenza». Questa versione leggermente più completa della formula aggiunge un punto importante alle versioni incomplete del Vangelo di Verità: non afferma soltanto che, poiché la Deficienza (o Dimenticanza: puri termini negativi) è venuta all’essere per la non-Conoscenza, cesserà con l’avvento della Conoscenza ma parla di «tutto il sistema» (“systasis”, un termine positivo) che ha origine dall’Ignoranza e della “sua dissoluzione” mediante la Conoscenza. Ciò suona molto meno tautologico della versione incompleta. Il lettore di Ireneo conosce naturalmente dal suo grande riassunto precedente della speculazione valentiniana che il «sistema» in questione era niente meno che questo mondo, il cosmo, l’intero regno della materia in tutti i suoi elementi, fuoco, aria, acqua, terra, che sembrano soltanto sostanze in se stesse, ma sono in realtà sotto-prodotti ed espressioni di processi o stati spirituali: sapendo ciò “egli” può comprendere l’argomento della formula che, altrimenti, dai semplici termini del suo linguaggio non sarebbe comprensibile, anche in questa versione più completa. Il lettore di Ireneo sa inoltre (il che è ugualmente indispensabile per la comprensione della formula) che l’Ignoranza e la Passione nominate qui non sono l’ignoranza e la passione ordinarie che sono in noi, ma Ignoranza e Passione in senso universale, su scala metafisica e all’origine delle cose; che, lungi dall’essere puramente astratte, esse denotano eventi concreti ed entità del mito cosmogonico; che gli stati soggettivi che apparentemente indicano, essendo quelli di potenze divine, hanno efficacia oggettiva, e un’efficacia sul piano della vita interiore di cui sono stati – la vita intima della divinità -, e perciò possono essere il fondamento di quelle realtà sostanziali, totali, come il cosmo e la materia. In breve, la premessa della formula, da essa presupposta e richiesta per la sua comprensione, è il mito valentiniano completo, di cui la formula è di fatto l’epitome: quella speculazione sull’origine delle cose che è stata svolta nel racconto del Pleroma, della Sophia e del Demiurgo. Il lettore di Ireneo è in possesso di questa premessa, anzi di parecchie versioni di essa, quando giunge al passo in questione.
Il lettore del Vangelo di Verità si trova forse nella stessa posizione, supposto che non abbia a disposizione che il Vangelo di Verità? Chiedere ciò significa domandarsi se il “racconto” degli inizi a cui la formula fa riferimento è riportato nel Vangelo stesso. La risposta è «sì e no». Il racconto è offerto e nello stesso tempo trattenuto, le sue linee essenziali sono chiare per coloro che lo conoscono già, ma sono velate in modo provocante per coloro che non lo conoscono. Ciò che segue è una citazione dei molteplici passi del Vangelo di Verità, in ordine di ricorrenza, che trattano il passato primordiale e – per adoperare l’argomento della «formula» – il futuro escatologico come suo contrappunto (44).
«Il tutto era alla ricerca di Colui dal quale era venuto… l’unico incomprensibile, impensabile, che è superiore ad ogni pensiero. L’Ignoranza riguardo al Padre aveva prodotto Angoscia e Terrore. E l’Angoscia divenne densa come nebbia cosicché nessuno poteva vedere. Perciò l’Errore (“plane”) guadagnò forza. Si mise a lavorare sulla propria materia (“hyle”), nel vuoto, non conoscendo la Verità. Si industriò per comporre una forma (“plasma”) sforzandosi di produrre in bellezza (bella apparenza) un sostituto della Verità (17, 5-21)… Essi erano un Niente, quell’Angoscia, quella Dimenticanza e quella forma di Falsità (17, 23-25)… Non avendo così alcuna radice l’Errore era immerso in una nebbia riguardo al Padre mentre si applicava a produrre opere e dimenticanze e terrori per attirare, per loro mezzo, coloro che sono nel Mezzo e imprigionarli (17, 29-35)… La Dimenticanza non aveva originato vicino al (o, con il) Padre, sebbene originasse a causa di Lui. Al contrario, ciò che ha origine in Lui è la Conoscenza che è stata rivelata, cosicché la Dimenticanza potesse essere dissolta ed essi potessero conoscere il Padre. Siccome la Dimenticanza venne all’essere perché essi non conoscevano il Padre, perciò se raggiungono la conoscenza del Padre, la Dimenticanza nello stesso istante non è più esistente. Quello dunque è il Vangelo di Colui che essi cercano, che Gesù Cristo ha rivelato al Perfetto, grazie alla misericordia del Padre, come un mistero nascosto (18, 1-16)… Il Tutto era bisognoso (del Padre) perché Egli aveva trattenuto in Se stesso la perfezione che non aveva accordato al Tutto (18, 35-38)… Egli aveva trattenuto la loro perfezione in Se stesso, accordandola ad essi (più tardi) affinché ritornassero a Lui e potessero conoscerlo per mezzo di una conoscenza unica in perfezione (19, 3-7)… Perché, di che cosa aveva bisogno il Tutto se non della conoscenza del Padre? (19, 15-17)… La perfezione del Tutto essendo nel Padre, è necessario che il Tutto riascenda a Lui (21, 8-11)… Essi avevano deviato (dai loro luoghi) quando avevano ricevuto l’Errore, a causa della profondità di Colui che circonda tutti gli spazi… Era un grande prodigio che essi fossero nel Padre senza conoscerlo e che fosse possibile che essi fuggissero via per loro volontà, perché non potevano comprenderlo né conoscere Colui nel quale essi erano (22, 23-33)… Tale è la Conoscenza di questo Libro vivente che Egli ha rivelato agli Eoni alla fine (22,37 – 23,1)… (Il Padre) rivela quello che di Sé era nascosto – ciò che di Lui era nascosto era Suo Figlio – cosicché per la misericordia del Padre, gli Eoni potessero conoscerLo e cessare di affannarsi alla ricerca di Lui, riposando in Lui (e) sapendo che il riposo consiste in ciò, che colmando la Deficienza egli (il Figlio?) ha abolito la Forma (schema): la sua Forma (della Deficienza) è il mondo (“cosmos”), al quale egli (il Figlio?) era stato sottomesso (24, 11-24)… Poiché la Deficienza venne all’essere perché essi non conoscevano il Padre, perciò quando conoscono il Padre, la Deficienza nello stesso istante cesserà di esistere. Come l’ignoranza di una persona, al momento che conosce, si dissolve spontaneamente; come la tenebra si dissolve all’apparire della luce, così anche la Deficienza si dissolve al giungere della Perfezione. Sicuramente da allora in poi la Forma non appare più, ma si dissolverà nella fusione con l’Unità… al momento in cui l’Unità perfezionerà gli spazi (= Eoni?). (Così anche) (45) per mezzo dell’Unità ciascuno (di noi) ritroverà se stesso. Per la conoscenza purificherà se stesso dalla diversità avviandosi all’Unità, consumando la materia in se stesso come una fiamma, la tenebra con la luce e la morte con la vita (24,28 – 25,19)».
Questo, dunque, è il racconto degli inizi quale il nostro scritto lo presenta, e la descrizione minuta del fondamento della speranza, che deve dare significato e conclusione alla proposizione condensata nella «formula». Ma tale racconto, destinato a sostenere una proposizione non altrimenti intelligibile, è esso stesso intelligibile così come è? Ritengo che la risposta sia «no»: è certamente suggestivo e complicato, ma adombra un mondo di significato che tuttavia sfugge alla nostra presa, a meno che non si possegga un aiuto estraneo. Dobbiamo naturalmente dimenticare quanto è a nostra conoscenza del mito valentiniano da altre fonti e consultare solamente il linguaggio del testo. Ora, che cosa può farsene un lettore impreparato dell’informazione che «l’Angoscia» divenne densa come nebbia, che «l’Errore» ha elaborato «la Materia» nel vuoto, che «esso» ha fatto una forma, ha prodotto opere, è andato in collera, eccetera? che il Tutto era alla ricerca, che «essi» non conoscevano il Padre? che la «Dimenticanza» ha avuto origine «a causa» della Profondità del Padre? che la «Deficienza» ha una «forma» e si dissolve all’arrivo della Pienezza, quando «essi» conoscono il Padre?
Qualunque scarsa spiegazione il testo fornisca di questo linguaggio criptico, essa è messa in modo che cade inosservata, e la maggior parte delle volte è posta troppo avanti nel racconto tanto che bisognerebbe leggerlo partendo dalla fine per profittare di quegli accenni. Così alla fine impariamo che è «l’Eone» che Lo ricerca, manca di conoscenza e giunge alla conoscenza di Lui: ma questo lo apprendiamo a p. 24 dove una volta tanto il nome è usato dopo precedenti affermazioni; da p. 18 in poi si ha la ripetizione del pronome «essi» senza spiegazione (46), che a sua volta rimpiazza l’espressione «il Tutto» con cui si apre il racconto a p. 17. Per quanto è possibile ricavare da quel che il Vangelo stesso ci dice, potremmo fino a quel punto non sapere che «il Tutto» non è il mondo, che «essi» non sono persone umane, ma che entrambi i termini si riferiscono al Pleroma degli Eoni divini che precedono la creazione. Oppure, per prendere un altro esempio, incontriamo alla fine, alla stessa p. 24, la parola-chiave “cosmos”, che spiega il significato di una quantità di termini precedenti che per se stessi non avevano alcun riferimento cosmologico: perché è detto che il cosmos è la «forma» (“schema”) della «Deficienza»; la Deficienza si può uguagliare alla «Dimenticanza» di p. 18 (perché prende il posto di quest’ultima nella formula), la Dimenticanza a sua volta è qui riferita all’«Errore» (“plane”) e alla sua «forma» (“plasma”), l’Errore a sua volta all’«Angoscia» e al «Terrore», essi di nuovo all’«Ignoranza»: e così tutta la serie di concetti apparentemente psicologici e umani, in mezzo ai quali procede il misterioso racconto, viene autenticata quasi accidentalmente nel suo significato cosmico, che fino ad allora il lettore non iniziato ha potuto tutt’al più indovinare. Egli si troverà ancora nell’imbarazzo su come rappresentarsi in concreto quelle astrazioni di mente e di emozione in funzione di attori in ruoli cosmogonici. Il racconto risulta manchevole ed allusivo senza il riferimento alle principali “dramatis personae” quali la Sophia e il demiurgo. Anche quei rari indizi che si son potuti raccogliere dal testo non sono dati semplicemente come fili conduttori, come il “dénouement” di cui il lettore era in attesa. Si suppone che egli avesse tutto capito fin da principio: i termini s’incontrano dove sono, come cosa del tutto naturale.
In altre parole, si supponeva che il lettore del Vangelo di Verità dovesse trovarsi a suo agio quando incontrava all’improvviso dei termini oscuri come «Angoscia», «Terrore» e così via, come risultato di una precedente conoscenza del mito valentiniano attraverso una versione completa (47) che gli dava la possibilità di leggere i passi del Vangelo di Verità come una ripetizione condensata di una dottrina ben conosciuta.
Ora tale scoperta è di una qualche importanza per la giusta valutazione del documento in questione. Innanzi tutto significa che non si ha un trattato sistematico o dottrinale, il che d’altra parte è evidente dal suo stile generale, omiletico. Inoltre è esoterico, rivolto ad iniziati: può perciò servirsi largamente, nelle parti speculative, di alcune parole in «codice», ciascuna delle quali è un’astrazione con un ambito in certo modo indefinito per quanto si riferisce alle entità mitiche concrete da esso indicate (48). Infine, il quadro ridotto che offre del «sistema» (senza menzionare la Sophia, il demiurgo, il numero e i nomi degli Eoni, eccetera) non giustifica il giudizio che esso rappresenti uno stadio incipiente, ancora non sviluppato, embrionale per così dire, di quel sistema speculativo (49). Esso rappresenta piuttosto un simbolismo di secondo grado. Ma è davvero significativo che il senso intimo della dottrina potesse essere espresso, almeno per i «conoscitori», in una forma così astratta invece di quella abbondante, personale con la quale era espresso nello stadio mitologico. E ciò contiene la risposta alla domanda: qual è il contributo del Vangelo di Verità alla nostra conoscenza della teoria valentiniana?
Nel campo della speculazione universale, che è quella che qui solo ci riguarda, il Vangelo di Verità può o non può aggiungere una nuova variante della dottrina valentiniana alle numerose conosciute dalla testimonianza patristica: qualsiasi ricostruzione di essa dagli accenni sparsi che il linguaggio del testo ci offre, non può che rimanere tutt’al più assai congetturale. Ma non è congetturale la concordanza nelle linee generali e nello spirito con l'”eidos” generale della speculazione valentiniana, perciò il Vangelo di Verità è di grande aiuto per una comprensione di quella speculazione che è molto più estesamente documentata nelle relazioni più antiche. Infatti, i passi speculativi del Vangelo di Verità non sono semplicemente un’abbreviazione o un riassunto di qualche versione più completa: essi mettono in risalto, nella loro contrazione simbolica, l’essenza della dottrina, spogliata dai suoi ampi accessori mitologici e ridotta al nucleo filosofico. Così, come il Vangelo di Verità può essere letto soltanto con l’aiuto del mito circostanziato, anche il mito riceve da tale lettura una trasparenza quanto al suo significato spirituale fondamentale che è velato dalla quantità di immagini sensibili e necessariamente non univoche. In questa funzione il Vangelo di Verità si comporta come una trascrizione pneumatica del mito simbolico. E ciò che è ancora più inestimabile è che dall’epoca della sua scoperta sappiamo per la loro stessa autorità ciò che i Valentiniani consideravano il cuore della loro dottrina: e che il cuore di quel cuore era la proposizione espressa nella «formula».
Sappiamo che quella formula era conosciuta anche prima (sebbene non riconosciuta come una formula) dal famoso passo di Ireneo che abbiamo citato. Ireneo stesso non le dà particolare rilievo: il passo è posto alla fine della relazione sulla dottrina valentiniana, tra informazioni supplementari diverse, ed è infilato dentro (o piuttosto, come credo, segue) (50) i capitoli che trattano dell’eresia marcosiana, ciò che ha condotto gli studiosi a vedere in esso un principio particolare di una varietà di questa ramificazione dell’albero valentiniano e non centrale del valentinianismo come tale.
Tuttavia il passo per lungo tempo ha fatto grande impressione sugli studiosi di gnosticismo per il suo significato intrinseco (51). Inaspettatamente tale impressione è ora confermata dalla testimonianza più autentica. Perché il Vangelo di Verità (la cui autorità deve essere stata grande tra i Valentiniani, se è il Vangelo di Verità che è attribuito ad essi da Ireneo) stabilisce in poche parole niente meno che la verità racchiusa nella «formula» è il vangelo di verità! Che il periodo in questione fosse di uso corrente come formula lo apprendiamo solo ora dalle ripetizioni adoperate nel nostro testo. Che fosse usata dai Valentiniani lo sappiamo da Ireneo. E soltanto i Valentiniani potevano usarla legittimamente, perché nessuna speculazione, tranne quella valentiniana, fornisce ad essa un contesto valido. Per comprendere ciò, il lettore è rinviato alla caratterizzazione generale del «principio speculativo del valentinianismo» all’inizio del cap. 7 (p. 190 s. in nero), che termina con l’esposizione di ciò che io chiamo là «l’equazione pneumatica», ossia: che l’evento umano-individuale della “conoscenza” pneumatica è l’equivalente inverso dell’evento precosmico universale dell’ignoranza divina, e, nel suo effetto redentore, è dello stesso ordine ontologico; e che perciò la realizzazione della conoscenza nella persona è nello stesso tempo un atto sul piano generale dell’essere. La «formula» è precisamente un’espressione stenografica dell’equazione pneumatica, che perciò è il Vangelo di Verità.
POSTILLA AL CAP. 11.
Nel capitolo precedente, aggiunto al volume nella seconda edizione del 1963 ho adottato la numerazione degli scritti di Nag Hammadi seguita dal J. Doresse. Essa, come pure quella differente di H. Ch. Puech, è ora superata dalla numerazione introdotta da Martin Krause, basata su un’analisi più accurata dei tredici Codici (1). Nella numerazione del Krause i numeri romani indicano il Codice (nell’ordine adottato dal Museo Copto al Cairo) e i numeri arabi che seguono indicano i singoli trattati, partendo dal numero 1 in ogni Codice. L’unita concordanza permetterà al lettore di convertire i numeri del Doresse, per quel tanto che compaiono nella mia presentazione, nel sistema di citazione oramai accettato.
1 = III, 1; 2 = III, 2; 4 = III, 4; 6 = IV, 1; 7 = IV, 2; 12 = V, 5; 19 = LX, 3; 27 = VII, 1 e 2; 36 = II, 1; 39 = II, 4; 40 = II, 5.
L’elenco completo ora conta cinquantatré o più trattati (contro i quarantanove contati dal Doresse e dal Puech) su un calcolo approssimativo di 1350 o più pagine originali, di cui si posseggono circa 1130 (più un certo numero di frammenti). Il progresso compiuto nello studio e nella pubblicazione di questo vasto materiale dal tempo della redazione del precedente capitolo è in parte documentato dalla Bibliografia supplementare aggiornata per questa edizione. Nella traduzione italiana essa è stata incorporata alla bibliografia precedente.
NOTA 1. M. Krause, «Der koptische Handschriftenfund bei Nag Hammacli: Umfang und Inhalt». Mitteilungen d. Dt. Archäol. Instituts, Abtl. Kairo 18 (1962).
NOTE AL CAPITOLO 11.
* L’elenco completo dei Trattati e la Bibliografia aggiornata su Nag Hammadi vedili nella Postfazione.
1. Uno scritto ricorre due volte, ed uno tre volte nella collezione.
2. “Evangelium Veritatis…”, ed. M. Malinine, H. Ch. Puech, G. Quispel, Zurigo, 1956; “The Gospel according to Thomas”, ed. A. Guillaumont, H. Ch. Puech. G. Quispel, W. Till, Y. ‘Abd al Maslh, Leida, 1959. Il primo testo poté essere utilizzato in una certa misura nella prima edizione di questo libro. [Ved. nota 3].
3. “L’Ipostasi degli Arconti”, il “Vangelo secondo Filippo”, e una cosmogonia senza titolo (n. 40 della collezione di Doresse, n. 14 di quella di Puech), tutte e tre tradotte in tedesco da H. M. Schenke: v. Bibliografia. Della cosmogonia tradusse solo la prima parte, che egli scambiò per il tutto. Per il titolo mancante della cosmogonia (n. 40), Schenke propone «Discorso sull’Origine del mondo», che noi adotteremo in forma abbreviata: “Origine del Mondo”. Il testo completo del trattato è stato pubblicato, con traduzione e commento, da A. Böhling e P. Labib: v. Bibliografia.
4. La “Sophia di Gesù” e il “Libro segreto di Giovanni” (citato in seguito “Apocrifo di Giovanni”).
5. W. TILL, “Die gnostischen Schriften des koptischen Papyrus Berolinensis 8502”, Berlino, 1955. Il codice sarà citato come BG.
6. Parigi 1958. (I riferimenti successivi a pagine di questa opera sono relativi alla sua traduzione inglese, “The Secret Books of the Egyptian Gnostics”, New York, 1960.) (N.d.T.). L’autore, un egittologo francese, si trovò sul posto quando, nel 1947, il primo di tredici papiri che comprendevano la scoperta fu comprato dal Museo copto del Cairo. Egli ne riconobbe l’importanza e da allora in poi si tenne al corrente degli ulteriori acquisti e delle contese che abbiamo ricordato. Avendo avuto visione, seppure per breve tempo, di tutti e dodici i codici del Cairo (un codice giunse in Europa e fu comprato dall’Istituto Jung di Zurigo), egli ha catalogato gli scritti che vi sono compresi e ha preso note – talvolta affrettate – del loro contenuto. Queste, racchiuse nel suo libro, rappresentano quanto di meglio abbiamo oltre gli scritti pienamente pubblicati e tradotti, citati prima.
7. Vi comprendono gli scritti del papiro di Berlino, la cui pubblicazione, finalmente, nel 1955, fu sollecitata dalla scoperta di Nag Hammadi.
8. I manoscritti sono probabilmente del quarto secolo, ma i contenuti sono più antichi, e alcuni si possono far risalire con certezza al secondo secolo.
9. E’ possibile che la collezione appartenesse ad una persona ricca, la quale però deve aver appartenuto ad un qualche gruppo, qualunque fosse la forma della sua adesione.
10. Per esempio, l'”Apocrifo di Giovanni”, l'”Ipostasi degli Arconti”, l'”Origine del mondo”, sono barbelo-gnostici, il “Vangelo di Verità”, la “Lettera a Reginos”, il “Vangelo di Filippo”, sono valentiniani, eccetera.
11. Nella mia opera in tedesco più particolareggiata una sezione speciale è dedicata ai sistemi delle «tre radici»: “Gnosis und spätantiker Geist”, I, p.p. 335-344.
12. Riguardo alla “Parafrasi di Shem”, Doresse ha richiamato l’attenzione (op. cit.
p. 150) sulla stretta somiglianza con ciò che riferisce Ippolito di una «Parafrasi di Seth» (Refut. V, 19-22). C’è tuttavia questa importante differenza: la prima parla alla maniera manichea dell’ascesa dalla Tenebra alla Luce, mentre la seconda parla della Luce attratta dalla Tenebra. Possiamo notare quante variazioni – o potremmo dire, libero gioco di varianti – ci fossero sui punti principali.
13. Per esempio, Adv. Haer. I, 30, 6.
14. Per esempio, Refut. VII, 25, 3.
15. Per esempio, Panar. 26, 2.
16. Uso la numerazione introdotta da Doresse. [Ved. aggiunta a p. 334 in nero].
17. 134, 27 – 135,4; 142, 21-26; 143, 4-7 (Schenke, col. 664; 667; 668).
18. 148, 29-33; 151, 3-28; 155, 17-34 (Schenke, col. 249; 251; 253).
19. BG 125,10 – 126,5 (Till, p.p. 290-293): il manoscritto di Nag Hammadi ha qui una lacuna.
20. BG 44, 9-16, confronta 54, 115.; 45,20 – 46,9 (Till, p.p. 128-133).
21. Per esempio, ai num. 2 = 7 «Sono un Dio geloso e non c’è nessuno all’infuori di me!»; identico a 1 = 6 = 36 (Apocrifo di Giovanni), dove l’esclamazione è presa come prova della sua consapevolezza «che c’è un altro Dio: perché se non ci fosse di chi sarebbe geloso?» (v. sopra, p. 145 in nero).
22. Non è tuttavia confinato a quel tipo: nella “Parafrasi di Shem” la caratteristica appare in un contesto che la dottrina delle «tre radici» pone decisamente nel tipo iranico. Il riassunto di Doresse non indica come in questo caso il demiurgo (come anche la Sophia) abbia origine. Ma da altri esempi sembra che Ialdabaoth possa essere concepito come un potere totalmente malvagio piuttosto che come figlio della Sophia decaduta. Mitograficamente, la figura è invero indipendente da quest’ultima e solo secondariamente è combinata con lei.
23. Num. 2=7 (Doresse, p. 178); n. 40, 151, 19 s. «Un Uomo immortale di Luce»; “Apocrifo di Giovanni”, in tutte le versioni, qui apparentemente come una voce che giunge alla Sophia dall’alto, ma udita anche da Ialdabaoth.
24. Confronta per esempio, Iren. I, 12, 4 per un ramo dei Valentiniani (v. sopra, p. 234 in nero); confronta, ibid. 30, 1 per gli Ofiti: la Luce primordiale nell’Abisso, beata, eterna e infinita, è «il Padre di tutti, e il suo nome è Uomo Primordiale»; confronta anche i Naasseni e l’arabo Monoimos in Hippol., “Refut.” V, 7; VIII, 12.
25. Confronta anche il “Vangelo di Filippo”, 102, 29 s. «Essi (gli Arconti) volevano prendere colui che è libero e farne il loro schiavo in eterno» (Schenke, col. 7).
26. Sia nell'”Ipostasi degli Arconti” che nell'”Origine del mondo”, il demiurgo Ialdabaoth, quando è rimproverato dalla Sophia per il suo vantarsi, è chiamato con l’altro nome di Samael, che si dice significhi «il dio cieco» (Hypostasis 134, 27 – 135, 4; 142, 25 s.; Origine, 151, 17 s.). Un’esegesi plausibile, ma secondaria (aramaica), spiega l’appellativo per il demiurgo «colui che è cieco» nel resoconto di Ippolito dei Perati, dove è basato su una allegoria della storia di Esaù (Refut. V, 16, 10; v. sopra, p. 127 in nero): sappiamo ora che il predicato «cieco» era più che un’improvvisazione esegetica “ad hoc”. Di fatto, la stessa descrizione degli arconti nell’lpostasi comincia così: «Il loro Signore è cieco. Per il suo potere, ignoranza e orgoglio, egli dice nel mezzo della sua creazione ‘Io sono Dio…’» (134, 27-31; confronta anche “Sophia di Gesù”, BG 126, 1-3). Un’altra etimologia (ebraica), trovata nell'”Origine del mondo”, è «Israele = l’uomo-che-vede-Dio» (153, 24 s.). Ciò è ben noto a Filone presso il quale acquista un grande significato dottrinale (confronta “Gnosis und spätantiker Geist”, II, 1, p. 94 s.s.). Una concordanza che mette alla pari l’ellenista colto e l’oscuro settario attesta un comune fondamento di esegesi ebraica ben stabilita.
27. Nonostante il nome Achamoth = ebraico “hokma”: una divinità pagana femminile come ha dimostrato Bousset, fornì il sustrato mitologico della figura.
28. «Senza il suo compagno», confronta Till, p. 277, nota a BG 118, 3-7.
29. Confronta anche la speculazione escatologica sulla «lacerazione della cortina» nel “Vangelo di Filippo”, 132, 22 s.s. (confronta 117, 35 s.s.).
30. Ved. sopra, p. 200 s. in nero; la «seconda» funzione del limite è tra il Pleroma e l’esterno: confronta per esempio Hippol. VI, 31, 6 «perché niente della deficienza potesse arrivare vicino agli Eoni nel Pleroma».
31. 17, 11-16: «L’angoscia si condensò come una nebbia, in modo che nessuno potesse vedere. A causa di ciò l’Errore acquistò forza e cominciò a lavorare la propria materia nel vuoto».
32. Confronta Hypostasis, 142, 10-15: «E un’ombra si formò sotto la cortina, e quell’ombra si trasformò in materia e… fu messa da un’altra parte (esterna)… paragonabile ad un aborto»; Origine, 146,26 – 147,20: «La sua parte esterna è Ombra che fu chiamata Tenebra. Da essa venne un Potere… I Poteri che sorsero dopo di essa chiamarono l’Ombra ‘il Caos senza limiti’. Da esso sorse la razza degli dèi… cosicché una razza di aborti seguì dalla prima opera… Il Profondo (Chaos) perciò viene dalla Pistis… Come quando una donna partorisce, tutta la sua abbondanza (dopo la nascita) se ne va, così procedette la Materia dall’Ombra». Questo è molto vicino alla dottrina valentiniana: la barbelo-gnosi a cui appartengono i due scritti (come anche l'”Apocrifo di Giovanni”), è in genere di tutte le varietà di gnosticismo quella più affine alla speculazione valentiniana sulle origini (confronta “Gnosis und spätantiker Geist”, I, p. 361).
33. Ved. sopra, nota 31 e 24, 22 s.s.: il mondo è la «forma» (schema) della «deficienza» [perciò «deficienza» la sua materia], e «deficienza» sorse a causa dell’Ignoranza primordiale riguardo al Padre.
34. «Essa vide la cattiveria e l’apostasia che aderivano a suo figlio. Essa si pentì…» (eccetera): v. sopra, p. 217 s. nero.
35. Per la generazione del demiurgo tramite un riflesso sulle acque dell’abisso, v. sopra, p. 180 nero, nota 16; confronta le osservazioni generali sul tema dell’immagine riflessa, p. 81 s.s. nero.
36. La differenziazione è presente in modo completo nel “Vangelo di Filippo”, 108, 10-15: «Altro è Ekhamoth e altro è Ekhmoth. Ekhamoth è la Sophia semplicemente, ma Ekhmoth è la Sophia di Morte… che è chiamata ‘la piccola Sophia’». Il “Vangelo di Filippo” è certamente una composizione valentiniana: confronta H. M Schenke in “Theologische Literaturzeitung” 84 (1959), 1, col. 2 s.
37. “Theologische Literaturzeitung” 84 (1959), 4, col. 246 s. [Vedi la traduzione italiana dei due scritti in LUIGI MORALDI, “La gnosi e il mondo. Raccolta di testi gnostici”, in I Tascabili degli Editori Associati 16 (Milano, Editori Associati 1988)].
38. Il m.s. ha «esterno»; un evidente errore.
39. Schenke (op. cit., 251, n. 39) osserva circa questo passo che l’insegnamento di questo (e del precedente) trattato, secondo cui “Ialdabaoth” proviene dal Caos, conferma in modo brillante le spiegazioni che già Hilgenfeld aveva proposto per lo strano nome del demiurgo: “yalda bahuth” (Figlio del Caos).
40. Per questa apparizione dell’Uomo celeste e la sua sequela nel nostro testo, che portano all’origine dell’uomo terreno, di Eros e della vita delle piante, Schenke propone due paralleli da due campi dello gnosticismo profondamente diversi: “Poimandres”, paragrafi 12-17, dove la “Physis” femminile che è presa d’amore per il divino “Anthropos”, corrisponderebbe alla Pronoia (op. cit., col. 254, n. 57; v. sopra, p.p. 163 s.; 173 s.s.; 185 s. [in nero]); e dalla dottrina di Mani, la funzione del «Terzo Messaggero» quando causa l’origine di piante, animali e uomini, facendo nascere il desiderio, con contaminazioni e aborti, degli arconti maschi e femmine (op cit., col. 247; v. sopra, p. 240 s.s. in nero).
41. Dal monastero di Zuqnin vicino Amida: la “Cronaca” si conclude con l’anno 774 d.C.; citata in U. MONNERET DE VILLARD, “Le leggende orientali sui Magi evangelici, p. 27 s.
42. La numerazione dei diversi studiosi varia alquanto.
43. Per una presentazione più completa dell’argomento trattato nelle pagine seguenti vedere i miei due articoli: “Evangelium Veritatis…”, «Gnomon» 32 (1960), 327-335 e “Evangelium Veritatis and the Valentinian Speculation”, «Studia Patristica», vol. VI (Texte u. Unters z. Gesch. d. Altchr. Litr. 81), Berlino, Akademie Verlag, 1962, p.p. 96-111.
44. Parti di questi passi sono state citate precedentemente alle p.p. 79, 197 s., 198, 199, 200, 201, 210 s. in nero. Altre citazioni da E V. si possono trovare alle p.p. 88, 90, 93, 94, 95 s., 103, 110, 196 (8), 210 in nero.
45. Qui c’è un passaggio dal macrocosmo al microcosmo, dalla salvezza universale a quella individuale, perché gli antecedenti si riferiscono agli Eoni e non all’uomo terrestre.
46. Questo in copto serve anche ad esprimere un passivo impersonale: così «essi non conoscono il Padre» = «il Padre è sconosciuto».
47. Non importa quale: l’E.V. riflette il punto centrale del valentinismo come tale e sotto questo denominatore comune concorda con qualunque versione di esso. Può anche riflettere una versione particolare e sconosciuta. Non dobbiamo dimenticare ciò che Ireneo ha detto circa la libertà personale di invenzione circolante nella scuola (Adv. haer. I, 18, 5).
48. «Angoscia» e «Terrore» non sembrano persone, ma devono essere stati di persone o di una persona, e qui si pensa alla Sophia, dai cui «affetti» nella speculazione valentiniana si condensano gli elementi di natura: e gli «affetti» a loro volta sono prodotto di «ignoranza». «Errore» è senz’altro una persona e qui si pensa al demiurgo. La «formazione» che forma dalla materia come un «equivalente» o «sostituto» (ossia, ad imitazione?) della «Verità» potrebbe essere secondo le generali analogie gnostiche sia l’universo che l’uomo, ma nel seguito dell’E.V. il riferimento cosmico predomina. Ciò che l’Errore forma è «la propria hyle»; perché «la propria»? E’ la «nebbia» in cui l’«angoscia» è condensata? Dal suo effetto oscuratore (spegnendo la luce e così la visibilità) l’Errore in principio «guadagnò forza»: una forza negativa, ossia «dimenticanza». Ma oltre ad esser la fonte, la «nebbia» (o un’ulteriore condensazione di essa?) può essere anche il materiale (“hyle”) per l’attività di questa forza: se così, si potrebbe dire che la «materia» è l’aspetto esterno, la «dimenticanza» quello interno della «deficienza» in cui l’Errore si oggettiva. Nel prodotto finale, la «deficienza» è il mondo come formato dall’Errore in una «forma» (“schema”) in cui la forza della dimenticanza che sta alla radice continua a vivere.
49. Questa tesi è stata avanzata da van Unnik (H. C. PUECH, G. QUISPEL, W. C. VAN UNNIK, “The Jung Codex”, London, 1955, p.p. 81-129): è trattata criticamente nei miei articoli nominati prima, nota 43. Il tenore dell’argomento è che sia più probabile che l’astrazione venga dopo l’immaginazione concreta e non prima. Di conseguenza l’E.V. sarebbe una specie di «demitizzazione» del valentinianismo (potrebbe ugualmente essere di Valentino stesso o di un contemporaneo). Si deve concedere che anche l’inverso, un principio pre-mitologico, quasi-filosofico, che viene poi rivestito di mitologia, non è impossibile per sé. Ma che l’E.V. col suo libero gioco di variazioni mistiche su un tema teologico soggiacente, con la sua immaginativa ricca, liberamente unita e mai mescolata, appartenga ad uno stadio immaturo del valentinismo è secondo me quanto mai improbabile.
50. Non sono mai stato convinto che Ireneo dal cap. 19 in poi tratti ancora dei Marcosiani e non dell’insegnamento valentiniano in generale.
51. Ved. per esempio, la mia trattazione in “Gnosis und spätantiker Geist”, I (1934), 206, 2; 374 s.; confronta II, 1 (1954), 162 s.
Epilogo.
GNOSTICISMO, ESISTENZIALISMO E NICHILISMO.
Mi propongo in questo capitolo di tracciare, in via sperimentale, un paragone tra due movimenti o posizioni o sistemi di pensiero molto distanti tra loro nel tempo e nello spazio e, a prima vista, in apparenza incommensurabili: l’uno dei nostri giorni, concettuale, raffinato ed eminentemente «moderno» in senso non soltanto cronologico; l’altro di un passato nebbioso, mitologico, rozzo, qualcosa di balzano anche al suo tempo, e mai ammesso nella rispettabile compagnia della nostra tradizione filosofica. Il mio punto di vista è che i due abbiano qualcosa in comune e che questo «qualcosa» sia tale che, studiato tenendo ben presenti somiglianze e differenze, possa contribuire a chiarirli entrambi.
Dicendo «chiarirli entrambi» ammetto che ciò sia nel senso di una certa circolarità. La mia esperienza personale può spiegare ciò che voglio dire. Quando molti anni or sono mi dedicai allo studio dello gnosticismo, mi accorsi che molti punti di vista acquisiti alla scuola di Heidegger mi permettevano di vedere aspetti del pensiero gnostico non prima avvertiti. Ed ero sempre più impressionato dall’aria di famiglia di ciò che appariva invece del tutto strano. Sono propenso a credere, guardando indietro, che fu l’emozione per questa affinità oscuramente sentita, che mi attirò per prima nel labirinto gnostico. In seguito, dopo un lungo soggiorno in quelle remote regioni, ritornando alla scena filosofica contemporanea che mi è propria, mi accorsi che ciò che avevo imparato là mi aveva messo in grado di comprendere meglio la sponda da cui ero partito. Il prolungato contatto con l’antico nichilismo si era dimostrato un aiuto – almeno per me – per comprendere il moderno nichilismo, proprio come quest’ultimo mi aveva permesso inizialmente di scoprire il suo oscuro cugino del passato.
Era accaduto che l’esistenzialismo, che mi aveva fornito i mezzi di un’analisi storica, era stato coinvolto nei risultati di essa. L’adeguatezza delle sue categorie alla particolare materia in esame meritava di esser presa in considerazione. Si adattavano come se fossero fatte su misura: erano davvero state fatte su misura? In partenza avevo giudicato questa adattabilità un semplice caso della loro presunta validità generica, che avrebbe assicurato la loro utilità nell’interpretazione di qualsiasi «esistenza» umana. Ma poi si fece luce in me che l’applicabilità delle categorie nel caso presente fosse piuttosto dovuta al genere di «esistenza» da entrambi le parti: quella che aveva fornito le categorie e quella che corrispondeva ad esse così bene.
Era il caso di un iniziato che credeva di essere in possesso di una chiave che avrebbe aperto tutte le porte: arrivai a questa porta speciale, provai la chiave e, meraviglia!, si adattava alla serratura e la porta si spalancò. Così la chiave aveva dimostrato quanto valeva. Soltanto in seguito, quando mi fui liberato dalla credenza in una chiave universale, cominciai a domandarmi “perché” questa chiave particolare aveva funzionato così bene in questo caso. Mi ero forse imbattuto proprio nel tipo di chiave fatta per quel tipo di serratura? Se sì, “che cosa” c’era in comune tra l’esistenzialismo e lo gnosticismo che permetteva che quest’ultimo si aprisse al tocco del primo? Con tale rovesciamento di approccio, le soluzioni in un caso diventavano domande nell’altro, mentre al principio erano solo sembrate conferma della validità generale.
Perciò l’incontro dei due, iniziato come incontro di un metodo con una data materia, terminò col darmi la certezza che l’esistenzialismo, il quale pretendeva di essere la spiegazione dei fondamenti dell’esistenza umana come tale, è invece la filosofia di una condizione particolare, storicamente determinatasi, dell’esistenza umana: e una situazione analoga (sebbene differente sotto altri aspetti) aveva dato origine ad una risposta analoga nel passato. L’oggetto in esame si cambiava in un esempio concreto, che dimostrava insieme la necessità e la contingenza dell’esperienza nichilistica. Il problema posto dall’esistenzialismo non perde con ciò di serietà, ma è acquisita un’esatta prospettiva, col rendersi conto della situazione che esso riflette ed a cui è limitata la validità di alcune sue intuizioni.
In altre parole, le funzioni ermeneutiche sono invertite e reciproche – la serratura si cambia in chiave e la chiave nella serratura: la lettura «esistenzialista» dello gnosticismo, giustificata dal successo ermeneutico, invita come naturale complemento alla lettura «gnostica» dell’esistenzialismo.
Più di due generazioni fa, Nietzsche disse che il nichilismo, «questo ospite fantasma», «sta alla porta» (1). Nel frattempo l’ospite è entrato e non è più ospite, e l’esistenzialismo, per quel che riguarda la filosofia, sta cercando di vivere con lui. Vivere in tale compagnia significa vivere in una crisi. Gli inizi della crisi risalgono al diciassettesimo secolo, quando si forma la condizione spirituale dell’uomo moderno.
Tra le caratteristiche che hanno determinato tale situazione ce n’è una che Pascal per primo ha affrontato in tutte le sue terrificanti implicanze ed ha esposto con tutta la forza della sua eloquenza: la solitudine dell’uomo nell’universo fisico della moderna cosmologia. «Gettato nell’infinita immensità degli spazi che ignoro e che non mi conoscono, ne sono spaventato» (2). «Che non mi conoscono»: più che l’infinità intimidante degli spazi cosmici e dei tempi, più che la sproporzione quantitativa, cioè l’insignificanza dell’uomo come grandezza in tale vastità, è il «silenzio», ossia l’indifferenza di questo universo di fronte alle aspirazioni umane – il non conoscere le cose umane da parte di quello entro cui si svolgono tutte le umane vicende – che costituisce la profonda solitudine dell’uomo nella totalità delle cose.
Come parte di questa totalità, come esempio di natura, l’uomo è soltanto una canna, esposta ad essere schiacciata ad ogni momento dalle forze di un universo cieco e immenso in cui l’esistenza non è che un cieco accidente particolare, non meno cieco di quanto sarebbe la sua distruzione. Come canna pensante, tuttavia, non fa parte della totalità, non appartiene ad essa, ma è radicalmente diversa, incommensurabile: perché la “res extensa” non pensa, così insegnava Cartesio, e la natura non è altro che “res extensa” – corpo, materia, grandezza esterna. Se la natura schiaccia la canna, lo fa inconsapevolmente, mentre la canna – l’uomo – anche quando è schiacciata, ne ha coscienza (3). Soltanto l’uomo nel mondo pensa, non perché è parte della natura, ma nonostante ciò. Come egli non partecipa al significato della natura, ma semplicemente attraverso il suo corpo ad una sua determinazione meccanica, così la natura non partecipa ai suoi problemi interiori. Così ciò per cui l’uomo è superiore a tutta la natura, la sua unica distinzione, la mente, non sfocia più in una integrazione del suo essere con la totalità dell’essere, ma, al contrario, segna un abisso insormontabile tra l’uomo stesso e il resto dell’esistenza. Estraniato dalla comunità dell’essere come un tutto unico, la sua coscienza lo fa soltanto sentire un estraneo al mondo, e in ogni atto di riflessione gli parla di tale completa estraneità.
Questa è la condizione umana. E’ finito il “cosmos” con il “logos” immanente con cui il proprio “logos” si sentiva affine; finito l’ordine del tutto in cui l’uomo ha il suo posto. Quel posto appare ora un puro accidente irragionevole. «Sono spaventato e sorpreso – dice Pascal – di trovarmi qui piuttosto che là; infatti non c’è nessuna ragione perché qui piuttosto che là, perché ora invece che dopo». C’era sempre stata una ragione per il «qui» fintantoché il cosmo era stato considerato come il posto naturale dell’uomo, ossia finché il mondo era stato visto come «cosmos». Ma Pascal parla di «questo remoto angolo della natura», in cui l’uomo si dovrebbe «considerare come perduto», dell’«angusta cella in cui si trova collocato, cioè l’universo (visibile)» (4). La totale contingenza della nostra esistenza nello schema priva quello schema di ogni senso umano, che possa farlo vedere come una struttura cui riferirsi per la comprensione di noi stessi.
Ma c’è in tale situazione qualcosa di più che un semplice sentimento di apolide, di solitudine e di paura. L’indifferenza della natura significa anche che la natura non ha rapporto col fine. Con l’esclusione della teleologia dal sistema delle cause naturali, la natura senza più scopi non fornisce alcuna sanzione per i possibili scopi umani. Un universo senza un’intrinseca gerarchia di essere, come è l’universo copernicano, lascia i valori senza sostegno ontologico e l’io è abbandonato interamente a se stesso nella sua ricerca di un significato e di un valore. Il significato non si trova più ma viene «conferito». I valori non sono più considerati nella visione della realtà oggettiva, ma sono postulati come sforzi di valutazione. I fini, come funzioni della volontà, sono soltanto mia creazione. La volontà sostituisce la visione; la temporalità dell’atto elimina l’eternità del «bene in sé». Questa è la fase nietzschiana della situazione in cui il nichilismo europeo appare alla superficie. L’uomo è ormai solo con se stesso.
“Il mondo è una porta
su deserti che si stendono freddi e muti.
Chi una volta ha perduto
ciò che tu hai perduto
non è mai fermo comunque il posto muti”.
Così parlava Nietzsche (in “Vereinsamt”), chiudendo la poesia con le parole: «Guai a colui che non ha casa!».
L’universo di Pascal, è vero, era ancora un universo creato da Dio, e l’uomo solitario, privo di ogni umano sostegno, poteva pur sempre sollevare il cuore verso il Dio transmondano. Ma questo Dio è un Dio sconosciuto, “agnostos theos”, e non è possibile scoprirlo nella sua creazione. L’universo non rivela lo scopo del Creatore col disegno del suo ordine, né la sua bontà con l’abbondanza delle cose create, né la sua sapienza con la loro proporzione, né la sua perfezione con la bellezza del tutto, ma rivela solamente il suo potere con la sua grandezza, la sua immensità spaziale e temporale. Perché l’estensione, o la quantità, è l’unico attributo essenziale lasciato al mondo, e quindi se il mondo ha qualche cosa da dire del divino, lo fa per mezzo di questa proprietà; e ciò di cui la grandezza può parlare è il potere (5). Ma un mondo ridotto ad una pura manifestazione di potere non ammette anche verso se stesso che una relazione di potere, ossia di padronanza, una volta che la relazione trascendente è messa da parte e l’uomo è lasciato solo di fronte a se stesso e al mondo. La contingenza dell’uomo, della sua esistenza qui e ora, è ancora per Pascal una contingenza dipendente dalla volontà di Dio; ma quella volontà che mi ha messo proprio in «questo remoto angolo della natura», è imperscrutabile e il «perché» della mia esistenza non trova risposta qui come non la troverebbe nell’esistenzialismo più ateo. Il “deus absconditus”, del quale non si può predicare che la volontà e il potere, lascia dietro di sé come eredità, dopo aver abbandonato la scena, l'”homo absconditus”, un concetto di uomo caratterizzato soltanto dalla volontà e dal potere: la volontà per potere, la volontà per volere. Per una tale volontà anche la natura indifferente è più un’occasione per il suo esercizio che un oggetto reale (6).
Il punto che interessa particolarmente agli scopi di questa discussione è che un cambiamento nella visione della natura, ossia dell’ambiente cosmico dell’uomo, è al fondo di quella condizione metafisica che ha dato origine al moderno esistenzialismo e alle sue implicanze nichilistiche. Ma se è così, se l’essenza dell’esistenzialismo è un certo dualismo, una separazione tra uomo e mondo, con la perdita dell’idea di un “cosmos” affine – in breve, un acosmismo antropologico – allora non è necessariamente la sola scienza fisica moderna che può creare tale condizione. Un nichilismo cosmico, qualunque siano le circostanze storiche che lo hanno prodotto, sarà la condizione in cui si possono evolvere alcuni lineamenti caratteristici dell’esistenzialismo. E la misura in cui di fatto lo troviamo realizzato potrebbe essere una prova della pertinenza che attribuiamo all’elemento descritto nella posizione esistenzialista.
C’è un’unica situazione che io conosca nella storia dell’uomo occidentale, in cui quella condizione – ad un livello mai raggiunto da nessun pensiero scientifico moderno – è stata perfettamente sentita e vissuta con tutta la forza di un evento da cataclisma. E’ il movimento gnostico, o meglio i più radicali tra i movimenti e gli insegnamenti gnostici che gli sconvolgimenti dei primi tre secoli dell’èra cristiana hanno prodotto nelle parti ellenistiche dell’Impero Romano e al di là dei suoi confini orientali. Perciò possiamo sperare di imparare da essi qualcosa per la comprensione di quell’argomento inquietante che è il nichilismo, ed io vorrei darne al lettore una dimostrazione, per quanto è possibile nel breve spazio di questo capitolo, e con tutte le riserve che l’esperimento di un tale raffronto esige.
L’esistenza di un’affinità o analogia attraverso i secoli, quale è qui affermata, non è sorprendente se si ricorda che sotto più di un aspetto la situazione culturale del mondo greco-romano nei primi secoli cristiani presenta ampi paralleli con la situazione moderna. Spengler è giunto al punto di dichiarare che le due età sono «contemporanee», nel senso che sono fasi identiche del ciclo di vita delle loro rispettive civiltà. In questo senso analogico ci trasportiamo ora nel periodo dei primi Cesari. Comunque siano le cose, c’è più di una semplice coincidenza nel fatto che ci riconosciamo in tanti aspetti della tarda antichità postclassica, molto più, in ogni caso, che nell’antichità classica. Lo gnosticismo è uno di quegli aspetti e il riconoscimento, reso difficile dalla stranezza dei simboli, ci colpisce come qualcosa di inatteso, in modo particolare per chi conosce lo gnosticismo, perché l’effusione della sua fantasia metafisica non sembra accordarsi con la disillusione austera dell’esistenzialismo, come pure il suo carattere religioso con l’essenza atea, fondamentalmente «postcristiana», con cui Nietzsche identifica il moderno nichilismo. Tuttavia un raffronto può offrire qualche risultato interessante.
Il movimento gnostico – così dobbiamo chiamarlo – era un fenomeno largamente diffuso nei secoli critici che abbiamo nominato, alimentato, come il cristianesimo, dagli impulsi di una situazione umana largamente prevalente, e che perciò erompeva in molti luoghi, in molte forme e molte lingue. Tra le caratteristiche che qui dobbiamo sottolineare c’è l’atteggiamento fondamentalmente dualistico che è alla base dello gnosticismo e ne unifica le espressioni assai diverse, più o meno sistematiche. E’ su questa base primariamente umana di un’esperienza profondamente sentita di sé e del mondo che poggia la dottrina dualistica formulata. Il dualismo è tra l’uomo e il mondo, e nello stesso tempo tra il mondo e Dio. E’ una dualità di termini contrari, non complementari; ed è unica, perché quella tra l’uomo e il mondo rispecchia sul piano dell’esperienza quella tra il mondo e Dio e deriva da questa come dal suo fondamento logico, a meno che non si voglia considerare “e converso” che la dottrina trascendente di un dualismo mondo-Dio provenga dall’esperienza immanente della disunione tra l’uomo e il mondo come suo fondamento psicologico. In questa configurazione di tre termini – uomo, mondo, Dio – l’uomo e Dio stanno insieme in contrapposizione al mondo, ma nonostante questo essenziale «stare-insieme», di fatto sono separati precisamente dal mondo.
Per lo gnostico tale fatto è il soggetto della conoscenza rivelata, e determina l’escatologia gnostica: “noi” possiamo vedere in esso la proiezione della sua esperienza fondamentale, che ha così creato per sé la propria verità rivelatrice. Primario sarebbe allora il sentimento di una totale frattura tra l’uomo e ciò in cui si trova collocato, il mondo. E’ tale sentimento che si esplica in forma di dottrina oggettiva. Nel suo aspetto teologico questa dottrina afferma che il Divino è estraneo al mondo e non ha niente a che vedere con l’universo fisico; che il vero dio, assolutamente trascendente, non è rivelato né minimamente indicato dal mondo ed è perciò lo Sconosciuto, il totalmente Altro, inconoscibile nei termini di qualsiasi analogia col mondo. Analogamente, nel suo aspetto cosmologico, afferma che il mondo non è creazione di Dio, ma di un principio inferiore, di cui esso eseguisce la legge; e nel suo aspetto antropologico, afferma che il sé interiore dell’uomo, il “pneuma” («spirito» in contrapposizione ad «anima» = “psyche”) non è parte del mondo, della creazione e dell’ambito della natura, ma è, all’interno del mondo così totalmente trascendente e sconosciuto in tutte le sue categorie terrene quanto lo è all’esterno il suo corrispondente transmondano, il Dio sconosciuto.
Che il mondo sia creato da un qualche agente personale è in genere dato per scontato nei sistemi mitologici, sebbene in alcuni sembra che operi nella sua genesi una certa necessità impersonale prodotta da un oscuro impulso. Ma chiunque sia colui che ha creato il mondo, l’uomo non gli deve obbedienza, né rispetto per la sua opera. La sua opera, sebbene circondi l’uomo in modo incomprensibile, non gli offre le stelle con cui dirigere il suo cammino, e nemmeno lo vuole la sua proclamata volontà. Poiché non può essere Dio il creatore di ciò che è così estraneo all’individuo, la natura manifesta semplicemente il suo demiurgo inferiore; come potere molto al di sotto del Dio Supremo a cui anche l’uomo può guardare dall’alto del suo spirito simile a dio, tale perversione del Divino ha conservato di lui soltanto il potere di agire, ma di agire ciecamente senza conoscenza e benevolenza. Così il demiurgo ha creato il mondo dall’ignoranza e dalla passione.
Il mondo dunque è il prodotto, e persino l’incarnazione, del negativo di conoscenza. Ciò che rivela è una forza non illuminata e perciò malefica, che procede dallo spirito di un potere che s’impone, dalla volontà di dominio e costrizione. La cecità di questa volontà è lo spirito del mondo, che non ha rapporto con la comprensione e l’amore. Le leggi dell’universo sono le leggi di questa dominazione e non della sapienza divina. Il potere diviene così l’aspetto principale del cosmo e la sua essenza interna è l’ignoranza (“agnosia”). Si aggiunge a ciò come complemento positivo che l’essenza dell’uomo è conoscenza, conoscenza di sé e di Dio: questo determina la sua situazione come quella di una potenziale conoscenza in mezzo alla non-conoscenza, della luce in mezzo alle tenebre, e questa relazione è al fondo del suo essere forestiero, senza società nell’oscura vastità dell’universo.
Questo universo non ha nulla della venerabilità del “cosmos” greco. Gli si applicano epiteti dispregiativi: «questi elementi miserabili» (“pauperrima haec elementa”), «questa minuscola cella del creatore» (“haec cellula creatoris”) (7). Pure è ancora “cosmos”, ordine, ma un ordine con vendetta, estraneo alle aspirazioni dell’uomo. Il riconoscimento di ciò è mescolato a disprezzo, timore e sfida. Il marchio della natura non sta in una qualche deficienza di ordine, ma nella completezza troppo invadente di esso. Lontano dall’essere caos, la creazione del demiurgo, per quanto cieca, è pur sempre un sistema di legge. Ma la legge cosmica, una volta adorata come espressione di una ragione con la quale la ragione dell’uomo poteva comunicare nell’atto di conoscenza, è ora considerata soltanto nel suo aspetto di costrizione che contrasta la libertà dell’uomo. Il “logos” cosmico degli Stoici, che era identificato con la provvidenza, è sostituito dall'”heimarméne”, il fato cosmico oppressivo.
Questo “fatum” è regolato dai pianeti, o dalle stelle in genere, personificazioni della legge rigida e ostile dell’universo. Il cambiamento di contenuto emotivo del termine “cosmos” non è meglio simbolizzato che dal dispregio di quella parte anticamente più divina del mondo visibile, le sfere celesti. Il cielo stellato – per i Greci dopo Pitagora l’incarnazione più pura della ragione nell’universo sensibile e la garanzia della sua armonia – guarda ora in faccia l’uomo con lo sguardo fisso di un potere e di una necessità straniera. Non essendo più affini, e tuttavia potenti quanto prima, le stelle sono divenute tiranni: temute ma nello stesso tempo disprezzate, perché sono inferiori all’uomo. «Essi (dice Plotino con indignazione degli Gnostici), che giudicano l’infimo degli uomini degno di essere chiamato loro fratello, negano da pazzi questo titolo al sole, alle stelle del cielo, persino all’anima del mondo, nostra sorella!» (Enn. II, 9, 18). Chi è più «moderno», possiamo domandarci, Plotino o gli Gnostici? «Essi dovrebbero smetterla (egli dice altrove) con i loro racconti pieni di orrore intorno alle sfere cosmiche… Se l’uomo è superiore agli altri esseri animati, quanto più lo sono le sfere, che non sono nel Tutto per esercitare tirannia, ma per conferire ad esso ordine e legge» (ibid. 13). Sappiamo già come gli Gnostici consideravano questa legge; essa non aveva nulla della provvidenza, ma era nemica della libertà dell’uomo. Sotto questo cielo spietato, che non ispirava più confidenza devota, l’uomo diventa cosciente della sua totale solitudine. Circondato da esso, soggetto al suo potere, eppure superiore ad esso per la nobiltà della sua anima, l’uomo non si riconosce parte del sistema che lo avvolge, ma inspiegabilmente posto in esso ed esposto ad esso.
E, come Pascal, egli è spaventato. La sua solitaria alterità che scopre se stessa nella solitudine, prorompe nel sentimento di paura. La paura come risposta dell’anima al suo essere-nel-mondo è un tema ricorrente nella letteratura gnostica. La reazione dell’io alla scoperta della propria situazione è di fatto essa stessa un elemento in quella scoperta: segna il risveglio dell’io interiore dal sonno o dall’ubriacatura del mondo. Perché il potere degli spiriti delle stelle o del cosmo in generale non è semplicemente un potere esterno di costrizione fisica, ma anche più uno interno di alienazione e di estraniarsi da sé. Acquistando coscienza di se stesso, l’io scopre anche che non è padrone di se stesso, ma è piuttosto l’esecutore involontario dei disegni cosmici. La conoscenza, “gnosis”, può liberare l’uomo da questa schiavitù; ma poiché il “cosmos” è contrastante con la vita e con lo spirito, la conoscenza salvifica non mira all’integrazione nel tutto cosmico e alla compiacenza per le sue leggi, come avveniva per la sapienza stoica, che cercava la libertà in un consenso consapevole alla determinata necessità del tutto. Per gli Gnostici al contrario l’alienazione dal mondo deve essere approfondita e portata a fine per la liberazione dell’io interiore che soltanto così può conquistare se stesso. Il mondo (non l’alienazione da esso) deve essere superato; e un mondo degradato ad un sistema di potere può essere vinto soltanto per mezzo del potere. E naturalmente il superamento di cui si tratta è tutt’altro che una padronanza tecnologica. Il potere del mondo è superato, da una parte, per mezzo del potere del Salvatore che penetra in questo sistema chiuso dall’esterno e, dall’altra parte, dal potere della «conoscenza» portata da lui, che come un’arma magica sconfigge la forza dei pianeti e apre la via all’anima attraverso i loro ordini.
Per quanto tutto ciò sia differente dalla relazione di potere dell’uomo moderno con la causalità del mondo, c’è una somiglianza ontologica nel fatto che l’opporre il potere al potere è la sola relazione che rimane all’uomo, in entrambi i casi, con la totalità della natura.
Prima di procedere oltre, soffermiamoci a chiederci che cosa è avvenuto dell’antica idea del “cosmos” come un tutto divinamente ordinato. Certamente in questa svalutazione catastrofica o spogliamento spirituale dell’universo non c’è niente di lontanamente paragonabile alla scienza fisica moderna. Basta notare che nel periodo gnostico l’universo è interamente demonizzato. Tuttavia ciò, insieme con la trascendenza dell’io acosmico, presenta delle curiose analogie con alcuni fenomeni che l’esistenzialismo ha individuato nell’ambiente moderno diversissimo. Che cosa dunque, se non la scienza e la tecnica, ha causato per i gruppi umani coinvolti la sparizione della pietà cosmica della civiltà classica, su cui poggiava gran parte della loro etica?
La risposta è certamente complessa, ma almeno una parte può esserne brevemente indicata. Siamo in presenza del rifiuto della dottrina classica del «tutto e delle parti» e alcune ragioni di tale rifiuto vanno ricercate nella sfera politica e sociale. La dottrina dell’ontologia classica secondo cui il tutto ha la precedenza sulle parti, è migliore delle parti ed è la ragione per cui le parti esistono ed in cui trovano il significato della loro esistenza – questo assioma da lungo tempo in valore – aveva perso la base sociale della sua validità. L’esempio vivente di questo tutto era stato la “polis” classica. [Rimandiamo il lettore alle p.p. 265-267 (in nero) di questo volume che riportano per esteso questa parte dello studio. Ne riassumiamo il senso riferendo l’ultima frase di p. 267.] Le masse recentemente disperse nell’Impero, che non avevano condiviso quella nobile tradizione, potevano reagire molto diversamente ad una situazione in cui si trovavano passivamente coinvolte: una situazione nella quale la parte era insignificante per il tutto, e il tutto estraneo alle parti. L’aspirazione dell’individuo gnostico non era quella di «rappresentare una parte» in questo tutto, ma – in linguaggio esistenzialista – di «esistere in modo autentico». La legge dell’Impero sotto la quale si trovava, faceva parte di una forza esterna, inaccessibile; e per lui la legge dell’universo, il destino cosmico, di cui lo Stato era l’esecutore terreno, assumeva lo stesso carattere. Il concetto stesso di legge era perciò messo in discussione in tutti i suoi aspetti: come legge naturale, come legge politica e come legge morale.
Questo ci riporta al nostro raffronto.
Il sovvertimento dell’idea di legge, di “nomos”, conduce a conseguenze etiche in cui il nichilismo dell’acosmismo gnostico, e nello stesso tempo l’analogia con alcuni moderni ragionamenti, è ancora più evidente che nell’aspetto cosmologico. Mi riferisco all’antinomismo gnostico. Bisogna concedere in partenza che la negazione di ogni norma oggettiva di condotta poggia su basi teoretiche molto diverse nella gnosi e nell’esistenzialismo, e che la gnosi antinomistica appare rozza e ingenua in confronto con la sottigliezza concettuale e la riflessione storica del suo corrispondente moderno. Ciò che doveva essere liquidato nel primo caso era l’eredità morale di un millennio di antica civiltà; oltre a ciò nell’altro caso c’erano duemila anni di metafisica cristiana occidentale come fondamento dell’idea di legge morale.
Nietzsche segnalò la radice della situazione nichilistica con la frase «Dio è morto», indicando innanzi tutto il Dio cristiano. Gli Gnostici, se richiesti di riassumere in modo simile la base metafisica del loro nichilismo, avrebbero detto semplicemente «il Dio del cosmo è morto», ossia è morto come dio, ha cessato di essere divino per noi e perciò di fornirci la stella polare per le nostre vite. La catastrofe in questo caso è senz’altro meno totale e perciò meno irrimediabile, ma il vuoto che ha lasciato, anche se non così abissale, non era meno profondamente sentito. Per Nietzsche il significato di nichilismo è che «i più alti valori sono svalutati» (o resi invalidi) e la causa di tale svalutazione è «l'”intuizione” che non abbiamo la più piccola giustificazione per porre un al di là o un ‘in sé’ delle cose che sia ‘divino’, che sia la moralità in persona» (8). Questa affermazione, insieme con quella sulla morte di Dio, dà ragione all’idea sostenuta da Heidegger che «nel pensiero di Nietzsche i nomi Dio e Dio cristiano sono usati per indicare il mondo trascendente (soprasensibile) in generale. Dio è il nome per il regno delle idee e degli ideali» (“Holzwege”, p. 199). Poiché è solamente da questo regno che può provenire la natura normativa dei valori, il suo svanire, ossia la «morte di Dio», significa non soltanto la svalutazione dei supremi valori, ma anche la perdita di ogni possibilità di valori che obblighino come tali. Per citare ancora una volta l’interpretazione di Heidegger del pensiero nietzschiano: «La frase ‘Dio è morto’ significa che il mondo soprasensibile è senza forza effettiva» (ibid., p. 200).
In una maniera modificata, alquanto paradossale, questa affermazione si applica anche alla posizione gnostica. E’ pur vero che il suo estremo dualismo è di per se stesso l’opposto di un abbandono della trascendenza. Il Dio transmondano la rappresenta nella forma più radicale. In lui l’assoluto che è al di là traspare attraverso gli involucri cosmici che lo circondano. Ma tale trascendenza, a differenza del «mondo intelligibile» del platonismo o del Signore del mondo del giudaismo, non è in rapporto positivo col mondo sensibile. Non è l’essenza o la causa di esso, ma la sua negazione e cancellazione. Il Dio gnostico, in quanto distinto dal demiurgo, è il totalmente diverso, l’altro, lo sconosciuto. In modo analogo al suo corrispondente interno all’uomo, il sé acosmico o “pneuma”, la cui natura nascosta si rivela solamente nell’esperienza negativa di estraneità, di non-identificazione e di indefinibile libertà, questo Dio ha più del “nihil” che dell'”ens” nel suo concetto. Una trascendenza senza una relazione normativa col mondo equivale ad una trascendenza che ha perso la sua forza effettiva. In altre parole, per tutto quel che riguarda la relazione dell’uomo con la realtà che lo circonda questo Dio nascosto è una concezione nichilistica: nessun “nomos” emana da lui, nessuna legge per la natura e quindi nessuna norma per l’azione umana come parte dell’ordine naturale.
Su tali basi l’argomento antinomistico degli Gnostici è altrettanto semplice quanto quello di Sartre, per esempio. Poiché il trascendente è silenzioso, Sartre ne deduce che, visto che «non c’è alcun segno nel mondo», l’uomo, «l’abbandonato» e lasciato a sé, reclama la sua libertà, o piuttosto non può fare a meno di prendersela: egli «è» questa libertà, perché l’uomo «non è altro che il suo progetto» e «tutto gli è permesso» (9). Che tale libertà sia di un genere disperato ed essendo un impegno senza scopo ispiri timore anziché esultazione, è un’altra questione.
Talvolta nel pensiero gnostico l’argomento antinomistico appare sotto forma di un soggettivismo convenzionale. [Per il seguito il lettore può riportarsi alla parte precedente del libro, precisamente ai due paragrafi alle p.p. 288-289 che cominciano «A questo proposito…» e terminano «…frustrando individualmente il loro disegno».]
Quanto all’affermazione circa la libertà autentica dell’io, bisogna notare che tale libertà non riguarda l’«anima» (“psyche”), la quale è propriamente determinata dalla legge morale come il corpo lo è dalla legge fisica, ma riguarda interamente lo «spirito» (“pneuma”), il nucleo spirituale indefinibile dell’esistenza, la scintilla straniera. L’anima è parte dell’ordine naturale, creata dal demiurgo per avvolgere lo spirito forestiero, e secondo la legge normativa il creatore esercita controllo su ciò che gli appartiene legittimamente. L’uomo psichico, che può essere definito secondo la sua essenza naturale, per esempio come animale razionale, è ancora uomo naturale e tale «natura» non può condizionare l’io pneumatico più di quanto nella concezione esistenzialista qualsiasi essenza determinante possa pregiudicare l’esistenza che proietta liberamente se stessa.
Viene qui a proposito il raffronto con un argomento di Heidegger. Nella sua “Lettera sull’umanesimo”, Heidegger sostiene, contro la definizione classica di uomo come «animale razionale», che tale definizione pone l’uomo nell’ambito dell’animalità, specificato soltanto da una “differentia” che riguarda il “genus” «animale» come una particolare qualità. Questo, dice Heidegger, è porre l’uomo troppo in basso (10). Non voglio insistere se non si celi un sofisma verbale nel modo di argomentare sul termine «animale» come usato nella definizione classica (11). L’importante per noi è il rifiuto di qualsiasi «natura» definibile dell’uomo che assoggetterebbe la sua esistenza sovrana ad un’essenza predeterminata e lo renderebbe parte di un ordine oggettivo di essenze nella totalità della natura. In tale concezione di un’esistenza transessenziale, «che si proietta liberamente», mi sembra di notare qualche cosa di paragonabile alla concezione gnostica della negatività trans-psichica del pneuma. Ciò che non ha natura non ha norma. Soltanto ciò che appartiene ad un ordine di nature – sia esso un ordine di creazione o di forme intelligibili – può avere una natura. Solamente dove c’è un tutto c’è una legge. Nella discutibile concezione degli Gnostici ciò è valido per la “psyche”, che appartiene al tutto cosmico. L’uomo psichico non può fare altro che attenersi a un codice di leggi e cercare di essere giusto, ossia in senso proprio «aggiustato» all’ordine stabilito, e in tal modo svolgere la parte assegnatagli nello schema cosmico. Ma il “pneumaticós”, l’uomo «spirituale», che non appartiene ad alcuno schema oggettivo, è al di sopra della legge, al di là del bene e del male, ed è legge a se stesso secondo il potere della sua «conoscenza».
Ma su che cosa verte questa conoscenza, questa cognizione che non è dell’anima ma dello spirito, e per la quale l’uomo spirituale trova salvezza dalla schiavitù cosmica? Una famosa formula della scuola valentiniana riassume così il contenuto della “gnosis”: «Ciò che ci rende liberi è la conoscenza di chi eravamo, che cosa siamo divenuti; donde eravamo, dove siamo stati gettati; dove ci affrettiamo, da dove siamo redenti; che cosa è nascita e che cosa è rinascita» (12). Una vera esegesi di tale formula programmatica dovrebbe spiegare il mito gnostico per intero. Mi contenterò di alcune osservazioni formali.
Notiamo innanzi tutto il raggruppamento dualistico dei termini in coppie antitetiche e la tensione escatologica tra di essi con la direzione irreversibile dal passato al futuro. Osserviamo inoltre che i termini non rappresentano concetti di essere, ma di divenire, di movimento. La conoscenza è di una storia, nella quale essa stessa è un avvenimento critico. Tra questi termini di movimento quello di essere stati «gettati» in qualche cosa colpisce la nostra attenzione, perché è un termine col quale siamo diventati familiari nella letteratura esistenzialista. Ci ritorna alla mente la fase di Pascal «gettati nell’infinita immensità degli spazi», o quella della “Geworfenheit” di Heidegger «essendo stati gettati», che per lui è un carattere fondamentale del “Dasein”, dell’autoesperienza dell’esistenza. Il termine, per quanto mi è dato di giudicare, è originalmente gnostico. Nella letteratura mandea è una frase che ricorre di continuo: la vita è stata gettata nel mondo, la luce nella tenebra, l’anima nel corpo. Essa esprime la violenza originaria che mi è stata fatta nel farmi essere dove sono e quello che sono, la passività di emergere senza possibilità di scelta in un mondo esistente che non è stato fatto da me e la cui legge non è la mia. Ma l’immagine del gettare impartisce un carattere dinamico alla totalità dell’esistenza così iniziata. Nella formula citata ciò è ribadito dall’immagine di affrettarsi verso un fine. Spinta nel mondo, la vita è una specie di traiettoria che proietta se stessa verso il futuro.
Questo ci conduce all’osservazione finale che desidero fare a proposito della formula valentiniana: nei suoi termini temporali non provvede in alcun modo per un “presente”, nel cui contenuto sia compresa la conoscenza, e la cui considerazione sostenga la spinta in avanti. C’è passato e futuro, da dove veniamo e dove corriamo, e il presente è soltanto il momento della “gnosis” stessa, l’avventura del passaggio dall’uno all’altro in una crisi suprema del “nunc” escatologico. C’è tuttavia da notare una distinzione con i paralleli moderni: nella formula gnostica viene significato che, sebbene siamo gettati nella temporalità, abbiamo un’origine nell’eternità e perciò anche un fine nell’eternità. Questo mette il nichilismo della gnosi, inerente al cosmo, di fronte ad un fondamento metafisico che è totalmente assente dal suo corrispondente moderno.
Per tornare ancora una volta al corrispondente moderno, facciamo un’osservazione che potrà colpire lo studioso dell’opera di Heidegger, “Sein und Zeit”, il programma più profondo ed importante della filosofia esistenzialista. Heidegger vi svolge una «ontologia fondamentale» in riferimento ai modi in cui l’io «esiste», ossia costituisce il suo essere nell’atto di esistere dà origine ai significati molteplici di Essere in generale, come correlativi oggettivi. Questi modi sono definiti secondo un certo numero di categorie fondamentali che Heidegger preferisce chiamare «esistenziali». A differenza delle «categorie» oggettive di Kant, esse corrispondono in primo luogo a strutture non di realtà ma di comprensione, cioè non a strutture conoscibili di un mondo di dati oggettivi, ma a strutture funzionali del movimento attivo di tempo interiore, da cui un «mondo» è mantenuto e l’io è originato come accadimento continuo. Gli «esistenziali» hanno perciò ciascuno separatamente e tutti insieme un significativo profondamente temporale. Sono categorie di tempo interiore o mentale, la vera dimensione dell’esistenza, e articolano quella dimensione nei suoi tempi. Stando così le cose, essi devono presentare e distribuire tra loro i tre orizzonti del tempo: passato, presente e futuro.
Ora, se cerchiamo di sistemare questi «esistenziali», le categorie di esistenza di Heidegger, secondo questi tre aspetti principali, come è possibile fare, facciamo una scoperta sorprendente: una scoperta, per lo meno, che mi colpì profondamente quando, al momento in cui il libro apparve, cercai di tracciare il diagramma nella maniera classica di una «tavola di categorie». E’ stata la scoperta che la colonna sotto il termine «presente» rimane quasi vuota, almeno per quanto si tratta di modi di esistenza «genuina» o «autentica». Mi affretto ad aggiungere che questa è un’affermazione estremamente abbreviata. Di fatto, si dicono molte cose sul «presente» esistenziale, ma non precisamente come dimensione indipendente a sé stante. Perché il presente esistenzialmente «genuino» è il presente della «situazione», che è completamente definito in termini di “relazione” dell’io col suo «futuro» e col suo «passato». S’accende improvvisamente, per così dire, nella luce della decisione, quando il «futuro» progettato reagisce sul «passato» dato (“Geworfenheit”) e in questo incontro costituisce ciò che Heidegger chiama il «momento» (“Augenblick”): il momento, non la durata, è il modo temporale di “questo” «presente»; una creatura degli altri due orizzonti del tempo, una funzione della loro dinamica incessante, e non una dimensione indipendente da soffermarcisi. Tuttavia, distaccato dal suo contesto di movimento interno, il semplice «presente», per se stesso, denota appunto il rifiuto della relazione genuina tra futuro e passato nell’«abbandono» o «rinunzia» al discorso, all’interesse e all’anonimità di «ognuno» (“Verfallenheit”): un fallimento della tensione della vera esistenza, una specie di deficienza dell’essere. In realtà, “Verfallenheit”, termine negativo che include anche il significato di degenerazione e deterioramento, è «l’esistenziale» proprio del «presente» come tale, che denota un modo derivato e «deficiente» di esistenza.
Perciò sta la nostra affermazione precedente che tutte le categorie rilevanti di esistenza, quelle che riguardano la possibile autenticità della personalità, si ordinano in coppie correlative sotto i capitoli di passato o di futuro: «fatticità», necessità, essere divenuti, essere stati gettati, colpa, sono modi esistenziali del passato; «esistenza», anticipazione del presente, anticipazione della morte, preoccupazione e risoluzione, sono modi esistenziali del futuro. Non c’è presente per l’esistenza autentica in cui riposare. Balzando fuori, per così dire, dal passato, l’esistenza si proietta nel futuro; si trova di fronte al suo termine ultimo, la morte; ritorna da questo sguardo escatologico verso il nulla alla pura realtà, al dato immutabile dell’essere divenuta ciò che è, “hic et nunc”; e lo porta avanti con la risolutezza che la morte infonde, nella quale è stato compreso il passato. Ripeto che non c’è presente in cui riposare, soltanto la crisi tra passato e futuro, solo il momento critico intermedio, in equilibrio sul filo del rasoio della decisione che si getta avanti.
Questo dinamismo affannoso presentò un’attrattiva terribile per la mente contemporanea, e la mia generazione in Germania negli anni tra i venti e i trenta ne è stata completamente presa. Ma c’è un problema in questa sparizione del presente come ricettacolo di un contenuto genuino, nella sua riduzione ad un punto zero inospitale di risoluzione puramente formale. Che tipo di situazione metafisica vi si cela?
E’ opportuno fare qui un’ulteriore osservazione. C’è in fin dei conti, oltre il «presente» esistenziale del momento, la presenza delle cose. Non è possibile che la co-presenza con esse offra un «presente» di un genere diverso? Ma Heidegger ci dice che le cose sono innanzi tutto “zuhanden”, ossia utilizzabili (di cui persino l’«inutilità» è un modo), e perciò in relazione col «progetto» di esistenza e la sua «sollecitudine» (“Sorge”), quindi incluse nel dinamismo futuro-passato. Tuttavia esse possono venir ridotte ad essere semplicemente “vorhanden” («poste di fronte a me»), ossia oggetti indifferenti, e il modo della “Vorhandenheit” è il corrispondente oggettivo di ciò che da parte esistenziale è la “Verfallenheit”, il falso presente. “Vorhanden” è ciò che è semplicemente e indifferentemente «ec-stante», il «qui» della nuda natura, per esservi considerato fuori della connessione con la situazione esistenziale e con «l’interesse» pratico. Significa essere ridotti ed alienati al modo della muta «cosalità». Questo è il modo lasciato alla «natura» per quanto riguarda il suo rapporto con la teoria – un modo deficiente di essere -, e la relazione in cui viene oggettivata è un modo deficiente di esistenza, la sua defezione dal futuro della «sollecitudine» nel presente spurio di un interesse di osservatore curioso (13).
Questa svalutazione esistenzialista del concetto di natura mostra in modo evidente la sua spogliazione spirituale per opera della scienza, ed ha qualche cosa in comune col disprezzo gnostico della natura. Nessuna filosofia si è occupata meno della natura di quanto abbia fatto l’esistenzialismo, il quale non concede ad essa alcuna dignità; questo disinteresse non va però confuso con l’atteggiamento di Socrate, il quale si asteneva dalla ricerca fisica perché pensava che fosse al di sopra della comprensione umana.
La considerazione di ciò che c’è, della natura come è in se stessa, dell’Essere, era chiamata dagli antichi col nome di contemplazione, “theoria”. Ma la differenza ora sta nel fatto che se la contemplazione ha come oggetto solo l’ec-stante, di nessun rilievo, allora perde la nobile condizione che aveva una volta – come pure il riposo nel presente, al quale trattiene l’osservatore, mediante la presenza dei suoi oggetti. La “theoria” aveva quella dignità per le sue implicanze platoniche – perché possedeva gli oggetti eterni sotto forma di cose, una trascendenza dell’essere immutabile che riluceva nella trasparenza del divenire. L’essere immutabile è eterno presente, nel quale può esserci contemplazione durante i brevi periodi del presente temporale.
Perciò è l’eternità, non il tempo, che garantisce un presente e gli conferisce uno stato proprio nel fluire del tempo; ed è la mancanza di eternità che spiega la mancanza di un autentico presente. Tale perdita dell’eternità è la sparizione del mondo delle idee e degli ideali, nella quale Heidegger vedeva il vero significato della frase di Nietzsche «Dio è morto»: in altre parole la vittoria assoluta del nominalismo sul realismo. Perciò la stessa causa che è alla radice del nichilismo è anche alla radice della radicale temporalità dello schema di esistenza di Heidegger, nel quale il presente non è altro che il momento di crisi tra passato e futuro. Se i valori non sono considerati nella visione dell’essere (come il Bene e il Bello di Platone), ma sono posti dalla volontà come progetti, allora l’esistenza è consegnata ad un continuo futuro, che ha la morte come termine ultimo; ed una risoluzione di (voler) essere puramente formale, senza un “nomos” per quella risoluzione, diventa un progetto dal nulla al nulla. Secondo le parole di Nietzsche che abbiamo citato: «Chi ha perso ciò che tu hai perso non sta fermo in alcun luogo».
Ancora una volta la nostra indagine ci conduce al dualismo tra uomo e “physis” come fondamento metafisico della situazione nichilista. Non bisogna trascurare una differenza molto importante tra il dualismo gnostico e quello esistenzialista: l’uomo gnostico è gettato in una natura antagonista, antidivina e perciò antiumana, l’uomo moderno in una natura indifferente. Soltanto il secondo caso rappresenta il vuoto assoluto, l’abisso senza fondo. Nella concezione gnostica l’ostile, il demoniaco, è ancora antropomorfo, familiare anche nella sua estraneità, e il contrasto stesso dà una direzione all’esistenza: una direzione negativa, certamente, ma una direzione che ha dietro di sé la sanzione della trascendenza negativa a cui corrisponde qualitativamente la positività del mondo. Alla natura indifferente della scienza moderna non è concessa nemmeno questa qualità antagonistica e da quella natura non ci si può aspettare nessuna direzione.
Questo rende il nichilismo moderno infinitamente più radicale e disperato di quanto sia mai stato il nichilismo gnostico con tutto il suo terrore panico del mondo e il suo insolente disprezzo per le sue leggi. Che alla natura non importi in un modo o nell’altro, è il vero abisso. Che soltanto l’uomo importi, posto nella sua finitezza di fronte a nient’altro che la morte, solo con la sua contingenza e l’insignificanza oggettiva delle sue intenzioni e progetti, è una situazione realmente senza precedenti.
Ma questa stessa differenza, che rivela la maggiore profondità del nichilismo moderno, ne mostra anche l’incoerenza. Il dualismo gnostico, per quanto fantastico, era almeno coerente. L’idea di una natura demoniaca contro cui la persona deve lottare, ha un senso. Ma quale senso può avere una natura indifferente che tuttavia contiene in sé ciò per cui la sua esistenza significa qualcosa? La frase «essere gettati in una natura indifferente» è un residuo di metafisica dualistica, che un punto di vista non metafisico non ha diritto di usare. Che cosa significa essere gettati senza colui che getta e senza un al di là da dove è partito? Piuttosto l’esistenzialista dovrebbe dire che la vita – coscienza, «preoccupazione», conoscenza di sé – è stata «buttata all’aria» “dalla” natura. Se ciecamente, allora il vedere è un prodotto della cecità, la preoccupazione è prodotto dell’incuria, la natura teleologica è generata in maniera non teleologica.
Un simile paradosso non fa nascere dei dubbi sul concetto stesso di natura indifferente, quell’astrazione della scienza fisica? L’antropomorfismo è stato bandito così radicalmente dal concetto di natura che persino l’uomo non può essere più concepito in maniera antropomorfa, se è soltanto un accidente di quella natura. In quanto prodotto di ciò che è indifferente, anche il suo essere deve essere indifferente. Allora il porsi di fronte alla morte giustificherebbe la reazione: «Mangiamo e beviamo perché domani moriremo». Non c’è ragione di preoccuparsi di ciò che non ha dietro di sé alcuna sanzione secondo una intenzione creativa. Ma se l’intuizione più profonda di Heidegger è giusta – cioè che di fronte alla nostra finitezza ci accorgiamo di preoccuparci non soltanto se esistiamo ma di come esistiamo – allora il semplice fatto che ci sia tale suprema preoccupazione, ove si voglia entro il mondo, deve anche giustificare la totalità che racchiude quel fatto, tanto più se «essa» sola era la causa produttrice di quel fatto, col far sorgere fisicamente il soggetto dentro di sé.
La frattura tra uomo e realtà è alla radice del nichilismo. L’illogicità della frattura, ossia di un dualismo senza metafisica, rende il fatto non meno reale, né più accettabile l’alternativa somigliante: lo sguardo fisso ad una individualità isolata, a cui l’uomo è condannato, può desiderare di scambiarsi con un naturalismo monistico che insieme con la frattura abolisce anche l’idea di uomo come uomo. La mente moderna volteggia tra Scilla e Cariddi. Se le si apre una terza soluzione – in cui la frattura dualistica possa essere superata e tuttavia possa essere mantenuto quel tanto di intuizione dualistica che permette di salvaguardare l’umanità dell’uomo – sta alla filosofia lo scoprirla.
NOTE ALL’EPILOGO.
1. “Wille zur Macht” (1887), par. 1.
2. “Pensées”, ed. Brunschvicg, fr. 205.
3. Op. cit., fr. 347: «Una canna solamente è l’uomo, la più fragile del mondo, ma una canna pensante. Non è necessario che l’universo si armi per distruggerlo: un soffio, una goccia d’acqua sono sufficienti per ucciderlo. Tuttavia, se il Tutto lo schiacciasse, l’uomo sarebbe ancora più nobile di ciò che lo distrugge: perché egli sa di morire e sa che l’universo è più forte di lui; ma l’universo non sa niente di ciò».
4. Op. cit., fr. 72.
5. Confronta PASCAL, loc. cit.: «In breve, è il più grande segno dell’onnipotenza di Dio che la nostra immaginazione si perda in questo pensiero» (cioè della immensità degli spazi cosmici).
6. La funzione di Pascal come primo esistenzialista moderno, che io ho abbozzato in breve come punto di partenza, è stata ampiamente esposta da Karl Löwith nel suo articolo “Man between Infinities”, in «Measure, A Critical Journal» (Chicago), vol. 1 (1950).
7. Marcione: TERTULL., “Contra Marcionem”, I, 14.
8. “Wille zur Macht”, par. 2 e 3.
9. J. P. SARTRE, “L’existentialisme est un humanisme”, p. 33 s.
10. HEIDEGGER, “Ueber den Humanismus”, Francoforte, 1949, p. 13.
11. «Animale» in greco non significa «bestia» ma «essere animato», compresi i demoni, gli dèi, le stelle animate, persino l’universo animato come un tutto (confronta PLATONE, “Timeo”, 30 C): nessun «abbassamento» dell’uomo ne viene dal collocarlo in questa scala, e il fantasma di «animalità» si è aggiunto al termine abusivamente. In realtà, l’abbassamento per Heidegger consiste nel porre l’«uomo» in una qualsiasi scala, cioè in un contesto della natura in sé. La svalutazione cristiana di «animale» in «bestia» che invero rende il termine usabile solo in contrasto con «uomo», riflette semplicemente la profonda frattura con la posizione classica, quella frattura per la quale l’uomo, come unico possessore di un’anima immortale, sta completamente al di fuori della ‘natura’. L’argomento esistenzialista parte da questa nuova base: il gioco sull’ambiguità semantica di «animale», mentre sottolinea un facile punto, nasconde questo cambiamento di base di cui quell’ambiguità è funzione e non risponde alla posizione classica con la quale è visibilmente in polemica.
12. CLEMENS ALEX., Exc. ex Theod., 78, 2.
13. Sto parlando qui di “Sein und Zeit”, non dell’ultimo Heidegger, che certamente non è «esistenzialista».
ABBREVIAZIONI.
C.H.: Corpus Hermeticum.
G: Ginza. Der Schatz oder das Grosse Buch der Mandäer, trad. di M. Lidzbarski, Göttinga, 1925.
E.V.: «Gospel of truth»: Evangelium Veritatis, ed. e trad. di M. Malinine, H. C. Puech, G. Quispel, Zurigo, 1956.
J: Das Johannesbuch der Mandäer, ed. e trad. di M. Lidzbarski, Giessen, 1915.
POSTFAZIONE
a cura di Raffaele Farina
HANS JONAS.
Breve nota biografica (1).
Hans Jonas, nato a Mönchengladbach, in Germania, nel 1903, ha studiato a Freiburg i.Br. con Husserl (1921-1923), a Berlino con Gressman per l’Antico Testamento e Spranger per la filosofia (1921-1923), Heidelberg e, in particolare, a Marburg (1924), dove si laureò con Bultmann e ottenne la libera docenza nel 1928 discutendo una dissertazione dal titolo “Il concetto di Gnosi”. Sotto la spinta di Bultmann e con l’appoggio di Heidegger, scrisse il primo volume sulla gnosi (che apparve nel 1934, nella Germania che egli aveva già lasciato da qualche mese), dando inizio a quelle ricerche che ne avrebbero fatto uno dei massimi specialisti dello gnosticismo. A Marburg, dove da Freiburg aveva seguito Heidegger, gli furono compagni di studio in quel tempo Hannah Arendt e Günther Anders. I trascorsi nazisti di Heidegger, che egli ha sempre considerato, nonostante tutto, come suo Maestro, gli hanno procurato una sofferta delusione e tanta amarezza.
Ebreo di nascita, iscritto al Sionismo a 17 anni, dopo l’avvento del nazismo emigrò, nel 1933, prima in Inghilterra e poi, nel 1935, in Palestina, a Gerusalemme, dove fu lettore di filosofia nell’Università ebraica. Ha partecipato alla seconda guerra mondiale, come volontario, nella «Brigata Ebraica» dell’esercito inglese. Come tale, ebbe modo di percorrere, dopo il 1945, buona parte della Germania vinta, visitando i luoghi della sua infanzia e soprattutto i suoi antichi professori, tra i quali Rudolf Bultmann. Superando le sue profonde convinzioni e una più che comprensibile ripulsione (sua madre era morta ad Auschwitz), non potendo rinnegare l’impronta che ne aveva ricevuto, volle incontrare anche il suo Maestro Heidegger, poco prima che questi compisse il suo ottantesimo compleanno.
A partire dal 1949 ha insegnato in diverse università nordamericane, prima in Canada e poi a New York, dedicandosi a studi di filosofia della natura e di filosofia della tecnica.
La sua attività scientifica si è mossa in due distinte direzioni: l’approfondimento storico e tipologico della gnosi nel quadro di una interpretazione globale dell’età tardo-antica (cristianesimo e neoplatonismo) e, negli ultimi decenni, un ripensamento radicale dei grandi temi etici della libertà e della responsabilità umane nel mondo contemporaneo.
Vive a New Rochelle, N.Y. E’ considerato oggi uno dei protagonisti del dibattito bioetico contemporaneo.
– La via allo Gnosticismo.
Come è giunto Hans Jonas allo Gnosticismo? Pur non essendo né un teologo (non è neppure cristiano), né uno storico, quanto piuttosto un filosofo, la domanda è del tutto legittima e gli è stata posta direttamente (2). Nella risposta che ne dà, egli si rifà ai primi studi, alle prime letture ed esperienze intellettuali, che lo portarono alla scelta inizialmente della filosofia e poi dello Gnosticismo.
Ricorda tre decisive esperienze che condizionano la sua giovinezza, negli anni che seguirono immediatamente la prima guerra mondiale. Prima di tutto il contatto con i “Profeti d’Israele”, che egli lesse non in ebraico, ma nella traduzione protestante, uscita dal 1911 in poi presso l’Editore Vandenhoeck & Ruprecht, a Göttingen, a cura di H. Gressmann, H. Gunkel, M. Haller, H. Schmidt, W. Stark e P. Volz. In secondo luogo va ricordato “Immanuel Kant”, di cui egli lesse prima di tutto “Fondazione della metafisica dei costumi”, che comincia con una sentenza, che risuonò nella sua mente per tutti gli anni della sua formazione intellettuale e lo ha accompagnato per tutta la vita: «E’ impossibile pensare nel mondo, e, in genere, anche fuori di esso, una cosa che possa considerarsi come buona senza limitazioni, salvo, unicamente, la “volontà buona”» (3). E infine “Martin Buber”, di cui lesse subito «Drei Reden über das Judentum», e «Die Legendee des Baalschem» (4).
Dalla assimilazione e mescolanza, un po’ strana, come egli stesso ammette (5), di queste tre esperienze, ne risultò la decisione, al momento di entrare nell’Università, di studiare filosofia. Unita a questa decisione ci fu il convincimento che la religione è un aspetto essenziale dell’umanità, e che non è possibile studiare filosofia senza la conoscenza approfondita del fenomeno religioso. A parte l’impegno personale di ognuno in una o nell’altra religione o confessione, la religione come tale, specialmente come parte della tradizione occidentale, è indispensabile alla scoperta di se stessi e di quel background della grande tradizione filosofica che con i Greci, Socrate, Platone e Aristotele ha costituito e costituisce la mentalità e la cultura dell’uomo occidentale. Questa scelta fondamentale ha accompagnato il giovane studente e poi lo studioso famoso per tutta vita ed è, a suo dire, una prima spiegazione di come egli, studente di filosofia, fosse condotto allo studio dello gnosticismo.
In realtà lo gnosticismo costituisce una sfida non solo per il filologo, lo storico e il teologo, ma anche per il filosofo. E come tale Jonas ha soprattutto dato il suo contributo alla conoscenza dello gnosticismo. Ma lo ha potuto fare, a differenza di altri colleghi, per il notevole bagaglio di conoscenze filologiche, storiche e teologiche che egli, nonostante la sua modestia, dimostra largamente nelle sue opere.
Tuttavia furono le circostanze esterne che lo condussero allo studio del Nuovo Testamento con Bultmann, in quanto amico del suo Maestro Heidegger, e dallo studio del Nuovo Testamento, in particolare del Vangelo di Giovanni, allo gnosticismo, che egli nonostante qualche tentativo di abbandono, non ha mai più tralasciato di ricercare e studiare.
Poiché ciò che, a suo dire, lo ha attratto veramente nello gnosticismo non fu il fatto banale di dover scrivere una relazione per il Seminario di Nuovo Testamento, diretto da Bultmann. C’è qualcosa in esso «che bussa alla porta del nostro essere, specie di noi esseri del ventesimo secolo. C’è l’umanità posta in una crisi e davanti ad alcune delle radicali possibilità di scelta che si possono fare a riguardo della propria posizione nel mondo, del rapporto di ognuno con se stesso, con l’assoluto e con il suo essere mortale. E c’è certamente qualcosa nello gnosticismo che aiuta a capire l’umanità meglio di quanto si possa capirla se non si fosse mai avuto idea dello gnosticismo» (6). In questo senso non è fuor di luogo parlare di modernità analogica dello gnosticismo antico o di uno gnosticismo latente nella mentalità moderna.
– La ricerca sullo gnosticismo (7).
Quello di Hans Jonas è stato definito giustamente «il più raffinato apparato concettuale» (8) messo in atto per penetrare e definire sistematicamente la gnosi. E con successo! Le sue ricerche infatti si sono rivelate fondamentali per una comprensione e definizione essenziale dello gnosticismo antico, ed hanno permesso di gettare una luce nuova, che merita di essere approfondita, sul pensiero occidentale moderno.
Per la parte storico-religiosa delle sue ricerche, soprattutto del suo libro “Gnosi e spirito della tarda antichità” (9), la fonte precipua è stata l’opera di Wilhelm Bousset “Hauptprobleme der Gnosis” (1907), (10) dalla quale egli trae anche la maggior parte degli esempi. Questo lo porta nell’ambito della “Religionsgeschichtliche Schule”, della quale fa parte ma non a pieno titolo. Egli vi assume infatti una posizione insolitamente cauta ed equilibrata. Nel mentre si avvale, nelle due fasi che caratterizzano la sua ricerca di storia delle idee, del materiale messogli a disposizione da detta Scuola, ne supera, allo stesso tempo, i presupposti sul piano metodologico ed ermeneutico.
Per la parte interpretativa Jonas trova invece nell’esistenzialismo del primo Heidegger una chiave ermeneutica, che non abbandonerà mai del tutto. Egli ha adoperato, soprattutto per il primo periodo delle sue ricerche sulla gnosi, una “Vorverständnis”, una preconcezione filosofica: l’esistenzialismo e l’ontologia fenomenologica heideggeriana. In seguito non sarebbe stato così entusiasta di questa che egli chiamava la «chiave interpretativa universale», ma serbava per essa intatta la sua ammirazione. «Quando mi fui liberato della credenza in una chiave universale, egli confessa, cominciai a domandarmi perché questa chiave particolare aveva funzionato così bene in questo caso» (11)
«In “The Gnostic Religion”, la “Vorverständnis” heideggeriana viene abbandonata, per far luogo ad una considerazione di storia delle idee il cui fine è di notare l’analogia tra due momenti spirituali, gnosticismo ed esistenzialismo, i quali, sebbene lontani nel tempo e molto diversi nella loro strumentalizzazione analitica, partono pure dagli stessi presupposti ‘esistenziali’. La ‘chiave universale’ si trasforma, semplicemente, in un ‘circolo ermeneutico’ che implica la comprensione vicendevole dello gnosticismo e dell’esistenzialismo» (12).
Hans Jonas è prodotto di un certo clima naturale, dettato dalle influenti produzioni della “religionsgeschichtliche Schule” da una parte e dall’esistenzialismo heideggeriano dall’altra. Eppure, nella misura in cui egli ha la saggia accortezza di evitare di pronunciarsi chiaramente e definitivamente a favore della tesi della “religionsgeschichtliche Schule”, i suoi lavori scritti nella sua prima giovinezza, frutto della preconcezione heideggeriana, sono molto meno invecchiati di alcuni lavori del suo maestro e discepolo Rudolf Bultmann (13).
Hans Jonas ha trovato numerosi critici e non poche delle critiche mossegli si sono dimostrate pertinenti e sono state ammesse da lui stesso. Il Prof. Simonetti, nel saggio introduttivo del presente volume, le ha inserite opportunamente nel contesto dell’opera “La Religione Gnostica” (“The Gnostic Religion”). Ma quanto questi limiti non abbiano per niente intaccato la freschezza, l’originalità e il vigore della sua ricerca globale sulla gnosi e in particolare dell’opera “La Religione Gnostica”, lo dimostra il fatto che le scoperte dei testi gnostici originali in lingua copta a Nag Hammadi non hanno reso affatto antiquato, né hanno sminuito la validità della sua sintesi sullo gnosticismo, che resterà a lungo l’unica, almeno fino a quando gli studi sui testi di Nag Hammadi avranno raggiunto una maturità e una assimilazione tale da permettere ad un nuovo «genio» una nuova sintesi.
Fino ad allora rimane d’obbligo la lettura e lo studio di quest’opera, che a giusta ragione riteniamo fondamentale, un «classico». «Dei classici ha soprattutto il fascino della convinzione e la poesia dell’amore per il tema trattato» (14).
NOTE ALLA “BREVE NOTA BIOGRAFICA”.
1. Confronta JONAS HANS, “A Retrospective View”, in GEO WIDENGREN (ed.), «Proceedings of the International Colloquium on Gnosticism (Stockholm, August 20-25, 1973)» (Stockholm-Leiden, Almqvist & Wiksell International-Brill E.J. 1977) 1-15; CULIANU IOAN PETRU, “From Gnosticism to the Dangers of Technology. An Interview with Hans Jonas”, in: «Gnosticismo e pensiero moderno: Hans Jonas» in Storia delle religioni 1 (Roma, L’Erma di Bretschneider 1985) 135-153; JONAS HANS, “Principe Responsabilité”, trad. francaise J. Greisch in Passages (Paris, Du Cerf 1990) 317-322 [bibliografia su Hans Jonas].
2. Confronta nota 1.
3. Immanuel Kant, “Fondazione della Metafisica dei costumi – Critica della ragion pratica”, a cura di Vittorio Mathieu in I classici del pensiero, Sez. III: Filosofia Moderna (Milano, Rusconi 1982) 79.
4. BUBER MARTIN, “Drei Reden über das Judentum” (Frankfurt a.M., Rutten und Loening 1920), e “Die Legende des Baalschem” (ivi l922) [trad. italiana: “La leggenda di Baalschem”, Firenze, ed. Israel 1925].
5. “A Retrospective View”, p. 3.
6. “A Retrospective View”, p.p. 13-14.
7. Confronta CULIANU IOAN PETRU, “Gnosticismo e pensiero moderno in Storia delle religioni” 1 (Roma, «L’Erma» di Bretschneider 1985) 49-50; 73-75; 88; 131-132.
8. Id. p. 106.
9. “Gnosis und spätantiker Geist”. 1: “Die mythologische Gnosis” (Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 3. Aufl. 1964); 2: “Von der Mythologie zur mystischen Philosophie” (ivi, 2. Aufl. 1964).
10. BOUSSET WILHELM, “Hauptprobleme der Gnosis” (Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht 1907).
11. V. a pag. 340 (in nero) di questo volume.
12. CULIANU, op. cit. 74-75.
13. Il riferimento è al volumetto di Rudolf Bultmann, “Das Urchristentum im Rahmen der antiken Religionen” (Zurich, Artemis Verlag 1949); in italiano: “Il Cristianesimo primitivo nel quadro delle religioni antiche”, trad. italiana di L. Zagari (Milano, Garzanti 1964). Confronta la dettagliata analisi che ne fa CULIANU, op. cit. 75-88.
14. Confronta la mia recensione alla prima edizione della traduzione italiana del presente volume in «Salesianum» 38 (1976) 182.

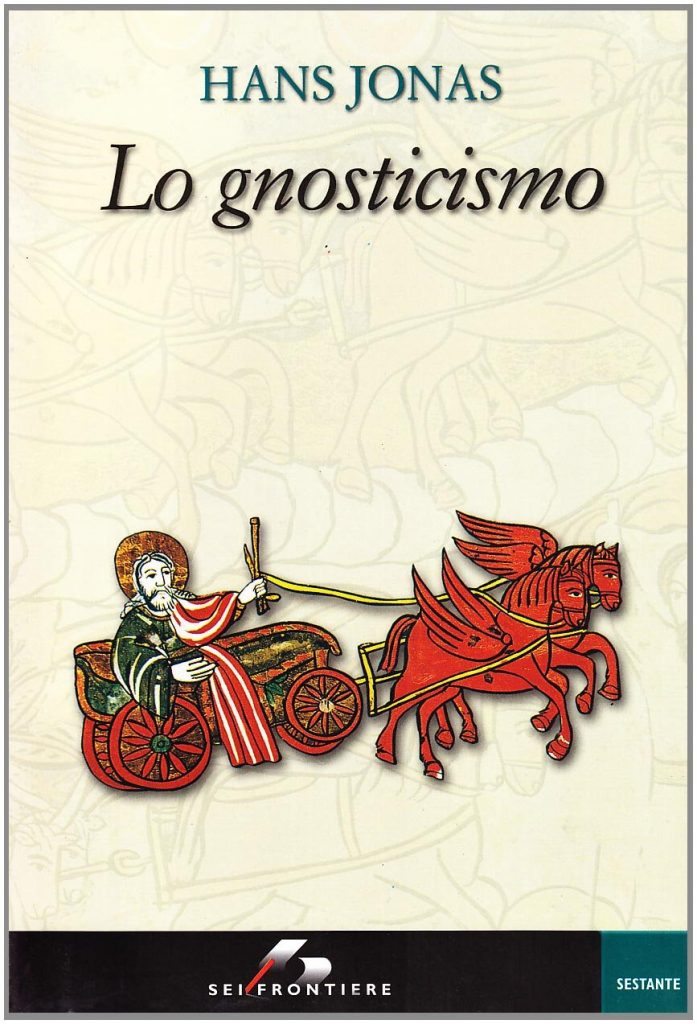
ゆうちゅうぶ|わくわく動画は人気の高いゆうちゅうぶを下記の検索窓でキーワードを入力することで簡単に探すことができます。
キャッシング会社総合ランキングです。単純な金利や融資枠だけでなく、歴史、利便性、サイトの分かりやすさ、サポート、ユーザーのクチコミ情報などを総合的に評価し、順位が決定されています。数あるキャッシング商品から厳選された総合ランキングですので、どの商品もおすすめです。
Lo si trova ancora in commercio, è incredibile che qualcuno lo abbia messo in rete nella sua veste originale e completo. Veramente un bel regalo, grazie
Prego Francesco