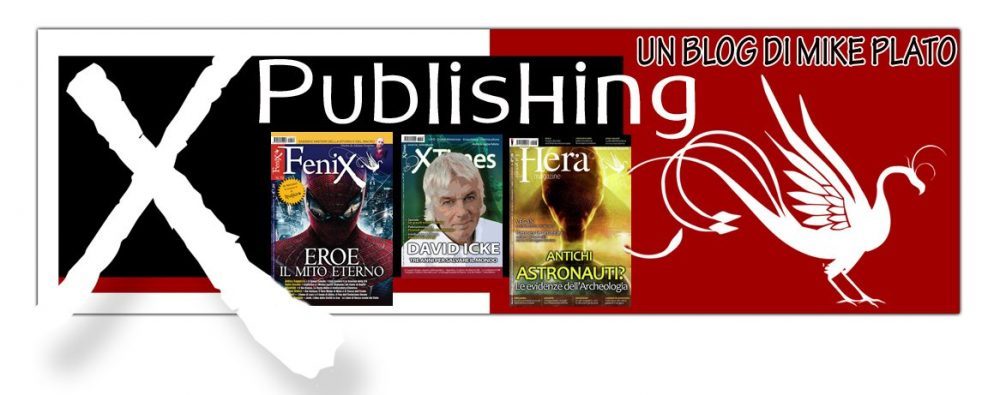Qui pubblico un articolo di Alberto de Luca sul Fatah, il Cavalierato nel Sufismo. Si tratta di principi che sono validi per ogni cavaliere di ogni tempo, che sia un templare, un samurai, un ashishin, un cavaliere del Graal. Vi sarà più facile comprendere cosa sia davvero un cavaliere secondo l’Antica tradizione
 In uno studio precedente dedicato alla futuwwa, abbiamo dimostrato, speriamo in maniera chiara, come il vero fatâ, o cavaliere nella sua “traduzione” occidentale, non sia altro se non che il mezzo, tramite il quale opera la Misericordia divina. Affinché Essa operi, è necessario però, che il fatâ sia cosciente di quanto lui è, vale a dire, che egli sia cosciente della sua ontologica condizione di servo e che, quindi, consideri l’essere un fatâ, quale designazione divina.1] Questo implica che, conseguentemente l’essere stato oggetto di una grazia divina, il cavaliere è continuamente messo alla prova dalla sua stessa “qualificazione”, cioè dal suo essere fatâ: ogni atto, in senso generale, che vada contro il suo swadharma, gli farebbe perdere la grazia ricevuta. Sono queste le condizioni sine qua non, per cui il fatâ rende possibile, attraverso la sua “propria esistenza”, la ri-proposizione nel basso mondo (ad-dunya) della nobiltà divina creatrice, vale a dire, la funzione del verbum Dei, in arabo Kun[2] corrispondente al Fiat latino. Il fatâ antepone gli altri a se stesso, dando preferenza, così facendo, a Dio. Ci spieghiamo meglio: nel momento a-temporale in cui Dio esistenziò il creato, Egli, l’Indipendente, in realtà non necessitava in alcun modo della creazione del creato, è stato, infatti, solo per la Sua Misericordia che Egli ha creato ciò che è stato creato.Quindi, l’aver anteposto, da parte di Dio, la necessità dell’esistenza del creato ad essere creato,[3] implica che il cavaliere anteponga “orizzontalmente” le necessità altrui alle sue. In ciò facendo, il fatâ non fa che dare preferenza a Dio, poiché è Dio che ha, invero, anteposto i bisogni delle Sue creature a Lui stesso. Quello che è accaduto con il Kun, che procede da Dio solo, è riproposto dal fatâ ogni giorno con la sua opera altruistica tra la gente. In altre parole, Dio en donnant une apparente raison à Sa création, fait acte de futuwwa;[4] perché rinuncia alla singolarità del Suo Essere (infirâdu-hu bi-l-wujûd); parimenti il cavaliere compie atto di futuwwa, quando “sceglie” di occuparsi degli altri a detrimento di se stesso, con la differenza che, così operando, non fa che accordare la precedenza a Dio e non alle altre creature, poiché è Lui che ha scelto il fatâ, affinché rivesta l’abito della futuwwa. La futuwwa è allora una qualità divina (na‘t ilâhî), quindi, la futuwwa de l’homme doit se modeler sur celle de Dieu, sans confondre avec elle. De même que Dieu en créant l’homme l’à préféré à lui-même, l’homme dans ses rapports avec les autres, ne doit viser que Dieu.[5] Il “mettersi” a disposizione di Allâh da parte del cavaliere, implica par suite, la santé de la volonté (irâdah) [que] consiste à remettre généreusement à Allâh sa propre faculté d’agir, à rester le sujet vide de pouvoir, par l’abandon du libre choix, à persévérer immobile devant le cours des décrets divins, comme le mort entre les mains du laveur, qui le retourne comme il veut.[6] Con questa sostanziosa introduzione, per forza molto sintetica,[7] siamo dunque giunti al punto centrale del presente studio: il libero arbitrio e il suo giusto “uso” o anche il suo abbandono. Per addivenire all’abandon du libre choix, il fatâ deve necessariamente combattere e sottomettere quella che è la propria egoità, ovverosia la nafs al-ammara bi-l-sû’ che finisce con il coincidere con il libero arbitrio, quando esso non “viene usato correttamente”. Poiché la natura umana, sotto forma di egoità (o di libero arbitrio) ostacola l’acquisizione degli attributi interiori che Dio ci ha ordinato di acquisire, e la futuwwa è uno di questi, è per mezzo della propria volontà e della propria intenzione che il fatâ educa la sua anima e la sbarazza dalle costrizioni della natura, affinché possa acquisire le stazioni (attributi interiori) a lui ordinate. Esse sono dunque raggiunte per mezzo della volontà e dello sforzo e sono acquisite in modo permanente, mentre gli stati spirituali sono doni che non possono essere raggiunti e non sono permanenti. Il cavaliere autentico segue dunque una via che è contraddistinta dall’abbandono, che è di due tipi: il primo è l’abbandono o superamento della propria nafs sotto il suo aspetto di libero arbitrio, con il connesso attaccamento per questo mondo e i suoi beni;[8] il secondo è l’abbandono fiducioso in Dio (tawakkul). Cercheremo, allora, di delineare al meglio tali due modalità di abbandono, precisando però che è impossibile parlarne, metodicamente, per compartimenti stagni, essendo naturalmente collegate fra loro da un preciso rapporto gerarchico.Inizieremo comunque affermando che il tawakkul, al suo grado più elevato non è altro che, l’espressione della nostra totale indigenza di fronte all’Onnipotenza divina, quella che l’essere realizza rinunciando alla sua illusoria pretesa di potenza (tabarrî min al-hawl wa-l-quwwa), dal momento che la forza e la potenza non appartengono che a Dio.[9] Come afferma Ibn‘Arabî, nelle Futûhât (cap. 263), si tratta di realizzare che le “marcheur” au moyen de la “creature” (al-khalq) n’est autre que Dieu Lui-même (al-Haqq), et Lui è “sul retto sentiero”.[10] Il “lavoro”, che deve essere portato a
In uno studio precedente dedicato alla futuwwa, abbiamo dimostrato, speriamo in maniera chiara, come il vero fatâ, o cavaliere nella sua “traduzione” occidentale, non sia altro se non che il mezzo, tramite il quale opera la Misericordia divina. Affinché Essa operi, è necessario però, che il fatâ sia cosciente di quanto lui è, vale a dire, che egli sia cosciente della sua ontologica condizione di servo e che, quindi, consideri l’essere un fatâ, quale designazione divina.1] Questo implica che, conseguentemente l’essere stato oggetto di una grazia divina, il cavaliere è continuamente messo alla prova dalla sua stessa “qualificazione”, cioè dal suo essere fatâ: ogni atto, in senso generale, che vada contro il suo swadharma, gli farebbe perdere la grazia ricevuta. Sono queste le condizioni sine qua non, per cui il fatâ rende possibile, attraverso la sua “propria esistenza”, la ri-proposizione nel basso mondo (ad-dunya) della nobiltà divina creatrice, vale a dire, la funzione del verbum Dei, in arabo Kun[2] corrispondente al Fiat latino. Il fatâ antepone gli altri a se stesso, dando preferenza, così facendo, a Dio. Ci spieghiamo meglio: nel momento a-temporale in cui Dio esistenziò il creato, Egli, l’Indipendente, in realtà non necessitava in alcun modo della creazione del creato, è stato, infatti, solo per la Sua Misericordia che Egli ha creato ciò che è stato creato.Quindi, l’aver anteposto, da parte di Dio, la necessità dell’esistenza del creato ad essere creato,[3] implica che il cavaliere anteponga “orizzontalmente” le necessità altrui alle sue. In ciò facendo, il fatâ non fa che dare preferenza a Dio, poiché è Dio che ha, invero, anteposto i bisogni delle Sue creature a Lui stesso. Quello che è accaduto con il Kun, che procede da Dio solo, è riproposto dal fatâ ogni giorno con la sua opera altruistica tra la gente. In altre parole, Dio en donnant une apparente raison à Sa création, fait acte de futuwwa;[4] perché rinuncia alla singolarità del Suo Essere (infirâdu-hu bi-l-wujûd); parimenti il cavaliere compie atto di futuwwa, quando “sceglie” di occuparsi degli altri a detrimento di se stesso, con la differenza che, così operando, non fa che accordare la precedenza a Dio e non alle altre creature, poiché è Lui che ha scelto il fatâ, affinché rivesta l’abito della futuwwa. La futuwwa è allora una qualità divina (na‘t ilâhî), quindi, la futuwwa de l’homme doit se modeler sur celle de Dieu, sans confondre avec elle. De même que Dieu en créant l’homme l’à préféré à lui-même, l’homme dans ses rapports avec les autres, ne doit viser que Dieu.[5] Il “mettersi” a disposizione di Allâh da parte del cavaliere, implica par suite, la santé de la volonté (irâdah) [que] consiste à remettre généreusement à Allâh sa propre faculté d’agir, à rester le sujet vide de pouvoir, par l’abandon du libre choix, à persévérer immobile devant le cours des décrets divins, comme le mort entre les mains du laveur, qui le retourne comme il veut.[6] Con questa sostanziosa introduzione, per forza molto sintetica,[7] siamo dunque giunti al punto centrale del presente studio: il libero arbitrio e il suo giusto “uso” o anche il suo abbandono. Per addivenire all’abandon du libre choix, il fatâ deve necessariamente combattere e sottomettere quella che è la propria egoità, ovverosia la nafs al-ammara bi-l-sû’ che finisce con il coincidere con il libero arbitrio, quando esso non “viene usato correttamente”. Poiché la natura umana, sotto forma di egoità (o di libero arbitrio) ostacola l’acquisizione degli attributi interiori che Dio ci ha ordinato di acquisire, e la futuwwa è uno di questi, è per mezzo della propria volontà e della propria intenzione che il fatâ educa la sua anima e la sbarazza dalle costrizioni della natura, affinché possa acquisire le stazioni (attributi interiori) a lui ordinate. Esse sono dunque raggiunte per mezzo della volontà e dello sforzo e sono acquisite in modo permanente, mentre gli stati spirituali sono doni che non possono essere raggiunti e non sono permanenti. Il cavaliere autentico segue dunque una via che è contraddistinta dall’abbandono, che è di due tipi: il primo è l’abbandono o superamento della propria nafs sotto il suo aspetto di libero arbitrio, con il connesso attaccamento per questo mondo e i suoi beni;[8] il secondo è l’abbandono fiducioso in Dio (tawakkul). Cercheremo, allora, di delineare al meglio tali due modalità di abbandono, precisando però che è impossibile parlarne, metodicamente, per compartimenti stagni, essendo naturalmente collegate fra loro da un preciso rapporto gerarchico.Inizieremo comunque affermando che il tawakkul, al suo grado più elevato non è altro che, l’espressione della nostra totale indigenza di fronte all’Onnipotenza divina, quella che l’essere realizza rinunciando alla sua illusoria pretesa di potenza (tabarrî min al-hawl wa-l-quwwa), dal momento che la forza e la potenza non appartengono che a Dio.[9] Come afferma Ibn‘Arabî, nelle Futûhât (cap. 263), si tratta di realizzare che le “marcheur” au moyen de la “creature” (al-khalq) n’est autre que Dieu Lui-même (al-Haqq), et Lui è “sul retto sentiero”.[10] Il “lavoro”, che deve essere portato a  buon fine da parte del fatâ, secondo il Suo Volere e la Sua Soddisfazione, consiste dunque nel rimuovere il velo costituito dal libero arbitrio, che è stato messo su ogni creatura da Dio stesso. La parola araba che rende il concetto di libero arbitrio è al-ikhtiyâr, derivante dalla terza persona singolare del verbo, che è ikhtâra, “egli sceglie”. Il significato accordato al termine in esame è quindi scelta, selezione, opzione, preferenza e libero arbitrio.[11] Già nell’etimologia della parola araba, si cela la “soluzione” del nostro studio: abbiamo detto, infatti, che, “egli sceglie” è la radice da cui discende il libero arbitrio, ma chi “sceglie” veramente? La lingua araba è una lingua sintetica e come tale dischiude in ogni suo vocabolo una molteplicità di significati, che corrispondono a una molteplicità di piani di riferimento, che possono essere raggiunti conformemente alle proprie capacità di con-prensione.[12] Il quesito poc’anzi posto ‑ chi “sceglie” veramente? ‑ , ci porta direttamente ad esaminare partitamene il pronome “egli” e poi l’azione verbale “sceglie”.Se scegliere, indica l’azione, che porta a distinguere tra più cose o persone, operata da un soggetto dotato di discernimento, saremo ovviamente portati ad associarla a una persona fisica, “egli”, per l’appunto. Sennonché il libero arbitrio è l’illusoria pretesa di potenza (tabarrî min al-hawl wa-l-quwwa) da parte dell’ego dell’uomo, che crede, illusoriamente, di essere unico giudice[13] di se stesso in questa vita e fintanto nell’altra (a detta di alcune persone). Liberarsi da questa illusione consiste, come attestato tra l’altro da Shiblî, nell’essere in rapporto a Dio come se non fossi mai esistito (kamâ lam takun) e Dio, in rapporto a te, come se non avesse mai cessato di essere (kamâ lam yazal), vale a dire, affermare che solo Lui esiste mentre noi, nelle migliori delle ipotesi, siamo paragonabili a quelle effimere apparizioni delle comete nell’universo.[14] Il pronome verbale “egli” va dunque riferito a Lui e l’azione di scegliere appartiene a Lui. E non è forse scritto, infatti: Non fosti tu a lanciare quando lanciasti, ma fu Allâh che lanciò?[15] Tutti noi siamo quindi velati dalla nostra egoità (libero arbitrio), che ci si presenta già in questa forma della terza persona singolare ‑ “egli sceglie” ‑ , infatti, Dieu le Très-Haut a placé sur le coeur du serviteur un talisman par le quel Il lui a voile la lumière de l’unité des actes.[16] Ad alcuni di noi sarà però concesso di svelarsi dal velo, che ci impedisce di conoscere la verità, ovverosia l’Unicità di Dio. Tra questi vi saranno sicuramente i fityan, plurale di fatâ.[17] L’“illuminazione” che giunge al fatâ e che questi mette in pratica, è che il libero arbitrio, o anche la “libertà dell’ego”, non è un fine quanto, invece, uno strumento di potenza attiva, che ha valore solo nel mondo fenomenico. Si ricordi sempre però, che la stessa “illuminazione” è in ogni caso frutto di una grazia ricevuta da Dio, poiché è Dio stesso che “sceglie”, chi debba essere “rivestito” dell’abito della futuwwa: è detto, infatti, nel Kitâb al-Futuwwa che la Futuwwah è prendersi cura del deposito affidatoci….[18] Non ci sembra allora minimamente in discussione che Spiritus ubi vult spirat e che quindi, chi parte dalla posizione diametralmente opposta, in forza della quale le creature possono “autodeterminarsi” per poi rinnegare il loro statuto ontologico di dipendenza da Chi le ha create, sia in grave errore![19] Il libero arbitrio, che abbiamo assimilato all’ego, esiste proprio perché deve essere “superato” in maniera attiva, al fine di ri-nascere nella metalibertà e nella metaschiavitù dei mondi superiori. Il velo posto da Dio sulle creature tutte, ne costituisce una prova[20]: vi sarà chi farà del proprio libero arbitrio l’unica ragione di vita, fintanto la propria divinità, quindi inevitabilmente perdendosi, mentre vi sarà chi lo utilizzerà come strumento per porsi al servizio di Dio: l’homme est néant en tant qu’il s’identifie à sa nature individuelle (son “corps”) et il est quand il a la conscience effective de sa propre nature essentielle ou de son identité fondamentale avec l’Être.[21] Dice a tal proposito Rûmî: In ogni atto che tu hai desiderio di fare, tu scorgi chiara la tua potenza di compierlo; in ogni atto che tu non hai voglia di fare, allora vedi la costrizione e dici: “È da Dio!”,[22]in realtà attraverso il libero arbitrio dell’uomo è il Volere di Dio che si manifesta e non il volere dell’uomo in quanto tale. Per questo, nonostante non ci sia “agente” e “volere” se non Dio e da Dio, tale verità è uno dei segreti della natura divina, che Dio stesso ha celato ai Suoi servi, conferendo loro esteriormente al-ikhtiyâr, “libero arbitrio”, affinché quest’ultimo costituisca un argomento contro gli stessi servi quando ne abusino: Dì: a Dio appartiene l’argomento definitivo.[23] Questo segreto, opportunamente nascosto da Dio, non può essere invocato da parte del servo in suo favore, evitando così di compiere gli atti che gli sono prescritti dalla Legge sacra o addirittura di disobbedirne le disposizioni, dal momento che questi atti prescritti sono contenuti nella Legge e concernono gli atti esteriori, in vista dei quali ogni servo è stato dotato del libero arbitrio per compierli adeguatamente. La shari‘â attribuisce l’azione al servo (‘abd) in considerazione del libero arbitrio che gli è stato conferito sul piano esteriore: è la dottrina dell’acquisizione dei meriti (kasb). Contrariamente, la realtà spirituale nega qualsiasi paternità al servitore dei suoi atti in considerazione della verità intrinseca delle cose: non c’è agente se non Dio e non vi è volere se non quello di Dio.[24] Al-ikhtiyâr è, come già si è detto, un’“arma a doppio taglio”: avendo la possibilità di scegliere e di fare il bene, l’uomo non ha scusanti nel momento in cui opta per il male.[25] E non è forse scritto: comportatevi da uomini liberi, non
buon fine da parte del fatâ, secondo il Suo Volere e la Sua Soddisfazione, consiste dunque nel rimuovere il velo costituito dal libero arbitrio, che è stato messo su ogni creatura da Dio stesso. La parola araba che rende il concetto di libero arbitrio è al-ikhtiyâr, derivante dalla terza persona singolare del verbo, che è ikhtâra, “egli sceglie”. Il significato accordato al termine in esame è quindi scelta, selezione, opzione, preferenza e libero arbitrio.[11] Già nell’etimologia della parola araba, si cela la “soluzione” del nostro studio: abbiamo detto, infatti, che, “egli sceglie” è la radice da cui discende il libero arbitrio, ma chi “sceglie” veramente? La lingua araba è una lingua sintetica e come tale dischiude in ogni suo vocabolo una molteplicità di significati, che corrispondono a una molteplicità di piani di riferimento, che possono essere raggiunti conformemente alle proprie capacità di con-prensione.[12] Il quesito poc’anzi posto ‑ chi “sceglie” veramente? ‑ , ci porta direttamente ad esaminare partitamene il pronome “egli” e poi l’azione verbale “sceglie”.Se scegliere, indica l’azione, che porta a distinguere tra più cose o persone, operata da un soggetto dotato di discernimento, saremo ovviamente portati ad associarla a una persona fisica, “egli”, per l’appunto. Sennonché il libero arbitrio è l’illusoria pretesa di potenza (tabarrî min al-hawl wa-l-quwwa) da parte dell’ego dell’uomo, che crede, illusoriamente, di essere unico giudice[13] di se stesso in questa vita e fintanto nell’altra (a detta di alcune persone). Liberarsi da questa illusione consiste, come attestato tra l’altro da Shiblî, nell’essere in rapporto a Dio come se non fossi mai esistito (kamâ lam takun) e Dio, in rapporto a te, come se non avesse mai cessato di essere (kamâ lam yazal), vale a dire, affermare che solo Lui esiste mentre noi, nelle migliori delle ipotesi, siamo paragonabili a quelle effimere apparizioni delle comete nell’universo.[14] Il pronome verbale “egli” va dunque riferito a Lui e l’azione di scegliere appartiene a Lui. E non è forse scritto, infatti: Non fosti tu a lanciare quando lanciasti, ma fu Allâh che lanciò?[15] Tutti noi siamo quindi velati dalla nostra egoità (libero arbitrio), che ci si presenta già in questa forma della terza persona singolare ‑ “egli sceglie” ‑ , infatti, Dieu le Très-Haut a placé sur le coeur du serviteur un talisman par le quel Il lui a voile la lumière de l’unité des actes.[16] Ad alcuni di noi sarà però concesso di svelarsi dal velo, che ci impedisce di conoscere la verità, ovverosia l’Unicità di Dio. Tra questi vi saranno sicuramente i fityan, plurale di fatâ.[17] L’“illuminazione” che giunge al fatâ e che questi mette in pratica, è che il libero arbitrio, o anche la “libertà dell’ego”, non è un fine quanto, invece, uno strumento di potenza attiva, che ha valore solo nel mondo fenomenico. Si ricordi sempre però, che la stessa “illuminazione” è in ogni caso frutto di una grazia ricevuta da Dio, poiché è Dio stesso che “sceglie”, chi debba essere “rivestito” dell’abito della futuwwa: è detto, infatti, nel Kitâb al-Futuwwa che la Futuwwah è prendersi cura del deposito affidatoci….[18] Non ci sembra allora minimamente in discussione che Spiritus ubi vult spirat e che quindi, chi parte dalla posizione diametralmente opposta, in forza della quale le creature possono “autodeterminarsi” per poi rinnegare il loro statuto ontologico di dipendenza da Chi le ha create, sia in grave errore![19] Il libero arbitrio, che abbiamo assimilato all’ego, esiste proprio perché deve essere “superato” in maniera attiva, al fine di ri-nascere nella metalibertà e nella metaschiavitù dei mondi superiori. Il velo posto da Dio sulle creature tutte, ne costituisce una prova[20]: vi sarà chi farà del proprio libero arbitrio l’unica ragione di vita, fintanto la propria divinità, quindi inevitabilmente perdendosi, mentre vi sarà chi lo utilizzerà come strumento per porsi al servizio di Dio: l’homme est néant en tant qu’il s’identifie à sa nature individuelle (son “corps”) et il est quand il a la conscience effective de sa propre nature essentielle ou de son identité fondamentale avec l’Être.[21] Dice a tal proposito Rûmî: In ogni atto che tu hai desiderio di fare, tu scorgi chiara la tua potenza di compierlo; in ogni atto che tu non hai voglia di fare, allora vedi la costrizione e dici: “È da Dio!”,[22]in realtà attraverso il libero arbitrio dell’uomo è il Volere di Dio che si manifesta e non il volere dell’uomo in quanto tale. Per questo, nonostante non ci sia “agente” e “volere” se non Dio e da Dio, tale verità è uno dei segreti della natura divina, che Dio stesso ha celato ai Suoi servi, conferendo loro esteriormente al-ikhtiyâr, “libero arbitrio”, affinché quest’ultimo costituisca un argomento contro gli stessi servi quando ne abusino: Dì: a Dio appartiene l’argomento definitivo.[23] Questo segreto, opportunamente nascosto da Dio, non può essere invocato da parte del servo in suo favore, evitando così di compiere gli atti che gli sono prescritti dalla Legge sacra o addirittura di disobbedirne le disposizioni, dal momento che questi atti prescritti sono contenuti nella Legge e concernono gli atti esteriori, in vista dei quali ogni servo è stato dotato del libero arbitrio per compierli adeguatamente. La shari‘â attribuisce l’azione al servo (‘abd) in considerazione del libero arbitrio che gli è stato conferito sul piano esteriore: è la dottrina dell’acquisizione dei meriti (kasb). Contrariamente, la realtà spirituale nega qualsiasi paternità al servitore dei suoi atti in considerazione della verità intrinseca delle cose: non c’è agente se non Dio e non vi è volere se non quello di Dio.[24] Al-ikhtiyâr è, come già si è detto, un’“arma a doppio taglio”: avendo la possibilità di scegliere e di fare il bene, l’uomo non ha scusanti nel momento in cui opta per il male.[25] E non è forse scritto: comportatevi da uomini liberi, non  servendovi della libertà come di un velo per coprire la malizia, ma come servitori di Dio.[26]Quanto detto finora, porta con sé il pericolo che, il volgo lo intenda come passività o meglio, come esso viene chiamato, “costrizione” (jabr) o predestinazione, attribuendo quindi a questi due termini una connotazione negativa. Nâbulusî, a tal proposito, replicava anche ai teologi, che obbiettavano che sostenere l’“unicità dell’esistenza” implicasse l’affermazione della pre-determinazione (e della pre-destinazione), dicendo che anche i sostenitori della wahdat al-wujûd affermano l’esistenza di un libero arbitrio nell’uomo, ma quest’ultimi lo fanno in considerazione della stretta analogia esistente tra Creante e creato. Ciò vuol dire che se il primo possiede evidentemente una libera scelta, un riflesso di questa si troverà anche nel secondo; il tutto però secondo un aspetto di trascendenza completa (‘alâ’t-tanzîh at-tâmm), ossia senza che l’analogia tra Creante e creato implichi identità assoluta tra i due.[27] L’uomo però che accetta in maniera cosciente e mettendosi dalla parte di Dio, ciò in cui i profani vedono solo la passiva accettazione[28] della predestinazione,[29] perché non sanno riconoscere l’agire arbitrario e artistico di Dio, è invero l’uomo più libero che esista. Pensare che “egli sceglie”, si riferisca all’uomo terreno in quanto soggetto “volente”, costituisce un buon viatico per perdersi nella molteplicità del basso mondo. Dio conosce prima del suo compimento il peccato e lo permette non volendolo: è l’uomo che reca danno a se stesso per mezzo di uno sbagliato uso del libero arbitrio, che gli è stato accordato![30] Allâh l’Altissimo ha detto: “… e se giunge loro un bene, dicono: “Viene da Allâh”, e se giunge un male, dicono: “Viene da te” (o Muhammad). Dì: “Tutto viene da Allâh”” in quanto atto (fi‘l). Egli ha quindi negato loro che il male venisse dal Profeta, così come ha detto riguardo a Mosè: […] per questo Egli ha aggiunto: “ … e ciò che ti capita di male viene da te stesso e non da Muhammad […] Egli ha quindi attribuito tutto ad Allâh e tutto è bene ed è nelle Sue mani, mentre il male (in quanto male, non in quanto atto) non dipende da Lui.[31] La bruttezza di un quadro, infatti, non coincide con la bruttezza dell’artista che lo ha realizzato, anzi, essa è l’abile riproduzione del brutto fatta da lui.[32] Bisogna allora discernere, nel caso dell’uomo, l’ordine dalla cosa oggetto dell’ordine:[33] dice in tal senso Ibn‘Arabî che chi accetta l’atto del destinare non è costretto per questo ad accettare la cosa destinata; l’atto del destinare è ordine di Dio ed è Lui che ci ha comandato di accettarlo, mentre la cosa destinata è ciò che è ordinato, e noi non siamo obbligati ad accettarla.[34] Lo stesso autore afferma del pari che non esiste (lâ mawjûda) altro che Allâh, ed Egli ha stabilito che la manifestazione (zhuhûr) delle cose avvenisse in concomitanza delle “cause seconde” (asbâb), quindi l’esistenza di Colui che causa (al-musabbib) non può avere luogo se non per mezzo della causa (sabab): ogni cosa esistente per una causa seconda ha dunque una faccia verso questa causa ed una faccia verso Allâh e costituisce in questo modo un “barzakh” tra la causa ed Allâh,[35] questo implica necessariamente che Allâh abbia fatto le cose del creato in occasione delle cause e non grazie a quest’ultime. Dio è l’Artista, per il Quale il brutto e il male sono strumenti per costruzioni misteriose valide su piani superiori, o futuri, dello spirito; ma ciò non implica passiva accettazione di quanto ci debba accadere, perché è il libero arbitrio, datoci da Dio, che ci viene in soccorso. Dice, infatti, Rûmî: accetti tu di portare il Suo peso? Egli porterà te in alto. Accetti tu il Suo ordine? Egli accetterà te, allora. Se tu accetti l’ordine Suo, Ne diverrai il portavoce, se cerchi l’unione con Lui, a Lui giungerai. Libero arbitrio significa sforzo di ringraziare Dio del Suo favore, il tuo predestinazionismo è la negazione di quelle grazie divine [che noi abbiamo ricevuto, tra cui al-ikhtiyâr]! Ringraziare Dio per il potere che ci ha dato di agire liberamente aumenta questo potere, il fatalismo ti strappa il favore di Dio…[36] All’uomo sono stati dati tutti i mezzi, per giungere alla soluzione di uno dei suoi problemi centrali: scegliere il bene e rifuggire il male. A tal fine egli è ben fornito per operare il giusto discernimento, è lui quindi che sbaglia se non ne fa l’uso appropriato e non ha giocoforza alcuna attenuante. Diciamo ancora di più: Allâh ha creato gli esseri umani privi sia di miscredenza (kufr)[37] sia di fede (îmân), poi ha raccomandato loro e ha formulato per loro degli ordini e dei decreti. Da ciò consegue che chi è miscredente lo è per proprio atto (fi’l), per propria rinnegazione (inkâr), per propria sconfessione (juhûd) della Verità, in virtù del fatto che Dio lo ha abbandonato; mentre chi crede lo fa per proprio atto, per approvazione e per proprio sincero assenso perché Dio gli ha fornito sostegno ed assistenza. L’attivismo cui è chiamato l’essere umano in genere e il fatâ in particolare, è ovviamente diretto verso la ricerca della Verità, che passa attraverso il giusto impiego del libero arbitrio, portando in definitiva al “raddrizzamento” della propria nafs al-ammara bi-l-sû’ (“anima che istiga al male”, attaccata alle cose temporali quindi e soprattutto ai beni materiali). Per certi versi, si può fare riferimento a Junayd quando parla dell’“uomo intelligente” o meglio “saggio”. Egli sostiene, infatti, che l’uomo dotato di ‘aql, qui inteso come saggezza, è colui che dopo aver adempiuto perfettamente l’oeuvre qui lui est imposée, renonce à se préoccuper de ce qui ne dure pas et à agir pour ce qui est éphémère et périssable.[38] I Sûfî, detti anche “figli dell’istante”, fanno del loro attivismo un punto centrale durante la loro vita terrena. È ovvio che non bisogna farsi ingannare da questo loro “secondo nome”, perché il loro “vivere alla giornata” non ha nulla a che spartire con quel carpe diem tutto godereccio così comune oggigiorno: l’uomo deve essere attivo nella ricerca della Verità ma giorno per giorno, poiché la Sconfitta o il Successo provengono solo da Dio. Di questo stesso avviso è Rûmî, quando scrive: Noi siamo arpe e Tu ci tocchi col plettro, il dolce lamento che proviene da noi, sei Tu che lo operi! Noi siamo il flauto, e il suono che è in noi è da Te; siamo montagne impervie e l’eco è quello della Tua voce. Noi siamo i pezzi degli scacchi, impegnati in vittoria o sconfitta, e Sconfitta e Vittoria sono da te, o Perfetto! Noi siamo come leoni, ma leoni dipinti su una bandiera: spinti dal vento si slanciano ad ogni istante. Visibili i loro slanci, invisibile il vento…e se noi lanciamo una freccia, noi non siamo che l’arco e Dio è l’arciere![39] L’Evo Moderno ha poi contribuito a ispessire ulteriormente il velo che sta sopra i nostri occhi, poiché il est resté cher aux Occidentaux par une série de malentendus provenant d’un abus individualiste de l’idée même de liberté:[40] la cosiddetta Rinascienza ha voluto presentare l’uomo come un tutto sufficiente a se stesso, capace di ordinare la sua esistenza in funzione dei suoi bisogni e delle sue aspirazioni. È stata così dimenticata la dipendenza ontologica delle creature, ossia la condizione di servitù, nei confronti del loro Creatore,[41] la qual cosa è evidente nella stessa concezione della figura del fatâ, che, per qualcheduno, non è un ‘abd bensì una sorta di semidio. Nella sua relazione con Dio, invece, l’uomo, ripetiamo, è fondamentalmente, ontologicamente povero, vale a dire dipendente: O uomini, voi siete poveri di fronte a Dio (al-fuqarâ’ ilâ’Llâh) e Dio è il Ricco, il Lodato.[42] È stato anche detto che Servitude is abandoning personal choice in the face of divine fate.[43] Non riempirmi di confusione il Giorno in cui essi saranno risuscitati. Il Giorno in cui né beni né figli saranno di alcuna utilità. Salvo colui che verrà a Dio con un cuore intatto,[44] è Abramo a pronunciare queste parole, lui che è la cifra della futuwwa,[45] della generosità e dell’ospitalità, lui che non è sviato dall’abbondanza dei beni. Il mondo è nella sua mano e non nel suo cuore, che è invece integro da ogni attaccamento terreno. A queste condizioni, i beni indicano una elezione spirituale e l’esercizio di una luogotenenza divina sulla terra,[46] presupponendo al contempo il dominio dell’anima e delle ricchezze, sul modello del Giuseppe del Corano quando chiede al Faraone, all’uscita della prigione: Affidami i tesori della terra, io sono un guardiano sicuro e
servendovi della libertà come di un velo per coprire la malizia, ma come servitori di Dio.[26]Quanto detto finora, porta con sé il pericolo che, il volgo lo intenda come passività o meglio, come esso viene chiamato, “costrizione” (jabr) o predestinazione, attribuendo quindi a questi due termini una connotazione negativa. Nâbulusî, a tal proposito, replicava anche ai teologi, che obbiettavano che sostenere l’“unicità dell’esistenza” implicasse l’affermazione della pre-determinazione (e della pre-destinazione), dicendo che anche i sostenitori della wahdat al-wujûd affermano l’esistenza di un libero arbitrio nell’uomo, ma quest’ultimi lo fanno in considerazione della stretta analogia esistente tra Creante e creato. Ciò vuol dire che se il primo possiede evidentemente una libera scelta, un riflesso di questa si troverà anche nel secondo; il tutto però secondo un aspetto di trascendenza completa (‘alâ’t-tanzîh at-tâmm), ossia senza che l’analogia tra Creante e creato implichi identità assoluta tra i due.[27] L’uomo però che accetta in maniera cosciente e mettendosi dalla parte di Dio, ciò in cui i profani vedono solo la passiva accettazione[28] della predestinazione,[29] perché non sanno riconoscere l’agire arbitrario e artistico di Dio, è invero l’uomo più libero che esista. Pensare che “egli sceglie”, si riferisca all’uomo terreno in quanto soggetto “volente”, costituisce un buon viatico per perdersi nella molteplicità del basso mondo. Dio conosce prima del suo compimento il peccato e lo permette non volendolo: è l’uomo che reca danno a se stesso per mezzo di uno sbagliato uso del libero arbitrio, che gli è stato accordato![30] Allâh l’Altissimo ha detto: “… e se giunge loro un bene, dicono: “Viene da Allâh”, e se giunge un male, dicono: “Viene da te” (o Muhammad). Dì: “Tutto viene da Allâh”” in quanto atto (fi‘l). Egli ha quindi negato loro che il male venisse dal Profeta, così come ha detto riguardo a Mosè: […] per questo Egli ha aggiunto: “ … e ciò che ti capita di male viene da te stesso e non da Muhammad […] Egli ha quindi attribuito tutto ad Allâh e tutto è bene ed è nelle Sue mani, mentre il male (in quanto male, non in quanto atto) non dipende da Lui.[31] La bruttezza di un quadro, infatti, non coincide con la bruttezza dell’artista che lo ha realizzato, anzi, essa è l’abile riproduzione del brutto fatta da lui.[32] Bisogna allora discernere, nel caso dell’uomo, l’ordine dalla cosa oggetto dell’ordine:[33] dice in tal senso Ibn‘Arabî che chi accetta l’atto del destinare non è costretto per questo ad accettare la cosa destinata; l’atto del destinare è ordine di Dio ed è Lui che ci ha comandato di accettarlo, mentre la cosa destinata è ciò che è ordinato, e noi non siamo obbligati ad accettarla.[34] Lo stesso autore afferma del pari che non esiste (lâ mawjûda) altro che Allâh, ed Egli ha stabilito che la manifestazione (zhuhûr) delle cose avvenisse in concomitanza delle “cause seconde” (asbâb), quindi l’esistenza di Colui che causa (al-musabbib) non può avere luogo se non per mezzo della causa (sabab): ogni cosa esistente per una causa seconda ha dunque una faccia verso questa causa ed una faccia verso Allâh e costituisce in questo modo un “barzakh” tra la causa ed Allâh,[35] questo implica necessariamente che Allâh abbia fatto le cose del creato in occasione delle cause e non grazie a quest’ultime. Dio è l’Artista, per il Quale il brutto e il male sono strumenti per costruzioni misteriose valide su piani superiori, o futuri, dello spirito; ma ciò non implica passiva accettazione di quanto ci debba accadere, perché è il libero arbitrio, datoci da Dio, che ci viene in soccorso. Dice, infatti, Rûmî: accetti tu di portare il Suo peso? Egli porterà te in alto. Accetti tu il Suo ordine? Egli accetterà te, allora. Se tu accetti l’ordine Suo, Ne diverrai il portavoce, se cerchi l’unione con Lui, a Lui giungerai. Libero arbitrio significa sforzo di ringraziare Dio del Suo favore, il tuo predestinazionismo è la negazione di quelle grazie divine [che noi abbiamo ricevuto, tra cui al-ikhtiyâr]! Ringraziare Dio per il potere che ci ha dato di agire liberamente aumenta questo potere, il fatalismo ti strappa il favore di Dio…[36] All’uomo sono stati dati tutti i mezzi, per giungere alla soluzione di uno dei suoi problemi centrali: scegliere il bene e rifuggire il male. A tal fine egli è ben fornito per operare il giusto discernimento, è lui quindi che sbaglia se non ne fa l’uso appropriato e non ha giocoforza alcuna attenuante. Diciamo ancora di più: Allâh ha creato gli esseri umani privi sia di miscredenza (kufr)[37] sia di fede (îmân), poi ha raccomandato loro e ha formulato per loro degli ordini e dei decreti. Da ciò consegue che chi è miscredente lo è per proprio atto (fi’l), per propria rinnegazione (inkâr), per propria sconfessione (juhûd) della Verità, in virtù del fatto che Dio lo ha abbandonato; mentre chi crede lo fa per proprio atto, per approvazione e per proprio sincero assenso perché Dio gli ha fornito sostegno ed assistenza. L’attivismo cui è chiamato l’essere umano in genere e il fatâ in particolare, è ovviamente diretto verso la ricerca della Verità, che passa attraverso il giusto impiego del libero arbitrio, portando in definitiva al “raddrizzamento” della propria nafs al-ammara bi-l-sû’ (“anima che istiga al male”, attaccata alle cose temporali quindi e soprattutto ai beni materiali). Per certi versi, si può fare riferimento a Junayd quando parla dell’“uomo intelligente” o meglio “saggio”. Egli sostiene, infatti, che l’uomo dotato di ‘aql, qui inteso come saggezza, è colui che dopo aver adempiuto perfettamente l’oeuvre qui lui est imposée, renonce à se préoccuper de ce qui ne dure pas et à agir pour ce qui est éphémère et périssable.[38] I Sûfî, detti anche “figli dell’istante”, fanno del loro attivismo un punto centrale durante la loro vita terrena. È ovvio che non bisogna farsi ingannare da questo loro “secondo nome”, perché il loro “vivere alla giornata” non ha nulla a che spartire con quel carpe diem tutto godereccio così comune oggigiorno: l’uomo deve essere attivo nella ricerca della Verità ma giorno per giorno, poiché la Sconfitta o il Successo provengono solo da Dio. Di questo stesso avviso è Rûmî, quando scrive: Noi siamo arpe e Tu ci tocchi col plettro, il dolce lamento che proviene da noi, sei Tu che lo operi! Noi siamo il flauto, e il suono che è in noi è da Te; siamo montagne impervie e l’eco è quello della Tua voce. Noi siamo i pezzi degli scacchi, impegnati in vittoria o sconfitta, e Sconfitta e Vittoria sono da te, o Perfetto! Noi siamo come leoni, ma leoni dipinti su una bandiera: spinti dal vento si slanciano ad ogni istante. Visibili i loro slanci, invisibile il vento…e se noi lanciamo una freccia, noi non siamo che l’arco e Dio è l’arciere![39] L’Evo Moderno ha poi contribuito a ispessire ulteriormente il velo che sta sopra i nostri occhi, poiché il est resté cher aux Occidentaux par une série de malentendus provenant d’un abus individualiste de l’idée même de liberté:[40] la cosiddetta Rinascienza ha voluto presentare l’uomo come un tutto sufficiente a se stesso, capace di ordinare la sua esistenza in funzione dei suoi bisogni e delle sue aspirazioni. È stata così dimenticata la dipendenza ontologica delle creature, ossia la condizione di servitù, nei confronti del loro Creatore,[41] la qual cosa è evidente nella stessa concezione della figura del fatâ, che, per qualcheduno, non è un ‘abd bensì una sorta di semidio. Nella sua relazione con Dio, invece, l’uomo, ripetiamo, è fondamentalmente, ontologicamente povero, vale a dire dipendente: O uomini, voi siete poveri di fronte a Dio (al-fuqarâ’ ilâ’Llâh) e Dio è il Ricco, il Lodato.[42] È stato anche detto che Servitude is abandoning personal choice in the face of divine fate.[43] Non riempirmi di confusione il Giorno in cui essi saranno risuscitati. Il Giorno in cui né beni né figli saranno di alcuna utilità. Salvo colui che verrà a Dio con un cuore intatto,[44] è Abramo a pronunciare queste parole, lui che è la cifra della futuwwa,[45] della generosità e dell’ospitalità, lui che non è sviato dall’abbondanza dei beni. Il mondo è nella sua mano e non nel suo cuore, che è invece integro da ogni attaccamento terreno. A queste condizioni, i beni indicano una elezione spirituale e l’esercizio di una luogotenenza divina sulla terra,[46] presupponendo al contempo il dominio dell’anima e delle ricchezze, sul modello del Giuseppe del Corano quando chiede al Faraone, all’uscita della prigione: Affidami i tesori della terra, io sono un guardiano sicuro e  sapiente.[47] Il Corano, che è Parola di Allâh, conferma: Così abbiamo stabilito fermamente (makkannâ) Giuseppe sulla terra…, da qui viene la nozione di tamkîn, che designa nel sufismo la perfetta maestria dello stato spirituale. L’insistenza posta sulla messa in guardia dall’attaccamento alla vita di questo mondo, prepara al “combattimento sulla via di Dio” (al-qitâl fî sabîl Allâh). Nel combattimento sulla via di Dio i beni svolgono un ruolo preparatorio al sacrificio[48] dell’“anima che istiga al male”. Tuttavia oltre questo sforzo su di sé (Atmâyajna),[49] l’uomo deve proseguire il combattimento “in Dio”: Coloro che hanno combattuto in Noi (jâhadû fî-nâ), li guideremo sulle Nostre vie.[50] I beni al pari delle anime possono pertanto servire da supporto in tale “sforzo”.[51] Mentre il jihâd, quale l’aveva definito il Profeta, “per innalzare la Parola di Dio”, non ha motivo di esistere che in certi momenti e in certi luoghi nella storia dell’Islâm, il combattimento mediante i beni può essere condotto in ogni circostanza, esteriore o interiore.[52] Il libero arbitrio è, quindi conferito da Dio ad ogni Suo servitore sul piano esteriore, di modo tale che ognuno abbia l’illusione di poter scegliere, ma la Potenza manifesta e la Saggezza ricopre. Non tutti, infatti, possono sopportare ugualmente quello che è il peso della Verità,[53] cioè che l’uomo in sé non è che un luogo e un mezzo nelle mani di Dio, e allora la maggioranza parlerà di libero arbitrio e di predestinazione. A ben guardare però, anche l’utilizzare i due termini poco fa citati, da parte degli uomini, è un velo posto da Dio, al pari del velo presente nel versetto coranico Non ho creato jinn e uomini se non perché M’adorassero:[54] solo chi è stato scelto da Dio in persona, potrà penetrare al di là di tali veli, infatti, Dio apre il petto di coloro che vuole dirigere,[55] perché il petto è il luogo della conoscenza e della comprensione dei misteri nonché il luogo della chiarificazione e della luce della fede.[56] Dice al-Ghazâlî: l’uomo è dunque costretto, perché tutto ciò avviene in lui non per causa sua, ma d’altri; ed è libero di scegliere perché sede d’una volontà che è costretta a nascere in lui, dopo che la ragione abbia giudicato esser l’azione buona e giusta. Ma anche il giudizio è costretto a formarsi, per cui l’uomo è costretto nella stessa scelta. Il fuoco per esempio brucia per pura costrizione, mentre gli atti di Dio sono pura scelta. L’uomo, invece, si trova in una posizione intermedia: è costretto nella scelta. Per questa posizione, le genti della Verità (ahl al-Haqq) hanno cercato un terzo nome: si sono rifatti al Libro di Dio e lo hanno chiamato “acquisizione” (kasb), che secondo chi la comprende, non s’oppone né alla costrizione (jabr), né al libero arbitrio (ikhtiyâr), ma le concilia ambedue.[57] Il corretto uso del libero arbitrio permette al fatâ di raggiungere la stazione del tawakkul, abbandono fiducioso in Dio, lasciando così che Egli operi attraverso di lui nel mondo, in maniera “orizzontale”. La stazione è ogni attributo interiore che Dio ci ha ordinato di acquisire, quali possono essere il pentimento (tawba),[58] la pietà e il tawakkul. Ibn‘Arabî, a tal proposito, dice che ogni cosa che ci è stato ordinato di fare, è una stazione che deve essere acquisita, e per questa ragione che la Gente della Via ha detto che le stazioni sono acquisite e gli stati ordinati.[59] L’autentico fatâ quindi, non si guadagna alcunché nel suo operare, bensì acquisisce dei meriti (kasb) che gli vengono addebitati dal Legislatore stesso, tramite la shari‘â, che gli ha ordinato di compiere tale o talaltro atto, specificatamente in termini di qualifica, di durata, di completezza, di perfezione e di correttezza. In realtà è invece Allâh che agisce sempre in prima persona,[60] dal momento che il cavaliere, superata la propria nafs e raggiunto il tawakkul, non esiste più in quanto personalità bensì come cosciente strumentum Dei. Tutte le azioni degli uomini, siano esse in moto o in quiete, sono invero un’acquisizione umana (kasb), mentre è Allâh il loro Creatore, quindi esse avvengono tutte per Sua Volontà, Scienza e Decreto. In forza di quanto detto in apertura, per cui il fatâ ri-propone in maniera “orizzontale” la Misericordia esistenziatrice del Kun, si può dire tranquillamente che il cavaliere è un’epifania del Locuteur divin. Più esattamente ancora, il fatâ è tale unicamente perché sia supporto di manifestazione e non già perché egli debba ricevere l’attribuzione, per l’appunto, di fatâ di modo tale che quest’ultima ne diventi l’essenza: l’esistenza nel cavaliere (fatâ) non è quindi l’essenza di quello che esiste, vale a dire l’essenza del fatâ, bensì è una condizione transitoria del cavaliere; da ciò si evince come esso non sia che metaforicamente esistente, realmente essendo che supporto di manifestazione dell’esistenza del Vero.[61] L’unica cosa che è accordata a ciò che rimane di tale personalità, che è stata vinta e domata attraverso una
sapiente.[47] Il Corano, che è Parola di Allâh, conferma: Così abbiamo stabilito fermamente (makkannâ) Giuseppe sulla terra…, da qui viene la nozione di tamkîn, che designa nel sufismo la perfetta maestria dello stato spirituale. L’insistenza posta sulla messa in guardia dall’attaccamento alla vita di questo mondo, prepara al “combattimento sulla via di Dio” (al-qitâl fî sabîl Allâh). Nel combattimento sulla via di Dio i beni svolgono un ruolo preparatorio al sacrificio[48] dell’“anima che istiga al male”. Tuttavia oltre questo sforzo su di sé (Atmâyajna),[49] l’uomo deve proseguire il combattimento “in Dio”: Coloro che hanno combattuto in Noi (jâhadû fî-nâ), li guideremo sulle Nostre vie.[50] I beni al pari delle anime possono pertanto servire da supporto in tale “sforzo”.[51] Mentre il jihâd, quale l’aveva definito il Profeta, “per innalzare la Parola di Dio”, non ha motivo di esistere che in certi momenti e in certi luoghi nella storia dell’Islâm, il combattimento mediante i beni può essere condotto in ogni circostanza, esteriore o interiore.[52] Il libero arbitrio è, quindi conferito da Dio ad ogni Suo servitore sul piano esteriore, di modo tale che ognuno abbia l’illusione di poter scegliere, ma la Potenza manifesta e la Saggezza ricopre. Non tutti, infatti, possono sopportare ugualmente quello che è il peso della Verità,[53] cioè che l’uomo in sé non è che un luogo e un mezzo nelle mani di Dio, e allora la maggioranza parlerà di libero arbitrio e di predestinazione. A ben guardare però, anche l’utilizzare i due termini poco fa citati, da parte degli uomini, è un velo posto da Dio, al pari del velo presente nel versetto coranico Non ho creato jinn e uomini se non perché M’adorassero:[54] solo chi è stato scelto da Dio in persona, potrà penetrare al di là di tali veli, infatti, Dio apre il petto di coloro che vuole dirigere,[55] perché il petto è il luogo della conoscenza e della comprensione dei misteri nonché il luogo della chiarificazione e della luce della fede.[56] Dice al-Ghazâlî: l’uomo è dunque costretto, perché tutto ciò avviene in lui non per causa sua, ma d’altri; ed è libero di scegliere perché sede d’una volontà che è costretta a nascere in lui, dopo che la ragione abbia giudicato esser l’azione buona e giusta. Ma anche il giudizio è costretto a formarsi, per cui l’uomo è costretto nella stessa scelta. Il fuoco per esempio brucia per pura costrizione, mentre gli atti di Dio sono pura scelta. L’uomo, invece, si trova in una posizione intermedia: è costretto nella scelta. Per questa posizione, le genti della Verità (ahl al-Haqq) hanno cercato un terzo nome: si sono rifatti al Libro di Dio e lo hanno chiamato “acquisizione” (kasb), che secondo chi la comprende, non s’oppone né alla costrizione (jabr), né al libero arbitrio (ikhtiyâr), ma le concilia ambedue.[57] Il corretto uso del libero arbitrio permette al fatâ di raggiungere la stazione del tawakkul, abbandono fiducioso in Dio, lasciando così che Egli operi attraverso di lui nel mondo, in maniera “orizzontale”. La stazione è ogni attributo interiore che Dio ci ha ordinato di acquisire, quali possono essere il pentimento (tawba),[58] la pietà e il tawakkul. Ibn‘Arabî, a tal proposito, dice che ogni cosa che ci è stato ordinato di fare, è una stazione che deve essere acquisita, e per questa ragione che la Gente della Via ha detto che le stazioni sono acquisite e gli stati ordinati.[59] L’autentico fatâ quindi, non si guadagna alcunché nel suo operare, bensì acquisisce dei meriti (kasb) che gli vengono addebitati dal Legislatore stesso, tramite la shari‘â, che gli ha ordinato di compiere tale o talaltro atto, specificatamente in termini di qualifica, di durata, di completezza, di perfezione e di correttezza. In realtà è invece Allâh che agisce sempre in prima persona,[60] dal momento che il cavaliere, superata la propria nafs e raggiunto il tawakkul, non esiste più in quanto personalità bensì come cosciente strumentum Dei. Tutte le azioni degli uomini, siano esse in moto o in quiete, sono invero un’acquisizione umana (kasb), mentre è Allâh il loro Creatore, quindi esse avvengono tutte per Sua Volontà, Scienza e Decreto. In forza di quanto detto in apertura, per cui il fatâ ri-propone in maniera “orizzontale” la Misericordia esistenziatrice del Kun, si può dire tranquillamente che il cavaliere è un’epifania del Locuteur divin. Più esattamente ancora, il fatâ è tale unicamente perché sia supporto di manifestazione e non già perché egli debba ricevere l’attribuzione, per l’appunto, di fatâ di modo tale che quest’ultima ne diventi l’essenza: l’esistenza nel cavaliere (fatâ) non è quindi l’essenza di quello che esiste, vale a dire l’essenza del fatâ, bensì è una condizione transitoria del cavaliere; da ciò si evince come esso non sia che metaforicamente esistente, realmente essendo che supporto di manifestazione dell’esistenza del Vero.[61] L’unica cosa che è accordata a ciò che rimane di tale personalità, che è stata vinta e domata attraverso una 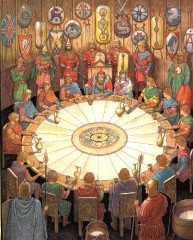 disciplina interiore (mujâhada), nonché l’unico mezzo del fatâ per sapere se ha operato bene, è il merito (kasb),come già detto, che viene conferito al fatâ per avere ben agito, ma che nella realtà suprema, ossia spirituale, gli viene conferito per aver fatto agire attraverso di lui, Egli.[62] Utilizzare il velo del al-ikhtiyâr per svelarsi, questo è il compito del cavaliere, che così sforzandosi, giungerà all’abbandono fiducioso in Dio, realizzando il suo swadharma, che è quello di essere il “ri-propositore” dell’Altruismo divino sul piano orizzontale, e, al contempo, attestandoNe l’Unicità. L’Unicità è una rivelazione dell’Essenza/Che appare come sintesi a cagione della distinzione delle mie qualità./Tutto in Essa è unico e ad un pari diversificato./Ammira dunque la molteplicità per essenza una!/In Essa, questo è anche quello, e ciò che va è come ciò che viene./Essa è la Realtà divina (al-haqîqah) della molteplicità/Contenuta nella Solitudine (al-wahdah) divina senza dispersione./Per Essa tutto si rinviene nel principio d’ogni cosa./Ed in cotal visuale la negazione (an-nafy) è identica all’affermazione (al-ithbât)./La “Discriminazione” (al-furqân) essenziale è la Sua forma compiuta,/E la molteplicità delle Qualità [comparenti in Essa] è simile alle verità dei versetti [nel Libro sacro]./Recitalo quindi e leggi in te stesso il segreto del Suo libro;/Dacché sei tu l’“evidente [Modello]” (al-imâm al-mubîn) ed [in te s’occulta “[il Libro] occulto” (al-kitâb al-maknûn).[63] Dice Ibn‘Arabî: ogni caratteristica della “nafs” del servo ed in cui il Vero non sia contemplato dalla “nafs” è difettosa (ma‘lûl), ed è per questa ragione che al suo riguardo si dice che essa è “nafs”; in altre parole il servo in ciò non vede che se stesso (nafsa-hu) e non vede che esso viene dal Vero, come invece vedono alcuni per i quali il Vero è contemplato in ciò.[64] Possiamo tranquillamente immaginare la difficoltà che avvolge la ricerca della “serenità del cuore” quando tutti intorno “fanno rumore”, ecco perché l’invocazione[65] di uno dei nomi divini durante lo “sforzo” (jihâd) quale aiuto “provvidenziale”, diventa per Ibn‘Arabî un’azione che segue il soggetto:[66] essa sorge con lui, è glorificata con lui ed è superficiale quando lui è superficiale.[67]
disciplina interiore (mujâhada), nonché l’unico mezzo del fatâ per sapere se ha operato bene, è il merito (kasb),come già detto, che viene conferito al fatâ per avere ben agito, ma che nella realtà suprema, ossia spirituale, gli viene conferito per aver fatto agire attraverso di lui, Egli.[62] Utilizzare il velo del al-ikhtiyâr per svelarsi, questo è il compito del cavaliere, che così sforzandosi, giungerà all’abbandono fiducioso in Dio, realizzando il suo swadharma, che è quello di essere il “ri-propositore” dell’Altruismo divino sul piano orizzontale, e, al contempo, attestandoNe l’Unicità. L’Unicità è una rivelazione dell’Essenza/Che appare come sintesi a cagione della distinzione delle mie qualità./Tutto in Essa è unico e ad un pari diversificato./Ammira dunque la molteplicità per essenza una!/In Essa, questo è anche quello, e ciò che va è come ciò che viene./Essa è la Realtà divina (al-haqîqah) della molteplicità/Contenuta nella Solitudine (al-wahdah) divina senza dispersione./Per Essa tutto si rinviene nel principio d’ogni cosa./Ed in cotal visuale la negazione (an-nafy) è identica all’affermazione (al-ithbât)./La “Discriminazione” (al-furqân) essenziale è la Sua forma compiuta,/E la molteplicità delle Qualità [comparenti in Essa] è simile alle verità dei versetti [nel Libro sacro]./Recitalo quindi e leggi in te stesso il segreto del Suo libro;/Dacché sei tu l’“evidente [Modello]” (al-imâm al-mubîn) ed [in te s’occulta “[il Libro] occulto” (al-kitâb al-maknûn).[63] Dice Ibn‘Arabî: ogni caratteristica della “nafs” del servo ed in cui il Vero non sia contemplato dalla “nafs” è difettosa (ma‘lûl), ed è per questa ragione che al suo riguardo si dice che essa è “nafs”; in altre parole il servo in ciò non vede che se stesso (nafsa-hu) e non vede che esso viene dal Vero, come invece vedono alcuni per i quali il Vero è contemplato in ciò.[64] Possiamo tranquillamente immaginare la difficoltà che avvolge la ricerca della “serenità del cuore” quando tutti intorno “fanno rumore”, ecco perché l’invocazione[65] di uno dei nomi divini durante lo “sforzo” (jihâd) quale aiuto “provvidenziale”, diventa per Ibn‘Arabî un’azione che segue il soggetto:[66] essa sorge con lui, è glorificata con lui ed è superficiale quando lui è superficiale.[67]
[1]Lorsque le Connaissant exerce le gouvernement ésotérique dans le monde au moyen de l’énergie spiritelle, il le fait en vertu d’un Ordre divin contraignant, et non en vertu d’un libre-choix (C.A. Gilis, Etudes complementaires sur le Califat, Parigi, p. 87). Quanto citato indica già la direzione, che seguirà il presente studio.
[2] Attraverso la pronuncia di una parola in genere, discostandoci per un momento dal Kun, la parola stessa ha un effetto su chi la sente. Nella lingua araba “discorso” ( che è un insieme di parole) viene reso da kalâm che è derivato dalla parole kalam, significante “ferita”. Come la ferita ha un effetto sul corpo della persona che la subisce, così la parola agisce su chi la ascolta. Il Fiat o Kun o Sia è la prima parola che abbia “penetrato” l’udito degli esseri mortali, quindi tutta la creazione non è che un aspetto esteriore della parola Sia!
[3]Tutti i mondi, con la globalità dei loro generi (ajnâs), specie (anwâ’) ed individui (ashâs), esistono a partire dall’inesistenza (‘adam) per mezzo dell’Esistenza di Dio, e non per se stessi; stando così le cose, l’esistenza per la quale essi esistono è in ogni istante l’Esistenza di Dio e non un’altra esistenza diversa da quella di Dio [così va capito il “rinnovamento della creazione ad ogni soffio” (tajdîd al-khalq ma‘a al-anfâs) e anche il senso di “figli dell’istante” attribuito ai Sûfî]. Tutti i mondi, dunque, di per sé sono inesistenti, di una inesistenza assoluta; ma dal punto di vista della Esistenza di Dio, essi esistono di un’esistenza unica, che non è altro, appunto, che l’Esistenza divina, mentre in sé e per sé non hanno assolutamente alcuna esistenza (A. Ventura, Un trattato di ‘Abd al-Janî an-Nâbulusî sull’“Unicità dell’esistenza”, Napoli, Supplemento n. 27 agli Annali, vol. 41 (1981), fasc. 2, pp. 27-28).
[4] D. Gril, Ibn‘Arabî: Ecrits sur la futuwwa, “La Règle d’Abraham”, Reims, 1996, n. 2, p. 6.
[5] Op. cit., p. 7. La Futuwwah è prendersi cura del deposito affidatoci e dire la verità (Sulamî, Il libro della cavalleria, Roma, 1990, p. 65).
[6] Ibn al-‘Arîf, Mahâsin al-Majâlis, edito e tradotto da Asin Palacios, 1933, p. 33. È d’altronde la stessa attitudine che il discepolo deve avere nei confronti del suo maestro.
[7] Cfr. il nostro studio “L’altruismo divino che si cela dietro il cavaliere: la futuwwa”.
[8] Invece che attaccarsi ai beni materiali, perciò stesso perituri, il fatâ e noi stessi dovremmo attaccarci all’“ornamento di Dio” , che non è condizionato dalla vita di questo basso mondo. Cfr. Cor., VII, 32.
[9] Al-Ghazâlî, L’Unicità divina e l’abbandono fiducioso, Rimini, 1995, pp. 7-8.
[10]Cor., XI, 56.
[11] Traini, Vocabolario Arabo-Italiano, IPO, Roma, 1989, pp. 329-330. Ringraziamo la dott.ssa Casseler per averci dato una piccola infarinatura di grammatica araba, poiché non possiamo fingerci ciò che non siamo, vale a dire degli arabisti.
[12] Ogni dottrina autenticamente tradizionale, nelle sue diverse possibilità d’espressione, tiene conto, proprio attraverso il suo linguaggio, delle possibilità di con-prensione di ognuno e ad ognuno offre quanto questi è capace di assimilare a misura della propria predisposizione essenziale.
[13] Giudice nel senso di colui che prende una decisione, arbitro.
[14] Al-Ghazâlî, L’Unicità divina e l’abbandono fiducioso, Rimini, 1995, p. 11.
[15]Cor., VII, 17.
[16] Ahmad Ibn’Ajîba, Deux traités sur l’Unité de l’existence, E.T., n. 466, p. 94.
[17] Vogliamo ricordare come, da più parti, l’aver messo in relazione la futuwwa alla cavalleria occidentale, anche iniziaticamente, debba far subito venire in mente quelli che sono i Piccoli Misteri.
[18] Sulamî, Il libro della cavalleria, Roma, 1990, p. 65.
[19] Ci riferiamo, non stancandoci mai di ribadirlo, a tutte quelle personalità tipicamente “occidentali” che affermano esista una differenza tra cavalieri indoeuropei e semitici, dove i primi sono esenti dal rapporto di sudditanza tra creatura e Creatore (‘abd/Rabb) che è presente nelle tradizioni semitiche. Ci sembra fin troppo palese l’assenza in dette personalità dello spirito a tutto vantaggio dell’elemento “psichico” nella sua parte deteriore, l’egoismo e quindi il libero arbitrio mal usato. Curioso e bizzarro che, chi si professa in “viaggio” per un Via iniziatica, sia ancora gravato dal peso della loro stessa personalità, proprio la prima cosa di cui ci si dovrebbe sbarazzare.
[20] Scrive Junayd: Sache que la preuve (de la spiritualité) est donne aux créatures quand elles peuvent voir la loyauté (sidq) et les efferts qui sont dépensés pour respecter les règles établies pour toutes les situations. L’homme parcourt celles-ci, l’une menant à la suivante, jusqu’à ce qu’il abortisse ainsi à la véritable servitude, dans ses manifestations extérieures, par l’abbandon du libre arbitre et l’agrément à l’action divine. C’est dans ces conditions que les créatures acceptent les preuves données à son sujet par les critères de la doctrine littéraliste et légaliste (‘ilm al-zâhir), et qui se trouvent rassemblées dans la nature de son comportement (Junayd, Enseignement spirituel, Parigi, p. 45).
[21] Al-Qâshânî, Traité sur la Prédestination et le libre arbitre, Parigi, p. 19.
[22] Rûmî, Poesie mistiche, Milano, 2000, p. 24.
[23]Cor., VI, 149.
[24] ..Car c’est Toi qui es l’Auteur de toutes les oeuvres de la création, et qui ne connais aucune chose qui ne soit pas de Toi [il principio delle creature] vient de Toi, […] l’ordre (qu’elles ont reçu) est (de retourner) à Toi, […] leurs manifestations extérieures et leurs pensées intimes sont recensées dans Ta Volonté! C’est Toi en effet qui donnes et c’est Toi qui retiens, et ce qui est nuisible et ce qui est utile sont l’effet de Ton Decret (qadâ’)… (Junayd, Enseignement spirituel, Parigi, p. 180).
[25] Cfr. Matgioi, La via metafisica, Roma, 1983.
[26]Prima lettera di Pietro, II, 16.
[27] A. Ventura, Un trattato di ‘Abd al-Janî an-Nâbulusî sull’“Unicità dell’esistenza”, Napoli, Supplemento n. 27 agli Annali, vol. 41 (1981), fasc. 2, p. 25.
[28] Cfr. Junayd, Enseignement spirituel, Parigi, pp. 193-194.
[29]L’on sait en effet que, dans le Christianisme, c’est ce terme de “prédestination” qui fut le plus couramment employé à propos de la prescience divine et de la prédétermination; toutefois, il n’englobe pas tout à fait notre sujet et se réfère plus particulièrement à l’idée d’élection, le consensus théologique n’ayant pu se resoudrè à reconnaître le “choix des damnés”. Aussi la notion de prédestination doit-elle complétée par celle de “réprobation” (al-Qâshânî, Traité sur la Prédestination et le libre arbitre, Parigi, p. 6).
[30] Dio conosce l’inesistente nella sua condizione di inesistente e sa quale sia, quando Egli gli dà l’esistenza, conoscendo, quindi, l’esistente nella sua condizione di esistente sapendo parimenti quale sia, allorché si “estingue”.
[31] Ibn‘Arabî, La conoscenza della “nafs” (cap. 267 delle Fut. Mak.), “Rivista di Studi Tradizionali”, 1984, gennaio-giugno, n. 60, p. 15, nota 13.
[32] Cfr. A.K. Coomaraswamy, La trasfigurazione della natura nell’arte, Milano, 1990.
[33] L’oggetto dell’azione è creato, mentre l’Atto di Dio è increato!
[34] Rûmî, Poesie mistiche, Milano, 2000, p. 24.
[35] Ibn‘Arabî, La conoscenza della “nafs” (cap. 267 delle Fut. Mak), “Rivista di Studi Tradizionali, 1984, gennaio-giugno, n. 60, pp. 10-11.
[36]Op. cit., p. 25.
[37] Ciò è collegato direttamente al mithaq primordiale in forza del quale Dio fece testimoniare la progenie di Adamo in ispirito: A-lastu bi-Rabbikum? Ed essi risposero: balâ (Cor., VII, 172). Chi è miscredente ha compiuto un alterazione di questa natura (fitra) o patto primordiale, mentre chi crede ha perseverato in essa. Cfr. G. De Luca, Non sono Io il vostro Signore?, “Quaderni di Avallon”, Rimini, 1993, n. 31.
[38] Junayd, Enseignement spirituel, Parigi, p. 59.
[39] Rûmî, Poesie mistiche, Milano, 2000, p. 24.
[40] Al-Qâshânî, Traité sur la Prédestination et le libre arbitre, Parigi, p. 7. In merito alla libertà umana, così si esprime Matgioi: La libertà umana esiste: ed esiste nelle condizioni che soddisfano la giustizia soggettiva e impegnano a sufficienza, dal punto di vista della sensazione che deve essere preveduta, le nostre responsabilità personali. Ma ciò essendo affermato e dovendo essere sviluppato altrove, la libertà degli esseri non esiste in quanto trattasi di particelle lanciate nella corrente dalla Volontà del cielo e destinate a essere raccolte da questa stessa volontà. Non dimentichiamo a qual mondo appartiene la serie di cui parliamo e che è sul piano metafisico – vale a dire sul piano divino – che verte il nostro ragionamento. Noi siamo qui di fronte alla Volontà Divina. Nessuna volontà esiste se non emana da questa volontà; dunque nessuna volontà può eguagliarla: perché, se una volontà eguagliasse quella divina, sarebbe esse stessa divina, e non una sua emanazione. Ogni volontà che eguagli quella divina è identica ad essa; dunque nessuna volontà può, su piede di parità ergersi contro la volontà divina. Non vi è dunque volontà che trionfi di quella divina; non c’è dunque libertà contro l’attività del cielo (Matgioi, La via metafisica, Roma, 1983, p. 91).
[41] Il senso secondo cui l’esistenza è ciò per cui ogni essere esiste, nell’Eterno e nel creato, è quello più vicino alla realtà: ecco perché l’essere contingente (mumkin), che è l’uomo o anche ‘abd, non può assolutamente fare a meno dell’Essere Eterno (qadîm), poiché l’esistenza di quello è l’Esistenza di questo.
[42]Cor., XXXV, 15. Il segno della ricchezza in Allâh è l’indipendenza dell’anima (‘izza an nafs) nei riguardi di ciò che possiedono gli uomini, la ricchezza nelle cause seconde situantesi al lato opposto di questa.
[43] Al-Qushayri, Principles of Sufism, Berkeley, 1990, p. 170.
[44]Cor., XXVI, 89.
[45]En effet de tous les fils d’Adam, Seth hérita de la Voie intérieure, la tarîqa, qu’Abraham adapta à ceux qui ne pouvaient en remplir toutes les conditions et transmit à Ismaêl (D. Gril, Ibn‘Arabî,: Ecrits sur la futuwwa, “La Règle d’Abraham”, Reims, 1996, n. 2, p. 4). A proposito delle virtù del tasawwuf, Junayd collega Abramo alla generosità d’animo (sakhâ’) mentre Ismaele all’accettazione del destino (ridâ’). Cfr. Junayd, Enseignement spirituel, Parigi, pp. 188-189.
[46] Sia ben chiaro che non intendiamo in nessun modo accostare il Califfato alla futuwwa. Ci riferiamo piuttosto al passo coranico Ed elargite di ciò di cui siete stabiliti vicari (Cor., LVII, 7): siamo tutti luogotenenti della scienza e dei beni dei quali abbiamo disponibilità, rimanendo comunque la loro proprietà nelle mani di Allâh, il Vero.
[47]Cor., XII, 55.
[48] Inteso come sacrum facere.
[49] Vedere lo studio omonimo di A.K. Coomaraswamy contenuta nella Doctrine du sacrifice, Parigi, VI edizione.
[50] Cor., XXIX, 69.
[51] Ricordiamo poi che il termine jihâd significa più sforzo che guerra! Il Cielo tiene conto solamente degli sforzi che si fanno per conoscerlo, e non del risultato di questi sforzi ( Matgioi, La via taoista, Milano, 1997, p. 49).
[52] Mawlânâ (Rûmî) disse: Qual è il nome di quel giovane? Gli fu risposto: Saif ud-Dîn (“Spada della religione”). Il maestro disse: Quando la spada è nel fodero, non la si può vedere. Il vero Saif ud-Dîn è colui che combatte per la religione e i cui sforzi sono tutti orientati verso Dio; egli distingue la rettitudine dal vizio e discerne la verità dall’errore. Anzitutto combatte con se stesso e purifica il proprio carattere (Rûmî, Il libro delle profondità interiori, Milano, 1996, 209).
[53] Oltre che il peso della verità, bisogna anche ricordare che , Il évite de rappeler a l’homme ce don gratuit car la futuwwa consiste à manifester les bienfaits des autres et à cacher les siens (D. Gril, Ibn‘Arabî: Ecrits sur la futuwwa, “La Règle d’Abraham”, Reims, 1996, n. 2, p. 7).
[54]Cor., LI, 56.
[55]Cor., VI, 125.
[56] Cfr. Cor., XCIV, al-Inshirâh oppure al-Sharh.
[57] Al-Ghazâlî, L’Unicità divina e l’abbandono fiducioso, Rimini, 1995, p. 45.
[58] Il pentimento comprende tre realtà spirituali che sono la contrizione, non ricadere in ciò che Dio ha interdetto e adoperarsi a rimediare ai propri torti. Cfr. Junayd, Enseignement spirituel, Parigi, p. 191.
[59] Ibn‘Arabî, Fut. Makk., II, p. 157.
[60]La verité qui est en lui le conduit ensuite à la contemplation (mushâda) de l’Être divin, et à la saise de ce qu’Il lui montre dans les changements qu’Il opère et qui sont dus au fait que ce qui est le mieux pour lui est ce que Dieu choisit à sa place (Junayd, Enseignement spirituel, Parigi, pp. 45-46).
[61] Se quanto detto è presentemente utilizzato per il fatâ, ebbene il tutto può senza alcun problema essere riportato anche al dhakir, colui che pratica il dhikr.
[62] Cfr. A. Ventura, Un trattato di ‘Abd al-Janî an-Nâbulusî sull’“Unicità dell’esistenza”, Napoli, Supplemento n. 27 agli Annali, vol. 41 (1981), fasc. 2, pp. 32-33.
[63] Al-Jîlî, L’Uomo Universale, Roma, 1981, p. 61. Segnaliamo come gli ultimi due righi si avvicinino molto al ambula ab intra ermetico, simboleggiato dalla sigla VITRIOL. Cfr. A. Ventura, Lumière sur les choses difficiles à percer, Milano, 1978.
[64] Ibn‘Arabî, La conoscenza della “nafs” (cap. 267 delle Fut. Mak.), “Rivista di Studi Tradizionali”, 1984, gennaio-giugno, n. 60, pp. 14-15.
[65] Ibn‘Arabî differenzia la preghiera dall’invocazione, perché c’è differenza tra chi chiede a Dio e chi domanda di Lui. La preghiera è una chiamata, il che implica una certa distanza nonché separazione e ciò è “adorazione”. L’invocazione invece è “dominio”, perché colui che invoca è assiso in Presenza di Dio. C’è un’invocazione e una preghiera da parte di Dio ed un’invocazione e una preghiera da parte della creatura. Se tu invochi Dio, Egli ti invoca; e se tu dici a Lui: “Signore”, Egli dice a te: “servo”; e se tu dici a Lui: “dammi”, Egli ti dice: “damMi”. Nel Corano Dio ti dice a proposito dell’invocazione: “invocaMi ed Io ti invocherò”, ed a proposito della preghiera Egli dice: “mantieni il tuo patto con Me. Ed Io manterrò il Mio patto con te”. Cosa scegli a questo punto? Se tu Lo invochi, Egli ti invoca, se tu Gli chiedi, Egli ti chiede! (Ibn‘Arabî, Kitâb al-Tarâjim, p. 52).
[66] L’uomo è un miscuglio di tutti gli elementi componenti il grande universo, per cui si vengono a produrre dei fenomeni attrattivi o repulsivi tra ognuno degli elementi componenti l’uomo e quelli dell’ambiente che lo circonda. L’azione umana varia allora a seconda del cambiamento dello stato nel soggetto: essa è il risultato di milioni di reazioni naturali e chimiche prodottesi nel suo essere.
[67] Segnaliamo all’attenzione di chi ci legge: A. Ventura, L’Islâm sunnita nel periodo classico, in “ Storia delle religioni . Religioni dualiste: Islâm”, Bari, pp, 223-224, 234.