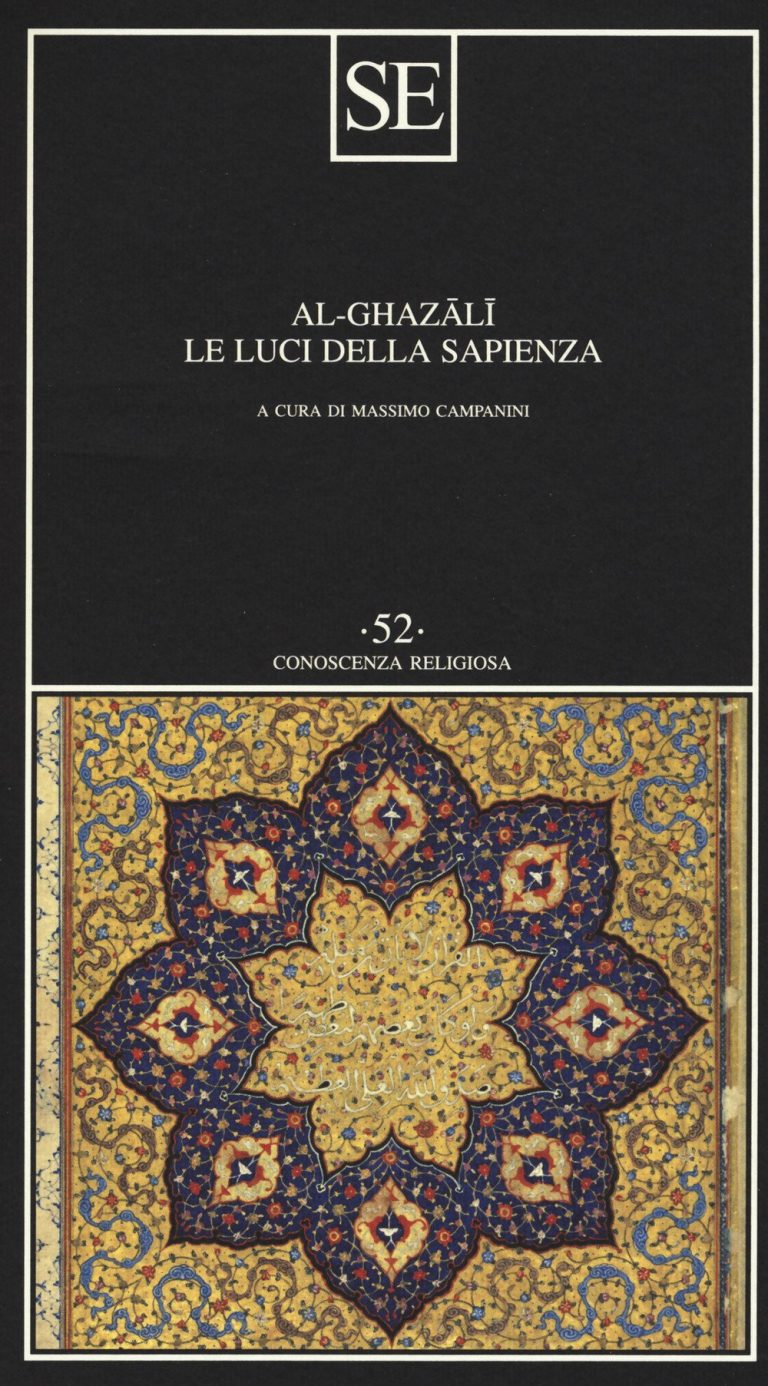
“Che si può dire in generale della via mistica? La purezza ne è la condizione primaria; lo svuotamento del cuore da tutto ciò che non sia Dio Altissimo. Ne è chiave il conseguimento della purità rituale in occasione della preghiera, immergendo completamente il cuore nel ricordo di Dio. Il suo fine è l’annullamento totale in Dio. Questo è quanto rientra nelle cose fondamentali che la libera scelta umana può conseguire. Purezza del cuore, purezza rituale e annullamento in Dio sono in verità le cose fondamentali della via mistica” (p. 52).
Così Al-Ghazālī descrive il sufismo ne «Il libro che preserva dall’errore» (Munqidh min al-dalāl). Il volume che presentiamo contiene, oltre allo scritto citato, anche la traduzione italiana di «La nicchia delle luci» (Mishkāt al-anwār), il commentario del maestro al sublime “Versetto della Luce” (Cor. XXIV, 35). Se «Il libro che preserva dall’errore» è un testo che, in una cornice autobiografica, si interroga sullo statuto della profezia, della gnosi e dei rispettivi rapporti con le altre forme di conoscenza, «La nicchia delle luci», mediante l’ermeneutica mistica applicata al verbo coranico, esibisce i fondamenti di quella scienza divina di cui solo il sufismo è il pieno depositario. Si tratta, insomma, di due scritti il cui accostamento è legittimo e che si illuminano a vicenda; due autentiche gemme opera del maestro persiano che Henry Corbin definì come “una delle più forti personalità, uno degli ingegni più sistematici che abbia avuto l’Islam, come è attestato dall’epiteto onorifico, che egli condivide con alcuni altri, di Hojjat al-Islām (la prova, il garante dell’Islam)”(cfr. H. Corbin, Storia della filosofia islamica, trad. it. di V. Calasso e R. Donadoni, Milano, 2007; p. 189).
Il libro che preserva dall’errore
(Munqidh min al-dalāl)
Scritto in risposta al quesito di un interlocutore definito “fratello nella fede”, in merito “al fine e ai segreti delle scienze, le superficialità e le profondità delle dottrine” (cfr. p. 5), il libro si presenta come l’esposizione dell’itinerario spirituale che condusse Al-Ghazālī alla via mistica, dopo aver saggiato e confutato gli errori della teologia dialettica (kalām), degli innovatori (ovvero di coloro che si oppongono alla sunna, identificata con l’autentica tradizione) e dei filosofi.
Al-Ghazālī dichiara che sin dalla giovinezza l’esigenza che mosse la sua ricerca fu quella di trovare la scienza capace di cogliere “l’autentica realtà delle cose” in modo certo e indubitabile, la quale corrisponde alla “natura originale” (cfr. p. 8) della conoscenza, così come essa si presenta prima dell’adeguamento dell’individuo alle convenzioni sociali, culturali e religiose. Il maestro, infatti, definisce il proprio cammino come l’audace tentativo di sollevarsi “dall’infimo della pedissequa imitazione all’altitudine dell’indagine personale” (cfr. p. 5). Si tratta, in altre parole, del superamento di un orizzonte religioso irrigiditosi nella lettera e pertanto incapace di far fronte alla richiesta di senso di colui che ne ha smascherato il formalismo. Sostiene infatti Al-Ghazālī che “è del tutto inutile piegarsi all’insegnamento di autorità tradizionali dopo essersene liberati; e chi si trova nella condizione di piegarsi alla tradizione, non sa di farlo, poiché se lo sapesse, il fragile involucro della sua acquiescenza andrebbe in frantumi. Né la frattura potrebbe essere riparata, visto che non è possibile rimettere insieme i frammenti ricomponendoli e riorganizzandoli, a meno di non liquefarli col fuoco e conferire loro una foggia del tutto nuova” (p. 16).
Spogliatosi di qualsiasi appoggio fornito dalle autorità precostituite, Al-Ghazālī realizzò in prima battuta di avere a propria disposizione solo due basi d’appoggio: i dati provenienti dalla sensibilità e la forma della necessità logica, così come essa viene articolata dalla ragione. Tali sostegni, tuttavia, si dimostrarono ben presto inutili. La sensibilità, infatti, può ingannarsi o essere ingannata, e i suoi simulacri disperdersi di fronte al giudizio. Allo stesso modo, come il giudizio dissipa la certezza sensibile, è possibile che una facoltà superiore, di cui ancora non si dispone, vanifichi i prodotti e le certezze della ragione.
Il maestro racconta che l’angoscia prodotta dal dubbio frutto di tali considerazioni lo precipitò in uno stato di profondo turbamento, durato alcuni mesi, da cui uscì, come testimonia, non tramite il ragionamento, ma “in grazia di una luce che Dio Eccelso mi proiettò in petto” (cfr. p. 14). Si trattava della luce che costituisce l’autentica fonte della conoscenza, la quale non ha origine da ragionamenti ben articolati, ma è dono gratuito della generosità divina che il fedele ha esclusivamente la possibilità di carpire nel momento di grazia. Tale luce, pertanto, non può essere cercata, ma solo implorata ed attesa nella vigilanza del cuore.
Ripresosi dalla malattia, Al-Ghazālī si rivolse a indagare la verità presso i saggi, o sedicenti tali, del suo tempo. Escluse ben presto il sapere di cui sono detentori i teologi dialettici, in quanto esso ha come scopo esclusivo il preservare la tradizione dal veleno degli innovatori. Sebbene i teologi siano talvolta pervenuti a qualche risultato sul piano della conoscenza autentica, il maestro sostiene che “si è trattato di qualcosa che si è mescolato alla supina aderenza alla tradizione”, e pertanto “risulta poco utile per chi non ammetta assolutamente nulla, a parte le verità necessarie” (cfr. p. 18).
Per quanto riguarda la scienza filosofica, Al-Ghazālī ammonisce che tutti i filosofi, seppure in gradi diversi, si macchiano di miscredenza (kufr) ed empietà (ilhād). Il maestro li suddivide in materialisti, naturalisti e teisti. I materialisti sono evidentemente atei e negano l’esistenza di un creatore. I naturalisti, attraverso lo studio della natura, giungono a riconoscere l’esistenza di Dio, ma inseguendo la linea del loro pensiero a dispetto del dato rivelato, si spingono ad affermare empietà come ad esempio l’impossibilità della sopravvivenza alla morte – tesi, questa, che distrugge le fondamenta dell’etica e della dottrina della salvezza. Per quanto riguarda i teisti, essi sono indicati da Al-Ghazālī essenzialmente nella scuola greca rappresentata da Socrate, Platone ed Aristotele. Sebbene tali filosofi prendano le distanze da materialisti e naturalisti per una maggiore consapevolezza del divino, tuttavia essi trattengono sovente nel loro pensiero evidenti elementi tacciabili di miscredenza e di innovazione e vanno pertanto evitati.
Per quanto riguarda le scienze filosofiche, il maestro le identifica con il gruppo costituito da matematica, logica, scienza della natura, teologia, politica ed etica. Tali scienze o si occupano di oggetti la cui considerazione non si eleva al piano della conoscenza sacra, come la scienza della natura e la politica, o nella neutralità del loro oggetto, se messe al servizio della sovversione, possono essere altamente svianti e pericolose per la loro persuasività, come nel caso di logica e matematica, oppure risultano aver dato luogo a manifeste e odiose deviazioni dottrinali, come ad esempio l’indagine filosofica applicata alle cose divine. Di quest’ultima Al-Ghazālī denuncia tre gravissimi errori attribuiti in particolare all’aristotelismo, ossia la negazione della resurrezione dei corpi, il fatto che Dio conosca solo gli universali e non i particolari, e l’affermazione dell’eternità del mondo.
Per quanto riguarda l’etica, ossia “l’esame delle caratteristiche degli attributi e dei costumi dell’anima” (cfr. p. 30), il maestro liquida tale scienza affermando che quanto di buono vi è in essa è stato dedotto dalla “dottrina dei mistici sufi, uomini pii dediti con perseveranza a rammentare il nome di Dio Altissimo (dhikr), e a distogliersi dalle passioni, camminando sulla via di Dio Altissimo e prendendo le distanze dalle lusinghe del mondo terreno” (cfr. p. 30). I filosofi avrebbero assimilato le dottrine dei mistici al fine di abbellire e rendere più appetibili le loro falsità. Il sufismo è identificato in questa affermazione con la forma universale della santità e della gnosi, e non esclusivamente nella sua espressione islamica: “Certo, anche ai tempi dei filosofi come in tutti i tempi, vi sono stati cercatori di Dio che Dio non ha mai fatto mancare al mondo. Essi sono i pilastri della Terra e grazie alla benedizione che hanno ricevuto la misericordia divina si è comunicata agli altri uomini” (p. 30).
A tal proposito, Al-Ghazālī si intrattiene in alcune riflessioni molto acute sui rischi connessi alla frequentazione dei testi e delle idee dei filosofi. Innanzitutto il rigore e la precisione del linguaggio matematico e la forza persuasiva della logica spesso ingenerano nell’insipiente l’idea che chi detiene degli strumenti di analisi talmente potenti da sembrare inconfutabili non possa sbagliarsi riguardo alla verità, portando così a identificare il mezzo con il fine, ed estendendo impropriamente le qualità di un ambito specifico della filosofia al suo intero scibile. Dall’altro lato, chi vuol tenere saldo l’orizzonte tradizionale, spesso per reazione all’attacco razionalista radicalizza il letteralismo religioso negando valore a priori a qualsiasi asserzione formulata dalle scienze filosofiche. Il maestro sottolinea che è proprio del volgo l’escludere una dottrina vera e concordante con la tradizione quando la sua fonte non sia musulmana, mentre è proprio del sapiente riconoscere la verità anche qualora il recipiente che la contenga fosse impuro come “la coppetta di un salassatore” (p. 33). Vi è inoltre il rischio concreto che chi non sia sufficientemente dotato di discernimento, nonostante non screditi a priori l’insegnamento dei filosofi, trovando verità e falsità commiste nei medesimi argomenti, come nel caso della scienza etica, ritenga integralmente falsa tutta la dottrina, anche nei suoi elementi di verità.
Ammonisce Al-Ghazālī: “L’abitudine dei deboli di intelletto è di conoscere la verità attraverso gli uomini e non gli uomini attraverso verità” (p. 31). Si comprende pertanto la necessità di proteggere coloro che non sono in grado di discernere sbarrando loro l’accesso ai testi che costituiscono un rischio per la salvezza. Tale servizio è provvidenzialmente svolto da qualsiasi autorità religiosa tradizionale nel normale esercizio delle sue facoltà di tutela dei mezzi di grazia che è chiamata a diffondere e a custodire, ed è pertanto da incoraggiare e da difendere.
Il terzo tipo di scienza preso in considerazione è quella degli innovatori, rappresentati in questa occasione dai Ta’limiti, ossia da coloro che sostengono che “per conoscere il senso profondo delle cose, bisogna rivolgersi all’imām impeccabile, saldo nella verità” (cfr. pp. 35-36). Il bersaglio della polemica di Al-Ghazālī sono gli Ismailiti di Alamūt, spina del fianco dei sovrani selgiuchidi e sostenitori dell’insegnamento per autorità, il ta’līm, le cui dottrine Al-Ghazālī si propose di confutare in numerosi scritti, assieme a quelle più moderate degli Sciiti duodecimani.
Gli argomenti del maestro vertono essenzialmente sul riconoscimento della necessità di una guida che conduca alla verità, ma sostiene che tale guida non può che essere Muhammad: qualsiasi ricorso ad altra autorità, oltre che a non raccogliere nella comunità l’unanimità dei consensi in merito alla genuinità del mandato, non sottrae comunque il fedele alla necessità di ricorrere a uno sforzo interpretativo che è indissolubile dal rapporto con una tradizione e un testo sacro.
Disilluso dalle scienze del proprio tempo, ma ancora determinato a trovare la verità, il maestro si rivolse infine ai saggi sufi, la cui via è descritta come un cammino di purificazione del cuore affinché in esso non sia presente altro che Dio e il ricordo del suo nome. In principio Al-Ghazālī si dedicò allo studio delle loro dottrine, ma giunse ben presto a comprendere che la verità, nella via mistica, non è un sapere ma uno stato, e pertanto va direttamente “gustata”. I sufi, ricorda Al-Ghazālī, “sono uomini di esperienza e non di parole” (cfr. p. 48).
In vista del cammino d’ascesi, il maestro raccolse tutte le certezze di cui disponeva costituenti il lascito della sua precedente vita di studioso. Si trattava di tre nuclei irriducibili di verità “radicati nell’anima non in grazia di una dimostrazione precisa, ma per una serie di cause, di circostanze e di esperienze su cui non è il caso di diffondersi in dettagli” (cfr. p. 48). Tali certezze erano Dio, la profezia e il Giorno del Giudizio. A queste aggiunse la persuasione, frutto del suo incontro con il sufismo, che l’uomo non disponeva di nessun altro metodo di realizzazione spirituale che non fosse “il timor di Dio e la liberazione dell’anima dai vani desideri” (cfr. p. 48).
Nell’incapacità di risolversi a lasciare famiglia, ricchezze e posizione sociale, Al-Ghazālī precipitò in una profonda crisi che lo condusse in prossimità della morte. Da essa uscì solo tramite la preghiera, che alleggerì il suo fardello d’angoscia e diede forza e stabilità alla sua decisione di lasciare il mondo. Stabilitosi in Siria per due anni, si dedicò in solitudine all’agone spirituale, alla meditazione e alla mortificazione, pervenendo così “a raddrizzare i costumi e a adornare il cuore della rammentazione del nome di Dio Eccelso” (cfr. p. 51). In questo periodo il maestro assolse all’obbligo rituale del Pellegrinaggio (Hajj). Dopo due anni, ritornato in patria, continuò a svolgere vita ritirata per un circa un decennio.
Tra i frutti dell’estasi e della meditazione, Al-Ghazālī annovera la certezza che “sono i sufi a percorrere la via di Dio Altissimo, e che il loro modo di vivere è il migliore, la strada da loro percorsa la più retta, i loro costumi i più puri. (…) Ogni movimento o riposo dei mistici, esteriore o interiore, attinge luce dalla nicchia della profezia, e non vi è altra luce sulla faccia della Terra che possa illuminare tranne quella profetica” (cfr. p. 52).
La comprensione della natura della profezia è il secondo grande guadagno che il maestro annovera tra i tesori del suo ritiro. “La grazia dei santi non è altro che l’inizio della profezia” (p. 53): colui che intraprende il cammino della perfezione giunge a gustare i misteri dello stadio “nel quale l’occhio acquisisce una luce nel cui alone luminoso si manifesta il mondo dell’invisibile, cioè quelle cose che non possono essere percepite dall’intelletto” (cfr. p. 57). La profezia corrisponde quindi a una facoltà superiore a quella intellettuale; quest’ultima, infatti, si rivolge esclusivamente agli oggetti intelligibili e con essa “si coglie che le cose possono essere necessarie, possibili e impossibili” (cfr. pp. 55-56). L’intelletto si eleva al di sopra della facoltà sensibili, presenti nell’uomo sin dalla nascita, e della ragione, che si sviluppa intorno ai sette anni di età; esso, tuttavia, non giunge là dove si spinge l’occhio profetico, il quale “coglie il mondo dell’invisibile e ciò che accadrà nel futuro” (cfr. p. 56). I rapporti gerarchici che sussistono tra la facoltà profetica e quella intellettuale sono chiariti dal maestro nei seguenti termini: “In sintesi, i profeti sono i medici del cuore. L’utilità che si può trarre dall’intelletto e la sua funzione consiste nel fatto che esso ci informa di tutto ciò, testimoniando la veridicità della profezia e riconoscendo la propria incapacità a cogliere ciò che coglie l’occhio della profezia. L’intelletto ci prende per mano e ci rende sicuri della rivelazione profetica, così come i ciechi si affidano alle loro guide e i pazienti ansiosi ai medici comprensivi” (p. 62).
Nel sogno, per grazia divina, l’uomo esperisce ordinariamente alcuni caratteri del mistero profetico, così come ne fa esperienza in tutte quelle conoscenze che non sono attingibili mediante il ricorso alle semplici facoltà intellettuali, come ad esempio alcune nozioni matematiche e astronomiche che non hanno come fonte né l’esperienza sensibile, né il giudizio, né tanto meno gli oggetti intelligibili. La pienezza della facoltà profetica, tuttavia, è accostabile esclusivamente tramite l’esperienza che ne fa il santo, e rientra pertanto nel dominio dell’ineffabile. Alla domanda su come sia possibile riconoscere un profeta, Al-Ghazālī risponde che è sufficiente osservarlo: chi ha una nozione preliminare della profezia la riconoscerà operante in colui che ne è portatore, cosicché “se intendi il significato della profezia e hai dedicato molto tempo allo studio del Corano e delle tradizioni, acquisirai scienza certa che Muhammad ha raggiunto i gradi più alti della profezia” (cfr. p. 58). Non sono pertanto i miracoli a costituire la prova della genuinità del profeta, ma la piena conformità del suo insegnamento e dei suoi atti ai caratteri universali della profezia, così come essi si disvelano nell’esperienza mistica.
L’aver fatto esperienza dei mezzi di realizzazione spirituale del sufismo e della realtà della profezia condusse Al-Ghazālī a rinunciare al proprio ritiro. Egli, infatti, osservò “quanto incerta fosse la credenza degli uomini nella profezia, nonostante la sua assoluta verità, e di quanto si fossero allentate le pratiche religiose da effettuarsi secondo le prescrizioni della profezia” (cfr. p. 62). Fu la necessità di intervenire nei confronti di tale morbo spirituale a convincerlo a tornare tra gli uomini, perché “l’ignoranza di Dio è un veleno mortale, e peccare contro Dio seguendo i propri desideri è una malattia. Conoscere Dio Altissimo, al contrario, è l’antidoto che ridona la vita; obbedirGli opponendosi ai vani desideri è il medicamento che produce la guarigione” (p. 61). In altre parole, il maestro riconobbe l’urgenza storica di predicare il ritorno ai dettami della religione ortodossa, laddove il loro senso era stato misconosciuto dalla perdita di comprensione del significato autentico del fenomeno profetico.
Le cause della disaffezione nei confronti dell’osservanza sono ravvisate da Al-Ghazālī in una serie di errori imputabili essenzialmente all’egocentrismo dell’uomo che pretende di ergersi a giudice della validità dei mezzi di grazia istituiti provvidenzialmente da Dio. Ciò che viene negato è l’universalità e l’attualità permanente delle prescrizioni profetiche, ora appellandosi all’autorità del giudizio degli uomini di scienza che se ne sottraggono, ora – come nel caso di alcuni sufi – attribuendosi uno stato spirituale per il quale ci si dichiara esenti da quanto è prescritto dalla religione ai non iniziati. Altre volte la deriva è di tipo razionalista, come nel caso dei filosofi, che dichiarano la relatività storica delle norme religiose e quindi la possibilità di indulgere in alcune prescrizioni, o di attenersi ad altre per pura convenzione sociale. Alcuni, di conseguenza, disorientati dalla molteplicità delle posizioni antitradizionali ed eterodosse, approdano a una forma di relativismo per il quale è impossibile discernere tra ciò che è certo e ciò che è dubbio.
L’occasione per il ritorno fu offerta ad Al-Ghazālī dall’appello del proprio sovrano, che lo invitò a riparare alla grave situazione. Vinte le resistenze interiori in merito ritorno, su consiglio di molti maestri spirituali che interpellò, e sulla scorta di alcune visioni mistiche che sciolsero gli ultimi dubbi, Al-Ghazālī maturò la convinzione che la sua funzione andava interpretata alla luce della promessa divina di rinnovare ad ogni secolo la religione. Sentendosi investito di tale mandato, il maestro uscì dal suo ritiro durato undici anni. Il suo ritorno all’insegnamento, tuttavia, non ebbe più come movente la gloria e le seduzioni del mondo: egli era infine un essere trasformato che poteva affermare di sé: “Desidero migliorare me stesso e gli altri. Non so se raggiungerò il mio scopo o se fallirò. Ma ho certa fede e salda cognizione che non c’è forza ne potenza se non in Dio Altissimo e Grande, e che non sono io a muovermi, ma è Lui a muovere me. Non io opero, ma è Lui che mi utilizza come strumento. Lo supplico di emendare me in primo luogo e poi gli altri attraverso di me; lo supplico di guidare me in primo luogo e poi gli altri attraverso di me, di indicarmi la verità di ciò che è vero e di sostenermi nel perseguirla, e di mostrarmi la falsità di ciò che è falso e di sostenermi nel respingerla” (p. 67).
Nella confessione di Al-Ghazālī risuona l’eco di una vicenda emblematica il cui valore è universale e intramontabile. Il santo, come avviene da sempre, dopo l’occultamento ritorna al mondo. Torna per misericordia, per irradiare la grazia che ha gustato, per diffondere la certezza di cui Iddio gli ha fatto dono. Porta con sé l’insegnamento che ciò che il dono profetico rivela ha una validità permanente, perché la fonte della profezia è eterna, e ciò che istituisce, lungi dal poter essere giudicato dall’uomo, pre-comprende ogni stato umano e ne è norma e misura. La profezia non è passibile di giudizio in quanto la ragione è una facoltà inferiore a quella profetica, così come la santità dischiude una scienza che è superiore al sapere umano e che quest’ultimo, nella sua vanagloria, non può intaccare.
Sopra il profeta che ne l’istitutore, il santo che ne è il realizzatore, il fedele che vi aspira, vi è l’unica religione voluta da Dio, che tutti riconduce all’Unico.
La nicchia delle luci
(Mishkāt al-anwār)
Il Mishkāt al-anwār è uno dei commenti tradizionali più noti al cosiddetto “Versetto della Luce” (āyat al-nūr): «Dio è la Luce dei cieli e della Terra, e la sua Luce assomiglia a una nicchia in cui è contenuta una lampada, a sua volta contenuta in una ampolla di cristallo, che è come una stella brillante; e la lampada brucia dell’olio di un albero benedetto, un ulivo né orientale né occidentale, che arde quasi come se non lo toccasse fuoco. E’ Luce su Luce e Dio guida alla sua Luce chi vuole» (Cor., XXIV, 35). L’epistola in questione, tuttavia, travalica i confini dell’esegesi per spingersi a delineare un’autentica metafisica della luce, nei suoi riflessi sulla gnoseologia mistica e sulla scienza profetica: si tratta di una dottrina sublime che si eleva ad “altitudini vertiginose, alle quali può pervenire soltanto l’occhio acuto dei dotati di vista interiore”, che non è opportuno diffondere, in quanto “il petto dei puri è la tomba dei segreti”. Il destinatario dell’opera è, infatti, un iniziato il cui cuore è “stato aperto alla luce” e il cui intimo è “sottratto alle tenebre dell’ignoranza”; a lui, Al-Ghazālī, per “brevi cenni e concise allusioni”, schiude tre parti della dottrina segreta (cfr. p. 80).
Il maestro precisa innanzitutto che il termine “luce” (nūr) ha più significati, dipendenti dal grado di conoscenza a cui si eleva colui che lo utilizza. Il significato essenziale si riferisce a Dio Altissimo, “la Luce più elevata e suprema”: “Egli solo”, infatti, “è Luce autentica e reale” e “nulla condivide con Lui questo attributo” (cfr. p. 81).
Il significato materiale del termine, comunemente utilizzato dai semplici fedeli, è relativo alla visione. Esso fa riferimento alla visibilità dei corpi in tre modi distinti: ai corpi la cui caratteristica è di non essere visibili in sé stessi, ovvero a tutto ciò che per essere visto deve essere illuminato; ai corpi visibili in sé stessi ma che non illuminano, come ad esempio le stelle; ai corpi che sono visibili e illuminano, come il Sole e il fuoco. Il termine “luce” è utilizzato propriamente solo per questa terza categoria. Tuttavia, sottolinea Al-Ghazālī, essendo l’attributo di luminosità materiale relativo alla percezione visiva, è corretto definire “luce” tanto ciò che illumina, quanto ciò che percepisce la luminosità, ovvero la vista.
La luce dell’occhio ha connaturata una serie di difetti che rendono la sua percezione fallace. Tali errori sono sette, e sono indisgiungibili dall’esperienza sensoriale. Esiste tuttavia un occhio interiore, l’occhio del cuore, che è immune da tali deficienze, tanto che esso può essere definito “luce” in un senso più adeguato di quello fisico. Esso è la facoltà che è comunemente denominata “intelletto”.
I sette difetti dell’occhio fisico corrispondono a sette virtù dell’occhio del cuore. L’intelletto, infatti, coglie sia ciò che è altro da sé che sé stesso, a differenza dell’occhio fisico che non ha cognizione di sé medesimo. Esso percepisce indifferentemente quanto è vicino e quanto è lontano, mentre l’occhio umano non vede altro che ciò che gli è prossimo. L’occhio del cuore dipana i veli, a differenza dell’occhio fisico che non coglie ciò che è celato alla vista. L’intelletto vede l’intimo e l’essenza e non soltanto l’apparenza e l’esteriorità. L’occhio umano, inoltre, si limita a cogliere gli oggetti esistenti, mentre l’intelletto scorge qualsiasi realtà intelligibile. L’occhio del cuore può giungere a percepire l’infinito, mentre la finitezza è l’attributo dei corpi materiali, oltre cui non può spingersi la sensibilità. Infine l’occhio umano si inganna sulle dimensioni e sul movimento, essendo il suo punto di vista vincolato all’attimo e alla posizione, mentre l’intelletto concepisce lo spazio e il tempo in maniera sintetica e totale.
L’intelletto, sostiene il maestro, non può commettere errore. Se ciò avviene, è esclusivamente a causa delle fantasie e dell’immaginazione che risiedono nel soggetto vedente inquinando la vista interiore. La responsabilità dell’errore va pertanto attribuita all’inadeguatezza di colui che vede e non alla facoltà intellettuale in sé stessa, che di per sé è infallibile.
L’occhio del cuore ha costantemente presenti una serie di conoscenze necessarie, quali gli assiomi logici, la cui evidenza è primaria. Esso inoltre è stimolato dalle proposizioni speculative, che né attivano il potenziale illuminante. Ciò che tuttavia stimola maggiormente l’intelletto sono i versetti del Corano e di “tutti gli altri libri rivelati da Dio”, tanto che ogni rivelazione autentica può essere definita “luce” in quanto capace di illuminare la facoltà intellettuale. Il maestro, infatti, sostiene che “i versetti del Corano stanno all’occhio dell’intelletto allo stesso modo in cui la luce del sole sta all’occhio materiale – infatti per suo mezzo si perfeziona la vista. E’ dunque ben opportuno che si denomini il Corano «luce», così come si è denominata «luce» la luce del Sole. La luce del Sole è tale in analogia al Corano, come la luce dell’occhio è tale in analogia all’intelletto” (cfr. p. 89). Esistono pertanto due Soli: quello fisico, esterno al soggetto, e quello del mondo superno, il Reame, interno; il mondo sensibile sta al mondo del Reame come “la buccia alla polpa, come la foggia e la forma esteriore in relazione allo spirito, come le tenebre in relazione alla luce, come il basso in rapporto all’alto” (cfr. p. 90). Nel passaggio dal mondo tenebroso della sensibilità al mondo luminoso dello spirito consiste la prima ascensione del servo che si approssima alla Divina Presenza, di cui è figura l’Ascensione del Profeta (mi’rāj). Da quell’altezza, da cui si domina il mondo superiore, si guadagna la certezza che dall’invisibile provengono le cause del mondo sensibile, il quale è come un’ombra del regno luminoso, e la cui conoscenza autentica non può che avvenire a partire dalla visione intellettuale, perché solo conoscendo le cause si possono conoscere gli effetti.
Ciò che permette dunque di accedere all’autentica conoscenza è la profezia, che può a buon titolo essere definita “lampada illuminante”, così come sono “lampade” i profeti che la diffondono e i santi che la recepiscono nella sua pienezza. Allo stesso modo, ciò da cui trae origine la profezia può essere definito “fuoco”, in quanto alimentante la “lampada”.
Lo Spirito (Er-Rûh), l’angelo della profezia, è tale fuoco. Le innumerevoli schiere angeliche, disposte gerarchicamente in ordine alla loro prossimità alla Luce somma, ossia Dio, sono coloro che presiedono alla diffusione della luce profetica, ognuno traendo la propria qualità luminosa dal grado superiore e diffondendola a quello inferiore. Tramite tale processione la luce profetica giunge fino al mondo fisico, cosicché “attraverso la luce umana inferiore si rende manifesto tutto l’ordinamento del mondo di quaggiù, esattamente come attraverso la luce angelica si rende manifesto l’ordinamento del Mondo Superno” (cfr. p. 101). Tuttavia solo la prima Luce può definirsi realmente tale, mentre le altre, prendendo a prestito la luminosità senza impoverirne la sorgente, possono essere definite “luce” solo metaforicamente. E’ possibile pertanto dedurre che la tenebra autentica è solo ciò che non può essere illuminato, ossia la non esistenza, mentre ciò che è esistente in senso autentico è solo ciò che possiede la luce in sé e non la prende in prestito da altro: “Realmente esistente è Dio Altissimo, come realmente Luce è Dio Altissimo” (p. 96).
Ogni cosa, sottolinea il maestro, se viene considerata al di fuori dell’esistenza che riceve da Dio, è non esistente, pertanto tenebra; allo stesso modo “se la si considera in rapporto a quel Primo Vero da cui deriva la sua esistenza, la si vede bensì esistente, ma non in sé, quanto in rapporto a Colui che l’ha fatta esistere. Perciò nulla ha esistenza tranne il Volto di Dio. Ogni cosa ha due aspetti: l’uno che guarda a sé, e l’altro che guarda al suo Signore. In relazione a sé è non esistenza, ma in relazione al Volto di Dio è esistente. Dunque non vi è in esistenza se non Iddio e il suo Volto e, continuamente e per sempre, tutte le cose periscono salvo il suo Volto” (cfr. pp. 96-97).
E’ questa la “verità delle verità”, la dottrina somma dell’“unicità dell’esistenza” (wahdat al-wujūd), che un secolo dopo troverà il suo compimento nella meditazione del “Più Grande dei Maestri” (Shaykh al-Akbar), Ibn ‘Arabî. E’ di estremo interesse notare come Al-Ghazālī metta in relazione il cosiddetto monismo esistenziale (wujūdī) con il cosiddetto monismo testimoniale (shuhūdī) di Al-Hallāj, attribuendo il primo a una esperienza di “gnosi sapienzale ”, e il secondo a uno stato in cui coloro che lo sperimentarono “persero del tutto la nozione di pluralità e si immersero nella individualità pura (…), e nessun ricordo rimase di sé, ma solo di Dio Altissimo” (cfr. p. 98). Si tratta di uno snodo decisivo per comprendere i rapporti tra le due dottrine, spesso contrapposte come due tesi alternative, ma che il maestro illustra come due gradi della medesima esperienza mistica, la prima vissuta nella pienezza contemplativa, come habitus spirituale consapevole e acquisito, la seconda come esperienza transeunte, “ebbrezza” che è opportuno celare, la quale è simile all’“unificazione” (ittihād) ma non è ancora autentica “estinzione” (fanā’); stato sublime in cui paradossalmente la creatura, dimentica di sé e della propria dimenticanza, “gusta”, anticipandola, quell’unità con il creatore che è tale solo quando la creatura cessa di esistere in quanto creatura, sussistendo unicamente l’Unico. Quando si giunge all’unità, avvisa il maestro, non è più possibile nessuna ulteriore salita, essendo abolito il molteplice, ed essendo l’ascesa un sommarsi di gradi che pertanto prevede la distinzione: se si affermasse un cambiamento di stato ulteriore, esso non potrebbe che essere un distacco dall’unità e una caduta verso il basso, “poiché in relazione al più alto, anche se non vi è ulteriore altitudine, vi è bassezza” (cfr. p. 102). Nel grido abissale del Cristo dell’Islam – “Io sono il Vero!” – echeggia la drammatica nostalgia, capace di sfidare l’empietà, di colui che si è spinto oltre l’incomunicabile.
Così, di fronte al mistero dell’Unico, risiedono due possibilità di visione: quella di colui che vede le cose attraverso Dio, a cui compete il “grado dei veridici”, e quella di colui che mediante le cose vede Dio, a cui compete il grado dei “ben fondati nella scienza” (cfr. p. 105). In entrambi i casi, non si tratta di modalità di conoscenza razionale, ma di stati mistici, in quanto “la via per arrivare razionalmente a Dio si occulta, poiché questa via consiste nella conoscenza delle cose mediante i loro contrari, mentre Dio non ha contrari e non vi è contraddizione apparente negli stati in cui Egli si manifesta” (cfr. p. 106). Oltre a queste due possibilità risiede soltanto l’indifferenza di coloro che sono velati alla verità.
Il mondo sensibile, pertanto, è il punto di partenza per ascendere al mondo superno e per approssimarsi a Dio: i due mondi, è ormai evidente, risultano saldamente interconnessi perché altrimenti non sarebbe possibile nessun passaggio dal primo al secondo. Questa possibilità è attualizzata dalla comprensione che qualsiasi realtà materiale è immagine di una realtà celeste. Tale dottrina è il pilastro della scienza dei simboli. In base a questa, le schiere angeliche, in quanto luminarie del mondo superno, sono simbolizzate dalle luminarie celesti sensibili, ovvero il Sole, la Luna e le stelle. Il passaggio dalla percezione sensibile al grado della comprensione simbolica è rappresentato nel Corano dal noto episodio della scoperta, da parte di Abramo, del monoteismo attraverso l’osservazione dei corpi celesti (Cor., VI, 75-79). Si tratta, in tale movimento, di un atto di trascendimento della relazione formale in direzione della nuda verità essenziale. Applicando questo metodo, nella piena comprensione dell’equilibrio e della gerarchia sussistenti tra i mondi, si schiude la scienza dei simboli, che ha il proprio compendio nella figura umana, capolavoro e immagine della Misericordia di Dio: “Iddio beneficò Adamo e gli diede una forma microcosmica, cosicché l’uomo è come se fosse tutte le cose del mondo, ovvero una copia in miniatura del mondo” (cfr. p. 114).
Dalla comprensione dell’armonia e dell’equilibrio sussistente tra i mondi, tuttavia, si deduce che corretta scienza dei simboli è quella che non elimina un polo della relazione a favore dell’altro: se si eliminasse il senso letterale a favore della interpretazione spirituale, si incorrerebbe nell’errore dei Bātiniti, ovvero coloro che dichiarano vero solo il senso nascosto del testo sacro; al contrario, eliminando il senso spirituale, si precipiterebbe nelle secche del puro letteralismo.
Nella comprensione del perfetto equilibrio dei rapporti gerarchici tra i mondi risiede il pieno intendimento degli atti di culto e delle prescrizioni religiose. Lo stadio in cui le forme della realtà sensibile divengono trasparenti alla luce delle essenze intellettuali è il grado dell’“ampolla di cristallo”. Scrive infatti il maestro: “L’immaginazione, dalla cui argilla sono tratte le immagini, è dura e vela segreti, frapponendosi tra te e il mondo delle luci. Quando si fa limpida tanto da divenire un’ampolla di cristallo non frappone più alcun ostacolo al passaggio delle luci, ma anzi diviene essa stessa conduttrice di luci. Ancor più: essa diviene ciò che conserva accese le luci senza che possano essere spente da colpi di vento” (cfr. p. 117).
La capacità di cui sopra, una volta desta, si esercita efficacemente tanto sulle forme del mondo sensibile, quanto sulle immagini mediante cui si esprime il dono profetico, pervengano esse in sogno o in visione. Mentre il sogno è un’esperienza profetica potenzialmente condivisa da tutti gli uomini, il profeta propriamente detto, ossia colui che incarna la funzione profetica, è in grado di vedere da desto ciò che gli uomini vedono nel sogno. Accade sovente, anzi, che egli prima percepisca l’essenza mediante la vista interiore, e, successivamente, questa venga trasmessa alla facoltà immaginativa che le conferisce una forma visibile.
Pertanto, il maestro ricorda opportunamente che le facoltà, o spiriti luminosi, che concorrono all’esercizio della scienza dell’interpretazione delle immagini sono, sinteticamente, tutti gradi di conoscenza dei viventi. Il primo grado corrisponde allo spirito sensitivo, che riceve direttamente il dato dalla sensibilità, comune ad animali e lattanti. Il secondo è lo spirito immaginativo, che riceve i dati dalla sensibilità e li raccoglie per trasmetterli all’intelletto. La facoltà della memoria risiede in questo spirito, che permette di richiamare quanto non è più presente alla percezione sensibile. Esso è comune agli uomini senzienti e ad alcune specie animali. Il terzo grado corrisponde allo spirito intellettuale, che percepisce le essenze universali e necessarie che si trovano oltre il mondo materiale. Esso è proprio, come il grado successivo, degli uomini senzienti. Il quarto grado corrisponde alla facoltà razionale, che combina e accoppia le essenza intelligibili e ne deduce le conoscenze di ordine spirituale. Il quinto grado è lo spirito della santità profetica, che appartiene solo ai profeti e ad alcuni santi. Esso è in grado di spingersi laddove nessun’altra facoltà può giungere, tanto che alcuni dati provenienti dallo spirito profetico non sono concepibili, nella loro altezza, né dall’intelletto, né tanto meno dalla ragione.
Tutte queste facoltà sono definibili luci, perché rendono manifeste qualsiasi cosa sia immaginabile. Al-Ghazālī incoraggia il proprio discepolo a perseguire lo spirito profetico, di cui si fa esperienza mediante il gusto, ossia mediante diretta esperienza, o perlomeno a divenire uno di coloro che ne hanno scienza. In caso entrambe le possibilità gli fossero precluse, lo ammonisce tuttavia di preservare la fede, stabilendo così una chiara gerarchia dei gradi della conoscenza: “La scienza, infatti, sta al di sopra della fede, e il gusto al di sopra della scienza. Il gusto è un’intuizione spirituale; la scienza una analogia intellettuale, mentre la fede è pura accettazione per obbedienza a un’autorità” (cfr. p. 121).
Il “Versetto della Luce”, nell’interpretazione di Al-Ghazālī, allude esattamente alla gerarchia degli spiriti luminosi.
La sensibilità è simboleggiata dalla nicchia, con cui condivide la molteplicità delle aperture verso l’esterno. L’immaginazione, della stessa materia del mondo sensibile, ma capace di elevarsi, se purificata, alla trasparenza del cristallo, al punto da divenire custode e ordinatrice dei dati intellettuali e di irradiarne la luce, è assimilabile all’ampolla.
Lo spirito intellettivo, “per mezzo del quale si percepiscono i nobili concetti riguardanti Dio” (cfr. p. 123), è assimilabile alla lampada. Lo spirito razionale, che principia da un’unica radice ma diparte in distinte direzioni, tante quante l’infinita molteplicità dei dati intellettivi che elabora, e che produce frutti che danno semi copiosi, quali sono i frutti della meditazione spirituale, è simboleggiato dal nobile albero di olivo, mediante il cui frutto si produce l’olio che alimenta le lampade. Esso è benedetto per l’infinità dei frutti che reca, commisurata all’inesauribilità degli oggetti intelligibili, e, conformemente alla natura di tali oggetti, né lontani, né vicini, esso è definito né orientale né occidentale.
Lo spirito razionale custodisce in sé due potenzialità: una che, per realizzarsi e dare frutto, abbisogna di essere istruita dall’esterno, e l’altra, invece, che trae da sé, nella sua purezza, il proprio monito. Tale è l’elevatezza della santità profetica realizzata da alcuni santi, che quasi non abbisogna del soccorso dei profeti, così come alcuni profeti non abbisognano del soccorso degli angeli. Si tratta dell’olio che “arde quasi come non lo toccasse fuoco”. Questo ordine, rigorosamente gerarchico, può essere ben definito “fuoco su fuoco”.
A tale versetto si contrappone, in maniera quasi speculare, il quarantesimo versetto della Sura detta “La Luce”: “Le loro azioni sono come tenebre in un mare profondo, coperto di onde e sopra altre onde, e sopra delle nubi, tenebre su tenebre. Quando costui stende la mano quasi non la vede. Chi non ha luce da Dio non avrà luce”.
L’oceano, ammonisce Al-Ghazālī, è l’oscuro mondo materiale. La prima onda sono le passioni quali la concupiscenza e il desiderio, che inducono alla ricerca del piacere e alla sottomissione alle lusinghe del mondo. Esse rendono ciechi e sordi, e pertanto sono definibili tenebre. La seconda onda sono le disposizioni disordinate dell’animo, quali ad esempio l’ira, che ottundono l’intelletto con una violenza tale da poter sopraffare anche il desiderio e la brama. Le nubi corrispondono all’errore e alla conoscenza perversa, che occulta la verità. In tali “tenebre su tenebre” anche ciò che è più prossimo – come la mano dell’ottenebrato – risulta pressoché invisibile, poiché solo Dio e Luce, e dove non vi è la Sua luce, vi è soltanto oscurità.
L’epistola del maestro termina con un breve commento al detto del profeta “Dio è celato da settantamila veli di luce e di tenebra, e se li rimuovesse, il suo volto sublime brucerebbe tutto ciò che lo raggiungesse con lo sguardo”.
Al-Ghazālī sottolinea innanzitutto che il numero “settantamila” suggerisce non una cifra precisa, ma una quantità innumerevole. Egli sostiene inoltre che esistono tre tipi di uomini a cui Iddio rimane celato: “quelli che sono velati da pura tenebra, quelli che sono velati da pure luce, quelli che sono velati da luce mista a tenebra” (cfr. p. 127).
Coloro che sono velati da pure tenebra sono gli atei che non credono né in Dio né nell’Ultimo Giorno. Appartengono a questa categoria i filosofi materialisti e coloro che hanno deciso di dedicarsi esclusivamente a loro stessi nella soddisfazione delle proprie passioni bestiali.
Coloro che sono velati da luce mista a tenebra sono di tre specie, a seconda dell’origine delle tenebre che li ottundono: esse possono risiedere nei sensi, nell’immaginazione e nei ragionamenti scorretti. Quelli che sono ottenebrati nei sensi sono essenzialmente gli esponenti di varie espressioni dell’idolatria, intesa come culto naturalistico rivolto ad oggetti sensibili. Gli ottenebrati nell’immaginazione, invece, sono coloro che hanno percepito che esiste qualcosa al di là dei sensi, ma non sono riusciti a sollevarsi oltre l’immagine sensibile di cui hanno esperienza. E’ il caso delle varie forme di antropomorfismo religioso e di coloro che raffigurano Dio con attributi materiali. Vi sono infine gli ottenebrati nei ragionamenti, che sono coloro che, nonostante affermino l’unicità divina, la declinano erroneamente, attribuendo a Dio qualità inconciliabili con la sua assoluta trascendenza.
La terza categoria è quella di coloro i cui veli sono di luce. Di essi Al-Ghazālī nomina, a titolo di esempio, tre categorie. La prima è quella di chi ha compreso che gli attributi divini non sono da concepire in senso antropomorfico, e ha pertanto descritto Dio non in sé stesso ma in rapporto alle creature. Vi sono inoltre quelli che si sono elevati a considerare i cieli e le intelligenze angeliche, giungendo ad affermare che Dio è il primo motore delle volte celesti. La terza categoria è quella di coloro che hanno riconosciuto che il movimento dei cieli non è un atto meccanico, ma un atto di obbedienza delle sfere celesti che obbediscono all’Ordine del loro Signore.
Di fronte ai velati, si parano invece quelli che, scostati i veli divini, sono stati arsi dallo splendore del Volto di Dio. Per essi, Dio “assomiglia a fuoco puro in rapporto alla brace”. Per alcuni di questi uomini meravigliosi, “ciò che la vista percepisce va distrutto e cancellato, e scompare”. Altri, eletti tra gli eletti, “loro stessi sono stati distrutti e cancellati, per cui non hanno neppure più avuto la possibilità di contemplare sé stessi”, rimanendo così soltanto l’Unico (cfr. p. 133).
Per alcuni la via per giungere alla perfezione è stata lunga. Per altri “Dio si è manifestato di colpo e per ciò lo splendore sublime del suo Volto ha arso tutto ciò che la facoltà sensibile della vista così come la facoltà intellettiva possono percepire” (cfr. p. 144).
“Ogni cosa perisce tranne il suo Volto” (Cor., XXVIII, 88).
