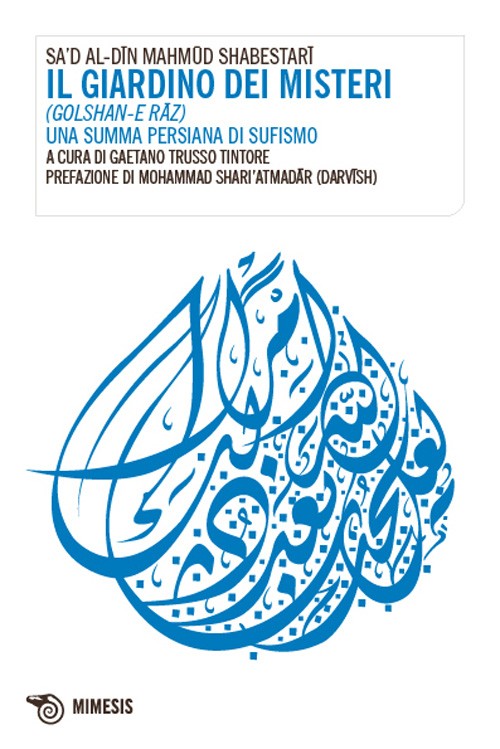
Al-Buhārī, in un noto hadīth, riporta l’episodio di un misterioso straniero che, giunto al cospetto del Profeta, lo interroga sulla fede, sull’Islam, sulle buone azioni e sull’Ora. Avute le risposte, l’uomo si allontana; Muhammad ingiunge di cercarlo, ma di egli non si trova più alcuna traccia. Il Profeta svela allora che ad interrogarlo è stato Gabriele, “mandato da Dio per insegnare agli uomini la loro religione” [1]. L’interrogazione di Gabriele, mediante cui Muhammad espone un’autentica sintesi dell’Islam – non perché Gabriele necessiti di essere istruito, e neppure perché il Profeta debba fornire una prova della sua conoscenza, ma affinché gli uomini, ricordando l’evento, ne siano perpetuamente edificati – diviene nella gnosi islamica uno degli archetipi della trasmissione della conoscenza sacra.
Il Golshan-e rāz di Shabestarī [2], il sufi persiano che Pio Filappani-Ronconi ebbe occasione di definire come un “ismailita «coperto»” [3], partecipa di questo orizzonte. Il testo, infatti, è composto dal maestro come risposta ai quesiti che Amīr Sayyed Husayni Herawī – venerato shaykh del Khorāsān in visita a Tabrīz in qualità di messo – rivolge in uno scritto a quelli che chiama “uomini di Conoscenza” e “Maestri dei misteri” (cfr. p. 42), e che il nostro autore definisce propriamente “maestri di simbologia spirituale” (cfr. p. 41). Shabestarī, su invito di “un uomo di esperienza”, figura che i commentatori identificano nel suo maestro Amīn Al-Dīn, risponde con il mathnawī affinché, come auspicato da quest’ultimo, se ne avvantaggino “tutte le genti del mondo” (cfr. p. 44). Il dialogo tra i sapienti, dunque, come nell’episodio dell’interrogazione dell’angelo, è il pretesto affinché la scienza sacra sia elargita come misericordia, e, quanto il suo prototipo, l’interrogazione dello straniero racchiude sinteticamente l’intero universo spirituale a cui si rivolge. Di qui la ricchezza del Golshan-e rāz, che la traduzione italiana, particolarmente apprezzabile nell’intento di preservare la letteralità del testo anche a scapito dell’eleganza formale, presenta non a torto come un autentico compendio di metafisica del Sufismo; di fatto, tuttavia, più che la componente metafisica, che può essere rinvenuta a vario grado anche in testi a carattere non iniziatico, è l’elemento esoterico quello che sembra propriamente caratterizzare l’opera: ciò che infatti maggiormente colpisce, al di là della sublime capacità dell’autore di sciogliere con rigore e semplicità i nodi delle questioni più criptiche poste dall’interlocutore, è l’evidenza con cui vengono chiamate in causa alcune tra le dottrine più delicate e controverse dell’intera gnosi islamica.
Conformemente alla natura sintetica del mathnawī si è scelto di fornirne una lettura meditata dei passaggi salienti, ordinati al fine di ricomporne un quadro organico ed esaustivo, evitando i rinvii bibliografici che, per quanto opportuni, vista la mole dei temi trattati, sarebbero risultati appesantire eccessivamente quella che vuole essere una semplice presentazione. Per lo stesso motivo abbiamo evitato di commentare gli ultimi quesiti, inerenti alla spiegazione di alcuni plessi simbolici simboli caratteristici della poesia persiana. Rinviamo quindi per tali approfondimenti alla traduzione italiana e alla bibliografia critica in essa citata.
[1] Cfr. Buhārī, Detti e fatti del profeta dell’Islām, a cura di V. Vacca, S. Noja e M. Vallaro, Torino, 1982-2009, pp. 92-93.
[2] Scrive Henry Corbin: “Mahmûd Shabestarī, uno dei grandi shaykh sufi dell’Azerbaigian, è una figura di primo piano della spiritualità persiana. Nato nel 687/1288 a Shabestar, vicino a Tabrîz, visse principalmente in questa città, capitale della Azerbaigian, in un’epoca in cui, sotto i sovrani mongoli, Tabrîz era luogo d’incontro di numerosi dotti e personalità eminenti. Grande viaggiatore, egli fu in contatto o in corrispondenza con numerosi spirituali. E a Tabrîz egli morì, ancora nel fiore della giovinezza, all’età di trentatré anni, nel 720/1320-1321.
Egli ha lasciato vari trattati di sufismo in prosa e in versi, ma è noto soprattutto per il suo mathnawî intitolato «Il Roseto del Mistero» (Golshan-e Rāz). In esso egli risponde a diciassette domande che gli erano state poste da Mîr Hosaynî Sâdât Harawî sulla teologia mistica (‘irfān) e la via spirituale (solûk). Questo poema, che contiene appena mille distici, menziona tutti i grandi temi della metafisica del sufismo (la ricerca mistica e il suo oggetto, l’Uomo Perfetto, i simboli dell’ora meridiana, del Sinai, di Sîmorgh e della montagna di Qâf, l’A’râf e l’intermundio, il Corano cosmico, i sette Imam dei Nomi divini, il viaggio dentro sé stessi, ecc.). Il poema, letto, riletto e meditato di generazione in generazione, è stato una sorta di vademecum dei sufi persiani” (H. Corbin, Storia della filosofia islamica, trad. it di V. Calasso e R. Donadoni, Milano, 1973-2007, p. 312).
Per un esteso commento al mathnawî di Shabestarī, cfr. H. Corbin, Trilogie Ismaélienne, vol. 3, Symboles choises de la «Roseraie du Mystére», Parigi, 1961.
[3] Cfr. P. Filippani-Ronconi, Un altro Islam. Mistica, metafisica e cosmologia, a cura di A. Iacovella, Roma, 2013, p. 37. Ricordiamo che nel testo di una conferenza inedita presentata nella medesima antologia, l’eminente studioso accosta Shabestarī ad Ibn ‘Arabi e Rūmi, “nei quali l’altezza metafisica, confortata da reale esperienza del Divino, si unisce alla più bella poesia che l’Islam abbia prodotto”. Cfr. ibid., p. 22.
Il Giardino dei Misteri
Il Golshan-e rāz muove a partire da una serie di questioni legate all’essenza del pensiero e al soggetto del pensare. Il pensiero autentico viene definito come il passaggio dall’errore alla verità. L’errore consiste nell’attribuire all’esperienza comune un grado di realtà e di consistenza che essa non possiede: “Tu dormi e quello che vedi è una specie di sogno: / Tutto quello che hai visto in esso è soltanto un simbolo. / Quando all’alba dell’ultimo giorno ti sarai svegliato, / Saprai che tutto questo è solo congettura e pensiero” (p. 56).
L’atto cognitivo ordinario parte dalla Reminescenza (Tadhakkur), ossia dall’idea che ogni oggetto della conoscenza sensibile è assimilabile solo in quanto pre-compreso dalla facoltà noetica, si sviluppa nell’Interpretazione (‘Ibrāt), che è il momento propriamente riflessivo del dato assimilato, e infine è completato dal processo logico, esemplificato nella forma del sillogismo, grazie a cui gli elementi intuiti e riflessi possono essere ordinati, indagati e chiariti. Questa dimensione naturale del pensiero, tuttavia, produce un sapere soltanto apparente; è necessario liberarsene – “Le stelle con la luna e il grande sole, / Sono i sensi, l’immaginazione e la ragione chiara. / Distogli il viso da queste cose, pellegrino, / Dì sempre: «Io non amo ciò che sparisce»” (p. 58) – per giungere all’autentica conoscenza, che è essenzialmente contemplazione dell’Unità nel molteplice: “Un cuore che grazie alla Gnosi (Ma’rifa), vede luce e purità, / In tutto ciò che vede, vede Dio per prima cosa” (p. 47).
Il pensiero ordinario, infatti, rimane costitutivamente invischiato nelle apparenze della contingenza, senza poter mai giungere all’evidenza della necessità: la Verità (Al-Haqq), che non possiede né simile né contrario, poichè “la dualità nell’Unità è del tutto assurda” (cfr. p. 82), non è permeabile dal processo logico, il quale si nutre e sostiene mediante l’opposizione: “L’esistenza del creato e la pluralità sono apparenti, / Non tutto ciò che appare è un vero essere” (p. 82). La via che parte dai fenomeni per giungere al loro principio è fallace, in quanto “il possibile non ha modello nel necessario” (cfr. p. 48); è doveroso pertanto abbandonare la sensibilità ordinaria, e con essa le facoltà cognitive ad essa adeguate, per guadagnare l’occhio spirituale capace di percepire la tenebra: “Il Lume della ragione, davanti all’essenza delle Luci, / E’ come l’occhio della testa davanti alla fonte solare. /Quando ciò che illumina si approssima alla vista, / La vista, a causa della sua percezione, si oscura. / L’oscurità, se tu sapessi, è Luce dell’essenza: Dentro la tenebra si trova l’Acqua di Vita” (pp. 51-52). La Luce essenziale, teofania dell’Unità, se è tenebra della coscienza ordinaria, è tuttavia percepibile indirettamente, come in uno specchio, nel molteplice che la manifesta, in un’esperienza di visione spirituale che sola può coglierla: “Il non-essere è lo specchio dell’Essere assoluto, / Ove si manifesta il riflesso dell’irradiare della Verità. / Poiché il nulla si pose in opposizione all’essere, / In esso si formò, come risultato, un’immagine riflessa” (p. 53).
E’ necessario ricordare che il soggetto dell’intero processo è Dio, l’unica Realtà, in quanto “Egli è colui che vede, l’occhio e la cosa vista” (cfr. p. 53); consapevolezza estatica che solo lo gnostico acquisisce in uno stato contemplativo in cui lo spazio e il tempo, conflagrando, rivelano contemporaneamente la loro indistinguibile omogeneità – “Da ogni punto di questo concatenato cerchio, / Trovano forma a migliaia le figure, / Un circolo si forma ad ogni punto: / Giro e centro lui stesso di una circonferenza” (p. 54) – e la loro natura puntiforme – “Non esiste il passato, né il sopravvenire di mesi e anni, / Cosa mai esiste se non questo unico punto nel presente?” (p. 82).
In questa esperienza ai limiti delle possibilità del linguaggio, in cui “il Cammino, il Viaggiatore, l’Opera, diventano una cosa sola” (cfr. p. 82), ogni particella della realtà testimonia l’Infinito – “All’interno di un singolo atomo cento soli fiammeggianti” (cfr. p. 53) – e l’Assoluto – “Sotto il velo d’ogni atomo è celato, / Il vivificante splendore dell’Amato” (p. 55); visione la quale, nella sua sfolgorante bellezza che annienta, ha come unico modello adeguato la teofania sinaitica: “Come Mosè di ‘Imran, va lungo questa via, / Fin quando non udrai: «Io sono Dio». / Fino a che avrai davanti il monte dell’esistere, / La risposta al «mostrati» sarà: «Non mi vedrai». / (…) / Se sulla montagna della vita giunge l’Epifania divina, / Quella vita, per la sua pochezza, si fa polvere sulla strada” (cfr. p. 58); “Entra nella valle della Pace, dove, improvvisamente, / Un rovo ti dirà: «In verità, io sono Dio». / Se è concesso a un roveto dire «Io sono la Verità» (anā al-Haqq) / Perché non sarà concesso a un uomo dalla sorte felice?” (p. 81).
E’ a questo grado, dunque, che si situa l’indicibile grido di al-Hallāj, “rivelazione dei segreti supremi”; voce che proviene dagli abissi della Verità stessa, poiché “se non la Verità, chi può osare dire «Io sono la Verità»? (cfr. p. 80). Shabestāri afferma senza riserve la difesa della professione di identità dal Cardatore: “Affermare l’essere alla prima persona, è conforme alla Verità, / Perchè «Lui» (Hū) è nascosto e ciò che è nascosto, è congettura e opinione. / L’inattingibile Maestà della Verità non ammette alcuna dualità, / In quella Maestà non esiste io, né noi, né tu” (p. 81).
Il mondo percepibile dai sensi fisici, se da una parte è solo uno dei mondi che esprimono l’infinita possibilità divina – “Medita sugli «Occidenti» e sugli «Orienti», dato che il mondo, / Di ciascuno di essi, ne possiede uno solo” (p. 56) –, dall’altra può divenire, mediante la coscienza simbolica, possibilità di accesso alle realtà spirituali. Esso, di fatto, al di fuori di tale considerazione, è pura non esistenza: “Gli accidenti sono effimeri, la sostanza è composta da essi: / Quando, dimmi, o dove, esisterà un corpo siffatto? / I corpi esistono grazie a lunghezza, profondità e larghezza, / In che modo s’è potuta manifestare un’esistenza da un’irrealtà?” (p. 82).
Per chi ha fatto esperienza dell’Unità che annienta, il grado ulteriore è quello dell’Unità che unifica: “L’essere di ciascuna cosa è unico: / Per questo si fa testimone dell’Unicità di Dio” (p. 101). La conoscenza che ne scaturisce è un’esperienza totalizzante di sintesi della realtà manifestata, la quale ha la propria figura nell’archetipo celeste del Libro: “Per chi giunge nell’anima alla Teofania, / L’universo è il libro di Dio Altissimo, / Le vocali sono come gli accidenti, e la sostanza come le consonanti. / I gradi sono come le pause e i versetti” (p. 59). Luogo privilegiato di questa meditazione sono i cieli e lo zodiaco – “Medita sulla creazione dei cieli, / Sino a diventare uno che loda Dio nei suoi Segni” (p. 61) –, poiché è proprio nella contemplazione della volta celeste che, all’occhio spirituale, è visibile nel modo più evidente l’unità macrocosmica in cui si estrinseca l’Onnipotenza divina. Sotto i cieli, inoltre, si manifesta l’ordine universale per cui gli elementi, nella loro reciproca avversità, si dispongono armoniosamente – “Quattro, per posizione contrari, e per natura, / Li ha mai visti qualcuno uniti insieme? / Ostile ognuno, per essenza ed aspetto, / S’è fatto per ordine della Necessità una cosa sola (p. 64) –, mentre dalla loro sapiente commistione sorgono i Tre Regni, ognuno tendente a realizzare la propria natura – “Per ordine e per la giusta volontà del Giudice, tutti sorretti dalla vita e sottomessi: / I minerali, per la Sua ira, caduti in terra, / Le piante, levatesi in alto, per la Sua Grazia, / Il desiderio animale, retto e sincero, / Preserva il genere, la specie, l’individuo (p. 64) –; l’intero universo, infine, manifesta inequivocabilmente il proprio «islam»: “Tutti hanno riconosciuto la signoria del Giudice / E giorno e notte, cercano Lui” (p. 65). Al di fuori del suo valore simbolico, tuttavia, il cosmo non è definibile né esistente, né inesistente: più di un nulla, in quanto la percezione sensoriale ne certifica un qualche grado di esistenza, ma meno dell’essere, in quanto comparato a ciò che esiste realmente appare illusorio e inconsistente. Esso è qualificabile esclusivamente per via negativa: “Come la forma non preesiste alla materia, / Così la materia senza di essa non è altro che nulla. / Le cose del mondo sorgono da queste due negatività, / Di loro, a parte la negatività, non è evidente altra cosa / Osserva né più né meno la tua realtà: / Non è, in sé, né esistente né inesistente / Privata dell’essere, altro essa non è che mancanza. / L’Essere, nella sua perfezione, pervade ogni cosa” (p. 84). Allo stesso modo, ogni parvenza di permanenza e continuità della realtà manifestata si infrange quando si considera come la creazione sia un fenomeno perpetuamente rinnovato dalla misericordia divina, che costantemente manifesta la propria signoria sul mondo preservandolo dall’annientamento: “Il mondo è il tutto, che ad ogni batter d’occhi, / S’annichilisce, non permane due istanti: / Una volta ancora un mondo fa la sua comparsa, / Un cielo ed una terra, in ogni istante” (p. 96). Ogni cosa proviene dall’Unità, in essa permane e in essa ritorna; ogni parvenza di molteplicità è solo un epifenomeno la cui realtà è unica: “L’Unicità è simile a un mare, ma un mare pieno di sangue, / Ove forsennate onde si levano a migliaia” (p. 85). Per questo “l’unione è il luogo della soppressione delle immagini: / Quando davanti a te dilegua l’alterità, si realizza l’Unione” (p. 86).
La chiave d’accesso alla comprensione dell’universo risiede intera nella conoscenza che l’uomo ha di sé: “Tutto ciò che esiste nel mondo, nell’alto e nel basso, / Mostra il suo modello nel corpo e nell’anima tua. / Il mondo è, come te, un individuo determinato, / Tu sei una sorta di anima per esso, un corpo, esso, per te” (p. 97). Esorta Shabestarī: “Avanti, signore, conosci bene te stesso” (p. 67).
Condizione imprescindibile di questo cammino è il riconoscere il proprio nulla individuale, coscienza che apre alla comprensione della Predestinazione (qadr) quale condizione di totale sudditanza ontologica nei confronti dell’Unico: “Le nostre azioni hanno con noi una connessione illusoria, / In verità, proprio la connessione non è che un gioco o una farsa: / Non esistevi tu, quando vennero create le tue azioni, / Tu fosti prescelto per un certo compito” (p. 88). Se l’uomo è non essere, qualsiasi apparenza positiva della sua condizione, quale l’affermarsi mediante atti liberi, non può che manifestare in realtà la sua dipendenza nei confronti del Principio: “Se il tuo essere è del tutto simile ad un non-essere, / Non ti domandi da dove ti viene la scelta?” (p. 87). E’ necessario liberarsi dall’idea della propria sovranità individuale per riconoscersi determinati dalla totalità trascendente, e così liberarsi, nell’abbandono, dalla prigione dell’ego: “Troverai liberazione da te stesso nella Totalità, / Grazie alla Verità, poveruomo, ti farai ricco, / Caro a tuo padre, avanti, abbandonati al destino! / Nei decreti divini trova la tua soddisfazione” (p. 90).
La conoscenza di sé che apre alla gnosi non si identifica con quella che il soggetto empirico ha della propria egoità, la quale si situa sul piano della mera apparenza – “Tu sei solo potenza d’essere e il niente è sempre in quiete: / In quale tempo la virtualità del possibile giungerà al Necessario?” (p. 83) –, bensì dell’archetipo umano, fatto a immagine e somiglianza di Dio – “Sei proprio tu la replica dell’immagine divina / In te stesso cerca tutto ciò che vuoi (p. 80) –, di cui l’individuo è riflesso come ogni altra realtà manifestata nei confronti della propria matrice principiale.
L’egoità, al contrario, è frutto di un processo di progressivo allontanamento dalla propria origine e di indurimento nelle proprie tendenze individuali, da cui solo la grazia divina può sottrarre l’uomo. Il cammino spirituale si configura pertanto come un ritorno all’origine: “Come il percorso del seme evolve nelle linee dell’albero, / Dal punto evolve la linea, e, dalla linea, un cerchio. / Quando il pellegrino ha completato il percorso lungo il cerchio, / Allora il punto estremo giunge all’origine (p. 74).
L’unica possibilità di accesso allo stato originario è un percorso di purificazione che spiani la strada all’illuminazione interiore: “Che cos’è mai «la purità più grande»? Chiarificar sé stessi” (p. 100). Tale cammino è la seconda morte, quella che Dio sceglie per l’uomo che vi è predestinato e a cui tale uomo non può che conformarsi irresistibilmente adeguandosi al volere divino: “All’essere umano appartengono tre diversi generi di morte: / La prima, ogni istante, secondo la sua natura, / La seconda di queste morti poi, è quella per scelta, / Il terzo suo morie è quello necessario” (p. 97). Ciò che è affidato allo sforzo dell’uomo è esclusivamente il rendersi un recipiente adeguato alla grazia divina: l’autentica conoscenza si acquisisce pertanto liberandosi dalle scorie che sensibilità, emotività e concupiscenza hanno sedimentato e calcificato intorbidendo la purezza dell’occhio interiore, creando così una barriera opaca che impedisce lo stato edenico naturalmente contemplativo: “Mai la conoscenza si fa compagna dell’avidità: / Se desideri l’angelo, caccia il cane lontano da te. / Si basano su virtù angeliche, le scienze religiose, / Non si trovano in un cuore che ha natura di cane: / (…) / L’angelo, di necessità, non entra mai / In una casa quando c’è un’immagine” (p. 92). Condizione della realizzazione della conoscenza autentica è dunque la virtù che, se esteriormente si presenta come un complesso – “I fondamenti del buon carattere sono l’equità, / Poi la saggezza, l’onestà e il coraggio. / Chi è dotato di questa quattro virtù, / E’ un saggio capace di retto parlare e di retto fare, / Ha il cuore e l’anima aperti alla sapienza, / Non è uno sciocco e nemmeno un impostore” (p. 93) –, è essenzialmente una realtà semplice ed omogenea, in quanto frutto del ristabilirsi di un equilibrio originario che naturalmente si afferma con il progredire del processo di purificazione, autentica alchimia dell’anima: “Quando acqua e fango si purificano interamente, / Giunge da Dio per essi, lo Spirito in aggiunta. / Quando le porzioni degli Elementi trovano compenso / Il mondo dell’anima dentro di loro prende a illuminarsi” (p. 94).
Riguadagnare tale stato è dunque null’altro che ricordare la propria essenza originaria. Motore privilegiato dell’anamnesi è la bellezza: “Cosa c’è nell’incanto del viso delle persone attraenti? / Non è solo bellezza. Tu che diresti che sia? / La seduzione dei cuori proviene da Dio soltanto, perché nessuno ha parte delle cose divine: / La bramosia rapisce il cuore degli uomini, / Dove attraverso l’effimero talvolta Iddio si mostra” (p. 95). L’uomo, infatti, è colui che sin dalla pre-eternità ha riconosciuto il proprio Signore – A chi, Dio disse: «Non sono io il vostro Signore?» / Infine, in quell’ora, chi fu che disse «Si»? (p. 79) –; questo patto primordiale, che testimonia come sia iscritto nell’uomo il ricordo di Dio, lo vincola alla via spirituale e ne costituisce garanzia della possibilità di realizzazione: “Stanotte hai stretto un Patto di sottomissione, / Però, per ignoranza, l’hai dimenticato. / La Parola di Dio è discesa, / Per ricordarti quell’iniziale Patto. / Tu hai veduto la Verità all’Inizio, / Ancora la potrai vedere, qui di nuovo” (p. 79).
Purificati dalle macule dell’individualità, l’uomo diviene uno specchio terso capace di riflettere la verità nel proprio centro più intimo, il luogo assiale e pontificale in cui l’individuale e il sovra-individuale comunicano; luogo che la fisiologia mistica identifica con il cuore di luce, organo sottile di cui il corrispettivo organo fisico è solo il riflesso corporeo: “Finché non allontanerai gli impedimenti da te stesso, / Non ti giungerà la luce dentro la casa del cuore” (p. 78). Ritornare all’origine è pertanto ricongiungersi al proprio archetipo, in un gioco di rifrazioni in cui il padre è generato dal figlio, se è possibile affermare che l’uomo è “colui dal quale si generò l’Uomo Perfetto” (cfr. p. 70).
L’archetipo umano, l’ «Uomo Perfetto» (al-Insān al-kamil), è compendio dell’intero universo, per cui la realizzazione dell’autentica conoscenza di sé conduce necessariamente a una comprensione sintetica di tutta la realtà manifestata: “Ogni corpo che ti sta di fronte è dotato di un’anima, / Ed essa è collegata a te per mezzo di una corda. / Ecco perché sono tutti sottomessi al tuo comando: / L’anima di ciascuno di essi è nascosta dentro di te. / Sei la sostanza del mondo, per questo ne sei il centro: / Sappi che tu stesso sei l’Anima del mondo” (p. 65). Una volta che si sia compreso come l’universo e l’uomo simboleggino reciprocamente, l’uomo può, nella comprensione del proprio destino individuale, conoscere il destino finale dell’intero universo: “La formazione e la distruzione dei due mondi / E’ come la creazione e la resurrezione dei figli di Adamo” (p. 98). Il ricongiungimento dell’uomo al proprio archetipo è pertanto identico al ricongiungimento dell’universo alla propria matrice principiale; significato, quest’ultimo, dell’escatologia totale: “Quando però questo basso mondo sarà passato così, / Tutto sarà eternità, nell’Altro mondo. / (…) / Tutto quello che esiste, in potenza, in questa vita, / In quel mondo, una volta per sempre, arriva all’atto (p. 99).
Se, come recita un noto hadith qudsī, Dio era un tesoro nascosto che voleva essere conosciuto, l’uomo è necessariamente il fine dell’intero creato. Egli detiene nell’ordine manifestato quella stessa centralità che Dio possiede nell’ordine della totalità, e pertanto ne è il vicario in terra: “Tu hai conosciuto tutti i Nomi, / Perché sei l’immagine riflessa del Nominato” (p. 66); “Una volta che egli ha compiuto il percorso / La Realtà posa sulla sua testa la corona del Califfato” (p. 72). E’ questa centralità, che solo possiede tra tutte le creature, a rendere degno l’uomo dell’onore degli angeli e conferendogli la facoltà di istruirli, sebbene egli occupi rispetto a questi un rango inferiore di prossimità a Dio: in quanto totalizzante l’intera realtà manifestata, l’uomo detiene le chiavi della conoscenza integrale, seppure allo stato ordinario in maniera puramente virtuale.
Solo colui che si è fatto «Uomo Perfetto» può giungere a realizzare la conoscenza dell’Unicità. Tale sapere, tuttavia, non possiede nessuna relazione di continuità con le tappe del cammino iniziatico – “Chi è diventato partecipe dei segreti dell’Unicità, / Non lo è diventato durante le soste della Via” (p. 77), in quanto l’identità non conosce differenza: “Ormai nessuna distinzione si mantiene: / Il conoscitore e il Conosciuto sono una cosa sola” (p. 78).
Ecco che ritrovare il Sé – “Quando si fa indicazione dell’Essere Assoluto, / Esso viene espresso mediante la parola «Io». / La Verità che si determina grazie ad una distinzione, / Nella lingua tu l’hai chiamata «Io». / Io e te siamo modi dell’essenza dell’essere universale” (cfr. p. 67) – significa perdere sé stessi – “Alla parola «Io» non corrisponde una persona particolare, / Così da dire che esista per essa un’anima particolare” (p. 68); “Appena ne sarai uscito tu, egli entrerà; / A te, privo di te, mostrerà il suo viso radioso” (p. 77); “Finchè tu non perderai te stesso totalmente, / Come diverrà una preghiera la tua preghiera?” (p. 78) “L’unione con la Realtà è separazione dalle cose create, / Divenire estranei a sé stessi è una forma di confidenza con essa (p. 83) –, in quanto l’individualità realizzata è riassorbita, sebbene mantenuta – “Ritrova dopo l’annullamento di sé la permanenza in Dio, / Va, secondo un diverso cammino, dalla fine verso l’inizio” (pp. 72-73) –, nell’Unità indifferenziata.
E’ questo il senso dei due momenti che portano a compimento la realizzazione spirituale. Nel primo momento, ascendente, l’individualità è ricondotta alla sua sorgente, l’Unità, nel vanificarsi dell’errore distintivo. Nel secondo momento, discendente, l’Unità è percepita ammantare completamente il molteplice, in cui lo gnostico non vede altro che espressione dell’Unità: “Il cammino del Pellegrino non comporta più di due passi: / Il primo passo è superare l’essere alla terza persona, / Avvolgere il deserto dell’essere il secondo. / In questo stato contemplativo si unificano i singoli e la totalità, / Come l’uno fluisce nella sostanza della numerazione. / Tu sei quell’insieme fattosi vera e propria Unità, / Sei quell’unico fattosi vera pluralità” (pp. 68-69). Lo stato estatico a cui perviene lo gnostico che ha oltrepassato il dominio formale in vista della pura verità è simile a un’ebbrezza spirituale in cui non persiste nessuna forma di alterità: “Privi di religione e mente, senza misura né discernimento, / Caduti nella polvere, sbalorditi e ubriachi, / Che valore dare all’Eternità, al Paradiso e alle Huri, / In un’intimità in cui l’estraneo non trova posto?” (p. 100).
La realizzazione spirituale trasforma integralmente l’essere che la consegue; egli, nonostante continui a persistere nel mondo, partecipa integralmente e coscientemente della Realtà, che ha scoperto essere da sempre custodita nel suo centro interiore: “Quando lo gnostico si congiunge con la propria certezza, / Il frutto è giunto a maturazione e la guaina si spacca: / La sua esistenza non appartiene più al mondo, / Ne è uscita fuori e non vi tornerà mai più” (p. 73).
Le singole credenze religiose, per chi ha raggiunto tale stato contemplativo, sono oltrepassate in quanto esse, rivolgendosi a un individuo particolare, espressione di una particolare civiltà e di una particolare epoca, dileguano nell’universalità informale della trans-coscienza mistica, assieme alla consapevolezza dell’essenziale irrealtà del soggetto empirico: “Tutto il dettato della Legge proviene dal tuo ego, / Perché esso è vincolato alla tua anima e al tuo corpo. / Quando il tuo ego non è in questione, / Qual è la Ka’bah, quale la Sinagoga, quale il Convento?” (pag. 68). La scienza spirituale permette di oltrepassare la forma e di giungere alla verità sovra-formale in essa custodita: “Spezza la madreperla, estrai la perla regale, / getta la scorza e afferra la polpa squisita! / (…) / Non trova la polpa chi prima non spaccò la scorza” (p. 93). E tuttavia colui che si è ricongiunto con il proprio archetipo non rinuncia alle forme dello spirito, bensì esse sono preservate – sebbene trasfigurate – alla luce del grado universale acquisito: “Fa della Legge religiosa la propria condotta esteriore, / Fa della Via spirituale il proprio abito interno. / (…) / Egli si dota di costumi lodevoli, / E’ reputato per scienza, per rigore e per virtù. / Ogni cosa è con lui, ma egli è distante da tutto, celato sotto i tabernacoli del Velo” (p. 73). Questo perché soltanto la gnosi può riconoscere, nella sua pienezza, tanto la necessità provvidenziale delle forme religiose, quanto il loro senso interiore: “L’involucro è la Legge; il frutto è la Verità spirituale. / Tra questa e quella si trova la Via mistica” (p. 73). E d’altra parte, senza passare attraverso la forma, non è possibile allo gnostico giungere al sovraformale: “Certo senza scorza nessuna polpa matura, / Viene dalla scienza essoterica la soave teosofia” (p. 92).
La coloritura squisitamente sciita del testo affiora quando Shabestarī accenna alla profetologia sottesa alla propria dottrina. Il maestro richiama infatti il tema del «Sigillo dei Profeti», ossia del compimento dell’intero ciclo profetico in Muhammad, la cui rivelazione è dispiegata nel suo senso interiore, come per quella di ogni profeta legiferante precedente, da un corrispondente ciclo di santità, il cui compimento è il «Sigillo dei Santi». “La missione profetica trovò manifestazione in Adamo, / La sua perfezione si realizzò nel «Sigillo dei Profeti». / L’Iniziazione spirituale si protrasse per terminare il viaggio, / Per compiere nel mondo, come un punto, un nuovo ciclo. / La sua completa manifestazione sarà nel «Sigillo dei Santi», / Con lui si completerà il giro intorno al mondo” (p. 74). Il santo (walī), l’Amico di Dio, è colui che è iniziato dall’Imam al senso interiore della rivelazione. Dal sapore decisamente ismailita è l’accenno al corpo mistico dell’Imam: “Le esistenze dei santi sono per lui [il «Sigillo dei Santi»] come le membra, / Ché egli è la totalità ed essi sono le parti” (p. 74). Condizione della funzione profetica, la santità trova in quest’ultima il suo coronamento; eppure è il senso interiore sotteso alla rivelazione la sua autentica ragion d’essere. La delicata questione della priorità di rango tra santo e profeta, in fondo, è solo una questione prospettica: il profeta è un santo che, in virtù della sua perfezione, viene investito provvidenzialmente di una missione; è pertanto superiore al santo in quanto la sua perfezione è compiuta e manifestata nell’opera che è chiamato a svolgere – “Giacché il Profeta è realizzato, nella profezia, / E’ superiore di necessità a qualsiasi uomo di Dio (p. 76) –; in altra prospettiva, la santità è condizione della funzione profetica, pertanto è più originaria, interiore e universale di quest’ultima, contenendola in sé come sua possibilità. Scrive Shabestarī: “Il Profeta è simile al Sole: l’Uomo di Dio alla Luna, / Questi a lui corrisponde nell’«Io sono con Dio». / La Profezia è trasparente, nella sua perfezione: / E’ manifestata in essa la divina Prossimità, non è celata. / Nell’Uomo di Dio la prossimità deve essere velata: / Nel Profeta l’Uomo di Dio si mostra apertamente” (p. 72).
Il ciclo iniziatico si compirà nell’avvento dell’Imam occulto, che dispiegherà integralmente l’esoterico della Rivelazione; tempo escatologico che appartiene, prima di tutto, a una cronologia dell’anima, se è vero che l’uomo compendia in sé l’intero creato. L’ora dell’Imam è il mezzogiorno spirituale in cui scompare l’ombra delle forme istituite dalla funzione profetica; in esso sussiste la sola luminosità abbagliante della Verità e della sua teofania. Shabestarī descrive questa immagine maestosa e trionfale in quello che è, probabilmente, il vertice poetico dell’intera opera: “In ogni istante, dal Sole si manifesta un’ombra / Che diventa supporto per l’ascendere della religione. / L’ora del mezzogiorno è il tempo del nostro Signore, / Esente da qualsiasi ombra ed oscurità. / Lungo la linea meridiana, non getta ombra, una figura diritta, / Né in avanti, né indietro, né a destra, né a sinistra. / (…) / A Lui non compete ombra, perché questa implica l’oscurità: / Benvenuta luce di Dio, Ombra divina! / Il suo Polo è tra Oriente e Occidente, / Per questo egli annega nella luce” (pp. 75-76).
